Carte nel Vento
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
periodico on-line del Premio Lorenzo Montano
Lorenzo Montano (1895-1958), il poeta cui è dedicato l'omonimo Premio organizzato dalla rivista "Anterem", nel 1956 ha deciso di pubblicare in volume i suoi "scritti dispersi" e li ha raccolti sotto il titolo "Carte nel Vento", volume edito da Sansoni.
Riproponiamo lo stesso titolo per la nostra rivista On Line, perché, come Montano, anche noi intendiamo mettere insieme ciò che il tempo ha "disperso" o il vento si prepara a fare.
(Per un problema tecnico del vecchio sito abbiamo irrimediabilmente perduto alcuni documenti dei primissimi numeri)
Gennaio 2025, anno XXII, numero 55
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura della redazione di "Anterem"

Nel 2020 si sono addensate sulla redazione di Anterem le nubi più nere: gestire l’editrice e il premio Montano in lockdowm, senza incontri e senza forum, portare a pubblicazione il numero 100 e quindi chiudere dolorosamente la rivista. L'incidente di Flavio e la pandemia, i problemi di salute e familiari, la giuria ridotta ai minimi termini. Rimasti in pochissimi a poter occuparsi delle note di presentazione.
E, viceversa, come un dono, la qualità altissima delle opere presentate al premio. Un onore grande per noi. La forza di ridare vita all'editrice. Grazie anche alla bellezza degli inediti. E opere edite strepitose. Lo testimonia il numero elevato di segnalati e finalisti. E soprattutto la qualità dei lavori. La forza della poesia.
Abbiamo dovuto attendere il 2021 per ridefinire la nuova redazione, ampliando la giuria del premio e tornando ad essere voci plurali nella recensione delle opere. Per il 2020, invece, ci presentiamo in pochi all'appello per le note e ci perdonerete la presenza pervasiva per l’edito…
Un edito di una forza poetica incredibile, nella ricchezza dei temi e degli stili. Si è già potuta constatare, nel numero precedente, la grande qualità dell'opera vincitrice e delle raccolte edite segnalate speciali. In questo numero sono presentate le diciotto edite finaliste.
Sono opere di grandissima qualità, lineari e sperimentali, liriche e filosofiche, che abitano poeticamente il reale, il sogno, il mito, il pensiero. Tra Cardini e Graffiti, Tavole e stanze, Polveri Squame Piume. In una Scena muta come nel Giardino della gioia. Muovendosi lungo Coordinate per la crudeltà e Levels. Portandoci Notizie da Patmos come da NT (nessun tempo). Aprendo spiragli onirici con scacciamosche (nugae) e speculativi con Colpa del mare e altri poemetti. Costruendo un Taccuino dell’urlo e Teatr/azioni. Modellando mito e tragedia in Figura e componendo Lilith. Un mosaico. Muovendo sulle orme innevate di Lupa a gennaio e proponendoci visioni con Una visita a Hölderlin.
Gli autori Nicoletta Bidoia, Fabrizio Bregoli, Maria Grazia Calandrone, Sonia Caporossi, Silvia Comoglio, Elena Corsino, Bruno Di Pietro, Rita R. Florit, Daria Gigli, Alessandra Greco, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Fabrizio Lombardo, Alberto Mori, Davide Nota, Fabio Orecchini, Ivan Schiavone, Massimo Scrignòli, sono tutti presentati da Laura Caccia.
Un piacere e un onore occuparsi di opere di così alto livello. Un grande dono per il premio Montano. Premio che, nell'edizione che sta per essere inaugurata, avrà scadenza il 15 maggio 2025: attendiamo le vostre opere inedite ed edite, certi sempre dell'alta qualità dei lavori, così come della partecipazione costante e attiva alla comunità poetica di Anterem.
La redazione
In copertina: Nobis sonavit diabolus (Omaggio a Niccolò Paganini), scultura di Gibo Perlotto
(anno 2022; Materiali Ferro, carta; Dimensioni 81x56,5x133,5 h; Peso 36 kg; Foto di Piero Rasia)
Nicoletta Bidoia, da “Scena muta”, Ronzani Editore 2020, nota di Laura Caccia - La parola che danza
La parola che danza
Perché la parola possa danzare occorre creare silenzio intorno. Fare del tacito il protagonista. Sul palcoscenico, come sulla pagina bianca. E perché possa trovare espressione occorre predisporre fondali di vita in cui fare esperienza di tutto il sospeso, il nascosto, il non detto. Necessita che si metta a nudo ciò che, nel paesaggio visibile, il silenzio accompagna: il biancore delle nevi e dei ghiacci, la durezza della stagione invernale, la stretta del gelo che assidera storia e natura. E che si penetri in ciò che, nel paesaggio invisibile, il silenzio custodisce: l’oscuro, il segreto, l’enigma.
Così Nicoletta Bidoia ci conduce, in Scena muta, attraverso i rigori taciti della realtà e la dolcezza misteriosa del reale più intimo, tra ‘La morsa’ e ‘Il caro enigma’. Cercando di «sottrarre al chiaro / ciò che conta», di esprimere quel «sentimento oscurato dalle labbra» che possa essere reso con la sola forza interiore. Quando il dolore «si imbosca / nelle parole». Fino a che la voce possa trovare, dentro di sé, i suoi passi, così come, nel movimento del corpo, il suo ritmo. A partire da quanto messo in luce dalla danza. Facendo rivivere sia le esperienze adolescenziali, nelle parti in prosa di ‘Ora per allora’, sia quelle di una figura leggendaria del balletto classico, nei versi dedicati a Vaslav Nijinsky in ‘Finiremo per trovarci’, attraverso la rielaborazione poetica dei suoi Diari. Uscendo così dal mutismo, per quanto in grado la danza, nei virtuosismi del ballerino russo, di mettere in luce interiorità e visione, intensità e follia, profondità e vertigine
Una danza che, dopo aver attraversato gelo e oscurità, non possa accontentarsi delle coreografie del visibile. Una danza che si faccia verità. Che, come il principio, scardini e stremi. E che richieda una scena muta intorno per innalzarsi e rimanere in sospeso. Che si nutra di quel sollevarsi nell’aria che più che movimento è immobilità e silenzio. Nella vertigine della fissità. In quell’azzurro che Nijinsky, anche nelle parole dell’autrice, afferma di conoscere, attraverso la sua capacità estrema di alzarsi in volo e di prolungarne la sospensione. In quel silenzio e in quella sospensione la parola poetica di Nicoletta Bidoia si fa anch’essa danza, scegliendo una «scena / da poco», «i versi muti di chi muore a sé / e non ritorna» e «una sintassi nuova / dove i segreti sostano per qualche ora / chiamandosi per nome».
Da: La morsa
Quando finirà
questo secolo lungo di ghiacci
e novene, l’irrigidirsi dei propositi
che cristallizzano col fiato?
Ci chiediamo se sia del bianco
l’invenzione dell’eterno.
***
Abbiamo puntellato le travi
perché non cedano agli inverni
e trovino forza dal basso.
Conversiamo sottovoce di pane
e di vento e di come da tempo
si raffreddi anche la retina
che tutto stenta a trattenere.
Ogni giorno, prima di uscire,
mandiamo a memoria gli alfabeti,
li prepariamo a concentrarsi
su pensieri di tundra
e la durezza che c’è.
Da: Il caro enigma
Eppure in questo esilio
c’è spazio per sussurri,
premure e capogiri
che si appoggiano alla gioia.
La si vede a occhio nudo.
In questa calma teoria di silenzi,
che cova godimenti e pleiadi
più intime, c’è una sintassi nuova
dove i segreti sostano per qualche ora
chiamandosi per nome.
E se è arduo decifrare nelle stanze
le rotte degli amanti, tradurremo
ogni passo in una data,
nell’ora immacolata della notte.
***
Siete tutti così intelligenti, così attivi.
Qui è scena muta, è scena
da poco. Si depongono
le attitudini come chi preferisce
mancare lo scopo e ama solo
i tempi morti.
Da: Ora per allora
III
Tornò settembre, il secolo era diverso; Com-prai al mercato tre rose bianche, una per ogni tomba. Prendemmo il treno per la laguna e puntammo dritte a San Michele. Questa volta il noi era due. Con la mappa del cimitero cercammo le lapidi e una scopa per pulirle. Il sole alto delle undici, il cielo limpido dei mistici. Pregammo Brodskij, Diaghilev e Stravinsky, li implorammo di esistere là dove già erano. Una rosa per chi si spaesa. Una rosa per la caduta. E una per chi resta.
Da: Finiremo per trovarci
I
Abbaglia ancora la bianca e santa Pietroburgo,
la neve appoggia sulle spalle il suo saluto.
Ala Scuola Imperiale ero Nežinka, il ‘tenero’,
ero il nervoso periodare del veggente. Io vedo tutto, io vedo il dolore che si imbosca nelle parole, il sentimento oscurato dalle labbra, io ascolto il mite, i versi muti di chi muore a sé e non ritorna. […] Già da allievo miracolavo nel salto perché se parto alla volta del cielo è per restarvi a lungo a mezz’aria. Non conosco altro azzurro se non quando prolungo l’incontro là in alto e mi sospendo, vi penso, mi calmo. E dopo ogni indugio ritorno a quel fuoco, plano, scendo in me come un perdono. […] II […] Per essermi fedele devo tradire l’aria di prima, il mio mulinare nel vento, devo interrare l’astro e l’arcata perché è venuto un tempo di pietra inatteso, c’è un’altra vertigine. Mai si è visto così tremendo il battito di ciglia dell’immobile. […] III […] Penso spesso alle stelle perciò so chi sono. Veglio il mondo e indovino. Sulla soglia aspetto e col palmo della mano a conchiglia raccolgo le voci all’orecchio, le attendo. Sono il solo in ascolto. […] In Finiremo per trovarci sono in corsivo nel testo le frasi di Vaslav Nijinsky tratte dai suoi Diari, nelle traduzioni di Gabriella Luzzani e Maurizia Calusio (entrambe per Adelphi). Nicoletta Bidoia, è nata nel 1968 a Treviso, dove lavora presso l’ufficio di un ente pubblico, e vive in provincia. Ha pubblicato i libri di poesia Alla fontana che dà albe (2002), Verso il tuo nome (2005, con prefazione di Alda Merini), L’obbedienza (2008, con prefazione di Isabella Panfido) editi da Lietocolle, e Come i coralli (2014) con La vita felice. Nel 2013 è uscito il libro di narrativa Vivi. Ultime notizie per Luciano D. per le edizioni La Gru. Nel 2006, con la cantautrice Laura Mars Rebuttini, ha ideato e realizzato lo spettacolo Un piccolo miracolo. Nel 2019, insieme al cantautore Gerardo Pozzi, ha realizzato lo spettacolo Sotto terra, sopra un prato. Ha inoltre collaborato con altri musicisti in occasione della presentazione dei suoi libri, tra cui: la cantante goriziana Gabriella Gabrielli, i cantanti romani Sara Modigliani e Andrea Belli e l’arpista Tiziana Tornari. Più volte è stata ospite a Fahrenheit di Rai Radio3 nella rubrica giornaliera “Il poeta della settimana”, in occasione dell’uscita de L’obbedienza e di Come i coralli, e nella rubrica “Il libro del giorno” presentando Vivi. Ultime notizie di Luciano D. nel dicembre 2013 (questa registrazione si trova in Youtube). Alcune sue poesie, apparse anche in raccolte e riviste, sono state tradotte in spagnolo nel libro Jardines secretos. Joven Poesìa Italiana, a cura di E. Coco (Sial, Madrid, 2008). Negli anni, è stata ospite al PoesiaFestival di Modena, al Festival di poesia internazionale di Genova, al Festival Vicino-Lontano di Udine, al Festival dei Matti di Venezia e al CartaCarbone Festival di Treviso. Oltre che in provincia di Treviso, ha effettuato presentazioni a Roma (Casa Internazionale delle Donne, Libreria Odradek e Libreria Altroquando), Bologna (Feltrinelli), Venezia (ex Mondadori, Fondazione Querini Stampalia, Libreria Marco Polo), Milano, Reggio Emilia, Cesenatico, Varallo Sesia, Gorizia, Brescia-Padernello, Opi (invitata da Dacia Maraini) e in altre città. Compone collage e teatrini di carta (rintracciabili sul canale stroega di Youtube e stroega di Instagram).
Fabrizio Bregoli, da “Notizie da Patmos”, La Vita Felice 2019, nota di Laura Caccia - Riparazione e oltre
Riparazione e oltre
Ci sono luoghi marchiati dall’abbandono e dall’esilio. Altri dal ritorno e dalla riparazione. Quali Notizie da Patmos ci giungono da Fabrizio Bregoli? Forse la dura arte del rientrare in patria, come ci precisa fin da subito la citazione in esergo dalla Comedia. Forse l’esigenza personale di affrontare il proprio vissuto e di riparare il passato. Forse quella più generale proiettata verso una ricerca di senso e di padri. A partire da ‘Nel nome del padre’, che dà titolo alla prima sezione. E da un quarto comandamento che diventa «Onora il nulla / il solo che ci è dato». Un padre che si dilata nei suoi significati plurimi fino ad arrivare ai fondamenti del cosmo, della vita, della poesia. Non solo per consentire il confronto con il «padre esatto di un teorema sbagliato», ma anche per dare modo di trovare, attraverso la parola, una «paternità restituita», una «Terra salda», l’ordine nel caos.
Non a caso l’autore, per affrontare la complessità, fa spesso utilizzo nella sua poetica delle strutture delle scienze esatte. Qui ne fa esplicita dichiarazione in premessa: per come a colmare una mancanza, suturare un baratro occorra mettere in atto una specifica «Arte della riparazione», propria dell’algebra come della poesia. La riparazione, però, come la poesia, chiede altro. Così questa poetica scarta, cerca «un passo in più, un verso oltre». Cerca un altrove e «in quell’altrove, un oltre». Vuole certo ricomporre, riparare, ma andando oltre, scuotendo il linguaggio consueto e capovolgendo assiomi. Nel solco, tra le molteplici altre suggestioni, della fisica quantistica, della relatività, delle geometrie non euclidee. Così come nell’apporto pluridimensionale delle arti e, a incrociare le domande di senso, delle riflessioni filosofiche e religiose.
Mentre si fa contaminare da matematica e musica, fisica e teologia, cinematografia e poetiche degli autori amati, la scrittura etica di Fabrizio Bregoli pare cercare in Patmos il perno del suo ritrovarsi. Nel rigore matematico e nella poesia degli endecasillabi. Nel pericolo e nel rischio della ricerca di senso. Confidando però nella parola che, nonostante le apocalissi private e collettive, può riparare e portare notizie salvifiche. Patmos: che, secondo tradizione, fu luogo di esilio e di elaborazione dell’Apocalisse di Giovanni, libro colmo di visioni tese allo svelamento attraverso immagini allusive e simboli anche numerici. Patmos: da cui prende spunto Hölderlin nella lirica omonima, densa, insieme, di prossimità e di inavvicinabilità al divino, per indicarci come cresca la salvezza dove c’è il pericolo, proprio al fine di poter partire e quindi ritornare più fedeli al senso.
Da: NEL NOME DEL PADRE
VOCABOLARIO MINIMO
Se scrivo è per non dire, cabotare
il bianco della resa, i giorni miti
del nostro indocile armistizio. Scrivo
la vena innominata della pietra,
veglio l’angolo illeso del respiro
quel suo retaggio fossile.
Accolgo la voce spoglia, il suo sfratto
il corpo intatto del ripudio.
Scrivo di noi, di un verbo contraffatto,
del suo frutto disseccato
sul pegno delle labbra. Scrivo di noi
grammatica di un vento lapidato.
Da: MISTERI INGLORIOSI
QUARTO COMANDAMENTO (RIPRESA)
Rimane la poesia, spietata e imbelle
tutt’intero il suo soldo bucato,
l’ovvio scrivere ciò che non sai dire
– assioma sghembo di un figlio scontato.
Onora il nulla
il solo che ci è dato.
Da:(DIGRESSIONE QUANTISTICA)
(PLANCK
(A invaderci talvolta
è un bisogno d’ordine, disgregare
il continuo indistinto delle vite,
parcellizzarle per addensarne il senso
rendere il vuoto confutabile.
Forse dobbiamo a questo il nostro perderci,
redimere quel ganglio opaco
tutto il suo corpo nero
ed anche noi scoprirci irradiazione
di un fulcro stabile, luce compatta
cifra di una costante universale.
Da: CARTEGGIO CLANDESTINO
NOTIZIE DA PATMOS
Comincia tutto ripetendo un nome
da un buio prossimo, colpo di coda
di qualche creatura d’abisso. Dopo
è la stagione del balbettio – certe
muschiose lallazioni – infine frasi
fatte, proverbi storpiati, eserghi
o falsi. Rovine che non sorreggono.
Comprendi davvero d’essere lingua
quando il futuro diventa ipoteca,
passato da riscrivere, scandire
polso a polso la ruggine dei chiodi.
La poesia non cambia nulla
è il nulla che la cambia. La fa possibile.
Da: BREVIARIO APOCRIFO
JOHN CAGE 4’33”
Nessun verbo migliore per descriverci
dell’intenzione che si fa rinuncia,
quel suo zero assoluto. Boreale.
Tutto il blasfemo
del suo parto gemellare
suono e sua scomunica.
Noi siamo entrambi. Quella voce
inabitata e tutto l’impossibile
del suo silenzio.
Da: COME UN INIZIO
*
Non si scrive d’amore, caro Rilke.
Se ne può dire solo per pudore
la luce impenitente dello scandalo
l’arteria dove si frantuma il legno.
Eppure che cos’è questo tacerne
se non per negazione dirne, ammetterci
imperfetti, cercarci oltre l’assunto
dello sguardo, quel sottinteso sordo?
Ed anche qui
l’amore lo si è scritto, in privazione
ipotesi che non si dà una prova.
Il nostro, un dimostrarlo per assurdo.
**
Quando s’addensa, dove
trapana – è un vuoto. Dopo (dopo, quando?)
in quell’altrove, un oltre:
la resa necessaria, un
silenzio sull’arco della parola.
Celato in quel mai, un ναί
il suo bianco fragilissimo. La neve
delle sue mani.
Fabrizio Bregoli, nato nel bresciano, risiede da vent’anni in Brianza. Laureato con lode in Ingegneria Elettronica, lavora nel settore delle telecomunicazioni.
Ha pubblicato “Cronache Provvisorie” (VJ Edizioni, 2015), “Il senso della neve” (puntoacapo, 2016), “Zero al quoto” (puntoacapo, 2018), “Notizie da Patmos” (La Vita Felice, 2019).
Sue opere sono incluse in “Lezioni di Poesia” (Arcipelago, 2015) di Tomaso Kemeny e in “iPoet Lunario in Versi 2018” (Lietocolle, 2018), sulle riviste “Il Segnale”, “Alla Bottega”, “Le voci della Luna”, “Il Foglio Clandestino”, in numerose altre antologie, sui più noti blog di poesia.
Ha inoltre realizzato per i tipi di Pulcinoelefante il libriccino d’arte “Grandi poeti” (2012) e per le edizioni Fiori di Torchio la plaquette “Onora il padre” (Seregn de la memoria, 2019).
Ha conseguito numerosi riconoscimenti per la poesia inedita, fra i quali gli sono stati assegnati i Premi San Domenichino, Daniela Cairoli, Giovanni Descalzo, Luciano Nicolis, Piemonte Letteratura, Terre di Liguria, Il Giardino di Babuk, il Premio “Dante d’Oro” dell’Università Bocconi di Milano, il Premio della Stampa al Città di Acqui Terme e più volte è stato segnalato e finalista ai premi Guido Gozzano e Lorenzo Montano.
Per la poesia edita gli sono stati assegnati, fra gli altri, i Premi Guido Gozzano, il Premio Letterario Internazionale Indipendente, Città di Umbertide e Rodolfo Valentino.
Collabora come recensore con il sito letterario “LaRecherche.it“, con la pagina Facebook “Poeti Oggi” e fa parte della redazione del blog letterario “Laboratori Poesia” per cui cura la rubrica “Poesia a confronto”.
Il sito dedicato alla sua poesia è: https://fabriziobregoli.com
Maria Grazia Calandrone, da “Giardino della gioia”, Mondadori 2019, nota di Laura Caccia - La cura dell’esistere
La cura dell’esistere
L’esistere chiede cure. Il suo giardino attenzioni. Per lo sbocciare del sentire, il gioire al colmo della fioritura, le situazioni infestanti, le calamità. Così come per lo sfiorire, l’appassire, il morire. E per la solitudine, la nostalgia, il dolore.
La poetica di Maria Grazia Calandrone in Giardino della gioia si prende cura di tutto, senza dimenticare alcun elemento del vivere, alcun sentire umano. Tra amore e disamore, bene e male, cura e abbandono, affetti e violenza, attenzione agli ultimi e atrocità di guerra. Oscillando in modo significativo e continuo tra le polarità della vita umana e del cosmo, del visibile e del mistero, del corpo e dell’anima.
A partire dai primi versi della raccolta, in ‘Io sono gli altri’. Dove pare di vedere riflessi i fotogrammi di Corpo e anima di Ildikó Enyedi. E dove si evidenzia, fin dall’esordio, come il prendersi cura riguardi l’attenzione alla fisicità mortale, così come al mistero spirituale. E, proseguendo nei testi, nel testimoniare di questo tutto l’esistere. Anzi ‘Il puro esistere’. Tutto quello che concerne il corpo: il corpo fisico, il corpo dell’altro, il corpo delle cose, la consistenza della materia, la ferita, la violenza, il taglio. E tutto quello che afferisce all’anima: l’emozione, il sogno, il mistero, il sogno stesso della materia. A costituire, con questo insieme, i presupposti delle relazioni sociali: la pietà, la compassione umana, la condivisione. In piena risonanza con l’altro e con gli altri, con la vita e con il cosmo, con la materia e con la storia. Nella convinzione profonda del senso etico e politico del vivere comune.
Una consonanza con l’esistere basata sulla gioia, che ne mette a fuoco l’apertura temeraria. In questo simile all’indagine di Jean-Luc Nancy sulla felicità, in quanto esposizione continua e rischiosa al fuori, in una fame di vita all’infinito che qui si ritrova nel sentirsi «esposti / alla felicita», in un «incessante / inno di gioia». Nel vibrare, a volte felice a volte drammatico, con tutto quanto accade e appare e, insieme, con quanto si cela nell’ignoto che la poesia riesce ad intercettare, per cui «basta il linguaggio, per / essere davanti / al mistero». Ed è una consonanza ancora, questa di Maria Grazia Calandrone, con la poesia stessa, poiché «le nostre molecole consuonano con la musica profonda della poesia, / che è la stessa in ogni lingua: un ultrasuono, un rumore bianco». Nel giardino del tutto.
Da: GIARDINO DELLA GIOIA
ogni cosa che ho visto di te, te la restituisco amata
tutta la vita è stata un esercizio per tornare
al tuo corpo
caldo come la terra
eppure scrivo della solitudine
di cocci d’osso
in conche di sabbia
scavate
con gli occhi delle scimmie che cercano riparo
corpi come scodelle rovesciate
i catini del cranio colmi di cielo
[…]
Da: TEMPO REALE
Non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo.
CONTRO L’ESILIO
Siccome nasce
come poesia d’amore, questa poesia
è politica.
*
La prima volta
che incontrai la persona che avrei amato
quando ci salutammo
provai la povertà d’essere al mondo, uno stento
irreparabile
dell’intero
essere emerso. Fu
più che una mancanza
un mancamento:
lo scodamento di un nero
getto di plasma
attraversava la costellazione
MGC 1.9.6.4 (uno.nove.sei.quattro). Il bene
lo riconosci cosi, quando vedi quel microcosmo, capace
di ogni bene e male, allontanarsi
sulla strada assolata
e sai che, se ritorna, smetterà un dolore
lungo tutta la vita, la nostalgia
che non sapevi provare e stava
sconosciuta e vicina come l’ombra alle spalle,
tua in silenzio e miseria
come la gioia che con la neve dura.
Roma, 20 luglio 2018
Da: IL PURO ESISTERE
STRUMENTI
Impara a fare le poesie come si fa il pane.
Impara a fare il superfluo. La nostra specie
si è ingegnata nel costruire oggetti
funzionali all’impianto biologico
del quale è dotata – le mani (forchette, penne, sigarette)
– o le gambe (pedali, automobili). Molto
veniamo rimpiazzati dagli oggetti.
Lo scopo è essere sostituiti nelle cure primarie degli apparati.
[Lo scopo è
essere liberi. Scorporare.
Oltre, stanno le rocce e gli alberi, quiete entità respiranti
che non appartengono a nessuno
e a niente di quanto si dissolve nell’atmosfera prima di toccare
[terra
Parola sostanziale regredita
dalla bocca alla mente
Verde, senza fiori, aromatica, verde di sangue raffermo, verde
[e petrosa, instabile
nella gioia matematica dello spazio
dove il reale è il vuoto della fisica
fra i battitori del grano
sopra una terra diventata immobile per l’attrito rovente delle
[atmosfere
su corpi che la poesia non salva.
Da: NEL SOGNO DELLA MATERIA
CIÒ CHE NON È MAI STATO È CIÒ CHE RESTA
Chiama «sole pomeridiano» un arco di memoria
tra solitudine e solitudine.
La sua lingua non basta, a dire «esilio».
Apre una mappa dei corpi celesti.
Trascrive le corrispondenze con l’atlante
anatomico (australopithecus
afarensis). Chi è il prossimo? «Proxima Centauri
si trova a circa 4,2 anni luce di distanza
da noi, pari a 270.000 volte la distanza fra la Terra
e il Sole». Vuole incontrare i simili. Vuole cominciare
ricordando il colore dello stagno nei pomeriggi estivi, quel ronzio
cosi prossimo al canto. Soprattutto, vorrebbe
ricordare una vita ancora possibile,
dove un gruppo di esseri umani ogni anno ripara
i danni della salsedine e del vento
sulle palizzate. Ma è lontana. È davvero
lontana. Si ripete che niente
è andato sprecato. In embrione
vede la fortuna.
Maria Grazia Calandrone (Milano, 1964) vive a Roma. Poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice Rai (ultimo ciclo: “Poesia in technicolor”), scrive per «Corriere della Sera» e per il settimanale «7»; dal 2010 pubblica poeti esordienti sul mensile internazionale «Poesia» e divulga poesia a RaiRadio3; è regista del ciclo di interviste “I volontari”, un documentario sull'accoglienza ai migranti e del videoreportage su Sarajevo “Viaggio in una guerra non finita”, entrambi pubblicati da «Corriere TV». Premio Montale 1993 per l’inedito, tiene laboratori di poesia nella scuola pubblica, in carceri, DSM, con i migranti e presta servizio volontario nella scuola di lettura per ragazzi “Piccoli Maestri”. Libri di poesia: La scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premio Pasolini Opera Prima), Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier, 2005), La macchina responsabile (Crocetti 2007), Sulla bocca di tutti (Crocetti 2010 – premio Napoli), Atto di vita nascente (LietoColle 2010), La vita chiara (transeuropa 2011), Serie fossile (Crocetti 2015 – premi Marazza e Tassoni, rosa Viareggio), Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (pordenonelegge 2016 – premio Dessì), Il bene morale (Crocetti 2017 – premi Europa e Trivio) e Giardino dellagioia (Specchio Mondadori 2019 – seconda edizione gennaio 2020), le traduzioni: Fossils (SurVision, Ireland 2018), Sèrie Fòssil (Edicions Aïllades, Ibiza 2019 – traduzione di Nora Albert) e l’antologia araba Questo corpo,questa luce (Almutawassit Books, Damasco 2020 – traduzione di Amarji); è in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi 2012). Libri diprosa: L'infinito mélo, pseudoromanzo con Vivavox, cd di sue letture dei propri testi (sossella 2011), Per voce sola, raccolta di monologhi teatrali, disegni e fotografie, con cd di Sonia Bergamasco ed EstTrio (ChiPiùNeArt 2016) e Un altro mondo, lo stesso mondo. Una riscrittura del Fanciullino di GiovanniPascoli (Aragno 2019); suoi racconti sono presenti in Nell’occhio di chi guarda (Donzelli 2014), Deaths in Venice (Carteggi Letterari 2017), Princesa e altreregine – a cura di Concita De Gregorio (Giunti 2018) e Un altro mondo, lo stesso mondo, riscrittura del Fanciullino pascoliano (Aragno 2019). Libri dicritica: ha curato e introdotto i volumi di poesie di Nella Nobili Ho camminato nel mondo con l'anima aperta (Solferino 2018) e Dino Campana. Preferisco il rumore del mare (Ponte alle Grazie 2019). Dal 2009 porta in scena in Europa il videoconcerto Senza bagaglio e dal 2018 Corpo reale, musica di Stefano Savi Scarponi e accompagnamento alla batteria di Arturo Casu. Nel 2012 vince il premio “Haiku in Italia” dell’Istituto Giapponese di Cultura e nel 2017 è nel docufilm di Donatella Baglivo “Il futuro in una poesia”, nel progetto “Poems With a View” del regista israeliano Omri Lior e nel progetto internazionale “REFEST – Images & Words On Refugee Routes”, pubblicato da “il Reportage”. Ha collaborato con i programmi di televisivi di Rai Letteratura e Cult Book. Sue sillogi compaiono in antologie e riviste di numerosi paesi. Il suo sito è www.mariagraziacalandrone.it
Sonia Caporossi, da “Taccuino dell’urlo”, Marco Saya Edizioni 2020, nota di Laura Caccia - Una cornice per il caos
Una cornice per il caos
Dopo L’urlo pittorico in serie di E. Munch e l’Urlo poetico di A. Ginsberg, Sonia Caporossi, in Taccuino dell’urlo, ci mostra un’altra modalità per esprimere la tensione emotiva che sboccia in un grido di dolore. Un urlo interiore che, in questi versi, si fa riverbero tra l’assenza e il richiamo, l’abbandono e il ritorno, il conflitto e l’oblio. Un urlo che non viene lasciato esplodere come nelle tele di Munch, ma che, dei suoi quadri sul tema, ha il contrapporsi delle figure in primo piano e ai margini. Così come il contrasto delle tonalità dei colori caldi e freddi, che pare rispecchiarsi, nella raccolta, nei dialoghi-scontri di una conclusa, ma ancora tormentata, storia d’amore. Con l’urlo di lui in primo piano e il virgolettato di lei sempre più evanescente sullo sfondo.
Solo una storia d’amore? Più indizi conducono a individuare la messa a fuoco del testo non solo e non tanto su una relazione affettiva drammatica e sofferta, quanto, attraverso di essa, sul rapporto, indagato a livello poetico, psicologico e filosofico, con il reale. Nella frattura tra desiderio e realtà, sogno e inganno, senso e perdita di senso. Nello «scarto tra «sé» e «sé»», nella solitudine che emerge sia dal rapporto amoroso sia in generale dallo stare al mondo. E, insieme, nell’esigenza, che l’urlo sottostante evidenzia, di dare a tale solitudine uno sbocco nella relazione umana come nella scrittura. Così emerge il bisogno di abbracciarsi, simili a «scatole d’assenza / riconoscerci a distanza», a partire da un disagio sociale che trova il suo rispecchiamento nell’Urlo dissacrante di Ginsberg. Così il riuscire a fare sbocciare, dal disagio individuale, la scrittura, tenendo conto di quanto chiaramente preteso dalla poesia. Poiché «per scrivere necessita una rabbiosa solitudine / e un istinto meno che umano».
La scrittura di Sonia Caporossi sperimenta un linguaggio percussivo e dissonante, ad evidenziare la drammaticità della tensione, in vivo contrasto con l’ordine della composizione. Quasi che tale tensione necessitasse di una cornice di contenimento per l’abisso e per il franto del linguaggio e della psiche. Un ordine nel caos. Non a caso il giusto ordine, anche nell’etimo, del Taccuino. Che raccoglie 32 stazioni di appunti-dialoghi numerati e i quadri alfa, omega e, all’interno, phi, dai significati plurimi, a sancire la centralità della riflessione sul desiderio e sulla dimenticanza, sulla «ragione che non trova il senso” e sul «tempo per dire ancora».
I.
si affida a una voce
ode sé stesso nel grembo infecondo degli orecchi
come sentirsi ridere a comando
a piacimento
nel bacchettarsi ieratico dell’imprinting feroce
dell’urlo
del richiamo a chi tace
quando l’ascolto si reitera intonso
nel fingere di prestarsi
di apprestarsi
di arrestarsi
alla domanda gonfia di fiato
quando le labbra si chiudono
nel richiamo
a chi tace
e nessuno risponde
a ciò che ha domandato.
XV.
Nell’assenza
{indesiderata, inerte}
sparge bruciore di :: fumo :: sui pianali del pensiero
quanto di lei gli rimane nel {sogno}
di un’indecenza pagana
nel suo rituale che lo condanna all’attesa
è l’essere scabro delle mani chiuse a pugno
che dentro, nel palmo, nel centro di tutto
concentrano il suo nome-odore-lignaggio
nell’ignobiltà ostentata del peso pericardico
che grava su quel petto illuso di visioni
come se la vedesse a un orizzonte di senso perduto
sorridente, estatica
chiamare il suo nome nel vuoto.
φ.
«mandami un cenno di mancata intesa
eludimi nel sonno
di una ragione che non trova il senso
rapprendimi, comprendimi, prendimi
ama la scorza d’arancia amara che mi avvolge
tocca la mia ovale, imperfetta nudità
sottintendimi, lasciami andare, virami
col timone del timore di paure troppo vuote
rilassami le corde del collo di tensioni
che non sanno duplicare dna d’alienazione
risuonami il colore
di un fonema troppo asciutto
ripetimi le promesse da infrangere
solo perché sei fragile come vetro
annebbiami le certezze, tu che sai di non sapere
abbi pietà e potenza
che c’è tempo per volere
c’è sempre tempo per dire ancora
quando il futuro è malnato e soffuso
come la luce che copre le disgrazie
come l’assenzio che imbeve il pericardio
e poi alla guida non si può mai bere
se non andando incontro
a questo strazio
allacciami le scarpe
per una scalza ingenuità
ricordati dei vuoti di memoria
che lamentavi durante l’impressum
ritorna da dove sei andata
e vieni da dove ti hanno creata
non c’è scampo per l’offesa
e non c’è scabbia sulla mia pelle
perciò toccami, amami, invogliami
incensami intonso e impuro
voglio solo percepire il magro orpello del tuo odore
voglio solo irretire lo scoglio scrostato
del mio assurdo desiderio
non c’è luce
non c’è odore
non c’è amore che possa stare
voglio solo addormentare questa voglia di volere
voglio solo
sempre e solo
rigirarmi dall’altra parte
e poi, stanco di stancarmi
dimenticare.»
ω.
alla fine lui resta in silenzio
nell’abbraccio addormentato
rimando scabro di un lembo di pelle
rabberciato {lungo i bordi} nella fame di poesia
alla fine rinuncia all’amore
si prende in carico l’infarto
l’assassinio autoindotto del cuore
in questa quieta decisione
tanto lo sa che ritornerà
il desiderio del suo {fuoco greco}
perché l’amore non serve poi a tanto
::
per scrivere necessita una rabbiosa solitudine
e un istinto meno che umano, e stanco
di ripensarsi interi
dopo la distruzione.
Sonia Caporossi (Tivoli, 1973), è musicista (con i Void Generator: Phantom Hell And Soar Angelic, Phonosphera Records 2010; Collision EP, 2011; Supersound, 2014; Prodromi, 2017; Anatomy of a Trip, 2019), narratrice (Opus Metachronicum, Corrimano, Palermo 2014, seconda ed. 2015; Deaths in Venice. Racconti dalla laguna, a cura di L. Liberale, Carteggi Letterari 2017; Hypnerotomachia Ulixis, Carteggi Letterari, Messina 2019), critica letteraria e curatrice (Un anno di Critica Impura, Web Press, Milano 2013; Poeti della lontananza, Marco Saya, Milano 2014, con A. Pierangeli; Pasolini, una diversità consapevole a cura di E.Campi, Marco Saya, 2015; Da che verso stai? Indagine sulle scritture che vanno e non vanno a capo in Italia, oggi, Marco Saya, 2017; La Parola Informe. Esplorazioni e nuove scritture dell’ultracontemporaneità, Marco Saya, 2018; La gentilezza dell’Angelo. Viaggio antologico nello Stilnovismo, Marco Saya 2019; Diradare l’ombra, antologia di critica e testi per Claudia Zironi, Marco Saya 2019), poetessa (La consolazione della poesia a cura di F. D’Amato, Ianieri Edizioni, Pescara 2015; Erotomaculae, Algra, Catania 2016; Alla luce di una candela, in riva all’Oceano a cura di L. Leone, L’Erudita, Roma 2018; La forma dell’anima altrui. Poesie in omaggio a Seamus Heaney, a cura di M. G. Calandrone e M. Sonzogni, LietoColle, Como 2019), saggista (La pietà del pensiero. Heidegger e i Quaderni Neri a cura di F. Brencio, Aguaplano, Perugia 2015). Dirige per Marco Saya Edizioni la collana di classici italiani e stranieri La Costante Di Fidia. Dirige inoltre i blog Critica Impura, Poesia Ultracontemporanea, disartrofonie e conduce su NorthStar WebRadio la trasmissione Moonstone: suoni e rumori del vecchio e del nuovo millennio. Vive e lavora nei pressi di Roma
Silvia Comoglio, da “scacciamosche (nugae)”, puntoacapo 2017, nota di Laura Caccia - Nel sonoro del tutto
Nel sonoro del tutto
Non ha origine sulla pagina, come non si conclude in essa, la scrittura di Silvia Comoglio, che in scacciamosche (nugae) conferma questo suo essere parte di altro. Di una totalità. Di una partitura più ampia. Una partitura, in questa raccolta per coro e voci, di cui sembrano rimanere solo brani isolati. Dove i diversi interlocutori appaiono a squarci: un tu spesso richiamato, dai volti molteplici, così come i soggetti sottesi ai pronomi della coralità. Dove la voce e le voci sono in dialogo. Una voce che si esprime in tutte le sue molteplici possibilità, conducendo a una visione e a una lingua altre. Una voce che, mentre nomina il visibile, evoca l’invisibile. Mentre provoca gli interlocutori sottesi, convocandoli in superficie, ne revoca l’affioramento. Mentre invoca, per ottenere una possibilità di conoscenza, tiene a trama fitta il mistero. Nel suo dire onirico, denso di immagini richiamanti in «ogni sogno — / uno scandalo», un turbamento, un presagio.
Qualcosa di sotteso si affaccia tra gli spiragli di suoni e visioni. Musicato tra sogno e finzione, immagine e bugia, anzi «in grazia, enorme, di bugia». Grazia e insieme bugia: forse del mondo che con la sua bellezza pare mascherare il vero, forse della parola nella sua tensione a liberarsi dell’apparenza verso una visione altra. Allora sarà il «buio a scacciamosche» a consentire di disperdere le false verità del visibile che disturbano il vero, per cercarne i segni nell’oscurità e nel sogno. Qualcosa sempre nascosto, in ombra, che solo una lingua onirica può riuscire ad amare. Così titolo e sottotitolo della raccolta appaiono scelti forse proprio per occultarne la relazione amorosa, mascherandola come fastidio da scacciare o come inezia, nugae, quale già in Catullo e Petrarca, tra gli altri, per le loro opere non certo minori.
Una relazione aperta invece a tutto quanto di prossimo al vero, sull’orlo del dire e nei suoi intermezzi, pare in attesa di annunciarsi. Nel dialogo tra le parti, in tondo e in corsivo. Nelle aperture sollecitate dei diversi segni grafici. Nei versi che si dilatano nel tempo, proseguendo anche oltre i post scriptum. E che spaziano muovendosi repentinamente dal terreno dolente e condiviso degli umani all’ultraterreno. Così come nel linguaggio, passando dal dire infantile e quotidiano del «dormire-qui-per-terra» al lessico alto in cui «ú- / signoli stupendi chérubinano in cielo / andando, indietro, tutti a ritroso…». La partitura di Silvia Comoglio è musica senza fine. Nel suo espandersi a ritroso e nell’oltre. Nel sonoro familiare, nel canto delle sfere.
ora dite se fu la notte di pubblica fatica
a farsi, farsi in questa stanza, forma —
gocciolata ad acqua! di sola mia coscienza
adorna, per amore, a peso di stupore
Da: I
di lingua congiunta alla tua forma —
tutto, torna, dopo il sonno a fede del suo tempo,
come se del lato dell’ombra fissata al petto
restasse qui sopra, su questa terra, un baciarmi
forgiato ad elmo pre-cosciente
*
Quanti, ancora, i folli folli di saliva? I mutati
te che passa venuti, sull’ombra della sponda,
come se in grazia, enorme, di bugia?
*
“sia tempo a notte di polmoni il dormire,
dormire-qui-per-terra!, ad atto che conosce
tutto del mio sogno : e sia, sia buio,
buio a scacciamosche!, l’ombra di bastone
che, curva di sutura, ruota sulla stella
sulla corsa sul leone
---
*
Saremo visti sui tempi da sognare,
erranti e ancora soli? a tratti già rimasti
di buio sempre in braccio? tenda, di tre passi,
entrata di difesa nell’ombra dell’elmo che ti porto
in grazia, enorme, di bugia?
Da: II
*
“sei stato, disse, così felice!, di grazia —
immota a luna, dove quanto ti sussurro
sono appena gl’occhi del tempo che non viene,
quésta sola fine vista dove spazia l’ál-
bero mortale —
*
se ti amo —
è per il bordo di bugia, per-chi-mi-sembri
quando sogni, sogni e mi nascondi, tutta —
la bugia
*
fu un dormire, un dormire?,
qui-per-terra, unici e prudenti?
un dormire, dite?, guardando cosa fare
e sognando, sognando poi di tutto —
per sapere cosa fare
---
*
“dirvi che vi prendo sempre solo in sogno?
che di terra vi corico per terra e vi prendo
sempre solo in sogno, sempre dove posso —
esservi-chi-sono?
*
è chiuso, disse, in aurora abbastanza,
il rullare di mani? l’ombra, di tutti,
i cambi di bosco che ú-
signoli stupendi chérubinano in cielo
andando, indietro, tutti a ritroso …
---
*
“questo fu mandato in segno di saluto,
il tempo, nel retro della casa, aperto sulla testa,
a morsa di stupore
_______
*
alla fine ci sentimmo —
consolati! baciandoci sugl’occhi,
su forme, a tempo, più sicure
*
p.s.
tu, sai dirmi?, dei grandi
baci a rispondi del mare di dio
Silvia Comoglio, laureata in filosofia, ha pubblicato le sillogi Ervinca (LietoColle Editore, 2005), Canti onirici (L’arcolaio, 2009), Bubo bubo (L’arcolaio, 2010), Silhouette (Anterem Edizioni, 2013), Via Crucis (puntoacapo Editrice, 2014), Il vogatore (Anterem Edizioni, 2015 – Premio Lorenzo Montano – XXIX Edizione - Sezione raccolta inedita), scacciamosche (nugae) (puntoacapo Editrice, 2017), sottile, a microchiarore! (Edizioni Joker, 2018), Afasia (Anterem Edizioni, 2021), În ape de tăcere/ In acque di silenzio (Editura Cosmopoli, Bacau, 2023), Il tempo ammutinato (partiture) (Book Editore, 2023).
Per Il vogatore è stata composta nel 2015 una partitura dal compositore e pianista Francesco Bellomi e per Via Crucis nel 2016 sono stati realizzati quindici disegni dall’artista Gian Paolo Guerini.
Suoi testi sono apparsi, tra l’altro, nei blog Blanc de ta nuque e La dimora del tempo sospeso, nel sito di Nanni Cagnone, sulle riviste Il Monte Analogo, Le voci della luna, La Clessidra, Il Segnale, Italian Poetry Review, Osiris poetry, nella rivista giapponese δ e nella rivista romena Poezia, e on-line nelle riviste Carte nel vento, Tellusfolio, La foce e la sorgente, Fili d’aquilone. Il portale BombaCarta le ha dedicato La lettera in Versi n. 56 curata da Rosa Elisa Giangoia. E’ presente nei saggi di Stefano Guglielmin Senza riparo. Poesia e Finitezza (La Vita Felice, 2009), Blanc de ta nuque, primo e secondo volume (Edizioni Dot.com.Press, 2011 e 2016) e La lingua visitata dalla neve (Aracne, 2019), nell’antologia Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta(puntoacapo Editrice, 2012), in Fuochi complici di Marco Ercolani (Il leggio, 2019) e in Anni di Poesia di Elio Grasso (puntoacapo Editrice, 2020).
Dal 2021 fa parte del Comitato di Lettura di Anterem Edizioni e della Giuria del Premio di Poesia e Prosa Lorenzo Montano.
Elena Corsino, da “Graffiti”, puntoacapo Editrice 2018, nota di Laura Caccia - Graffiare la lingua
Graffiare la lingua
Una parola concentrata, trattenuta tra i lembi di un graffio, di una crepa. Sottratta a tutto il superfluo del dire. Lasciata esposta nel suo farsi sfregio. In Graffiti,nel reciproco rispecchiarsi di versi e di immagini, le poesie di Elena Corsino e le fotografie di Max Carcione concorrono alla rappresentazione del distillato di un senso preciso relativo alle cose e alla lingua. In particolare, l’essere accomunate, la materia e la parola, da uno stesso destino. Resti sopravvissuti alla casualità degli eventi e alle scalfitture del vivere. Tracce superstiti del vuoto e del caos primigeni e, insieme, effetti degli urti, visibili e invisibili, del tempo e dell’esistere.
La materia e la parola. Una parola che necessita di portare alla luce quanto resta sottostante alla trama apparente del visibile, attraverso «i graffi della lingua lacerata». Una materia che esprime il bisogno di liberare l’energia che scaturisce dalle crepe e dalle increspature. E che, insieme, riflettono una stessa condizione, quasi fossero le pagine di un foglio smarginato, graffiato, strappato. O la tela su cui l’incisione di tagli spalanca, come nei lavori di L. Fontana, un varco verso uno spazio altro. «Tagli lasciare / su retina o tela, / lo fa anche il vento» scrive l’autrice, mostrandoci come anche lo sguardo si lasci incrinare e fessurare: «Niente è il vissuto / se non invisibile urto / con scie di crepe, / di figli e ferite, / e luminosi attriti».
È una parola «scabra» quella inseguita da Elena Corsino, cercata tra le crepe di una «lingua / sberciata», nei graffiti da cui germogliano luce e «soffio, respiro vivo». Dai tagli della tela la luce va oltre. Dai graffi della materia trapela il nascosto. Attraverso quelli del dire, scrostato dal «babelico quotidiano», si affaccia «L’oltreterra». E il soffio, che riesce ad emergere, abbraccia la totalità, «nel corpo / che respira audace», come nei movimenti del cosmo. Così è la voce, quando sboccia dal corpo e dal caos «fino al frutto, all’urlo dall’ugola». Così la poesia, quando riesce ad oltrepassare il visibile, a partire da minuscoli sfregi per «infrangere l’infinita trama / a graffi crepe tracce», fino a musicarne il respiro lungo gli «spazi siderali / in battere/ pausa/ e levare».
Tra i graffiti della lingua
sberciata cerco la parola
scampata all’artiglio
delle conseguenze
e delle cause naturali.
Nella fascinazione del caos
e dell’elencazione
inseguo la parola scabra
a nutritura e a calore
della mia forma contratta,
misura e arto del nome.
Sgraffio sfregio scrivo
– la glottide che si contrae –
per un soffio, respiro vivo.
***
Dai corpi primi, quando per vento
tratti e da oscuri dèi congiunti,
dall’oscillante canto degli amanti
fuori del tempo, in spazi siderali
in battere/ pausa/ e levare,
in battere/ pausa/ e levare
nella tensione estrema –
nell’ampiezza prodiga del respiro
vive la sequenza elicoidale:
orme di corpi nella fanghiglia,
bava di parole e di baci,
materia della vita sulla selce –
in battere/ pausa/e levare,
in battere/ pausa/ e levare
nello slancio all’immenso moto.
***
Nottetempo caddero
dall’equamente nero
gocce
tratte da vortice d’omphalos,
da vento di smistamento:
imperdùte e attese
schegge di fuoco e semi,
erronee, scarti
per terra, e cieli.
***
Nell’equilibrio dello zero,
nella casualità del moto
– infrangere l’infinita trama
a graffi crepe tracce:
vacuo per pieno – vana
l’infinitesimale essenza:
la goccia di sangue sul lenzuolo,
la macchia della vita sui lini.
***
Riposano gli occhi
nelle cavità oculari,
s’addensa e si disperde
il mondo –
luce senza segni.
L’oltreterra
è nel corpo
che respira audace:
raccolto nell’alveo quieto
di un momento.
***
Le forme semplici, le spirali
elicoidali della vita, –
radure immense del mio verso
tratto dalla sintassi puntuale
del corpo e del caos –
con la morte dentro
la vita che esplode nel ventre
a moltiplicare l’imperituro gesto
della semina, l’odore del grano.
Fluire, salire, a–cadere
senza dimora fino alle radici
tre le umide zolle
fino al frutto, all’urlo dall’ugola,
nel vortice del vomere
e degli abbracci – vuoto su vuoto
dove un seme è morto
***
Tra i graffi della lingua lacerata
da te-a-me – team – te amo
rimuovo – cado nel cancellare
sgrattare vuoti.
Incido infiniti segni nel tempo
saturo del babelico quotidiano.
da te-a-me – team – te amo
Rimuovo – cado scalfita,
sono muro carta parete pietra,
a sangue da lacerti primordiali
di oscure memorie
di alfabeti sgangherati,
a sparpagliati echi.
Rimuovo – cedo: incido
parola che innervi il gesto
da te-a-me – team – te amo
da te-a-me – team – te amo
Elena Corsino (1969) è traduttrice e insegnante. Ha tradotto opere di poeti e scrittori russi, tra cui M. Cvetaeva, I. Brodskij, F. Tjutčev, F. Dostoevskij. Dal 2017 conduce laboratori di lettura di poesie nelle scuole superiori.
Per la poesia ha pubblicato le raccolte Le pietre nude (Il Filo 2005) e Nature terrestri (puntoacapo 2013). L’opera presentata Graffiti è stata pubblicata nell’ottobre del 2018 da puntoacapo.
Bruno Di Pietro, da “Colpa del mare e altri poemetti”, Oèdipus 2018, nota di Laura Caccia - Sulla riva del dire
Sulla riva del dire
Sulla riva: dove la marea porta il respiro dell’origine e insieme la corrente del divenire. In particolare sulla riva eleatica dell’essere parmenideo. E, in generale, nelle acque in cui confluiscono sia il principio unitario sia lo scorrere del molteplice eracliteo. Nell’opera antologica di Bruno Di Pietro Colpa del mare e altri poemetti tutto questo resta sotteso, ma risonante nella figura archetipa del mare, «nei rumori dell’acqua sempre al ciglio / dell’essere del dire del non dire». In una poetica che trattiene il respiro ontologico nella sensuale e sensoriale adesione alla bellezza luminosa della realtà come nei suoi aspetti più intimi e nascosti, tanto che, rimarcato dalle parentesi, «(il reale si ama se è segreto)». Dove la riva accoglie i richiami oscuri del principio e la marea vi deposita, insieme all’incanto, elementi di dubbio sulla possibilità del pensiero e della parola, quasi ‘Velieri in bottiglia’, di poter davvero dire, se non la precarietà e l’inesorabilità del divenire.
Colpa del mare? La dialettica tra essere e divenire fa da sfondo, insieme alle contraddizioni dell’esistere, a quella che emerge in modo conflittuale e dichiarato tra un reale aperto alle sue antinomie e un sapere, al contrario, problematico. Dove il mare, da archetipo, si fa metafora: «Colpa del mare / del pendolare dubbioso / tra il frutteto in rigoglio / e l‘orgoglio della scienza». E dove il rapporto con la realtà passa dalla sensualità e dall’adesione alla meraviglia e alla dolcezza della natura mediterranea all’esigenza di utilizzare alter-ego e travestimenti per affrontare gli aspetti biografici e storici in opposizione agli abusi del sapere. Ecco allora le figure dell’eresia in campo matematico, quali Ippaso e Liside, e in quello teologico, quale Francesco Pucci. E le figure della transizione e dell’antipotere, incarnate dai poeti Massimiano Etrusco e Ovidio. Figure di confine. Sul ciglio. Sulla riva.
Questa poetica, insieme lirica e speculativa, musica di continuo lo stare sul bordo. Sull’orlo del principio e del confine. E se, a livello ontologico, anche qui tra parentesi, «(le parole confessano indigenti / la poca confidenza con il vero)» e, a livello esistenziale, «non trovano la strada / per dire quest’esilio», è alla parola che Bruno Di Pietro affida comunque il suo sentire. Una parola immersa nel respiro del mare, nel battito dei versi brevi, nel ritmo degli endecasillabi. Dove ragione e immaginazione, metafisica e metapoetica, etica ed estetica, al loro interno e nel rapporto reciproco, muovono i versi con lo stesso movimento, altalenante tra abbandono e ritorno, della marea.
Da: ELEATICHE
I
forse l’indisciplina degli eventi
forse l’incerto dire inesistenti
l’identico la trama la ragione
concedono alle volte un’occasione
ma com’è disadorno il divenire:
gettati alle correnti senz’appiglio
nei rumori dell’acqua sempre al ciglio
dell’essere del dire del non dire
cosa accadrebbe poi se il maestrale
venisse a dirti al termine del giorno
che il sentiero in fondo è sempre uguale
e non c’è altra via che del ritorno
VIII
la semplice struttura del reale
batte ogni giorno puntuale un chiodo
come a dire che il modo del male
è vicino allo sciogliersi del nodo
nella prossimità discreta della scelta
più dell’attesa di un fato onnipotente
per dirti quanto sia inadempiente
non superare la soglia divelta
così incolpa ogni tuo tergiversare
fra il battere dell’ora e il suo passare
ma non ti dice nulla di concreto
(il reale si ama se è segreto)
Da: COLPA DEL MARE
I
Mi dicevo
gli Dei possono niente.
Edificio colonne palatine
catturo il fuoco con le lenti.
Non mi accechino i tuoi occhi
Lampi irridenti
sulle opere
dei giorni.
VIII
Colpa del mare
del pendolare dubbioso
tra il frutteto in rigoglio
e l‘orgoglio della scienza.
Colpa della tua assenza
se il barlume di aprile
non lucida i capelli
di giallo di arancio
e costringe al bilancio
al conto del fare
e disfare il disegno.
Colpa dell’ingegno
che chiude le sere
fra poca luce
e un pugno di olive nere.
Da: CANTO DI LISIDE
IV
Amici morti per il fuoco
se l’acqua è inizio
ora interrogate il dopo
conoscete lo scopo
del pensare.
La cenere ha confuso il mare
deluso il cielo.
Il nostro era un viaggio terreno
e questa è terra di ulivi
di tramonto
terra di sale
da Elea a Metaponto.
Da: VELIERI IN BOTTIGLIA
(I)
i
di certo non mancavano i dettagli
costruito come eri nel pensiero:
amore senza pianti senza sbagli
chiuso in bottiglia inutile veliero
Da: AVARI FIORI
ii.
ma te li immagini i sofisti antichi
gravi pensosi sgranocchiare chele
senza quest’uva dolce questi fichi
traboccanti di resina, di miele
Da: PICCOLA SUITE
(Andante)
le parole non trovano la strada
per dire quest’esilio, lontananza
dalla luce che subito digrada
come evolve il suono in dissonanza
Bruno Di Pietro(1954) vive e lavora a Napoli esercitando la professione forense.
Ha pubblicato le raccolte poetiche: “Colpa del mare” (Oédipus, Salerno-Milano 2002)“[SMS] e una quartina scostumata” (d’If,Napoli 2002) “Futuri lillà”( d’If, Napoli 2003) “Acque/dotti. Frammenti di Massimiano” (Bibliopolis, Napoli 2007) “Della stessa sostanza del figlio” (Evaluna, Napoli 2008) “Il fiore del Danubio” (Evaluna, Napoli 2010) “Il merlo maschio” (I libri del merlo, Saviano 2011) “minuscole” (Il laboratorio/Le edizioni, Nola 2016) “Impero” (Oèdipus, Salerno-Milano 2017) “Undici distici per undici ritratti” (Levania Rivista di Poesia n° 6/2017) “Colpa del mare e altri poemetti” (Oèdipus ,Salerno Milano 2018) “Baie” (Oèdipus ,Salerno-Milano 2019).
È presente in diverse antologie fra cui: Mundus. Poesia per un’etica del rifiuto (Valtrend, Napoli 2008) Accenti (Soc. Dante Alighieri, Napoli 2010) Alter ego. Poeti al MANN (Arte’m, Napoli 2012) Errico Ruotolo, Opere (1961-2007) (Fondazione Morra,Napoli,2012) Polesìa (Trivio 2018, Oèdipus Edizioni).
Articoli e interventi sulle sue opere sono presenti in riviste e blog (Nazione Indiana, Infiniti Mondi, ClanDestino, Trasversale, Versante Ripido, Frequenze Poetiche, Atelier, Levania , Trivio , InVerso, Menabò, Poetarum Silva). E’ stato cofondatore con Gabriele Frasca e Mariano Baino della Casa Editrice “d’If” e socio della Casa Editrice “Cronopio”.
Rita R. Florit, da “Cardini”, La Camera verde 2018, nota di Laura Caccia - La rosa dei versi
La rosa dei versi
Si muove lungo le coordinate spazio-temporali che delimitano l’orientamento nel mondo Cardini di Rita R. Florit. Nel microcosmo, come nel macrocosmo. Nella realtà visibile, come in quella mitico-sacrale. Delineandone i riferimenti, sia fisici che meta-fisici, nelle due parti della raccolta, rispettivamente i punti cardinali nello spazio e le fasi stagionali nel tempo. Un ordine che cerca di dare voce alla complessità dell’universo e che viene declinato nei testi attraverso l’impasto di una materia, insieme, terrena e celeste, mitologica e divina. Tra le polarità opposte che coesistono nell’intero. Un intero non più indistinto, come l’essere primigenio, ma già condotto ad una visione umana e poetica che circoscrive il proprio mondo. Dove la ciclicità della rotazione cardinale e della successione stagionale evidenzia un continuo ritorno, poiché «dimorare è tornare».
Nella prima parte la parola plasma i cardini geospaziali, nel loro incessante creare e ricreare. Dalla luce aurorale di Oriente e del suo «oro nascente» all’ombrosità di Occidente e della sua «rosa occidua». Dal sole di Mezzogiorno e del suo «cromo-inferno» all’oscurità di Mezzanotte e della sua «notte cava». Colmando i versi di richiami alla grecità, all’induismo, alla mitologia norrena. E di camei di poeti, da Lucrezio a S. Beckett, da E. Dickinson a M. Zambrano, da S. Plath a E. Villa. Nella seconda parte la parola fa danzare le stagioni, in una complessa mobilità concettuale e linguistica, tra le parti in lingua occitana, i riferimenti a detti e leggende che riguardano la natura e ancora i camei di poeti, da Y. Bonnefoy a S. Heaney.
Le parole orientano? E la poesia, nel suo farsi stella polare? E i versi dei poeti, chiamati a divenire cardini essi stessi? Il linguaggio di Rita R. Florit, denso di rimandi e teso di continuo oltre quanto mostra, plurisemantico e multilingue, pare orientare in direzioni molteplici. Nella rosa dei versi dell’autrice e dei poeti convocati è come se il polo magnetico si spostasse di continuo. A costituire di volta in volta un perno di attrazione per terra e cielo, umano e divino, nel calamitare, da angoli prospettici diversi, l’origine e la fine, l’ignoto e il visibile, l’oscurità e lo splendore del mondo.
Da: CARDINI
Nel mezzo d’un universo che promana propaga e
prolassa centrifugo distopico disforico crudo anelito al che?
si dimena diradandosi dilatandosi ...
toh! sarà l’antaura che dilania, l’accetta nella testa;
l’occhio stroboscopico, bianca polpa del nulla; sarà l’insulso
schermo protervo stante il fibrodelirio,abbattuta volgendo al fuori
dall’ego-centro al quadrivio vede-va
(a) Oriente oro nascente perla perfetta soavità del(la)rosa
Aura Au-r-ora fionda sferza il neogiorno appena nato già
muore (1)
gravide grida nel chiaro
il coro greco sullo
sfondo sbiadisce l’arcana nyctadea amata dalla cicuta lei la sola
la perduta fuggita dalla casa del padre (2)
mattino cupola d’oro e lapislazzuli quando vaticinava a Delfi quae
tripode ex Phoebi, lauroque profatur (3) la ressa il soffoco
l’inascoltata voce
desolata cassandra
più a Est l’animale sacrale rumina micro-giungle
domestiche; Ganesh alla catena da secoli; Vembanad
stende il suo tanfo viola inedia invasiva liquefa scivola
nelle retro acque piatte, squarci di spazio tempo sulle
strade di polvere, scotomi.
Orienti dominatori sventrarono città fasciate;
onde prue protese polene; i lenti accecamenti
Mater-puella nell’abbaglio argento petraie, orde
scagliate nelle gole degli dei divoratori di luce
l’Athanatos dannato nei tuoi forzieri aperti.
[…]
Da: CES SONS SESONS
Vēr
Vēr primo vere invera
veritas, in vino no! in campo
in bosco in prato ego virido
mi irido rido
genera la terra i fiori
pori tutti fuori di sé
dal seno aperto sciamano
abhelas, reptilia, nòus anima-lia
en saut (1) in balzi in neve
di lanugine ver-tigine
tiepidi serici nidi
gemmano cori e mugolii
nugoli et nugae
arbor arbita arbitra Carnea
viridat e reti and thirsts
my nightly shadow feasts (2)
blu crudo incombe
arioso maggio d’erba voglio loglio
manger son blé en herbe (3)
Verno
Verno perno firmamentum
oldest seasonson endurci
gris in-tingo rame lingue ignee
camini pini querce noci
rovi torvi corvi neri eri
invasione di tronchi
mantelli folti di volpi latte
di lupe perdute galaverne
nevi solenni evi fondi fate
H’eman Kalash (1)
aquila chiôm-ata (2) coltre alata
vernis d’iverns (3) glace-soupir
te soit la grand neige (4)
Iarnă (5) - arnia del nero
in-chiostro signo in hoc
locus iste scoscesa
tana lana bianca vitalbe
ringhia scarno giaciglio falco
calco interno Verno.
Note
Cardini
(1) S. Beckett, Mal visto mal detto, Einaudi, 1986
(2) M. Zambrano, Chiari del bosco, B. Mondadori, 2004
(3) M. Zambrano, I Beati, Se, 2010
Ces sons seson
letteralmente ces sons dal francese questi suoni e sesons dal dial.
friulano stagioni, hanno simile pronuncia
Ver
(1) in occitano: api serpi nuovi anima-li in salto
(2)“e seti le mie notturne feste d’ombre” S. Heaney, Station Island,
Mondadori, 1996
(3) manger son blé en herbe, detto risalente al XVI° secolo: poiché il
grano acquisisce valore quando arriva a maturazione, chi mangia il
grano in erba dilapida il suo denaro
Verno
(1) Kalasha popolo di uomini liberi come si autodefinicono i Kefiri
dell’Hindu Kush, mai islamizzati, h’eman è l’inverno nella loro
lingua come hêman lo è in sanscrito
(2) Chiôm neve in greco
(3) Vernis è anagramma di Iverns che è inverno in occitano
(4) “te soit la grand neige le tout le rien” Y. Bonnefoy «La grande
neige», in Début et fin de la neige, ripreso in Ce qui fut sans
lumière, Gallimard, 1995
(5) Iarnă inverno in romeno
Rita R. Florit ha pubblicato "Cardini" (2018), “Nyctalopia" (2018), "Passo nel fuoco" (Premio Mazzacurati-Russo 2010), "Lezioni inevitabili" (2005). Più volte finalista al Premio Montano. Ha tradotto Louis Zukofsky, Ghérasim Luca, Joyce Mansour e autori contemporanei. Ha ideato e realizzato vari videopoemi tra cui: Inside me-mories (2018), Aestas (2016), Passionement (2015)
Daria Gigli, da “Una visita a Hölderlin”, Moretti & Vitali 2019, nota di Laura Caccia - L’epifania poetica
L’epifania poetica
Non si tratta propriamente di una visita, se pur letteraria, come precisa Daria Gigli in premessa a Una visita a Hölderlin. Appare piuttosto la scelta di assumere un punto di vista, tenere aperta una finestra, nel modo desiderativo del vedere, come specifico dell’etimo di visita. Così visitare è vedere: spalancare la visione su un mondo, attraverso lo sguardo del poeta tedesco. Un mondo sotteso all’apparenza. Dove il senso del divino, anche se smarrito, anche se difficile da afferrare, continua a permanere. Ad abitare le cose, pur essendone stato allontanato. Ed è uno sguardo insieme colmo di straniamento e di prossimità quello che muove le teofanie della raccolta, dove le varie manifestazioni del divino si fanno vicinissime, dalla complicità mitica degli dei greci fino all’epifania de ‘Il dio dentro’.
L’epifania di un dio che è vento, soffio, suono. Un’apparizione che trascina i nomi «a sorsi infocati» e insieme sussurra. E che, nel passaggio dalle teofanie mitologiche alle poesie sulla realtà, trasforma anche le cose in divinità. Così l’autrice ci mostra «l’occhio di neve come un dio», l’innaffiatoio verde che dorme nella nebbia, la pioggia che «ha incantato le persiane». Anche i luoghi fisici e antropici, dalla natura al museo, dalla biblioteca alla sala da concerto, appaiono risuonare di visioni d’altrove. Come quelli interiori, dove «Manca sempre qualcosa», «dove non sai chi sei», a indicare il bisogno di una presenza altra. E, ancora, come quelli letterari, dove scrittori e musicisti irrompono nel testo, lungo «le stanze come un sogno di Baudelaire», «in mezzo alla Tempesta di Beethoven» o nell’orchestra di un «Mahler metropolitano».
Nella sua epifania poetica, la parola di Daria Gigli porta in visita, e a vista, sia il divino che il sentire intimo, umano e personale. Dal riecheggiare delle figure archetipe e delle divinità mitologiche fino al vibrare dei temi esistenziali e letterari, riuscendo a condurre a manifestazione, secondo il concetto di alétheia rivisitato da Heidegger, le cose come entità del reale. Portando a presenza l’occulto, il mistero. Un disvelamento che la parola poetica può rendere possibile. In un percorso anche personale dell’autrice verso sé stessa. Muovendo dalla visione del mondo esterno a quello interiore. Dalle rivelazioni del sacro alle manifestazioni dell’inconscio e dell’onirico. Fino al volteggiare nel sogno del ‘Decalogo’ finale. In fondo ancora un’epifania. Ancora ‘Il dio dentro’. Poiché, ed è sempre Hölderlin a ricordarcelo, l’uomo è un dio quando sogna.
Da: UNA VISITA A HÖLDERLIN
Musa
Musa,
stanotte ti piace giocare con me
e ti diverte – ne sono certa –
la mia incapacità di leggerezza.
Tu sai le vicende della terra e del cielo stellato
e passi lieve:
puoi dirmi perché altro non so fare
che coniugarmi su confuse ossessioni,
siano anche – ora – gli occhi chiari
e visionari
di Wilhelm Kempff
in mezzo alla Tempesta di Beethoven?
Il dio dentro
Un dio a volte di notte
mi tiene compagnia,
mi sussurra all’orecchio tutti i tuoi nomi
e poi – un prestigiatore non potrebbe di più –
li trascina giù dentro
a sorsi infocati.
Sottovoce sibila una litania
e pasticcia malinconia in mania,
ossessione in beata visione.
Il teologo, turbato,
ha già pronta una definizione
che pare una diagnosi letale:
trasfigurazione consustanziale!
Ma lui, divelto il chiavistello della notte,
guizza via flessuoso in una maschera di luce.
Solo in certe mattine zitte zitte d’estate
siede su una panca di Borgogna
a masticar litanie,
le mani compunte in grembo
per un dolce scempio
e una cocolla pietrosa
calata fino in fondo
su un volto senza volto.
Da: UNA LEZIONE D’ORCHESTRA
Mahler metropolitano
Fagotto scordato di un fusto nano,
Mahler metropolitano
in un tristeroico azzurro di castello!
Porge l’oboe il la e verrà
verrà un accordatore
a intonare svariare emendare.
Non senti come scuote l’asfalto il corista?
Pare un rabdomante
in cerca di una vena profonda
che trovi infine nel baccano
l’armonia delle acque d’Oceano!
Da: IMPROVVISI
***
“l’allegoria del mito” recita il testo
e gelido rimane e impassibile
l’occhio di neve come un dio
***
guardami con occhi visionari,
fa’ che sia in questa mezza luce,
ti prego, chi non sono
***
minaccia giorno,
in un rapido gorgheggio tutto il buio d’inverno,
le stanze come un sogno di Baudelaire
Da: FUNAMBOLESCO MUSICALE
***
Manca sempre qualcosa
perché qualcosa sia,
nulla è mai
che niente importi,
le notti intere
e un giorno pieno mai.
Scivola di mano
la fiaccola alla sera
e cade
dove tu non vai.
Decalogo
Scrivi un rondò per Praga
o se vuoi, una ballata;
prendi il bastone e va dentro alla giuncaia
dove lirica fa rima con sterpaglia,
e tu buttala sulla brace universale
finché non fa più male.
Impara a vagare
dove non sai chi sei,
suona la glassarmonica
e coppa dopo coppa scoppiala:
bello è lo scoppio e il non restare,
come in sogno caracollare.
Daria Gigli, nata a Firenze nel 1949, ha insegnato Letteratura greca presso l’Università di Firenze. Si è occupata di onirocritica greca anche con un approccio psicanalitico, di retorica di età imperiale, ma soprattutto di poesia epica tardoantica nei suoi vari sottogeneri di poesia mitologica, cosmogonica, oracolare-teologica, innodica ed ecfrastica. Predilige lo studio della poesia a carattere filosofico e in particolare di tradizione platonica e neoplatonica. Oltre a numerosi contributi su riviste scientifiche nazionali e internazionali, miscellanee e Atti di convegno ha pubblicato i seguenti saggi:
Metafora e poetica in Nonno di Panopoli, Firenze 1985
La ‘Cosmogonia di Strasburgo’, Firenze 1990
Nonno di Panopoli, Le Dionisiache (Canti I-XII) Volume primo. Introduzione, traduzione e commento di D. Gigli Piccardi, Milano BUR 2003 (che ha avuto varie ristampe. Sua la direzione scientifica degli altri tre volumi che completano l’opera)
Giovanni di Gaza, Tabula mundi. Introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di D. Gigli, Alessandria. Edizioni dell’Orso (in corso di stampa).
Per quanto riguarda la poesia ha pubblicato la raccolta “Una visita a Hölderlin”, Moretti&Vitali, 2019.
Alessandra Greco, da “NT (nessun tempo)”, Arcipelagoitaca Edizioni 2020, nota di Laura Caccia - Per nodi e passaggi
Per nodi e passaggi
Le pagine di NT (nessun tempo) di Alessandra Greco si mostrano come luogo connesso e continuo di una ricerca linguistica articolata secondo i principi topologici e, insieme, di una scrittura desiderante in tensione verso la totalità. Una scrittura labirintica e rizomatica che non avviene su uno spazio piano, bensì su una superficie non orientabile, ottenuta modificando la pagina, e sé stessa, senza strappi né lacerazioni. Senza prima né dopo. Dove il movimento continuo non ha successione temporale. Senza sotto né sopra. Dove, per penetrare nel profondo, non si può agire rovesciando il visibile. Occorrono invece varchi. Passaggi psichici, esistenziali. Porte. Una ‘porta del passaggio’ che si declina, tra le altre, nella ‘porta profonda’ come in quella ‘del rifugio’, nella ‘porta della fenditura’ come in quella ‘del mutismo’.
Una scrittura che si prende perciò cura dei nodi critici e delle connessioni. Con un bisogno di sovrapporre sopra stati liquidi o indistinti, quali acqua, sogno o suono, precise reti di relazioni con grafi e nodi, ‘rami e archi’. Reti e nodi insieme topologici e quantici. A deformare la realtà, a cercarvi il reale nascosto. Un’esigenza che appare evidente nelle immagini prodotte dall’autrice, in apertura agli otto ‘settori-nodi’ in cui è articolata la raccolta. A mappare l’insieme così come ad affrontarne le zone ignote, non mappate. In modo che possa emergere una visione altra del visibile e dell’invisibile, dell’onirico e dello psichico, del desiderio e del mistero. Senza le prospettive separate del soggetto e dell’oggetto. Come fossero, questi, figure topologiche dove l’uno si deforma nell’altro. Così come si modificano e trasformano reciprocamente la corporeità e la coscienza, la vita e la morte, il compreso e l’inconosciuto, nei loro passaggi e nelle loro reciprocità e connessioni.
E la sfida, che ne consegue, appare il tentativo di portare anche il linguaggio a figura topologica, facendone deformazione continua, non solo strumento conoscitivo o poetico, ma esso stesso modificato e modificante l’apparire. Tra fluidità e nodi, la scrittura di Alessandra Greco introduce varchi e passaggi, consente transiti. Creando ponti e relazioni. Schiudendo porte di accesso. Aprendosi soprattutto all’inconosciuto e all’imprevedibile, in ogni tentativo di riconfigurazione o interpretazione che comporti «una rinuncia al ‘rifugio’ trovandosi sul limite di ciò che può venir compreso».
Da: porta del passaggio
(nessun tempo)
il corridoio limbico ha numerose porte che corrispondono ad altrettante possibilità
le porte sono chiuse
si osserva aprirle in successione e richiuderle senza varcarle
l‘osservazione di quello che c‘è oltre le porte non è pervenuta
apparentemente osservatore e osservato non hanno una reale possibilità di incontrarsi
altrimenti si produrrebbe l‘immagine
forse si incontrano e si dimenticano subito dopo forse si produce un‘immagine che
tuttavia non ricordano
non hanno immediata coscienza l‘uno dell‘altro perché la scelta viene sempre rinviata
ciascuna porta è bianca da un estremo all‘altro non si vuole essere simili
l‘esperienza insegna che per differenziarsi da qualcosa bisogna averne percezione
oltre le porte vi sono possibilità che l‘osservato si produca se l‘osservatore lo compone
deve poter mettere un riferimento lasciare una giacca un odore una storia
allora potrebbe svegliarsi e sapere di aver fatto un sogno che lo riguarda molto da vicino
--- -- - potrebbe parlarne - -- --- -- - --
Da: (SETTORE-NODO I) porta profonda
(BALEEN) lupo_struttura dell’abitare in superficie
• PARTE CHE DESCRIVE LA STRUTTURA ANIMALE
spazio parola forma accesso a
profondo baleen lupo Nūn et Mīm et
et lungo facciate forma enti evocate
fulgore igneo vampa fluente corpo forma parola
ombre passanti nel ritaglio di tutte le figure
dentro del bianco del giorno del nero della notte
tracciare. 3 evoluzioni off & vedere accesso a senza istruzioni per mostrare il rientro dentro corpo a incasso corpo entrata a natura tendineo connettiva erba e olfatto liquida messa se stessa in un frame quasi trema
nienet. varco in metropolitana sul circuito aperto dal corpo vedente al corpo visibile che ha fatto della voce risonanza in forma di profondo e altezza macchine dorso treni convessi all‘orecchio in rilievo di ossa e sinovie del corpo grande capacità di sistema filtro forma trachea e apparati tempie goût a goût pelle sistema dorsale e udito sequenza di tutte le figure di volo e caduta verso l‘immane fondazione de eredità et iter sagoma – vela di quello che resta
[…]
Da: (SETTORE-NODO II) porta communicans
Nodi
Contrario alla folgore che riceve l'istante, il silenzio sottomette il tempo.
Un nodo, in generale, deve avere tre caratteristiche:
la semplicità di esecuzione,
una buona tenuta,
la possibilità di essere sciolto agevolmente.
• NODO SENNEH
dicono che nel silenzio si nasconda sommessamente tutto ciò che è passato
teleidoscopio minuscola piccola ballata un piccolo giro nel bosco attraverso
praterie e ripidi sentieri miniatura fortificata nel cuore risolto quando ha lasciato
allora il distacco sul colore
l‘image – di quello che era prima – non corrisponde più alla sua descrizione
è un déjà vu
con moltiplicati rami e campi gruppo doppi
simula inquadrature di situazioni familiari nodature
(contigue al corpo in modo da
formare angoli
di spola sul retro verso della pelle) – l‘apertura si cangia e si assorbe
[…]
Da: (SETTORE-NODO VIII)al lato della carne_ramo aggiunto (pars addita)
nessun tratto di penna può percorrere senza salti una e una sola volta il percorso dei
sette ponti di Königsberg
la soluzione a questo primo problema di topologia fu data dal matematico Leonard Euler nel 1608
sarebbe stato necessario costruire un ottavo ponte una riconfigurazione
le riconfigurazioni non hanno sempre conseguenze prevedibili comportano una
rinuncia al 'rifugio' trovandosi sul limite di ciò che può venir compreso
--- questo approssimarsi – disnodarsi – frantumarsi ---- teorie delle frontiere e incidenti di frontiera ---- includendo in habitat ---- anche strettoie in cui non vi sia autonomia ---- mutando forma -- in ogni caso autoregolandosi con la rapidità del proprio tempo di pensarsi ---- ridisponendo ---- porosità ---- ché le diverse interpretazioni – a volte non si intendono – ---- – se si insiste eccessivamente si soffre
la colorazione indica di solito l’origine di una disarmonia
ci sono aperture immediate che lasciano passare con facilità altre porte vagliano nient‘altro che fili sottili come la seta i più piccoli cambiamenti
e questa continuazione
Alessandra Greco, Roma, 1969. Vive e lavora a Firenze.
Ha scritto Del venire avanti nel giorno, Libro Azzurro (Lamantica Edizioni 2019). La memoria dell'acqua_Grésil sur l'eau pour faire des ronds, silloge finalista al Premio Lorenzo Montano XXVII Edizione (2013), Opera Prima Poesia 2.0 (2014). Press Soundtrack_Colonne sonore dalla cronaca, racconti brevi, per i Quaderni di Cantarena (2012), ai quali l‘emittente Ryar Web Radio ha dedicato la puntata n° 26 della trasmissione Scritti Parlanti condotta da Stefano Ferrara (2013). Rabdomanti (2016), a contributo per il sito Descrizione del Mondo, Installazione collettiva d'immagini, suoni, scritture, a cura di Andrea Inglese. Couplets, Relazioni tra i recinti e l'ebollizione (2016) con le sonorizzazioni di Luca Rizzatello (soundcloud. com/couplets). La OT Gallery, spazio installativo virtuale, a cura di Giulio Marzaioli, ospita un suo contributo, International Date Line_Meridiano 180° (2014), sulla linea del 180° meridianoterrestre. Ha realizzato performance e letture con attenzione al suono e la sua ricerca si è estesa alla fotografia.
Ha ideato ed è tra i curatori del festival PartesExtraPartes, micro-rassegna di musica sperimentale, scritture e arti visive (Firenze, 2018-2019).
Suoi testi sono antologizzati in oomph! – contemporary works in translation / a multilingual anthology, vol. 2 (2018), nella traduzione di Marcella Greco, e in Poesia di Strada 1998/2017 (Seri Editore 2018). Sue scritture sono apparse in riviste e lit-blog tra cui “Carteggi Letterari”, “eexxiitt.blogspot.com”, “Nazione Indiana”, “Niederngasse”, “L‘Ulisse”, “Versodove”.
Marica Larocchi, da “Polveri Squame Piume”, puntoacapo 2020, nota di Laura Caccia - Nel vibrare della lingua
Nel vibrare della lingua
Una parola oscura e illuminata, profonda ed eterea, cosmica e prossimale, colma di sonorità e di visioni, quella di Marica Larocchi che, in Polveri Squame Piume, conferma il suo percorso poetico, introducendovi nuove immersioni nelle risonanze e nelle vibrazioni originarie del cosmo e del dire. Le dualità che, insieme ad elementi di fulgore, avevano caratterizzato, a partire dal titolo, le precedenti raccolte, tra le tonalità della parola e del mondo, gli elementi del macro e del microcosmo, lo splendore e l’impervio della materia reale ed esistenziale, qui si fanno tripartite e apparentemente più opache. In un’opera che mantiene lo stretto legame, intrecciato in precedenza, tra l’universale e il particolare, l’eco dell’enigma e la complessità del dire, ma che vi intensifica gli elementi di mutazione e di trasformazione.
Composta da quattro sezioni in scrittura poetica e una centrale in versi sull’arte di Mosè Bianchi al lavoro nel duomo di Monza, tutta la raccolta ruota sui processi compositivi - cosmici, artistici e poetici - e sulle loro disgregazioni. Tra Polveri, materie dell’origine e del dissolvimento, Squame, elementi di metamorfosi e di trasformazione, e Piume, palpiti dei nidi e dell’altrove. Nuclei del formarsi del mondo e residui della corrosione del vivere. Materiali dell’arte, anche. E della parola. Minimali, ma vividi e risonanti. Ad esprimere le vibranti mutazioni cosmiche e interiori. Gli strappi e i disordini. Le passioni e gli attriti. I vuoti e le rigenerazioni. Dopo «vacanze agli inferi o scorribande nell’orto». Ora tra «zoppia dei versi» o «sopra l’orizzonte del soffio più audace».
In una lingua fulgida e plurisemica. Concentrata e dislocante. Dall’affondo fermo e arrischiato e dal riverbero interminato e lieve. Una parola perturbata, quella di Marica Larocchi. E sempre illuminata, anche quando il materiale si fa più essenziale e dolente, meno sfolgorante. Quando prevalgono ‘polveri’ e ‘squame’ su ‘oro’ e ‘cobalto’, ‘rugiada’ e ‘cristalli’. Quando viene chiesto alla parola di spogliarsi di orpelli, di farsi cicatrice del lutto e di varcare «nell’ultima capriola lo spiraglio che s’apre vorace sul preludio dei fulgori. Là, ogni furore, ambascia e ustione potrebbe finalmente valicare la griglia dei segnali, mente e soggetto abrasi».
Da: L’ALTRA PLACENTA
1
Prima del senno mattutino promettiamo di triturare afflizioni e cilici, anche se qualcosa ci storna, ci transenna, quasi un divieto bleso o l’indice virtuale di chi ha gia centellinato la sua pozione di melassa e zolfo. Lei ci accoglie, ospitale come un prudente orzaiolo; c’invita a svuotare il sacco, a rimuginare il fato con sillabe disarcionate. Poi ci tranquillizza affinché ci prepariamo insieme a doppiare l’etimo più rischioso del passaggio in salotto. Allora: eccoci appesi al filo dei pronostici, imbozzolati dentro la gerla greve di sinapsi ancora in germe.
Ci avverte che non udremo né il bisbiglio dei bulbi sotto le membrane, né lo squittio stroboscopico di memorie contumaci: nemmeno un rantolo di foia che si squami dalle sue commessure sapienti. Sentiremo, piuttosto, uno strappo di cedole molli, di frazioni o di eclittiche in mezzo al disordine di antiche decalcomanie. Oppure sarà come se l’orma del suo dito ci rigeneri nel menù variabile dei cicli, degli zodiaci sempre impegnati nelle loro staffette… Nascite mercuriali, quindi, per sinossi fosforescenti e vaporose.
7
Il vaticinio, infine.
D’ora in poi: esentati dal soggiorno nel monolocale periferico con modanature di orazioni in rilievo tutt’intorno alla buia cavea del cuore. Altro che zaffiri e lapislazzuli! In realtà, lei l’aveva gia affittato senza scrupoli d’oblio a un giovane, inquilino insigne, ma per brevi scadenze... In effetti, se consenzienti, non fruiremo più di visioni avvampanti né di ricambi d’alfabeto. Niente più vacanze agli inferi o scorribande nell’orto. Invece fileremo, senza interruzioni di carattere, il nostro bozzolo di vocali asettiche, di dittonghi al minio, di ricicli e tremoli come dentro le minugia di una larva ad interim, per diatesi tronche tra crepe di acidi, capriole basiche e lampi corrucciati, immutabili. Da vera amica, ci assicura che ci sarà accanto per sempre, come rosa alla tempia per caso sfogliata senza antonomasie sul bordo di borragine smorta.
Da: NEL PAESE DEI TOTEM
5
Si. Li abbiamo visti slittare insieme sopra la cute metallica dei sogni dentro piroghe di corteccia e muschio; e nel berretto, penne d’aquila reale per incidere profili allucinati. Filavano via – ve l’assicuro – più impercettibili delle comete traverso l’arco di Ulisse all’orizzonte.
Notizie di qui? Avvistamenti a iosa di scafi e carcasse per la fame adunca di vampiri nababbi, quasi sul greto d’agonie in frantumi. In effetti, Caronte mai rinuncia al suo turno di guardia sulla battigia dove ragli e litanie fanno da contrappunto agli esiliati d’ebano a cui spuntano in premio cuori occhiuti.
Da: AUTOBIOGRAFIA
9
Del resto, dovete infine accasciarvi qui, sul foglio. Anche se vi esorto a disperdervi adagio come certi semi prillati fuori da capsule gremite di desideri in conflitto, di giubili dolenti e di appelli desueti. Ormai àptere, piumette o caruncole di misteriose transverberazioni, ora non siete che trottole minuscole al loro estremo volteggio prima dell’approdo - della caduta? - sopra questo silenzioso candore dove già s’intravedono tracce spettrali, prossime e remote.
Spogliatevi d’ogni orpello, imprimetevi, dunque, colate come bronzo fuso, minuzie mie! Fatevi cicatrice, solco e memoriale del vostro medesimo lutto; e, pari a effimere fiacche, varcate nell’ultima capriola lo spiraglio che s’apre vorace sul preludio dei fulgori. Là, ogni furore, ambascia e ustione potrebbe finalmente valicare la griglia dei segnali, mente e soggetto abrasi.
Da: SOPRALLUOGO
13
No, non è una resa. Vorremmo scalare ancora il dorso gibboso di certi suoni male pronunciati, quasi sfiato di mantice frusto; e infine issarci con agile piede sopra l’orizzonte del soffio più audace; ma i tracciati ormai sbordano sulle mappe di questa dizione, quasi per un colpo di frusta. E noi, svelti, c’immergiamo nello scafandro di penombre abilissime a compattarsi contro luci irrimediabilmente in fuga dalla reticella ormai fiacca del nostro appetito.
Viene da lontano; è qui, accanto all’avida fonte del nostro vuoto, e rintocca come voce piena.
Marica Larocchi, lombarda di madre slovena, vive e lavora a Monza.
Ha pubblicato diverse raccolte di poesia, fra le quali Lingua dolente (Milano 1980, Premio Cittadella 1981), Fato (Milano 1987), Solstizio in cortile (Novi Ligure, 2009), La cometa e l’ibisco (Varese, 2013), Di rugiada e cristalli (Ferrara, 2017); opere in prosa narrativa e saggistica, da Trieste (Verona, 1992) a Rimbaud, un racconto (Lecce, 2005), da Luogo e formula, per una lettura d’Illuminations (Lecce, 2009) a Fantasmi (Lecce, 2013).
Ha curato e tradotto Primi versi e Ultimi versi di Arthur Rimbaud, un’Antologia dei poeti parnassiani (Oscar Mondadori, Milano 1992-1996); opere di R. Radiguet, di P. J. Jouve, di Charles Baudelaire (Milano 2005-2012) e L’infinitude di Jean Flaminien (Ferrara, 2012, Premio per la traduzione, Universita di Bologna 2013).
Collabora a riviste letterarie italiane e straniere con testi in poesia, in prosa e traduzioni
Vincenzo Lauria, da “Teatr/azioni”, puntoacapo Editrice 2018, nota di Laura Caccia - Nel rovescio delle parti
Nel rovescio delle parti
Quale scenografia viene messa in opera da Vincenzo Lauria in Teatr/azioni per dare luogo ai gesti poetici che capovolgono cliché e stereotipi? Si tratta di metateatro? Oppure di un teatro nel teatro? Qui, in realtà, la parola non si fa riflessione sulla rappresentazione scenica, né messa in atto di un’animazione dell’assurdo con l’abbandono di trame e linguaggi consueti. Qui la parola si fa propriamente teatro: «luogo/non luogo» di pubblico spettacolo. E insieme azione-non azione. Un’azione che spalanca e rovescia sé stessa, riuscendo a mettere in luce non solo quanto si nasconde dietro le quinte, ma quello che, nel suo ribaltamento, ogni volta accade davanti ad esse. Invisibile però ad uno sguardo che colga solo l’apparire e non quanto, «per un andar del vero / in opposta direzione», si mostri al contrario «irrealisticamente verosimile».
Tutto, nel retroscena come «nell’al di qua / del vero», dalle scenografie alle luci, dal palco alla platea, dalle prove ai monologhi, dal plauso all’inchino, viene sottoposto, «di cliché in cliché», a continue mosse di capovolgimento. Così, sulla scena-non scena teatrale, viene eliminato il sipario, il palco diventa platea e viceversa, gli spettatori diventano attori e ad applaudire è un pubblico assente. E così la parola entra in azione: rovesciando cliché e luoghi comuni, con continui colpi di scena. In una finzione, implicita nel senso stesso del recitare, come del resto dello scrivere, che viene ribaltata da un’ulteriore finzione, da questa annullata e, nello smarrirsi del senso apparente, condotta ad un senso più veritiero.
Non solo la parola fa di sé teatro e, insieme, antiteatro. Il poeta fa di sé stesso teatro e antiteatro. Nel rovesciare le parti, si ritrova «Innanzi al palco / far la propria conoscenza» quando “fatale è lo svelamento / per l’inganno si dice il vero / e in suo onore / il saper stare al gioco / si fa baratro». Con una particolare modalità di scrittura, Vincenzo Lauria mette in scena veri e propri coup de théâtre nella realtà e nella propria interiorità: dallo svelare le finzioni del visibile al ricercare un senso oltre a quello apparente, fino alla discesa nel proprio abisso. E il tratto che ne caratterizza la scrittura, quello di separare con barre oblique le parole al loro interno ponendone in luce la pluralità semantica, evidente già nel titolo, trova in questi testi il suo significato scenico e insieme più autentico: spalancare ogni volta il sipario dell’apparenza che vela ogni parola, mostrando la scena nascosta dei suoi doppi, multipli sensi. La sua voragine. Il suo baratro.
TEATR/AZIONI
(Il teatro, luogo/non luogo, percorso, di cliché in cliché,
al buio di una maschera)
¶
L’inconsistenza
ci traccia nel non essere
in lunghi avvita/menti
è nel chiamarsi
un rinnegarsi per i conosciuti nomi
per apparire al solo desueto.
E in quel cappotto a quadri
scalderei nuda la mia ri/conoscenza
il sapersi per un verso bisbigliato
in bocca/scena.
Farò di me teatro
per un voler di sorte
senza un sol sipario,
fuliggine nell’aria
nel tutto retroscena.
Cliché II
La messa in scena
Pavide le menti
i para/venti
collimano con lo svelarsi
poco a poco
un négligé oblige
la noblesse d’âme à se détruire.
La mise en scène
au ralenti – dice un improbabile vero
mentre piove il virtuale.
S’intingono le pelli
di mutanti colorazioni
e nell’accingersi
segna la distanza il plauso mancato
per l’aprirsi al pubblico
di un boudoir privato.
Cliché IV
Il palco
Scale
dai gradini di neve
l’algido apparire
di me a somiglianza.
In recitar respiri e pause
solitudini escludi
e ammanti l’aria del circostante
di un’aura
nell’imminenza d’altra presenza.
Contar fra il pubblico
di un rapimento in maschera
e quel che è
non rassomiglia al nulla
al privato accaduto
al viso degli astanti sfigurato.
Innanzi al palco
far la propria conoscenza
salire
e scontar di verità la penitenza.
Cliché XIII
La scena
La ricostruzione della scena
sa di delitto annunciato
le maestranze si curano del luogo
per il replicarsi delle parti.
S’incendiano le luci
nel tratteggio delle sagome
e il sangue scorrendo ancor
si fa spettacolo.
Il movente oscuro
nell’infittirsi del mistero
accresce il campo del sospetto
l’indizio dice di un unico colpevole
tra il pubblico cadavere
Cliché XVII
Il plauso
Chiuse sale
in raccoglimenti
prima di un inizio.
La voragine ci sospende ai bordi
prima dell’attrazione,
fatale è lo svelamento
per l’inganno si dice il vero
e in suo onore
il saper stare al gioco
si fa baratro.
Confondersi al fondo
in uniforme annullamento
né luci violeranno i contorni
per la mimesi in corso.
La voce narrante rimase muta
per un sorprendersi sul palco
l’andar in scena di un pubblico scrosciante
nel colmare il vuoto dello spettacolo.
Vincenzo Lauria inizia nel 2001 la condivisione del suo percorso in Stanzevolute, gruppo di 11 poeti selezionati da Domenico De Martino. Dal 2010 collabora con Liliana Ugolini ai progetti multimediali “Oltre Infinito”. Ha collaborato dal 2012 al 2019 con l'associazione Multimedia91-Archivio Voci dei Poeti.
La sua prima raccolta edita "Teatr/azioni" (Puntoacapo Editrice) è stata finalista al Premio I Murazzi (8^ edizione) e al Premio Lorenzo Montano (34^ edizione).
Nel 2021 ha pubblicato con Liliana Ugolini la raccolta "Oltre Infinito" (La Vita Felice) che ha ricevuto la segnalazione speciale alla 35^ edizione del Premio Lorenzo Montano.
Suoi testi sono presenti nel periodico on-line "Carte nel Vento" e nel blog "Casamatta".
Fabrizio Lombardo, da “Coordinate per la crudeltà”, Edizioni Kurumuny 2018, nota di Laura Caccia - A crudo del resistere
A crudo del resistere
Non appare tanto la messa in luce di parametri per affrontare la ferocia del vivere, lungo le ascisse e le ordinate del vissuto e del sociale, come il titolo dell’opera di Fabrizio Lombardo, Coordinate per la crudeltà, indurrebbe a pensare. Quanto piuttosto, parrebbe, una messa a nudo, o meglio a crudo, seguendo l’etimo di crudeltà, dei nodi irrisolti del sentire dal punto di vista di chi tale brutalità, esplicita e implicita, subisce. Senza poter trovare criteri di riferimento per resistervi. In più, avendone perso o scordato le coordinate. Appare una precisa scelta. Non solo e non tanto un mettere l’accento sugli elementi di violenza del potere storico-sociale contemporaneo come delle avversità che sottraggono affetti e speranze. Quanto posizionarsi su un piano altro: quello del riconoscersi, operando un ribaltamento di prospettiva, nella percezione di tutto ciò che è falso, mancato, dimenticato.
Nell’oscillazione del senso, nei rovesciamenti dei punti di vista, nella sottrazione progressiva del dire. Rovesciamenti che appaiono visivamente nelle barre oblique interne ai versi ad evidenziare, nella separazione di dati ribaltati o contrari, il capovolgimento continuo, in «questo disfare/ e trattenere», della percezione e del sentire. Tutto mostra segnaletiche e confini e tutto sfugge, resta indecifrabile. Nel dolore personale, «lasciandosi dietro la vita intera». Nei percorsi esistenziali delle ‘false partenze’ e della mancanza di un «punto fermo / o coordinata da ricordare». Nel sociale degli spazi commerciali e del profitto dove con maggiore intensità si mostra la ferocia della «dittatura del contemporaneo». In una continua sottrazione, che è anche «sottrazione di sé».
La parola è crudele? Sicuramente nel dire del potere, nel «freddo tagliente delle frasi fatte», nel mescolare «vergogna e vita vera con la sintassi / della menzogna». Tanto che Fabrizio Lombardo, di questo svendere parole, non può che dichiarare: «Non chiamarlo progetto di poetica / geometria binaria, o gioco d’ombre». Non conosce invece crudeltà, se non il mettersi a crudo, quando la parola ammette la propria insufficienza, quando si mostra a nudo, quando riconosce che «solo la dissonanza ci descrive». Ed è proprio questa posizione, etica e poetica insieme, ad apparire in piena luce: un dire senza potere, senza ordine né geometrie. Poiché mettere ordine non è compito della poesia. La poesia non si muove per coordinate. Lascia libere le discordanze, la loro intensità, la loro resistenza, il loro dolore.
Da: FALSE PARTENZE
***
È molto più onesto ora farsi da parte, dirsi fuori quota
per gare come questa. Ammettere che non è il terreno
adatto. Che è stata solo una falsa partenza. Dire
che la pazienza è andata. O anche scrivere
delle solite cose, ripetere i fondamentali
e risparmiare fiato per i giorni che verranno
per l’ennesimo novembre di silenzio e allenamenti mancati.
***
Ora che la geometria dell’occhio mostra la città
tra le rette parallele dei binari cominceremo
a contare gli anni, le voci e i silenzi, gli addii
che lì si sommano. Grammatica del vuoto/ snodo del futuro.
D’estate, la sera, qualche volta si vedono le ombre
venire da lontano/ passarci il cuore da parte a parte.
***
Scrivo il falso – spesso – e svendo le parole
mischiando vergogna e vita vera con la sintassi
della menzogna. Non chiamarlo progetto di poetica
geometria binaria, o gioco d’ombre. Serve più coraggio
a vivere i pochi gesti possibili/ quelli rimasti.
Qualche respiro preso in prestito. La notte, nelle case.
***
solo la dissonanza ci descrive. un modo per dire
che tutto quello che è venuto a mancare – non l’amore
intendo (non qui), ma il rancore/ la gola che brucia,
la voce inceppata, raccolta dietro i vetri,
fra i libri, o fra le giunture delle mani – è un altro
silenzio ancora/ una memoria che dobbiamo – tu e io –
mescolare a questo rumore/ perché possa appartenerci ancora.
Da: COORDINATE PER LA CRUDELTÀ
***
Nella camera solo la resistenza dell’aria contro
le vetrate. Tu sai quello che mi consuma:
il vento freddissimo/ l’attesa. Inutile
spostare il cappio che indosso come un regalo
d’addio/ molto alla moda però. I nervi
ancora fuori posto. La traccia curva lasciata dalla luce
confonde/ cede a questo falso lirismo/ irrita anche le parole.
***
Ho dimenticato ancora una volta le coordinate per la crudeltà.
Riprovo con i vetri aguzzi, il ghiaccio tra i denti,
l’incertezza/ la resa. Abito vestiti soliti.
Con poche sfumature di grigio e di nero
per mimetizzarmi meglio con la ghiaia davanti a casa.
***
raccogli la mia morte senza nessuna parola
cercando di non concedere saldi all’esistenza ed evitare
sconti alla vita. almeno oggi, metti ordine alle cose
rimaste indietro, pulisci casa, indossa la mia ombra.
***
ora che anche il verde è venuto a mancare
rimane solo il muro, qui, appena fuori dalla porta.
ti ho cercato anche oggi, ma con pudore,
sperando che non ti accorgessi di nulla
nascosto tra le righe scritte storte a matita,
in apnea dentro ai giorni. storti anche loro.
***
Provo a spezzare questo dolore in due parti
come pane appena fatto. Lento, mastico la mia
e faccio briciole della tua sperando che i merli
ne mangino. Che non ritrovi la via di casa nostra.
Da: PER I GIORNI DI PIOGGIA
***
senza dare peso alle cose. a nient’altro. in questa
stanza chiusa come per un trasloco fatto in fretta.
contare i giorni/ la vita arrugginita alle pareti
e cancellare ogni traccia. dire di non esserci
stati. dentro alla storia. in questi anni. abitare
l’ombra/ e perdere. anche quel poco.
Da: RETAIL
***
Continua a chiedere se voglio un’altra birra il grassone
dietro al banco nella Zum Uerige a Düsseldorf. Tra facce
d’affari e ubriachi abituali ripenso
a come quello che abbiamo visto oggi sarà superato
e vecchio tra pochi anni. L’innovazione degli spazi
commerciali – siamo qui per questo – suonerà vuota
dentro al freddo riflesso dello smart shopping:
dittatura del contemporaneo/ monopolio di mercato.
***
Piove cenere. Con trent’anni di meno fotograferesti
questo sole mancato, questo cielo da Instagram
nel tentativo di una descrizione in atto. La questione non
è più privata. Ti è concesso solo di guardare la serratura
né buco né chiavi. Ricominciare da capo. L’ululato dei lupi
che non sono lupi, tutt’attorno.
Fabrizio Lombardo (Bologna, 1968), ha fondato nel 1994 “Versodove, rivista di letteratura”. È direttore operativo di una catena di librerie. Cura la rassegna di poesia Passaggi di versi all’interno del festival di saggistica Passaggi (Fano). Ha pubblicato Carte del cielo, (VersodoveTesti, 1999), di quello che resta (Fara,1998), Confini provvisori (Joker, 2008) e Coordinate per la crudeltà (Kurumuny 2018): finalista al premio Tirinnanzi, segnalato ai premi Pagliarani e Bologna in lettere.
È presente in: Il grande blu, il grande nero (Transeuropa), Sesto Quaderno di Poesia Italiana (Marcos Y Marcos), Ákusma (Metauro) Parole di passo (Aragno), Parola Plurale (Sossella). Suoi versi sono apparsi su Il Verri, Poesia, Tratti, Atelier, La clessidra, L’Ulisse, e su numerosi quotidiani.
Ha curato le note del volume Yellow, di Antonio Porta (Mondadori)
Alberto Mori, da “Levels”, Fara Editore 2020, nota di Laura Caccia - Passaggi a livelli
Passaggi a livelli
Quanti piani si intersecano in Levels, opera in cui Alberto Mori esplicita alcuni livelli e altri ne lascia intravedere? Appare un graduarsi dal basso verso l’alto, evidente nei titoli delle tre sezioni: ‘low’, ‘medium’, ‘high’. E, insieme, un convergere dei livelli, nel punto in cui si incontrano i desideri del cielo e della terra, come viene anticipato dalla poesia, posta in esergo, di Kikuo Takano, che nell’immagine dell’albero fa confluire, in una sola, le forze opposte di cima e radice, quale unità dei contrari nell’intero. E, ancora, un mantenere i piani in equilibrio, dall’etimo stesso di livello, come esemplificato in alcune poesie a due colonne separate e allineate, in contrappeso come una bilancia a due bracci oppure come una livella. E, nello stesso tempo, un posizionarsi ad un livello di soglia, che i passaggi testuali lasciano scorgere, per l’accesso, in sequenza e insieme in affinità, al principio, al corpo, all’oltre.
I livelli appaiono mobili, spesso invisibili, come viene dichiarato in premessa: «Livelli mobili scompaiono alterni». Scandendo i transiti, gli attraversamenti, le contaminazioni nei tre specifici stadi in progressione. «Verso radici senza immagini»: lungo le impronte e le tracce dei passaggi e della scrittura nell’estensione orizzontale delle acque, delle strade, dei fogli e dei loro sostrati oscuri, in ‘low’. «Fra gli sguardi del corpo»: attraverso gli affioramenti di natura e civiltà, da cui emergono le luci e «la voce sfarina», nella dimensione corporea, in ‘medium’. «Nel volo avveduto di sole arie»: tra orbite e «nubi oscure all’aria / Invisibili al segno terrestre», nella tensione verticale verso la sospensione e l’assenza di gravità, in‘high’.
Attraverso la compressione essenziale del senso e il distillato della parola, Alberto Mori prosegue la sua ricerca nel concentrare elementi concreti e rarefatti, quali stazioni e silenzi, vagoni container e balzi d’umore, creando microtesti densi e ariosi al tempo stesso: «Valichi bianchi sopra il foglio / La mano mancina scrive aria / Rarefa grafia esitata e ripresa». Dove i movimenti poetici coinvolgono la percezione della realtà esterna come della corporeità, della mente, dell’inconscio. E anche, nei suoi diversi livelli, della parola: scritta, a voce, pensata. Se l’oralità è il punto di forza dell’autore, gli altri livelli, di pensiero e scrittura, sono ugualmente e intensamente presenti. Quale in basso e quale in alto? Come per l’albero di Kikuo Takano, nella poesia si incontrano, fino a coincidere in un’unica forza, i desideri della terra e del cielo, delle profondità e dei voli, delle radici e delle cime della parola.
Da: Low
Prelude attesa per bikers
Immagine franta dai tempi espositivi
Struscia sfreccio curvo del passaggio
Crome sfocate nella pedalata sottile del ritmo
***
Le ruote ormai improntano il foglio
Fra le tracce sulla carta
scrive di non conoscere gelosia per lei
La ama da sempre
Lo scritto resta a perire sulla ciclabile
***
Le spalle delicate
Valichi bianchi sopra il foglio
La mano mancina scrive aria
Rarefa grafia esitata e ripresa
***
La stazione disgrega inagibile
Qui preme tempo naturale
Incrina strati
Accorda piccoli sterpi nei sassi
dove fra efflorescenze sparse
respirano silenzi d’aria e polvere
Da: Medium
Corpo seduto Capelli disciolti
Dalla nuca equilibrio in riannodo
***
Dove sticker non incolla & scrosta
il millimetro mancato sillaba
La voce sfarina sulla pellicola del muro
***
Qui puro balzo d’umore vitreo
materia traluce spaiata dai bagli
L’altro lato senza ottica rifrange
***
Nell’aria umida profondano margini bui
La piccola strada discende e risale
Le luci affiorano vicine e lontane
Da: High
Gravità dissolta
Tempo dismesso
Perdura vacante
***
Il buio dilegua alla prima luce
La terra allenta ombre
Depone arie accese
Concresce cielo
Millimetri di spazio
Corpi migrati dalle sillabe bianche
***
Tratto illetto
Nuvola illesa
Piogge papille
Lingua nasconde
Ripassa veglia
Neutro crea
Sapore del cielo
***
Ondulo diviene solco radiale
L’anello ruota ad accerchio
Orbita
Porta nubi oscure all’aria
Invisibili al segno terrestre
Alberto Mori, Crema 1962, poeta performer e artista, sperimenta una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando in interazione altre forme d’arte e di comunicazione.
Dal 1986 ha all’attivo numerose pubblicazioni. Nel 2001 Iperpoesie (Save AS Editorial) e nel 2006 Utópos (Peccata Minuta) sono stati tradotte in Spagna.
Per Fara Editore ha pubblicato: Raccolta(2008), Fashion(2009), Objects(2010), Financial (2011), Piano(2012), Esecuzioni(2013), Meteo Tempi (2014), Canti Digitali (2015), Quasi Partita (2016). Minimi Vitali (2018), Levels (2020). Nel 2017 Direzioni (edizioni del Verri). Dal 2003 partecipa a Festival di Poesia e Performing Arts fra i quali: V Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (Lisbona, 2005), Biennale di Verona (2005 e 2007), IX Art Action International Performance Art Festival (Monza, 2011), Bologna in Lettere (2014, 2015 e 2016 e 2018). La produzione video e performativa è consultabile nell’archivio multimediale dell’Associazione Careof / Organization For Contemporary Art di Milano.
Davide Nota, da “Lilith. Un mosaico”, Luca Sassella Editore 2019, nota di Laura Caccia - La lingua di un nuovo occhio
La lingua di un nuovo occhio
In un intarsio di prose poetiche, tra scrittura del quotidiano e tensione all’altrove, si compongono le tessere di LILITH. Un mosaico. Novantanove frammenti, raggruppati in tre parti di 33 tasselli ciascuna, in cui Davide Nota dispone un materiale smembrato e plurimo, denso e fluido insieme. Isolando, nei reperti di un montaggio che infrange il succedersi della narrazione, inquadrature sul visibile, vivide percezioni e stati di coscienza. A partire dalla messa in crisi della visione e della decifrazione della realtà, poiché «Difficile vedere. Ma descrivere è impossibile». Ed evidenziando le diverse fenditure che attraversano ogni tentativo di ricomposizione. Poiché la tensione verso un intero sempre irraggiungibile, così come ad un divino inaccessibile, chiamato in causa anche nella numerazione dei frammenti, può solo manifestarsi attraverso brani, tasselli, lacerti.
Lilith, figura che si declina nei suoi molteplici aspetti, quale demone nella religione mesopotamica o prima donna creata per l’ebraismo o simbolo dell’emancipazione femminile, trova nell’opera la sua contemporaneità. In una storia smembrata tra città di provincia e aule universitarie, ordinaria quotidianità e suspense, depravazione e trascendenza. Mentre la scrittura, che attraverso una registrazione neutra ne costruisce il montaggio, si pone sul bordo di più sguardi, tra fisico e inconscio, mitico e metafisico. Nel fitto di contaminazioni e metamorfosi. Dei soggetti, delle storie, dei pensieri. Del quotidiano e del mito, del visibile e dell’oltre, dell’etico e dell’estetico. Poiché «Esistono stadi lucidi della coscienza in cui anche la più turpe depravazione torna ad essere raccolta tra gli eventi estetici della materia che muta».
Anche la lingua subisce metamorfosi, a partire dall’essere una voce muta. La parola del poeta è muta, necessita di un passaggio estremo, di una radicale, rinnovata espressione, visiva e sonora. Contro il linguaggio abusato della comunicazione ordinaria, infrangendo e variando l’ordine delle cose, Davide Nota cerca uno sguardo iniziale e una lingua inedita. Un occhio inconscio e sorgivo per una parola libera, ibrida e vitale. «Qual è la nuova lingua del nuovo occhio?», si chiede l’autore. Disseminando, in risposta, molteplici indizi: la «vitalità dell’improvvisazione», il montaggio spontaneo di «nuovi reperti» e “brandelli di repertorio», così come «(il “gesto” di un “suono”)», con cui viene identificata la poesia, e ancora il suono stesso, «il flusso musicale, non un ritorno all’ordine, ma alla canzone». Nel trapasso dello sguardo. Nel collasso dell’alfabeto, mentre torna alla sorgente.
Da: Lilith
4.
L’inquadratura è pianificata per omettere ogni elemento riconoscibile della stanza. Un individuo non esiste più, è solo un lembo di camicia, una cerniera di jeans che si apre come un binario un binomio due brani speculari di tessuto anonimo da cui sporge oltre la terra nera il fallo lombricoso della rovina è una testa indigena da leccare assieme in cerchio. Lo guardo come un altro me che avviene in questo specchio elettrico striato dai pixel della connessione. Chi agisce non si sa. Lilith scrive: “quanti anni hai”. Endimione risponde: “42. e tu?”. “21”. Si slaccia il reggiseno e lascia rotolare le sue mammelle ruvide africane nella visione.
12.
Le foglie cadute di notte di chi erano da chi sarebbero state raccolte? Noi eravamo così impassibili di fronte a un troppo grande mistero. Camminammo alla ricerca del sentiero che conduce ad un’antica quercia. (Essa apparì così come l’avevamo immaginata.) Oh se la vita fosse questo eterno esterno oh se la vista fosse questo esercito di occhi erosi rossi parassiti assedianti il travertino poroso tra i coppi di sangue dove una rondine cadde sul tetto era il cielo sognato una volta di stelle al contrario era un petalo forse di oleandro o di geranio tra le dita spezzato ma non ridere di me ti prego non riderne. Lui dice una rosa era di certo un petalo sanguinante tra le crepe purpuree della grotta e fuori un grande mare immenso scintillante e sempre il sole. Ti ricordi? Per questo (dice) sono giunto a te, Cibele. Lei risponde la mia vita è la morte precedente di un dio. Quando l’immagine nasce l’eternità è già corrosa. Ha inizio il grande esodo nella separazione.
25.
Non c’è oggetto sacro senza un altare. E non c’è altare senza uno spazio vuoto da attraversare. Il miracolo è in te che ti fai viandante in questo eterno errare dal silenzio a un silenzio più esteso. Dacché il dio non rispose rispondendo per te una risposta più grande.
26.
Perché un occhio significa un albero. E un albero è la sua tribù di sacerdoti e fabbri. Essi furono deposti dal dio a custodia della soglia. Ma una soglia è visibile solo dopo un labirinto. E attraversare il labirinto significa danzare. Eppure la danza non è realmente una danza. Ogni rivelazione ci è data attraverso immagini che la circondano.
32.
Difficile vedere. Ma descrivere è impossibile. La torre in una nebbia gotica. Petra tossisce, chiude la porta della stanza, carica un pezzo dei Black Sabbath su youtube. Era tutto di una banalità tragica. Gli ombrelli riaperti agli scrosci, tutto franava si inzuppava era impossibile mantenere una distanza dalla decomposizione. Io non avrò mai una casa disse (pensò). Era in treno. Era distesa sul letto di una stanza universitaria. Un occhio denutrito che non vede, vede. Scopare (dice) fino alla morte dell’io. Un organismo monocellulare che si espande fino a sciogliersi, questa è la mia dipendenza, my addiction is this obscenity (oskené) (fuori di scena) (fuori di me).
Da: Giorgio uccide il drago con la forza del pensiero
56.
Quando dicesti: Tutto sarà inghiottito dal sisma solare, prepariamoci. Il nostro fine è questo: precipitare al centro di quell’occhio nero. Iride. Questo significa volare.
Ho raggiunto l’orizzonte degli eventi. Anello dove il tempo si riposa mentre lo spazio, suo fratello, muore. Allora torneremo in uno a ritroso leggendo come capovolti la legenda dell’icona.
(La nuova prole di metallo e ottone circumnavigherà la nostra estinzione.)
64.
Lenisci le ferite metafisiche.Lei chiuse la sua bocca cavalcandogli il volto. Perdette così anche l’uso della parola.
Da: Legenda dell'icona
74.
Il filosofo rivela l’apocalisse, la sua parola è fine (il fine, la fine; aggettivo e sostantivo). Il suo ghigno è feroce e anche nel gioco è inconsolabile. Il poeta prega la palingenesi, la sua parola è muta.
80.
Una lingua del silenzio. Non uno stare in silenzio ma un adibire il vuoto. Per abitarlo. Essere in grado (nella grazia) di silenziare l’abbaglio storico.
87.
Così è la poesia (il “gesto” di un “suono”), questa nemica naturale della comunicazione.
88.
Lirica, ibrida. In polimetria e libertà rimica trobadorica, dove la rima muti agevolmente in assonanza. Data una norma la vita assume senso nella sua infrazione e variazione spontanea. Ciò che conta è adesso il flusso musicale, non un ritorno all’ordine, ma alla canzone. (Nella vitalità dell’improvvisazione, che ciò che non cerca trova.)
Davide Nota è nato nel 1981 a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, da padre lucano e madre marchigiana. È cresciuto ad Ascoli Piceno, ha studiato a Perugia e ha vissuto a Roma per alcuni anni. Nel 2015 si è trasferito a Macerata. Ha pubblicato i libri di poesia Battesimo (LietoColle, 2005), Il non potere (Zona, 2007), La rimozione (Sigismundus, 2011), l’ebook I rovi (2016) e una raccolta di racconti dal titolo Gli orfani (Oédipus, 2016). Ha svolto alcuni esperimenti di video-arte installativa con il duo Ermes Daliv (Amateur, Uno (Trittico), Come crescono le piante la notte) e di teatro multimediale con il Collettivo ØNAR (Ppss). Nel 2019 è uscito per Luca Sossella Editore il romanzo di poesia Lilith. Un mosaico.
Fabio Orecchini, da “Figura”, Oèdipus edizioni 2019, nota di Laura Caccia - In morte e in vita della lingua
In morte e in vita della lingua
Alcesti si fa figura. Certo, lo era già, personaggio mitico e protagonista della quasi-tragedia di Euripide: personificazione dell’amore disinteressato fino alla scelta della morte al posto dell’essere amato. Fabio Orecchini, però, in Figura ne fa, da soggetto di una trama, emblema di una molteplicità di sensi, sdoppiamenti, finzioni, creazioni. Figura dell’inquieta condizione esistenziale, della ricerca identitaria, dell’alterità e dell’incorporeo, così che «nelle pause dire l’altro sommessamente adire abito un nome non un corpo […] un io / residuo». Figura quindi da modellare, dall’etimo stesso di figura e del suo tema in fingĕre, plasmare. Fingere e fingere di fingere. Figurare e sfigurare. Figurare altrove.
I titoli delle quattro sezioni, in cui si articola la raccolta, ne evidenziano i molteplici piani. Dalla tanatomorfosi di ‘cercatemi e fuoriuscite’, dal richiamo rosselliano, ai canti figurati di ‘la circostanza del doppio’, dallo stralcio della ‘deposizione di Admeto’ alla vertenza di ‘essere pendente’. Piani che polarizzano sdoppiamenti e divari. Con la ripresa dei frammenti del testo euripideo e, per contrasto, nell’assenza di continuità con cui ne vengono rielaborate le sequenze. Con l’inserimento di citazioni poetiche e, insieme, dei linguaggi della contemporaneità. Con accenti sulle opposizioni tra visibile e altrove, vita e morte, corpo e incorporeità, presenza e assenza, figura e controfigura. E con l’uso di registri plurimi: poetico ed etico, estetico e giuridico, lirico e politico. Nei quali si evidenzia la pendenza sul falso e sul vero. Il condurre a dimensione storica la lingua e la vicenda mitica. E, nello stesso tempo, portarla altrove. In un figurare che si modella e rimodella rispetto all’identità, all’altro, all’oltre.
Anche la parola si fa figura. Un canto figurato del dire-non dire, di una voce che, per Fabio Orecchini, «detenga detenuta | diurno il regno dell’ombra». Una voce che accetti di morire e poi di tornare a vivere trattenendo in sé la morte. Una parola che, nella responsabilità di dire, metta in discussione la comunicazione ordinaria e abusante, attraverso i «guasti metrici», paradigmi dei guasti esistenziali e linguistici. Così da definirsi in una poetica del plasmare se stessa e il proprio canto in figura, non tanto nella forma classica del testo scritto, quanto in quelle della voce recitante e della parola visiva. Nel farsi figura, come Alcesti, dell’incorporeo e dell’ombra. E, insieme, dell’incarnazione del dire negli inferi della violenza storica. Da cui uscire alla luce. Rinascendo al mondo colma del proprio autentico tornare alla lingua.
Da: cercatemi e fuoriuscite | tanatomorfosi
“...tre giorni al confino Alcestina
tre giorni e tutto torna come prima..”
***
al dire lontano
che fu sapersi detta, circoscritta nella forma o figura
appena pronunciata, figurante asservita alla scena
appena trascorsa -evocata- qualcuno provi a soccorrermi
a sfigurarmi
almeno, figurarsi altrove
***
fuoriuscita dalla prigionia
neuma dei morti anche il vento impietrito, addio addii,
interdetta risata della notte-abituro del dire cercatemi e
fuoriuscite mi dissi ha detto ripeti o, rientrare nel covo
covo mortalmente chiedere ai restanti minuti di vivere
soltanto, il tempo di morire
***
dopo nei giorni
ritrovi ancora schegge -parti di parti di un discorso- o più
semplicemente ora, la gola è un gelo l’arcata del cielo
non detiene, le viscere calde amputate sul pavimento e
poi il lutto
pulire ciò che detto, le parole buttate sul letto
***
Le voci plateali
a fare peso, dove tutto è solo forma già compiuta nelle
pause dire l’altro sommessamente adire abito un nome
non un corpo o ancora un filo che attraversa un io
residuo uni-sonante come un silenzio elettrico
uno sparo, siamo deserti fertili di bombe
Da: la circostanza del doppio | canti figurati
S t a s i m o / libera trascrizione per cori da Euripide
***
Si segnalano guasti metrici.
***
Vita è già presso?
ombrosa notte sopra gli occhi
crepe le mani d’ombra muove Alcesti
braci, acconsente che s’avventi
l’inverno e l’infezione
se taci, si, resti
per quanto cercassi, nulla vidi mai
che più forza avesse della morte
della vita gli incanti d’Orfeo la voce estinta
Da: deposizione di Admeto | stralcio
***
Oltre il canto figurato pura funzione del volo i suoi passi
figura tangente i corpi dati ad usodi norma
del vero, di circostanza
dai piedi ombra un rapace si tende ai miei passi, pura
finzione del volomi figuro tangente la norma
del vero, della decenza
***
il sospetto che a mentire sia il verdetto
imputata la parola il giudice il corrotto
dimmi Alcestina dimmi
l’inferno bianco Alcestina, color di falena
Da: essere pendente | vertenza
***
se poi parliamo siamo ombre
di parole, o dentature
a calco, per masticazioni
brevi, non vere, Alcestina,
scadenti risa attonite
al trapianto dell’anima
***
si disse altro per non dire oltre:
***
La sua voce detenga detenuta | diurno il regno dell’ombra
Fabio Orecchini (Roma, 1981) è poeta, antropologo, artista. Ha pubblicato Dismissione (Luca Sossella Editore, libro+cd, Roma, 2014),Per Os (Sigismundus editrice, Ascoli Pieno, 2017) e Figura (Oèdipus, Salerno, 2019). Suoi testi sono apparsi su numerose riviste tra cui Alfabeta2, Versodove, L’Ulisse e Nuovi Argomenti ed è presente nel documentario GenerazioneY – Poesia italiana ultima prodotto da Rai5. Ha eseguito installazioni site-specific in spazi quali l'Ex G.I.L di Campobasso, il Palazzetto dei Nobili de L’Aquila, la Mole Vanvitelliana di Ancona, e,a Roma, presso la Biblioteca Nazionale, l’Accademia d’Ungheria, il Teatro Argentina e la Fondazione Primoli. Con l'installazione TerraeMotus si è aggiudicato il Premio "Elio Pagliarani" 2018. Con alcune opere inedite si è aggiudicato il Premio "Poesia di Strada" (XVII ed.) e il Premio "Città di Gallipoli". Collabora con la rivista Argo e la casa editrice Argolibri, per la quale dirige la collana "Talee"; ha inoltre curato la prima edizione italiana di After Lorca di Jack Spicer (Gwynplaine/Argo,2018) e il volume L'altra voce (Giometti & Antonello, 2019), epistolario della poetessa argentina A.Pizarnik.
Ivan Schiavone, da “Tavole e stanze”, Oèdipus edizioni 2019, nota di Laura Caccia - Olografia dell’erranza
Olografia dell’erranza
Parlare di erranza quando, a partire dal titolo, l’opera Tavole e stanze di Ivan Schiavone ci conduce a immagini circoscritte sul foglio e nella realtà, potrebbe apparire incongruo. D’altro canto l’errare e il dimorare si mostrano, nella raccolta, quali polarità della condizione umana, in cui «randagio sotto il sole della mutazione va l’uomo» e le delimitazioni di rendono necessarie come «argine al nulla». Mappe etiche per affrontare la ferocia del presente storico, stanze esistenziali per assaporare l’abitare nell’altro. Dove non si smorza però la percezione dell’erranza, dell’estraneità esistenziale. E dove il linguaggio «è orma in cui l’uomo nominando incede / quale estraneo nella sua propria casa a cui la lingua non nasconde, ruba».
Quali tavole, quali stanze spalancano i versi? L’apertura delle tavole, da un atlante multiforme, illumina un quadro di assenza, scissione e sradicamento. E, insieme, un bisogno di riparazione, come in Giappone l’uso dell’oro per colmare le crepe di un vaso. Tavole e stanze preziose, allora. Riparatrici e riverberanti. Tavole e stanze del mondo. Del visibile e dell’oltre. Dell’uno, del mistero. Come della barbarie e della corruzione. Anche tavole e stanze interiori. A segnare la divisione dell’uomo dall’uno e il suo riflettersi nell’alterità. E ancora tavole e stanze della lingua, dove la parola veicola assenze e, «nel miraggio della totalità, veicola il proprio essere riflesso».
Il riflesso crea dislocamenti continui, riverberando una realtà a più dimensioni. Quasi fosse il fascio di raggi laser di un’olografia e, insieme, il suo riflesso speculare. Che la raccolta appaia simile ad un’olografia, come, del resto, dal suo etimo, diviene interpretabile fin dall’accento iniziale: «tutto nel tutto s’intrica e compenetra». Anche se poi la totalità è un miraggio e del reale non si conosce tutto, «soltanto gli istmi e i margini del nostro linguaggio / all’interno del quale solo accadono verità ente ed evento». Il fascio di luce appare allora essere la parola poetica. Nelle tavole e nelle stanze della lingua, nel loro montaggio labirintico, «attraverso la maieutica del discorso caotico», la parola di Ivan Schiavone mostra i suoi riverberi. Non solo riflessi però. La parola appare propriamente l’oro che, sul piano poetico, illumina. E, sul piano etico, ripara.
Da: postulati e apostasie
tutto nel tutto s’intrica e compenetra, dalla brama d’inerte della macchina
alle rotazioni lungo le ellittiche, mosso e irretito in una sola legge
l’infinitesimale e l’infinito, animato da un palpito, da un soffio
lo spirare manifesto nel verso di una bestia, nella lingua che traccia
un perimetro in cui la nostra psiche edifica, schermo al reale, il mondo
lucerna effimera per scarno lume contro le ampie volte della notte
***
non possiamo che trovare rifugio nell’immaginario e in esso abitare
poiché di tutto ciò che è a noi più prossimo la contemplazione ci annienterebbe
della realtà conosciamo soltanto gli istmi e i margini del nostro linguaggio
all’interno del quale solo accadono verità ente ed evento, ed il mondo
la disponibilità assoluta, è orma in cui l’uomo nominando incede
quale estraneo nella sua propria casa a cui la lingua non nasconde, ruba
Da: tavole da un atlante
dall’assenza, dalle scissioni, dall’anestesia, dai deradicamenti,
dall’ibrido; talmente fragili
che ogni passaggio di intensità minima — quando un vaso si rompe,
in Giappone, connettono le crepe con dell’oro
riparandolo
chiamano questa pratica kintsugi — come dopo forzata apnea il respiro
come quando comparsa l’ascia a un cavaliere
lasciate le redini
rimessosi all’istinto del cavallo
estinta la volontà
affidato a — tre gocce di sangue stillò sulla neve lo squarcio dell’oca ferita dal falco
il rosso ed il bianco (mysterium coniunctionis) —
per nostalgia della sposa perduta
di una fanciulla smarrita
che non impresse mai traccia sulla pelle del mondo
in cerca di un corpo
reale
e interiore al contempo
su cui verificare il collimare del riflesso — all’alba, attoniti, per stordimento
per il disparire lento dei fantasmi
all’acuminarsi dei raggi
tra le feritoie dei cumulonembi — per nostalgia di un futuro terso
ci siamo consegnati a vicenda testimonianze d’orrore
di dolore
quasi — sino al punto più estremo del viaggio
il ritorno
lì dove sorge la nostra casa
e a noi la nostra immagine assomiglia
***
a Adriano Padua
non sappiamo più nominare il fuoco
per non essere noi da tempo prossimi
al fuoco — o
per troppa prossimità al domestico
all’addomesticato — o per la vanità
uno dei modi della fame
uno dei modi della ferocia che dilania questo tempo
in cui agape è lo scandalo
aggressione l’abitudine — o come il giardiniere
che al ritmo circadiano della cura
contrasta con la forma il naturale — astro assurdo
sordo all’urlo
mezzato da un balcone
da un fiore in controluce — indugiando tra le crepe
tra le tracce materiali del conflitto
non tra crolli ma tra moniti ad occuparsi della statica
— e formiche che si agitano
tra i decori floreali di tovaglie impressionate
dalle cene e dagli avanzi — prestasti ascolto al suono e il mondo scruti
di quel dolore avendo pena
per compassione
all’ascesa rinunciasti — quando tra le navate di una fabbrica
l’empatia tra i bassi, l’alba e le sostanze assunte
disegnava le mappe chimiche dell’estasi — riposando in te sereno
in te radiosa tra i gesti minimi
di un quotidiano che la fame estingue
— nella convalescenza del cielo e dei suoi influssi
Da: variazioni artiche
da moto impercettibile i lembi discosti, frammenti
frammisti percorsi da fremiti tra il vasto ed il vano
pianissimo, poi piano si spaia
il bianco coeso, una linea affilata che si staglia
a orizzonte, scissura in cui filtra una luce da strozza
che scucendo riduce il paesaggio ad un raggio introflesso
a mosse menomate che alternano soste e latenze
al passo di una lenta carrozza
avvolta dall’alone soffuso emanato da un vano
nel piano elemento isolato che impressiona un tracciato
sull’elitra esile del ghiaccio
Da: cantico piano
soltanto per celare la dimora che a me fu disvelata dal tuo sguardo
la quiete in sé vibrò, per risonanza, e fu la luce, fu, dal cosmo all’atomo
la legge che sorregge la meccanica perfetta del reale, fu splendore
soltanto perché sia in stella binaria il nostro centro, i nostri fuochi e l’orbita
***
trasfigurato hai in iconostasi dei quotidiani oggetti la presenza
l’acqua, il tavolo, il letto, gli indumenti compresi nella luce per te acuita
che non adombra usata consuetudine di scale anzi rischiara, sino al limite
il punto a cui s’arresta la domanda e il dimorare è quiete ed evidenza
Ivan Schiavone (Roma, 1983) ha pubblicato : Enuegz ( Onyx, Roma 2010 e, in versione ebook, 2014), Strutture ( O èdi pus, Salerno/Milano 2011), Cassandra, un paesaggio ( O èdi pus, Salerno/Milano 2014), Tavole e stanze ( O èdi pus, Salerno/Milano 2019). Ha curato diverse rassegne letterarie tra cui Giardini d’inverno e Generazione y – poesia italiana ultima (da cui il documentario omonimo realizzato da Rai5); ha diretto, con la poetessa Sara Davidovics, la collana di materiali verbali Ex[t]ratione per le edizioni Polìmata. Dal 2016 dirige per la casa editrice O èdi pus la collana di poesia Croma k.
Massimo Scrignòli, da “Lupa a gennaio”, Book Editore 2019, nota di Laura Caccia - La parola estrema
La parola estrema
Tra le falde di parole innevate. Di paesaggi oltre. Nell’affondo delle tenebre. E nel preludio della fioritura. Così lascia le sue tracce, sulla pagina bianca, Lupa a gennaio di Massimo Scrignòli. Nello stesso tempo, assecondandone altre, percependone i richiami, «seguendo della lupa di Gennaio le tracce delle prossime notti». Nell’aprire la parola al mistero. Nel corteggiarne l’ombra gravida, come la sposa, insieme, predestinata e rivelata. Così il plenilunio di gennaio, quello che per i nativi americani è la Luna del lupo, segna il periodo dell’attesa, «l’ingresso docile degli occhi nella neve oscura», e del silenzio, «un silenzio maternale», fonte degli atti creativi della riproduzione come della produzione poetica.
Il paesaggio, visibile e invisibile, percepibile e interiore, è disegnato dal biancore e dall’attesa. Dall’assenza e dal desiderio. Dalla morte e dalla rigenerazione. E dalla musica. Tutto è avvertito, dai sensi e dalla mente, attraverso la visione e l’ascolto. Un sentire che consente di vedere. E viceversa. Un vedere e un sentire oltre. Un oltre che giunge imprevisto. Tra i fondali dove affiora «l’anfratto di un dio dimenticato». Nell’apparizione di cose e animali come aperture significanti. Sotto la pelle, dove «se anche l’infinito finisce […] si muore nuovamente». E ancora, e soprattutto, nella rivelazione che risveglia la verità, il suo «valore indiviso». Anche se non manca la sua attesa continua, quando, nella tensione verso di essa, «conquistare il contorno di un vuoto è di nuovo spostarne le origini».
Tra questi estremi, nell’attesa del vero e nell’apertura al suo manifestarsi, si muove la parola. Non il linguaggio ordinario che ha il compito di dire, ma una lingua sempre sull’orlo dell’albore e dell’annuncio. Come «rugiada quando abita la soglia». Parola dell’origine e dell’oltre. Mentre la storia, invece, «inganna la meta». Parola del desiderio e del rivelarsi. Anche se manca sempre qualcosa tra il visibile e l’invisibile, tra il verde ostinato di un prato e «l’aria che respirano i morti». La scrittura poetica di Massimo Scrignòli raccoglie, nell’assenza e nell’attesa, questo respiro intermedio. Il respiro che avverte il soffio del principio, il respiro su cui «la morte si è arresa». Attraverso una parola che, proprio come la lupa, lascia le sue tracce, tra gli echi di René Char e di Paul Celan, su pagine dense di «fiducia in questa lingua che ci parla». Una «parola che non deve dire». Una «parola estrema, qui, ritrovata».
***
Poi sarà l’improvviso. Musica. Non suo-
ni in punta di penna; musica da leggere
sull’impronta, come solo spiraglio dentro
l’oscuro del sentire quel Tu che lúmina la
fiamma delle urne di Primavera.
E le ombre, tutte, incendia.
Così io muovo. Vado dove sono.
1.
Così anche noi. Scendendo alla nave
con la marea del giovane naufragio già
pensavamo alle alture e alle rocce nel
deserto. Eppure anche noi, senza averle
sentite, stavamo seguendo della lupa di
Gennaio le tracce delle prossime notti.
L’oltre arrivò imprevisto: il ritorno verso la
fronte.
2.
Ha inizio nuovamente in una parola.
Viene da lontano, la sola che atterra da
un silenzio maternale. E respinge ogni
possibile teoria, fino a quando il fondo,
in noi, diviene cima.
Niente altro se non tutto questo è il
grano sotto la neve, in Gennaio.
11.
Cercando il marmo oscuro di Paul, diviso
tra il canto dei corvi ingigantiti dalla
pioggia e l’inizio inseguito, avanzano
verso di noi pochi piccoli sassi colorati:
un nome dorato scritto con il nero latte,
sette schegge di specchio tedesco, neve
fossile ghiacciata.
Tutto invita verso il lato più scuro del
cielo, nell’ultimo retablo dell’anno. Ar-
cipelago in movimento e già rallentato
dalla parola estrema, qui, ritrovata.
12.
E nonostante ritorna, tutta, ritorna,
l’acqua ammutolita della Senna. Per
concessione suprema di Eraclito questa,
oggi, è quella stessa acqua. Così anche
noi continuiamo a toccare il freddo del
gorgo, che solleva lo sguardo oltre il viso.
Nell’attesa della parola che non deve dire
c’è l’istituzione della rugiada quando
abita la soglia. Come una madre, prima
del fianco ostinato della foglia.
23.
Tuttavia si avanza togliendo. E conqui-
stare il contorno di un vuoto è di nuovo
spostarne le origini.
Anche Novembre non lascia più cadere
le sue foglie. La storia accelera i nostri
passi, ma da lontano ci sopravanza e
inganna la mèta.
26.
Tuttavia mai, mai sapranno che è scrit-
to. Anche questo non sanno. In nessun
momento conosceranno. Né potranno
sapere che non siamo ciò che cerchiamo:
ma siamo, per il viaggio dell’arca, il suo
compimento.
Tuttavia mai ascolteranno il sonno
materno della Sposa rivelata: lei sola,
dormendo, dell’alba risveglia la verità.
Questo soltanto: tutto il valore indiviso
della verità.
28.
Insiste a farsi vedere, il sole. Non teme
nessuna malattia incurabile.
Ma in Gennaio, se ci pensi, per unire il
verde ostinato di un prato del nord, per
unire il suo verde all’aria che respirano
i morti, manca sempre qualche cosa: un
sentiero, una scala, o una mano chiusa
piena di neve.
La vita non è tutto.
***
Viene in visita la neve, ma sopra l’Oceano
a Gennaio l’inverno si ritira.
Forse non si potrà mai pronunciare il
luogo silente anche se è stato nominato.
L’indicibile purifica l’azione
corteggiandone la luce.
Eppure dorme, questo secolo: è un sonno
senza sogni, adagiato sul fondale di un
tempo tuttora indifeso dalle antiche
profezie di Vulcano.
E noi non abbiamo ancora messo in salvo
la cenere.
Massimo Scrignòli, bolognese di adozione, vive in provincia di Ferrara. Nel corso di un trentennio di dialogo e collaborazione con i più importanti critici e poeti italiani del secondo Novecento, ha pubblicato, con prefazioni, tra gli altri, di Raboni, Ramat, Pampaloni, Sanesi, diversi volumi di poesia: dal libro d’esordio Notiziario tendenzioso (1979) a Vista sull’angelo (2009), tutti raccolti nel volume antologico Regesto (2014, seconda edizione 2023). Presente in numerose pubblicazioni antologiche e didattiche in Italia e all’estero, sue poesie sono state tradotte in inglese, spagnolo, portoghese, croato.
Ha partecipato ad autorevoli festival internazionali di poesia e letteratura; nel 2006 e nel 2009 ha rappresentato l’Italia all’International Poetry Festival di Zagabria.
A testimonianza di una costante attività culturale, anche come “compagno d viaggio” di artisti contemporanei, sono le edizioni d’arte in collaborazione con pittori di fama internazionale, come Baj, Chia, Benati Pozzati, Bonalumi.
Da molti anni svolge un’intensa attività nel campo dell’editoria, curando e coordinando collane di poesia, critica letteraria, filosofia, in cui sono stati pubblicati, tra gli altri, scritti di Leopardi, Poggioli, Sanesi, Crovi, Porta, Sanguineti, e in cui hanno visto la luce anche nuove traduzioni di Auerbach, Eliot, Tagore, Yeats, Bauchau, Flaminien, Char; sue sono la versione e l’introduzione critica di Relazione per un’accademia e altri racconti di F.Kafka (1997).
Ultima pagina 1/ Audiolettura di Elena Corsino, Nell’equilibrio dello zero, su una foto di Max Carcione
Ultima pagina 2/ Videolettura di Patrizia Dughero, con una nota di Giorgio Bonacini
Nota per Alle amiche di Patrizia Dughero
In queste poesie Patrizia Dughero rivolge il suo sguardo a fotografie in cui figure amiche di donne del passato, alcune forse conosciute (la nonna?) altre forse no, vengono tutte rese vive e ri-conosciute fin dalle prime parole: “Appena sveglia restituisci/chiarore e lucentezza”. Inizia così un’intensa rappresentazione dove le parole della poesia riescono, avvolte da un incanto di inattualità, a farci sentire quella consistenza aerea che sola può oltrepassare l’incessante fuggire del tempo, con uno sguardo che coglie il prima e il dopo, il vicino e il lontano. Un parlare “oltre” che restituisce la necessità di un tempo mobile e sospeso, in cui passato, presente e futuro si richiamano nel fluire delle immagini. Ed è con questa bella espressione che l’autrice apre i passaggi tra il vedere e il pensare, tra l’osservare e l’immaginare, superando il contesto fotografico verso la meraviglia di una scrittura cristallina che è vita e dà vita. Ad esempio l’amica Luigia, “umile che cerca lume”, dove il chiarore sta tutto dentro la semplicità, la riservatezza che sola può, cercando delicatamente, arrivare non alla luce - che sarebbe un eccesso, un sopravanzare chi possiede solo “poche intime verità”-, ma avvicinarsi a ciò che illumina. E in questo sta la visione immaginativa che realizza una scena fatta di emozione e sentimento, insieme al trasporto che affiora verso una conoscenza rimodellata da una domanda o da un gesto. Provando anche a valicare i limiti dell’immediato, verso le trasformazioni a cui il dire tende per aderire alle cose: senza spazio e senza tempo, in un gioco mai usato di nuove geometrie. Dunque non trasfigurazioni ma relazioni fra sensi e percezioni, e gentili minuscole azioni in tempi e luoghi diversi eppure corrispondenti. Un divenire che rende leggeri e cambia un paesaggio di forme naturali in musica interiore, lì dove “il canto si compone”. Perché la storia personale, puntualizza con precisione Patrizia Dughero, se non ne “percepisci gli oggetti, se non li scrivi”, non esiste ed è solo in questo modo che possono rivivere le esistenze: nei particolari. Ecco allora: lo sgabello di velluto, le scarpe nuove, il fiocco tra i capelli, l’abito frusciante, le calze color panna, i drappi sulle tende (cose di buon gusto, capovolgendo Gozzano, a cui però, siamo certi, sarebbero piaciute queste poesie) che rendono quel mondo unico. Un mondo prezioso, speciale, dove però non è sufficiente il ricordo: ciò che serve è la testimonianza, il segno che imprime l’esserci dentro al “giardino dell’amica con le amiche”. E qui l’autrice cerca negli occhi e tra i pensieri, ipotetici ma veritieri, ciò che pensa l’amica Anna affacciata alla finestra: quasi un’immedesimazione, un abbraccio al passato. Ma anche l’amica Alma, con cui dialoga partendo dalla malinconia di una domanda :”Sarò ricordata qualche volta?”. Mettendo in risalto condizioni esistenziali possibili e sicuramente verosimili, per i luoghi vissuti, le cose sperimentate, la stessa immagine di lei che risalta all’esterno nella sua intima essenza. E allora ecco un’abbondanza nell’infanzia, una carità nell’adolescenza, uno spavento, una colpa e l’incertezza in una sua vita anteriore. Con queste parole, ma specialmente per il modo in cui ricombinano il pensiero in poesia, Patrizia Dughero ci dimostra, ancora una volta di più, come la poesia sia sostanza materiale, una forma di vita anche lì dove sembra esserci solo vuoto. E lo fa attraverso la figura di Livia che riesce, nonostante gli “occhi allenati allo sguardo/verso terra” , e malgrado l’evento della grande guerra che ha travolto il mondo generato per amore , in cui lei si riconosceva, ad accerchiare la realtà con parole buone. Ecco la cura: la capacità di dire, portando una parola di guerra come “accerchiare” al suo contrario, la bontà. Solo la scrittura nella dimensione poetica riesce in questo, ponendo domande che non interrogano ma considerano attentamente la presenza fisica e impellente di un futuro presente al suo passato: Quali parole porteremo, Come finiremo. E allora si capisce perché, insieme all’elenco delle Amiche, nella poesia finale vi siano elencate, solo per nome ma riconoscibili, alcune tra le autrici a cui va la sua gratitudine: “Amelia, Antonia,/ Ingeborg, Elisabeth, Ida e le altre/piene di grazia,/che avete donato fatti al futuro,/non solo parole…” Giorgio Bonacini>09.03.2024
Ultima pagina 3/ Videolettura di Marina Petrillo, con una nota di Ranieri Teti
MEME
Un meme decade dal suo detto
avocando in remoti frammenti di linguaggio.
Indescritti “geni egoisti” replicano
nuovo logos, di ogni culto afoni, fecondi
all’insipiente clone gravido di nulla.
Una genetica difforme crea esistenze
mediatiche, relazioni tra realtà e parvenza
del cui stato rituale si imbeve l’esperire.
A spersi fotogrammi divampa
la solitudine dell’imperio straniato
Offusca in diagonale. Confina
ogni lirismo a sua minaccia.
Ruminatio sottesa al violato limen
emersa in sotterfugio linguistico
parafrasi dell’anemico adagiarsi in linea retta.
Abdica oltre il crogiolo temporale
Accogliendo variazioni nel potenziare
sviluppo di istantanee derubricate
alla “Santa Inquisizione “di Sua Vastità la Rete.
Il vuoto campo di liturgie simboliche
in apparizioni devote a lemme sconfinante
il nitore del cogitante paradigma, naufragano
l’Archetipo a messe gravida di scorie emozionali.
Isole emerse da generanti veli sterili
Condensa in stille disarmoniche
Offuscate da torpide allucinazioni condivise.
Rifulge in mugghiante anomalia
Homo sacer asceso in spazi paralleli
“il futuro è solo una malattia dell’enigma”
che promana in dissacrata, spenta liturgia.
Un vocabolario ricercato, attualissimo e antico, attraversa questa poesia di Marina Petrillo: già nel titolo c’è il “meme”, uno dei simboli del nostro tempo, ci sono “esistenze mediatiche” e allo stesso tempo latinismi e termini recuperati da un dire passato.
Tutto questo produce una lingua ibridata, metamorfica, che è la base per la costruzione di un testo che via via diventa una forma di resistenza.
In questa poesia si crea un cortocircuito linguistico tra contaminazioni e versi memorabili: questo spaesamento è lo stesso che si coglie nel suo senso complessivo, come se l’autrice osasse andare sempre un po’ più in là, verso dopo verso. Non c’è tregua, nessuna sospensione: l’opera chiede all’autrice di evitare “ogni anemico adagiarsi”.
Quarta di copertina: Cristiana Panella sulla scultura di Gibo Perlotto
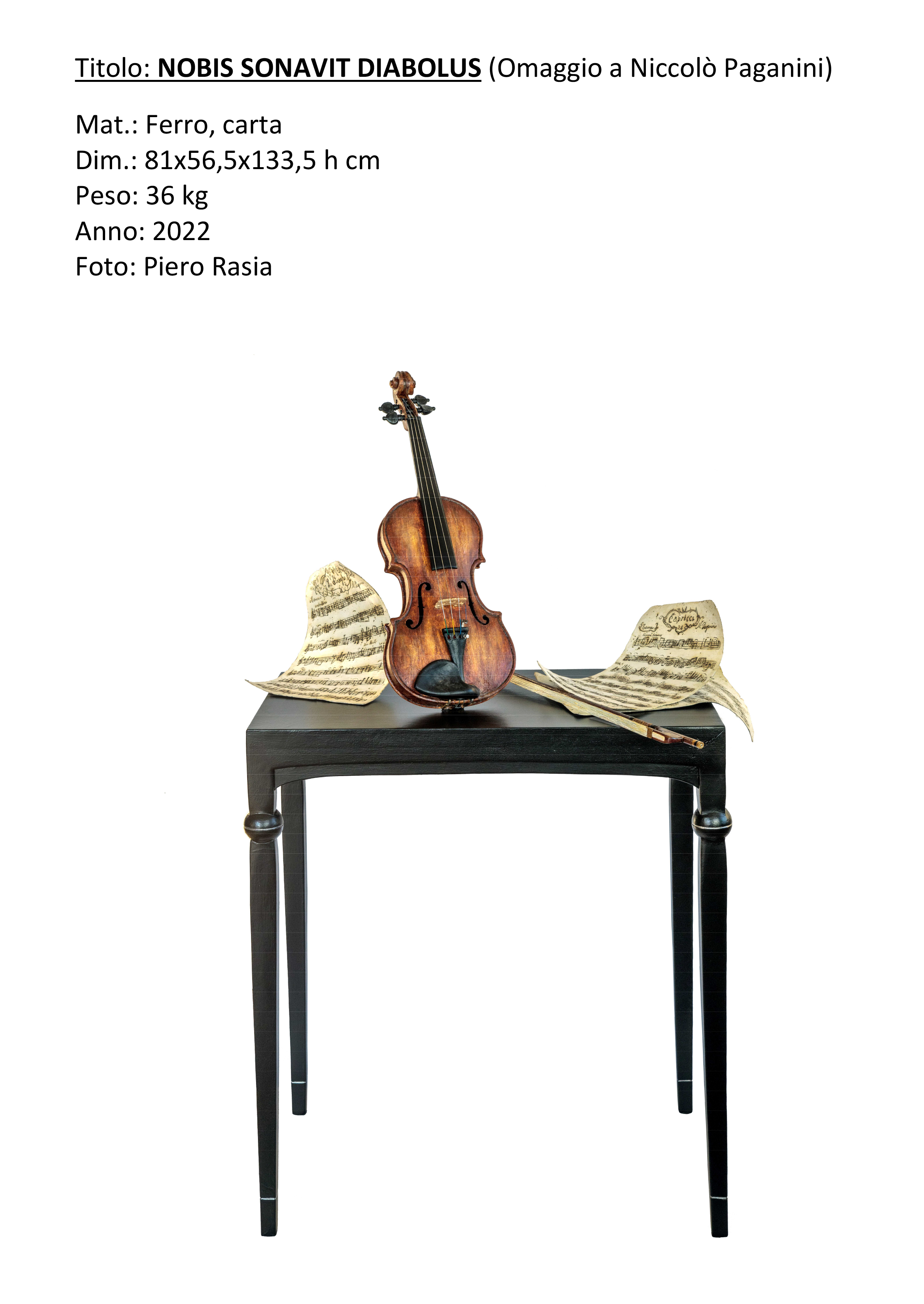
No*bis sonavit diabolus (2022)
Cristiana Panella
« Paganini le fantastique/Un soir, comme avec un crochet/A ramassé le thème antique/Du bout de son divin archet/Et brodant la gaze fanée/Que l’oripeau rougit encore/Fait sur la phrase dédaignée/Courir ses arabesques d’or »
Théophile Gautier, Émaux et Camées, 1852
No*bis sonavit diabolus è un’opera dello scultore Gibo Perlotto in omaggio a Niccolò Paganini. cela nel ferro l’alito fatuo del djinn, il genio femminile e maschile di lisiera che stanzia tra selva e villaggio, tra integrazione e disintegrazione, tra il fuori e il dentro, ora doppelgänger, ora entità altra di straniamento. mago ctonio che governa i riti di possessione attraverso la musica, guardiano dell’ombra cui in Africa occidentale i cercatori d’oro si raccomandano con il sacrificio del gallo prima di violare la terra. questo stato di ambiguità liminare affiora dalla copresenza tra la staticità del tavolino e gli spartiti volatili, il violino sospeso per incantamento, l’archetto che interseca il bordo come una linea di fuga. prima di accorgersi che in questo ordine apparente tutto pulsa in un vortice impalpabile. il tavolino stesso, che dovrebbe assicurare una centratura, una simmetria, come nel caso di Le sorgenti di Arturo, opera coeva dedicata ad Arturo Toscanini, ha una vibrazione liberatrice e allo stesso tempo déroutante, cioè che porta fuori strada, su un’altra strada. che porta via. le zampe del tavolino diventano nero malmignatta, l’argia, la velenosa Latrodectus tredecimguttatus, che nella taranta prenderà le spoglie simboliche della più innocua Lycosa tarantula. nella pizzica salentina che animava il rituale coreutico domestico di depossessione dal morso della taranta, il violino era strumento maestro per scazzicare la bestia del disagio, ossia pungolarla, attraverso la danza carnale delle tarantate, i piedi abitati che, come si imputava alle « strie », non riuscivano a chetarsi. la chiave di lettura di questo impercettibile Moto perpetuo, per riprendere il titolo di un’opera di Paganini, è celata nei due spartiti. il Capriccio #24, l’ultimo, il più ardito e arduo, dei Capricci, e Le Streghe, variazione del 1813 sul tema del balletto Il noce di Benevento, messo in scena da Salvatore Viganò, sulla composizione di Franz Xavier Sïssmayr, a La Scala di Milano l’anno prima, di cui Paganini riprende l’annuncio dell’oboe : l’entrata delle streghe e il patto col diavolo.
il foglio del Capriccio si increspa nella curva dell’arabesco. arabesco e fantastico. le arti del Romanticismo considerano « fantastico » il movimento randomico, una fantasmagoria che svela dietro un unico sipario il demonico, la manifestazione del divino nel mondo, l’appuntamento degli opposti di Goethe, e il demoniaco, l’azione mefistofelica che uccide Eros : la bizzarria, lo spavento di meraviglia, il grottesco, l’attrazione che ripugna. il fantasque, intraducibile con un aggettivo solo in italiano, più rutilante del weird. imaginarium di falesia tra bellezza e inquietudine. nel 1790, Christian Steiglitz allaccia le arti attorno all’arabesco mettendo in dialogo gli arabeschi ferici di Raffaello con la romanza picaresca di Ariosto, preparando il terreno alla teoria dell’arabesco di Friedrick von Schlegel, « questa misteriosa aspirazione segreta verso il caos incessantemente al lavoro ». il racconto di Klingsohr, parte dell’Enrico di Ofterdingen di Novalis (1802), è un viaggio epico alla ricerca del « fiore azzurro » (die blaue Blume), il ricettacolo della forme di conoscenza attraverso il compimento dello stato d’amore. qui il poeta interpreta l’arabesco in termini musicali, descrivendo il movimento sincopato, eppure armonico, di una melodia cangiante che compone immagini sulla tavola dei commensali durante la festa in cui Enrico incontrerà Mathilde, figlia del poeta Klingsohr, riconoscendovi il volto in cui si era mutato il fiore azzurro nel sogno che apre il racconto. un rimando alla magia sospesa dell’oscillazione degli astri, la musica delle Sfere che Berlioz riprenderà nella Sinfonia fantastica (1830), nel solco di von Schleger e del grottesco hugoliano. in particolare, Le Orientali di Hugo (1829) e la sua « chanson de pirates », ispira al compositore quell’« accompagnamento di tempesta » di cui egli scriverà in una lettera del 2 febbraio 1829 all’amico Humbert Ferrand. il ritmo frastagliato del crepitìo di fuoco fluisce così nella Sinfonia e nel suo ultimo movimento, «songe d’une nuit de Sabbat ».
la definizione di Gautier sostantiva un aggettivo federatore tra le arti di alta pregnanza simbolica. pertanto, definire Paganini « fantastico » significa metterlo al centro del maelstrom artistico del suo tempo e del retaggio della sua figura-opera. colui che con il divino archetto del « Cannone », il Guarnieri del Gesù, che Hoffman paragona alla scopa delle streghe, fa scorrere arabeschi d’oro, non è fantastico. È il fantastico. nel bene e nel male. l’editore e critico Jules Janin testimonierà di questo coacervo di astio e ammirazione : Paganini, il « misérable italien » ha rotto tre corde del suo violino per conservarne una sola, « une seule corde pour tant de passion ! Une seule pour toute cette âme ! ».
fedele alla linea dello svelamento del quotidiano, No*bis sonavit diabolus restituisce il reale meraviglioso, quell’ipermetropia delle anime capienti lontana, tuttavia, da un iperrealismo distopico e ipertecnologico. un occhio di veglia che ha disimparato, che si è dilatato nella materia accogliendo l’esperienza estetica, la senzienza di una semplicità verticale. Gibo è estraneo alla natura gotica e bifronte di Paganini, al suo artificio di stupefattura. è figlio delle terre interne del Vicentino e del Trevigiano. calca le orme di cima di Rigoni Stern, di Meneghello, di Zanzotto, artigiani della luce che abbracciavano il creato dalle radici attraverso i suoi araldi di umiltà, quelli che fanno cintura : le bisacce di trincea, gli scarponi, il silenzio. « un tempo povero, sì, ma ricco forse di altre cose che abbiamo perduto », scrive Rigoni Stern sul complesso scultorio di Gibo « Memoria contadina » (2001). dal ferro, nella sua restituzione della venatura, della grinza, della crepa, prende forma una riconoscenza ecumenica, una fedeltà alla vita che si incarna nei doni del creato attraverso un’ars che non soverchia. il cespo di verza di Madre Terra (2013) non è verosimile, è parola del ferro che chiama ‘verza’. così come gli spartiti di No*bis sonavit diabolus, leggiadria paradossale per vulcanizzazione, non sono riproduzione ma specchio « da un’altra lingua ». Gibo e Niccolò, pur appartenenti a emisferi celesti opposti, formano la sfera in quell’intercapedine che è il momentum di creazione, il giusto tempo che avvince intuizione e azione. Gibo sublima un ferro già addomesticato per intenzione chiara, coagula nella forma il soffio di un’anima mundi trascendente che posa il suo sguardo a terra, che diventa immanenza e per bocca delle semplici cose coniuga umiltà e potenza. Niccolò travaglia il ferro interiore : la sindrome di Marfan, identificata soltanto alla fine dell’800, e l’intossicazione da assunzione cronica di mercurio a seguito di diagnosi errate, sempre più invalidante. finché riesce a suonare, piega il suo talento di zoppìa al ritmo scosceso dell’archetto, scazzica l’impossibile tra inerzia e volo. piange sfidando. ognuno a mani sue fa voto.
Riferimenti bibliografici
Gautier, Th. [1852] 1981. Émaux et Camées. Parigi : Gallimard.
Janin, J. 1863. Contes fantastiques et contes littéraires. Parigi : Michel Lévy Frères, Libraires Éditeurs. Projet Gutenberg : https:// www.gutenberg.org
Loisel, G. 2017. « ‘Cette confusion ordonnée avec art’ : la Symphonie fantastique comme œuvre arabesque ». In C. Bayle & E. Dayre (eds) L’Arabesque, le plus spiritualiste des dessins. Parigi : Kimé, 57-73.
Menichetti, A. 1984. « Dal ‘Noce di benevento’ alle ‘Streghe’ », Quaderni dell’Istituto di Studi Paganiniani, 4, 27-31.
Mango, E. G. 2007. « Un muet dans la langue », Annuel de l’APF, 1, 49-68.
Novalis [1802] 1997. Enrico di Ofterdingen. Milano : Adelphi.
Rubycki, M.H. 2000. « Janin e Paganini », Quaderni dell’Istituto di Studi Paganiniani, 12, 37-44.
Marzo 2023, anno XX, numero 54
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura della redazione di "Anterem"

Ci sono, al cuore di Anterem, alcune domande che urgono. Una di queste coinvolge la discrepanza tra realtà e reale, tra l’apparenza delle cose e la profondità che vi si nasconde. Una profondità misteriosa e indefinita. Verso cui tende la parola poetica, cercando di avvicinarsi ad essa, dandole forma mentre la nomina. E, senza pur giungere a compimento, percorrendone l’aperto. Ponendosi come lingua altra. Lingua dell’origine e dell’essenza. Lingua della soglia e dello sconfinamento. Lingua senza confini e senza tempo.
Allora ci piace pensare questo: se la realtà declina le tappe del premio e il tempo del fare umano, il reale conserva la scrittura che non ha scadenza, il tempo senza tempo della poesia.
Così, anche noi, con Carte nel vento, proviamo ad assecondare questo tentativo di portarci oltre la realtà che esaurisce ogni cosa con la fretta del fare e del consumare. Di dare valore, piuttosto, all’altrove poetico, al suo senso che permane oltre il quotidiano.
E, tornando al 2020, per dare l’avvio alla presentazione delle opere della XXXIV edizione del Premio Montano, non ci pare di tornare indietro, ma di guardare avanti. Di far risuonare di nuovo versi e raccolte, prose e libri di poesia. Avendone custodito l’essenza preziosa, mentre tutto intorno a noi ruota vorticosamente e di quel tempo pandemico, che ci ha impedito forum ed incontri, si tende a non avere più memoria.
Siamo grati alle autrici e agli autori che ci hanno atteso.
In questo numero molto sonoro, innervato dall’arte musicale di Francesco Bellomi, incontriamo un saggio sull’ascolto di Loredano Matteo Lorenzetti, un saggio di Diego Terzano sul sonetto finalista nel 2020 di Mario Novarini (e un suo inedito), le presentazioni dei vincitori 2020, grazie anche ai contributi della “giuria critica”, le note di Laura Caccia per i segnalati speciali per l’edito dello stesso anno. Il tutto confezionato con i preziosi collages di Francesca Marica.
E attendiamo le nuove opere, a cui saremo lieti di dedicarci con la consueta passione, all’attuale edizione (2023) del premio che avrà scadenza il 30 aprile prossimo.
La redazione
scarica il bando del 37° Montano
In copertina: Francesca Marica, C’est la fête!
Loredano Matteo Lorenzetti, saggio, “Il suono dell’immensità”
“Sta come un pesce
che ignora l’oceano
l’uomo nel tempo”
Kobayashi Issa
“La vita reale è
soltanto il riverbero
dei sogni dei poeti”
Stendhal
1.
L’ingegnoso orecchio d’un telescopio ha udito il primo segno sonoro con cui l’universo ha manifestato il suo realizzato, ambizioso, desiderio d’immensità.
Simile al soffio musicale d’un flauto, l’inizio del cosmo ha pronunciato il balbettio del tempo. Giunto fino a noi, oggi, sottoforma di radiazione di fondo, dovuta allo scoppio primordiale, incandescente, di energia ovunque sparsa.
Così ci è dato sapere che la sonorità degli eventi ci appartiene. E’ la storia, il tessuto, di cui è fatta la realtà. Quella che ci ha nominati, parlando la lingua materica del remoto e del presente, che noi diciamo nei segni verbali dell’esistente e della nostra esistenza.
La stessa con cui l’eveniente è sul punto d’incontrarci, affinché la calda voce della vita continui a vivere della sua impalpabile essenza, con cui ci sfiora emozionandoci, accalorandoci, parlando della sua presenza e dell’oltre a sé che annuncia. Nella fredda caducità con cui l’istante scompare, muore a se stesso, perché possa apparire il dopo di sé.
L’apertura al venturo è condizione e cifra mutante dell’accadere degli eventi. E del poter nominare quel che, essendo stato, è sperimentabile, pensabile, dicibilmente conoscibile.
Allo stesso modo in cui il pensiero poetico nell’accennare a qualcosa la oltrepassa, per poterla mantenere al di fuori del suo destino d’impermanenza.
La poesia è il luogo del segno scritturale-sonoro che sfida la precaria fragilità, la labile transitorietà, la temporanea instabile fugacità del tempo. L’impersistenza d’ogni cosa, evento, circostanza, nel suo momentaneo presentarsi alla coscienza. Che l’attrito del tempo logora, consuma, polverizza. Perché fattuale, mutante, percettivamente sfuggente.
Essa nel di-segnare l’orizzonte dell’in-visibile del reale, nel superare l’apparente in-esistenza di ciò che il senso comune non afferrando esclude, ri-vela un in-conosciuto, che si sottrae all’aggressione con cui il tempo occulta, deturpa, modifica la realtà, nel noto suo apparire. L’abituale osservare, distraente e annullante la visione della profondità del reale, con cui, comunemente, guardiamo e verbalizziamo l’esperienza.
Sicché la poesia può mantenere quella ‘radiazione di fondo’ che pervade la voce del senso intimo, straorinario, originario e originale delle cose. Che essa sola, frastornante, possiede e nomina. E che le permette d’attraversare lo spazio temporale dei secoli e dei millenni. Mantenendo, intatta, l’integrità del suo fragore stordente. Che il radar dell’animo umano, captandola dagli abissi del tempo, rende stuporoso l’udito.
2.
Anche il rumore della parola poetica, provocato dall’urto con quella discorsiva, genera onde sonore creanti una diversa, alternativa, dimensione e significato della realtà.
Scontro risonante che l’udito sorprende e meraviglia. E che fa muovere lo sguardo dell’anima da ogni parte, per cogliere le cangianti, mobili forme di senso prodotte, vaganti nella vastità dello spazio da quell’impatto originatosi.
Il poetare consente di scrutare l’immensità del repertorio dei significati disponibili nell’universo del pensabile e del dicibile dell’esperienza, dell’esistenza. E non solo quelli della realtà, ma pure quelli che la trascendono e quelli che l’immaginano al di là di ciò che lo sterro reale/irreale sa pronunciare.
Tuttavia, secondo Thomas Stearns Eliot il genere umano non può sopportare troppa realtà.
Il verso poetico resiste a tale insopportazione. Perché ogni poesia, a proprio modo, ne contiene l’esatta quantità che l’occhio può incorporare, la mente sostenere, l’emozione amplificare, l’anima tremare.
Non può esserci alcun sovrappiù di nessun genere in un testo poetico. Se non la garbata misura che rende essenziale i suoni del suo dire.
Anche a motivo di questa sostanziale indispensabilità di parole il verbo poetico non dà corso a eccedenze d’alcun tipo.
E’ dalla penuria di suoni verbali che riescono a pronunciare l’impronunciabile che il poeta tenta di far deflagrare il cosmo sonoro del verso.
Ed è la parola che va in cerca del poeta. Di colui che le impedisce di soffocare nelle pagine compresse, ingiallite, usurate, dei vocabolari del quotidiano discorrere, lasciandola respirare nell’aperto dei significati dell’inchiostro poetico. Colui che le dà labbra per sillabare altra voce, tono, intensità, ritmo, senso, da quello che il chiacchierare ordinariamente le affida.
Tuttavia, il poeta sa che è la creatura della propria penna e che grafa, con atto panico, un ‘infinito scritturale sonoro’, che neppure a lui è dato sapere, del tutto, la vastità a cui accenna. Lasciando che alfabetici inchiostrati segni poetici vaghino per il mondo a incontrare un orecchio che, ascoltandoli, possa nutrire la mente, ampliare l’immaginale, penetrare il nero che li traccia e palpitare il cifrato suo messaggio.
Diego Terzano sulla poesia inedita finalista di Mario Novarini, “Il risveglio dell’amante”. Con un inedito dell’autore
Il risveglio dell’amante (cui religas comam?)
Non sarà rivelato il suo segreto,
se all’alba appare come fresca rorida
bianca rosa carnosa o come morbida
pèsca intatta per arcano decreto
di qualche poco invidïosa complice
divinità; ma so che in un piovoso
pomeriggio di noia con grazioso
gesto raccolse i capelli in un triplice
nodo, una piccola treccia sinuosa
sulla curva del collo. Era rivolto
il mio sguardo al profilo del suo viso:
ore vuote hanno senso d’improvviso
in luogo del grigiore ora dissolto
brilla una felicità dolorosa.

Perturbamento – e forma – del perturbamento
Lettura del Risveglio dell’amante (cui religas comam?) di Mario Novarini. Con un inedito
In questa nota mi avvalgo di alcuni spunti derivati dal colloquio intrattenuto con Mario Novarini dopo la conclusione della trentaquattresima edizione del Premio Lorenzo Montano. In quell’occasione, si è molto parlato del processo di redazione del testo che è qui preso in esame. Non intendo produrre la trascrizione di un’intervista, quanto uno spazio critico e una testimonianza del farsi della poesia: ovvero, una nota redatta a specchio del parere di chi è stato a capo della scrittura. Ringrazio l’autore – anche per l’inedito che conclude il tutto.
È molto interessante che in una recentissima lettura della poesia di Novarini (con particolare riferimento a Gli occhi della materia, 20081) ne sia stato indicato il quid nell’intrinseca condizione mediana; o meglio, in una medietà, per così dire, posizionale: contemplante sia la consustanzialità assoluta, sia, in via simmetrica, la riduzione materiale di ciò che può essere sussunto, teoreticamente, alla nozione di essere. Da una parte, dunque, con occhio alle estrinsecazioni formali, un «frammentismo» creativo, percettivo e ragionativo; dall’altra, un movimento contrario teso non alla «dissoluzione bensì [a] evitarla». È precisamente a fronte di questo paradigma che Novarini può essere inteso come un peculiare «medium che riconcili entrambe le posizioni»2.
Ora, credo sia importante comprendere quanto tale medietà speculativa possa essersi applicata non solo alla dimensione meramente concettuale del testo del Risveglio dell’amante (intesa tale dimensione come sintesi tematico-formale delle intenzioni autoriali e delle menti in cui queste trovano applicazione alla lettura), ma anche alla sua estensione, potrei dire, processuale, che acquista rilievo in considerazione del modo in cui il testo si presenta: ovvero, come un sonetto3. Entro tale forma si articola uno svolgimento tematico all’apparenza minimo ma problematico, se concepito e indagato con il proposito di rintracciare le tensioni che non solo manifesta, ma implica.
Ma innanzitutto: anche se ci si trova di fronte a ciò che per ora, nella produzione di Novarini, costituisce un unicum (non risultano pubblicati altri sonetti), può essere utile individuare alcune costanti condivise con l’esperienza precedente. Mi sembra si possa parlare in questo senso di un gusto per l’aggettivazione – per l’aggettivazione doppia o plurima – coestensivo a una propensione conoscitiva (volta cioè alla determinazione dell’oggetto) che si è manifestata, finora, con tutta regolarità: un’attitudine che ha contestualmente spinto l’esito estetico a legarsi via via a una certa grammatica della materia, per la quale la distanza tra soggetto e oggetto poetico(-filosofico) è andata riducendosi.
Questi elementi, tesi lungo una dialettica tra unità e molteplicità (semplificando: un solo sostantivo determinato da più attributi; l’affilata sincronia tra soggetto e oggetto contro la dispersione di questi) hanno effettivamente dato forma e struttura alla pratica poetica novariniana.
Rilevo anche che, non raramente, i momenti di intimità lirica come questo (tra gli altri, si può pensare specialmente a Forse un giorno,in Radiazione del rosso, 20174) comportano la comparsa della prima persona – anche se l’altra persona (qui: la novella Pirra) resta sullo sfondo quasi inavvicinabile: quasi terza persona. Tornerò su questi motivi.
Per allineare due degli ambiti affrontati corsivamente – cioè da una parte la continuità e dall’altra, in subordine, la questione della forma, di cui si parlerà qui in senso proprio – è utile ricordare quanto Enrica Salvaneschi ha scritto di un componimento ancora incluso in Radiazione del rosso. Mi riferisco a La balaustra sullo spazio, «nella cui, pur liberissima, forma chiusa ogni lettore può constatare un esempio (o meglio, exemplum) della “danza in catente” di nietzscheana memoria»5. Riporto la prima e l’ultima strofa della poesia, per chiarire di che si parla:
Ormai spenta la fiamma dell’arroventata sfera,
al di sopra dei tetti, in una limpida sera
nel cuore dell’estate campeggia un quarto di luna;
s’infittisce il silenzio e l’aria diventa bruna.
[…]
e un’alta balaustra nella notte verticale
punteggiata di stelle nitidamente è protesa,
come su una voragine, sull’infinita distesa
dello sterminato luminoso blu siderale.
(La balaustra sullo spazio, vv. 1-4; 29-32)
Quello che l’autore ha definito, oralmente, «uno schema tendenziale ma non perfettamente rigoroso» consiste nell’adozione di versi lunghi per cui la cesura cade sempre dopo il settenario – o talvolta, altrove, l’ottonario; indipendentemente dalla composizione interna del verso, in ogni quartina la rima finale (per cui lo schema è di volta in volta variabile) è sempre perfetta. L’ultimo verso della poesia, come si vede, scompagina deliberatamente il quadro di iterazione accentuale e la relativa cesura, pur rispettando la misura fondamentale di quindici sillabe e – appunto – la rima.
Queste ultime considerazioni immettono direttamente alla discussione del sonetto. Ha un valore patente il fatto che l’autore, interrogato sulle ragioni dell’adozione di questa forma chiusa tout court, abbia citato a titolo di esempio – in primis – la rima sdrucciola complice : triplice; rima che, per quanto storicamente ammessa, rimane imperfetta.
Novarini spiega che la poesia fa sintesi e organizza due versioni anteriori («quasi due testi distinti») confluite in uno sia per affinità tematica, sia per l’evidenza di alcune rime spontanee (come quella citata) che al di fuori della forma non risultavano in posizione enfatica.
Se – sostiene l’autore – le rime possono individuarsi spontaneamente, per via inconscia, la coazione del materiale libero ha indotto rime e aperture tematiche che, senza i limiti tradizionali, non sarebbero sussistite. Due strategie a capo della chiusura, quindi: (1) la valorizzazione della rima già spontaneamente acquisita; (2) il lasciarsi guidare dalla forma a posizioni non propriamente previste precedentemente.
In questo senso, «la poesia si autogenera»6. Se è consentita l’analogia, sembra quasi che Novarini abbia posto un’ideale cristallizzazione a reagire chimicamente con una materia mobile: se non fosse, però, che alcuni residui di quella mobilità sono effettivamente presenti, o anzi potrebbero essere stati indotti proprio dal tentativo di arginare la materia in un equilibrio formale. Mi riferisco al fatto che il sonetto presenta dei concreti spazi di eversione, tali da non rispettare un’attesa fondata sulla necessità di forma del tutto avvertibile nel testo – e appena confermata dalle parole del poeta (è dunque una ‘frustrata’ attesa jakobsoniana). Così, sono imperfette le rime rorida : morbida; complice : triplice (vv. 2, 3; 5, 8). Non sono propriamente canonici, da un punto di vista accentuale, il quarto e l’ultimo endecasillabo. E l’ultima quartina non è organizzata dalla punteggiatura, se non per il punto finale.
Si parlava all’inizio di un certo posizionamento mediano a fronte di opposte tensioni speculative – sub specie ontologica. Ecco, questi fenomeni microformali (e questa è la ragione per cui se ne parla) dimostrano quanto la dinamica della scrittura si organizzi correlativamente alla ricerca – di volta in volta – di una posizione in grado di dialettizzare tensioni opposte: qui, quelle all’adesione e all’eversione alla tradizione. Anche in questo caso – nel caso di un sonetto – si può dunque parlare di una se non liberissima, almeno libera forma chiusa: per cui il trattamento delle rime risulta paradossalmente più libero che nella Balaustra sullo spazio.
L’esigenza strutturale della reductio ad unum (o ad medium) trova un sigillo non solo dal punto di vista più propriamente processuale – per cui, a capo del duplice obiettivo di valorizzare le rime preesistenti e di trovarne nuove, resta in questo caso la necessità di fare sintesi di due corpi testuali anteriori e orbitanti intorno a un centro da individuare (tra eversione e adesione). Va anche considerata, infatti, l’evocata dimensione tematica, che non può essere scissa dal trattamento sintattico del componimento: questo comporta una protensione ridotta a inerzia solo dalla fortissima cesura al sesto verso (semanticamente più rilevante di quella al decimo) in cui lo scarto di pensiero è marcato dall’avversativa e divide l’ambito del presente usuale dal movimento verso il passato. A questo punto, le epifanie memoriali conducono all’elaborazione rievocante di una teoria minima di gesti d’amore (e dell’oggetto d’amore): ma tali gesti assumono consistenza in virtù della dialettica implicita – e chiarita dal titolo – tra la memoria del quotidiano e la memoria colta. Senza l’avantesto latino (Hor. carm. 5, 1), e cioè l’associazione tra la donna e la Pirra oraziana, probabilmente, il testo non sarebbe stato possibile in questi termini: sia perché la memoria classica plasma il presente, cioè ne condiziona l’interpretazione; sia perché l’approfondimento o lo sdoppiamento dell’istanza passata (appunto: quotidiana e letteraria) sembra non consentire una piena adesione al presente. L’ultima strofa, dopo l’ulteriore scarto sintattico e nel segno dell’ossimoro finale, configura infatti un hic et nunc in cui l’orizzonte di «senso» (v. 12) si presenta alla memoria come dimidiato, cioè latore di una sofferenza sinteticamente e sinesteticamente integrata alla «felicità» (v. 14).
Il sonetto gioca, riassumendo, su movimenti binari e antitetici: il passato consustanziale al presente; i movimenti opposti agli arresti sintattici; l’adesione e l’evasione; il perturbamento e la forma, integrati a loro volta in una forma del perturbamento – o di una Unheimlichkeit (se si pensa a una famosa traduzione). Si verifica, in corso, il cristallizzarsi della mobilità incistata nell’unità.
***
Richiamando l’analogia minerale (di cui sopra), è possibile concepire il Risveglio dell’amante come uno scheletro chimico perfetto, disordinato da dentro. Ora, durante il dialogo presupposto a questa nota, Novarini ha ritenuto curioso che tale affinità – da me individuata, in primis, proprio in quella sede ermeneutica – rimandasse non tanto all’assetto formale, quanto al centro tematico di una poesia inedita, letta al Forum Anterem il 16 marzo 2019 (a conclusione, presso la Biblioteca Civica di Verona, della trentaduesima edizione del “Montano”). Viene pubblicata adesso per la prima volta. L’analogia minerale, qui, si sviluppa con la vita in atto, che seguirebbe una via innata – fisiologica, potenziale – se non contemplasse vari fattori di perturbazione. Come per il quarzo, la forma intrinseca non è comunque tradibile:
Quarzo
Il fitto reticolo cristallino
che in uno spazio vuoto
allo zero assoluto
per nodi e filari senza difetto
realizzerebbe l’abito ialino
della molecolare
sequenza regolare
inscritta nel suo limpido progetto
inconoscibile
perfetto…
ma sono tutt’altro che rari,
anzi la norma,
termodinamici
meccanici accidenti,
e allora si adegua, si deforma
e conforma
in più o meno
irregolari imprevedibili
strutture improbabili,
che pure non rinnegano
l’esagonale prismatica
glaciale trasparenza,
come molto assomiglia,
nel segno dell’imperfezione,
la duttile provvisoria
pluricellulare concrezione
del nostro vivente peregrinare
nel tempo e nello spazio
al suo inflessibile reticolare
minerale destino…
1 Ro Ferrarese, Book Editore.
2 Le precedenti citazioni sono tratte da Simone Turco, Materia senziente e sentimento del tutto. La poesia di Mario Novarini, in «Gradiva», 59, 2021, pp. 150-155: 150.
3 Novarini, dunque, tocca o guarda a una tradizione postrema per cui rimando a Natascia Tonelli, Aspetti del sonetto contemporaneo, Pisa, ETS, 2000.
4 Ro Ferrarese, Book Editore.
5 Enrica Salvaneschi, nota a Mario Novarini, Radiazione del rosso, Ro Ferrarese, Book Editore, 2017.
6 Sono ancora parole di Novarini.
Mario Famularo su Mario Novarini
Un testo che ha l’aspetto esteriore del sonetto, quello di Mario Novarini, che non si traduce però in un ozioso esercizio di stile, come è possibile notare dalla scelta opportuna di preferire le assonanze alle rime in più di un’occasione, o un’accentuazione non canonica in diversi endecasillabi, che consentono un andamento meno cantilenato.
L’utilizzo dell’inarcatura, infine, realizza una dinamica dei versi caratterizzata da un andamento ondulatorio e non monocorde.
Le immagini, richiamando diversi topoi di tradizione classica, con una preferenza verso l’iperaggettivazione (“fresca rorida / bianca rosa carnosa”, ad esempio, oppone ben quattro aggettivi ad un sostantivo), sembrano ricordare l’opera di certi versi di Squarotti, dove un ritratto idealizzante femminile, partendo da dettagli minimi e preziosi, diventa possibilità di accesso alla grazia (“ore vuote hanno senso d’improvviso / in luogo del grigiore ora dissolto”), restituendo all’io del testo, che ne è testimone, lo splendore di una “felicità dolorosa”.
Francesco Bellomi, brani originali per i vincitori 2020: Federico Federici, Angela Passarello, Anna Chiara Peduzzi, Italo Testa
L’arte compositiva di Francesco Bellomi approfondisce sempre più le opere. Sempre più rappresenta un’altra prospettiva del testo…
Tiziana Gabrielli e Sofia Demetrula Rosati sulla poesia inedita “L’intero della neve” di Federico Federici
La luce dell’origine precede l’epifania dell’intero. L’intero è la neve, “un impasto d’ordine e materia” sui sette profili alpini di Narbona. La neve, nell’opera di Federici, si fa partitura di una sinfonia naturale mitica e fiabesca, contraddistinta da un respiro panico, orfico. Logico e stoico. “Il vero è l’intero”, scrive Hegel, e la neve assurge, in questo testo, ad archetipo di una verità che diviene trapassando in cui natura e spirito seguono un codice geometrico ed etico d’ispirazione spinoziana.
Il bosco è il centro di un mistero segreto e vibrante che sospende le voci, i suoni, ed interroga persino il cuore degli animali, rinserrati nelle tane ed assetati, mentre la “neve cade a caso / sul paesaggio già innevato” e copre “torsoli di mela”, “bacche e tronchi rosicchiati, / biancastre piaghe di licheni / sui rami snervati, nòccioli/ e gemme succhiati dai caprioli”.
Nei suoi giri in aria, la neve riequilibra i pesi nella “metrica del contatto” con i corpi, e “sull’ardesia fa / fiorire il ghiaccio” nel bianco che è il nome del “bosco intero e per metà”. Neve che “è luce e per metà silenzio”. Tiziana Gabrielli
È come poggiare lo sguardo su di una stampa di Utagawa Hiroshige, l’intima lettura a cui induce Federico Federici, con la sua poesia. L’intero della neve.
Un unico impasto d’ordine e materia pesa sull’indivisibile. Passo dopo passo, nell’osservazione di ciò che accade ad un bosco spinto dal centro di un seme, il creato anticipa l’intenzione del creatore. Si ode un premere della luce, della venazione che incurva l’universo e che dispone gli esili nervi della galaverna.
Tutto è movimento nell’inerzia del fine dello spazio: corpuscoli, scaglie, spore, polveri. Cervi e lupi che si rincorrono annusando. Cuori rintanati nell’attesa. E se il disegno è l’ordine dell’universo, la neve dispone una sua geometria reinventando, strato su strato, il paesaggio. Stabilendo la metrica del contatto che esalta i contorni, divide le forme, impone il bianco allo sguardo di ogni bestia. L’archetipico sguardo capace di separare la luce dal silenzio. L’intero, dalla neve. Sofia Demetrula Rosati
Federico Federici, “L’intero della neve” (7 profili innevati da Narbona)
dal centro di un seme
l'intero bosco spinge
luce, nella luce che permane
preme, nel peso dell'origine
un impasto d'ordine e materia
sulle siepi gli aghi della galaverna
nervi esili di mondo, filamenti
inerti per il fine dello spazio
e corpuscoli sterrati intorno
e, indurite sotto coltri di poltiglia,
scaglie, scorie, spore, polveri
di tralci d'edera riscossi
lascia la saliva il cervo sulla resina,
l'odore impregna la corteccia
asciutta; calpestato il fosso, scalcia
la pietra che ogni notte il lupo annusa,
batte lo zoccolo sul tronco
bagna la zampa sottile
nell'acqua non ancora dura
poi tra le balze scatta per sparire
rinserrati lentamente nelle tane,
assetati, amalgamati ai fili d'erba,
animali occhieggiano fermando il cuore
da che frasche sgorghi il sole
da che fresche fonti l'acqua
poi la neve cade a caso
sul paesaggio già innevato
altri torsoli di mela copre,
bacche e tronchi rosicchiati,
biancastre piaghe di licheni
sui rami snervati, nòccioli
e gemme succhiati dai caprioli
spazzata ai piedi degli abeti
sigilla i buchi delle tane
lo stampo ghiacciato delle impronte
che non portano lontano
a vederla diradarsi lentamente
rigirando in aria, poi sedimentare,
a fatica rifinirsi in un disegno
e nell'unirsi ai corpi
equilibrarne i pesi
nella metrica del contatto
ricopre il prato che divide
stelo e stelo, e croco e cardo
ripiega sull'argilla e sull'ardesia fa
fiorire il ghiaccio
neve, negli occhi di ogni bestia,
è il bianco in cui sta
il bosco intero e per metà
è luce e per metà silenzio
Mara Cini sulla prosa inedita “Oiseau di Hanoi” di Angela Passarello
Le note biografiche dell’autrice dicono che Angela Passarello è artista visiva e poeta e che molto ha prodotto scrivendo, dipingendo, lavorando la creta, testimoniando con il suo lavoro un impegno di viva partecipazione agli accadimenti “del mondo”, siano essi eventi quotidiani, memorie, figure naturali o brevi illuminazioni fantastiche.
E certo occorre dare uno sguardo ai suoi lavori per dire qualcosa che inquadri la brevissima prosa vincitrice del “Montano 2020”, Oiseau di Hanoi.
Non sappiamo se questa “descrizione” ripercorra un’esperienza diretta relativa alla tradizione orientale des oiseaux chanteurs, ma sappiamo che il ricco mondo immaginativo di Passarello presta costante attenzione alle tracce di tutti gli “esseri viventi”. Vediamo infatti che nel testo tutto si anima, da foglia a farfalla, da frammento geometrico a cosa con le ali, da forma bidimensionale a entità viva, messaggera di un risveglio.
Le cose hanno un nome. I nomi hanno una luce. La luce ha un respiro che dà vita ai “corpi”, in uno scambio costante tra i generi.
Con grande cautela l’autrice percorre le sagome visive che si presentano allo sguardo, esita a nominarle in modo definitivo. Conosce la sorpresa e la volatilità dell’apparenza. Infatti, cosa possiamo trattenere noi dell’accadere? Talvolta solo sembianze di piccolo oiseau.
Angela Passarello è nata ad Agrigento. Vive e lavora a Milano.
E' stata cofondatrice della rivista “Il Monte Analogo”.
Ha collaborato con la rivista “La Mosca” di Milano.
Ha pubblicato la raccolta di racconti Asina Pazza ed Greco @ Greco.1997
La raccolta di poesie La Carne dell'Angelo ed.Joker
Le prose poetiche Ananta delle voci bianche ed. I Quaderni di Correnti.2008
Piano Argento ed. del verri 2014, Bestie sulla scena ed. del verri 2018.
Suoi testi sono presenti in diverse antologie.
Angela Passarello, “Oiseau di Hanoi”
La strana figura se ne stava immobile, come di cosa inanimata, somigliante a una foglia autunnale spezzata . Avrebbe potuto essere, o, forse, lo era, farfalla diurna, in preghiera, davanti all'ingresso di Bach Ma, l'antico tempio buddista. Pareva da sempre cosa, incollata nell'aria, vicina ai numerosi sandali, lasciati davanti all'ingresso dai visitatori. Non dava cenni di respiro, di cosa viva. Nessun rumore o sussurro avrebbe potuto destarla dalla sua fissità. Presenza priva di peso, quasi inesistente. Forma bidimensionale, diventata qualcosa nello sguardo di chi l'aveva intravista ,e, poi, scansata. Appariva fragile nella sua immobilità. Effimera, innominabile, messaggera di un risveglio, o, forse, parte sottile di materia non rivelata. Vivente lo era, di vedente non possedeva sguardo; senziente si sospettava lo fosse, lo si intuiva dal suo impercettibile movimento. Sarebbe ritornata nella luce profonda del buio, e, nell'attesa, l'immobilità le avrebbe conferito una possibilità d'esistenza. Era soltanto cosa senza sguardo, visibile a chi aveva avuto sentore della morte, delle trasmigrazioni, delle comparse apparenti. Nel mutamento era diventata atto di un' inclinazione terrestre che, comprendendola nella gravità, la rendeva partecipe di un'illusione assiale. Cosa l'aveva condotta al tempio? Forse era un segno dell'eternità, racchiuso in un frammento geometrico, caduto per volere dei fluttuanti cosmici. Diventata cosa di passaggio, nell'incontro dei corpi vaganti nell' immemoria. Improvvisamente si è aperta.
Entità magnificata dal luogo. Vola lungo la proiezione di luce. Scompare. Era stata cosa con le ali. Nella visione guardata. Non vista. Effimera dello spazio. Invisibile a se stessa. Esistita nell'attimo. Luce senza nome. Impossibilitata ad essere ancora cosa . Presenza dell'invalicabile. Davanti all'altare, appare per scomparire. Riappare in sembianze di piccolo volatile. Saltella seguendo i segni, percorre le icone, gli altari, le candele tra i budda. Un' illusione la invola. Oiseau. Petit oiseau saltellante nel tempio di Bach Ma.
Riappare. Vola. Scompare. Bird. Oiseau di Hanoi.
Antonio Devicienti e Carlo Ragliani su “Figure semplici” di Anna Chiara Peduzzi
www.anteremedizioni.it/nuovi_libri_figure_semplici_di_anna_chiara_peduzzi
www.anteremedizioni.it/anna_chiara_peduzzi

Laura Caccia su “L’indifferenza naturale”, Marcos y Marcos 2018, di Italo Testa
Il canto del disamore
Cosa rende il sentire, che attraversa L’indifferenza naturale di Italo Testa, così simile e nello stesso tempo così diverso dai lavori poetici e filosofici che sul tema dell’incuranza della natura hanno attraversato i secoli, da oriente a occidente? E quale indifferenza mettono a nudo i versi? I punti di vista che la declinano appaiono complessi, molteplici. A partire da un sentire soggettivo, che del tutto percepisce l’impermanere, tra precarietà, abbandoni e distacchi. E nel delineare, al suo opposto, una visione oggettiva della natura, colta nel ritmo ignoto del suo accadere, nella «vita che anonima fermenta». Per lasciare soprattutto emergere, dal loro incrocio, un pensiero che con il reale intreccia una relazione dinamica. Nei confronti di una natura da cui si è catturati e a cui ci si abbandona e che, nello stesso tempo, si concorre a determinare, quando «lo sguardo è lenta costruzione» e «la mente rumina le cose / le afferma nella sottrazione». Lo stesso sguardo che, insieme alla luce, concorre alla visione dei colori delle cose. La stessa luce chiara o rarefatta, cupa o sospesa che colma i versi, che perturba col suo nitore, che quando «ti ferisce è anche gioia».
Una luce che divarica i contrari. Quei contrari, insiti nell’in-differenza, che i versi lasciano fluire tra costruzione e abbandono, pienezza e sottrazione, storicità e anonimia, amore e disamore, presenza e assenza. Un’assenza, di cui tutto «immobilmente splende», a chiusura della raccolta, dopo che la mente ha completato la sua opera di sottrazione. Non prima però di aver attraversato le sue antinomie e, tra queste, due elementi naturali che si fanno emblemi. La barena, terreno lagunare sovrastato periodicamente dalle maree, che richiama le immagini del sommerso: l’occulto, l’assenza di forza vitale, la putredine, la decomposizione. E l’alianto, l’albero del cielo dalla crescita invasiva nelle aree incolte, che, al contrario, muove le visioni dell’emerso: il radicamento, la forza vitale, l’agguato, la ridondanza. In una natura oscillante nei suoi riflessi e rispecchiamenti, in cui la visione e il paesaggio, il sentire e il visibile mutano reciprocamente e gli opposti perdono i loro confini. Nella sospensione indefinita, spossata e sensuale, a cui ci si affida.
Da qui ci parla Italo Testa: «da questa indifferenza / che nel torpore consuma le cose». La parola, che si abbandona ad essa, trasforma la natura, ne fa continua metamorfosi. Come lo sguardo costruisce, mentre lo avvicina, l’oggetto della sua visione, la parola dà forma, andandovi incontro, al corpo del suo dire. Con una lingua di luce e insieme di marea. Entrambe altalenanti tra attrazione e noncuranza, perturbanza e distacco. Un’oscillazione che l’endecasillabo e il distico evidenziano. Nell’altalenìo del costruire e del sottrarre, dell’emerso e del sommerso, della meraviglia e del dolore. Dove lo sguardo disegna il suo oggetto, ma ne viene a sua volta definito. E la natura trova un ruolo attivo, non solo nell’artigliare le sue prede, ma anche nel farsi argine al disamore. E nel sollecitare, rispetto ad esso, la visione e la parola. Restituendo uno sguardo e una voce all’incuranza sottesa a tutta la raccolta: l’indifferenza umana. Colta anche nell’affiorare dei paesaggi urbani, dove il «carico d’angoscia risale il cavalcavia tra i tir incolonnati» e «l’anima è un biancore imbevuto di neon e aree industriali». Paesaggi dell’umano che si riflettono nelle acque di barena o vengono avviluppati dall’alianto. Metafore, entrambi, anche delle decomposizioni e del degrado contemporaneo. E possibilità, insieme, di rispecchiamento per la poesia. Ed è così che «la vita che punge», può riconoscere alla fine l’autore, «gli occhi mi ha aperto al canto / di tutto quello che non ho amato». Ed è così che il disamore si lascia invadere dalla luce. E dall’indifferenza fa germogliare la parola.
Da: BARENA
lo sguardo è lenta costruzione
brivida e traluce dai rami,
la lamina tenera del cuore
riveste il pensiero e l’azione.
il giorno è muta esposizione
alle intemperie e alla luce,
la mente rumina le cose
le afferma nella sottrazione.
codice stradale
ma il salice piegato a difesa dei container non ha istruito il giorno il suo carico d’angoscia risale il cavalcavia tra i tir incolonnati non conosce quest’attesa a corsie alternate se l’anima è un biancore imbevuto di neon e aree industriali rattrappite nella nebbia qui è sempre linea continua qui solo gli aironi possono testimoniare ogni sorpasso qui ruotare il becco a presidio della strada qui squalificare gli astanti il guardrail sfondato.
Pastura
folaghe e acqua, medaglie nel cielo,
lo stagno si oscura se chiudo gli occhi:
imbiancate dalla lana dei pioppi
le auto ondeggiano nella luce chiara:
la vita che ignota fermenta dai fossi
in un’onda di calore svapora:
gettato come pastura ai pesci
il sonno ci avvolge e impasta la bocca:
muti boccheggiamo alla rinfusa
come anguille nel fitto di una chiusa.
la lenza
guarda la vita che anonima fermenta
il ritmo uguale dei giorni senza meta:
da qui ti parlo, da questa indifferenza
che nel torpore consuma le cose:
le senti in aria, le gemme già esplose,
come chiaro e tremendo il verde incomba?
lo sguardo sbarrato, la bocca aperta,
l’incuria mi ha preso alla sua lenza.
Da: LUCE D’AILANTO
# 1
ailanti, alle vostre falci piego il capo,
a voi, ovunque arborescenti, ailanti
nel brillio del mattino mi consegno:
vi lascio correre sui bordi incolti
dietro le massicciate, addosso ai muri:
e nel trapestio dei pensieri, infestanti
mi confondete ai fiori, miei ailanti
# 2
ovunque insinuanti lame,
falci verdi degli ailanti
improvvise tra i carrubi
ondeggianti nell’aria
risalendo le terrazze
vegetali epidemie
flessuosi, infidi ailanti,
dinanzi a voi ritrovati
alle svolte del sentiero
come germi soffocanti
riemersi dal pensiero
# 5
ailanti, ora che senza voi le gemme
incrudeliscono e agguanta gli occhi
la vostra assenza nel verde esploso
sui bordi scoscesi delle strade
dov’è la ridondanza delle lame,
lo sciame che rigurgita dai fossi,
ancora spogli quando avanza il niente
nell’aria più lucida, e più demente.
Da: LA PREDA
guarda su di un’acqua ferma lo svolio
di uno stormo di rondini
il guizzo delle piume in controluce
guarda e con la mente nuda
senza più un pensiero pensa
a questo candore lucente
in cui mi incido
a questo splendore
a cui m’affido
ma mutando d’un colpo la rotta
lo stormo assorbito nell’ombra
ormai si confonde
con la superficie opaca
sul manto ferroso del lago
la luce d’un colpo dilegua
a questo splendore muto
che m’allontana
a questo terrore
che mi richiama
***
nient’altro che la luce sul muro bianco
in alto, e un’aria come di resa e congedo:
niente a che vedere con la furia del buio
e l’incongruità di una sedia sospesa
sopra un palo infiammato al tramonto:
e tu sei lì, a poco a poco ti cancelli
dal registro delle cose animate
a favore delle nuvole turchesi
di un faro insocievole nella luce verde,
a favore di niente che t’appartenga
che testimoni che siamo stati attesi:
così aspetti, e come stanno le cose
è questione che solo il vento dirime
quando cade e lascia udire sull’acqua
il colpo d’ala d’un gabbiano in picchiata,
il guizzo di terrore di una preda
uncinata dall’artiglio della vita.
Da: L’IMPERMANENTE
chi ha scoperto il disamore
e ha guardato nella pioggia
un acero, il globo acceso
nell’arancio autunnale,
chi sa di non aver amato
fuori espone il suo dolore
sui tuberi nel vaso
tra i bossi sul balcone,
ora che il verde lo ha invaso
all’inguine sente una fitta,
la lingua come una foglia
gocciola nella sua bocca.
***
ma la luce non avrei visto
se non avessi bruciato le carte
un giorno, uscendo per strada
ho sentito di essere nudo.
ma la folgore non mi ha colpito
ho continuato a camminare in silenzio
sulla piazza, già sterminata
al primo sguardo sarei caduto.
e la vita che punge nel vento
scorticandomi vi ha vendicato
quando gli occhi mi ha aperto al canto
di tutto quello che non ho amato.
***
l’impermanente, il filo che si perde,
l’ansia, la bava che cola alla bocca,
l’inapparente, l’acqua sulle foglie,
la trafittura che più non ci tocca;
era questo, e non è più nominabile,
iridescente, il manto d’apparenza:
la ghirlanda stesa, sul cuore immobile,
immobilmente splende dell’assenza.
Italo Testa (Castell’Arquato, 1972) vive a Milano. È cresciuto nella provincia emiliana, ha passato molti anni a Venezia e fatto studi nomadi tra Francoforte, Berlino, Parigi e Marsiglia. Tra i suoi libri di poesia: Tutto accade ovunque (Aragno, 2016), i camminatori (premio Ciampi – Valigie Rosse, 2013), La divisione della gioia (Transeuropa, 2010), Luce d’ailanto (in Poesia contemporanea. Decimo quaderno italiano, Marcos y Marcos, 2010) canti ostili (LietoColle, 2007), Biometrie (Manni, 2005), Gli aspri inganni (LietoColle, 2004). Dirige la rivista «L’Ulisse», è resident DJ su «Le parole e le cose» e collabora con altri litblog. Pubblica la rivista/poster «2x2» in collaborazione con l’Otis College di Los Angeles e l’ArtCenter College of Design di Pasadena, e cura per l’Accademia di Brera la collana di multipli non_identità e il laboratorio da>verso: transizioni arte-poesia. Saggista e traduttore, insegna filosofia teoretica all’Università di Parma.
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “Quinta dimensione - Poesie scelte 1958-2018”, Mondadori 2018, di Corrado Calabrò



Varcare la porta
Con l’opera antologica Quinta dimensione Corrado Calabrò presenta poesie scelte del periodo 1958-2018. Aggregate per nuclei tematici, tra due cornici di riflessione: all’inizio la nota che accompagna il poema ‘Roaming’, alla fine il saggio ‘C’è ancora spazio, c’è ancora senso per la poesia, oggi?’. Permettendo così una visione completa della poetica dell’autore e del suo pensiero sulla stessa. Una poetica che appare da sempre tesa a varcare soglie. Attraverso i passaggi che i titoli delle sezioni, alcuni già titoli di opere precedenti, e le poesie di una vita evidenziano. Nella realtà più composita come nel sentire interiore. Nella memoria personale come nella tensione civile. Nei mascheramenti di un autoritratto come nel sogno. Negli spazi siderali come nel tempo sincronico. Facendo varcare così, alla poesia, porte che aprono mondi diversi.
La quinta dimensione declinata dall’autore suggerisce infatti diverse direzioni di senso. Dilatandosi tra l’invisibilità dello spaziotempo pentadimensionale, come le teorie astrofisiche delineano nell’incrocio dei campi gravitazionale ed elettromagnetico, e il sommerso della psiche, nell’ardere magmatico del desiderio. Una dimensione che appare di natura poetica e che consente l’accesso ad universi ulteriori, nel pensiero e nel sentire. Come evidenzia la poesia che dà titolo alla raccolta, a partire dal cosmo, dall’altrove e dal fuoco interiore per concludersi nell’inconscio, dopo aver espresso la necessità, per l’amore, di inoltrarsi «a ritroso, contro senso, / nel vuoto di memoria del futuro. // Bisogna oltrepassare, come Alice, / la lastra riflettente di cristallo / e senza aprirla varcare la porta / per cui s’accede alla quinta dimensione».
Nei suoi versi Corrado Calabrò tiene poeticamente uniti la scienza e la parola, la realtà e il desiderio. Il mare si dilata ovunque, ma più del mare il sentire interiore del mare. Così l’amore, più di quello visibile e concreto quanto di esso si infuoca nell’inconscio. Così la verità, che si occulta in una dimensione nascosta «come un sasso nell’acqua». Occorre allora varcare la porta. Accettare il rischio che il desiderio, l’amore e la ricerca del vero comportano. Tra la sfida e il mistero. Pur nell’inconcludenza della ricerca, nell’impossibilità di comprendere il cosmo, come di padroneggiare il tempo. Le citazioni, tra le tante presenti, scelte per ‘Roaming’, in esergo di Senofonte e T.S.Eliot e in chiusura di S.Weinberg, ne confermano le difficoltà e l’ampiezza. Varcare la porta, ci mostra questa poetica, spalanca mondi. Aperture critiche, per il pensiero. E la bellezza, per la parola.
Da: Autoritratto? Certo, ma è il mio?
LO STESSO RISCHIO
Razionalmente, certo, il mare è un rischio;
ma io non l’ho mai sentito come tale.
il mare va preso come viene
così, con la sua stessa inconcludenza:
portando verso il petto, a ogni bracciata,
un’onda lieve che non si trattiene.
Non c’è altro senso nel tendere al largo,
dove l’acqua è mielata dal tramonto,
se non di tenere la cadenza
fino a quando stramazzano le braccia
e spegnere nel mare il desiderio
di raggiungere a nuoto la soglia
che segna il limitare a un nuovo giorno.
Se allora ci si gira sopra il dorso,
come pescispada dissanguati,
agli occhi gonfi d’acqua e indeboliti
spalanca il cielo la sua occhiaia vuota:
ma il corpo sta sospeso in un’amaca
che lo sorregge come si è riamati
nell’età antecedente la ragione.
Passata quell’età, l’amore è un rischio,
infido quanto più ne ragioniamo.
Al mare si va incontro come viene,
in un’illimitata inconcludenza,
sentendosi lambire a ogni bracciata
da una carezza che non si trattiene.
È una scommessa tutta da giocare
fino alla sua estrema inconseguenza.
La cosa più penosa è far le mosse
sulla battigia, invece di nuotare.
(1981)
Da: Presente anteriore
QUINTA DIMENSIONE
Stelle grosse come tordi,
appollaiate sui Peloritani,
da prendere nel cavo della mano
dentro la notte, nera e trasparente
quasi quanto le notti del Sahara.
Credevo, inseguendoti, d’amarti
e ero solo un turista dell’amore.
Per tutto questo tempo t’ho cercata
- chi sa perché -
come un bambino, altrove.
Rode come la brace
la calce viva che mi porto dentro
e che, per sopravvivere, divora
le cellule nervose in cui è incarnato
il segno a fuoco della tua presenza.
S’è fatto indistinguibile il divario
tra di essa e l’immagine riflessa,
che s’allunga all’indietro nello specchio
via via che si consuma la candela.
Unica chance, se ti voglio seguire,
è inoltrarmi a ritroso, contro senso,
nel vuoto di memoria del futuro.
Bisogna oltrepassare, come Alice,
la lastra riflettente di cristallo
e senza aprirla varcare la porta
per cui s’accede alla quinta dimensione.
Forse da dentro mi aspetti a quel varco:
recessivi
sugli estremi planari dell’inconscio,
come la sorte s’aprono i tuoi occhi.
(1984)
IL SASSO NELL’ACQUA
Eh, la verità… Tu credi?
Secondo me
la verità gioca con un gatto
come una pallina
in sospensione in una boccia d’acqua.
Ci vuoi provare? Vedi questo ciottolo?
Lancialo così, a paragone.
Ecco, la verità
è come un sasso nell’acqua.
Ne puoi scorgere i cerchi in superficie
ma se lo segui con lo sguardo al fondo
non si distingue in mezzo agli altri ciottoli.
(1992)
Da: Ancora telestupefatti
FUORI ORARIO
Sono chiusi il portone sulla piazza
e quello secondario lato mare
nella cattedrale del silenzio.
Non suonano da tempo le campane
l’Ave Maria
nel villaggio globale.
Torpido e dolce il sole si dilunga
sul mare e fa le fusa
nella grande vetrata laterale.
(2009)
Corrado Calabrò è nato a Reggio Calabria, sulla riva del mare.
Il primo volume di poesie, scritto tra i diciotto e i vent’anni, venne pubblicato nel 1960 dall’editore Guanda di Parma col titolo Prima attesa.
Sono venuti poi altri ventitré volumi, tra cui: Agavi in fiore (1976), ed. SEN; Vuoto d’aria (1979 e 1980), ed. Guanda; Presente anteriore (1981) ed. V.Scheiwiller; Mittente sconosciuta (1984) ed. F.M.Ricci; Rosso d'Alicudi, pubblicato nel 1992 da Mondadori, raccolta completa (all’epoca); Lo stesso rischio (2000), ed. Crocetti; Le ancore infeconde (2001), ed. Pagine.
Nel 2002 ancora Mondadori ha pubblicato una vasta raccolta dell’ultraquarantennale produzione in un Oscar dal titolo Una vita per il suo verso. Del 2004 è la raccolta Poesie d’amore, edita da Newton&Compton. Nel 2009 sono uscire due importanti raccolte: La stella promessa, nella collezione “Lo Specchio” di Mondatori; T'amo di due amori, raccolta tematica delle poesie d’amore, Ed. Vallardi.
Recenti edizioni italiane sono: Dimmelo per SMS (2011), Ed.Vallardi; Rispondimi per SMS (2013), ed. Vallardi; Mi manca il mare (2013), Genesi Editrice; Stanotte metti gli occhiali da luna(2015), Genesi Editrice; Mare di luna (2016), Il Convivio Editore.
L’ultima pubblicazione in Italia è Quinta Dimensione, Oscar Mondadori 2018, che è la sua più completa opera poetica.
Sono più di trenta le edizioni straniere delle sue opere in venti lingue, oltre le traduzioni di poesie singole. Delle sue poesie sono in circolazione vari CD con le voci di Achille Millo, Riccardo Cucciolla, Giancarlo Giannini, Walter Maestosi, Paola Pitagora, Alberto Rossatti, Daniela Barra. Numerose sono le trasposizioni teatrali e musicali dei suoi versi, di cui una in musica sinfonica, con recital in una trentina di città, anche all’estero.
Ha pubblicato anche alcuni saggi critici, tra cui: Per la sopravvivenza della poesia uccidiamo i poeti, “Poesia” Crocetti, n.143, ottobre 2000; Il poeta alla griglia, “L’illuminista”, dicembre 2003; Rappresentazione e realtà, Nuovi Argomenti, aprile/giugno 2011. Ed è autore di un romanzo, Ricorda di dimenticarla (Newton & Compton, 1999), finalista al premio Strega del 1999, tradotto in rumeno e in spagnolo.
Numerosi i premi letterari e i riconoscimenti ricevuti per la sua attività letteraria, tra cui le lauree honoris causa da parte dell'università Mechnikov di Odessa, nel 1997, dell'università Vest Din di Timişoara nel 2000 e del l'università statale di Mariupol nel 2015. Nel 2016 l'università Lusófona di Lisbona gli ha attribuito il Riconoscimento Damião de Góis. Nel luglio 2018 l’Unione Astronomica Internazionale, su proposta dell’Accademia delle Scienze di Kiev, ha dato all’ultimo asteroide scoperto il nome Corrado Calabrò per avere rigenerato la poesia aprendola, come in sogno, alla scienza.
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “E non si sa a chi chiedere”, Marcos y Marcos 2020, di Anna Maria Carpi


In cosa credere
C’è qualcosa che resiste nelle interrogazioni di Anna Maria Carpi nell’opera E non si sa a chi chiedere. Così come nelle invocazioni che alzano l’intensità di una scrittura meditativa, pervasa dal senso di impermanenza di tutte le cose e dall’inconsistenza dei riscontri umani. Attraversata dal disagio di fronte alle alienazioni del contemporaneo e alla generale mancanza di umanità. Fino alla difficoltà del chiedere ascolto: «Ma oggi chi sopporta questa piena / da uno solo, da un singolo? / Dov’è più il diritto di dire ascoltami?». Insieme all’amaro riscontro, sia individuale che sociale, per quanto riguarda l’assenza di interlocutori: «Dicono che si scrive per guarire. / Da che dolore? Non c’è più dolore, / solo incertezze / e non si sa a chi chiedere».
Allora a chi si rivolge, nonostante tutto, la poesia? E «perché ci esalta / perché ci dà speranza / questo modo d’esprimerci traslato»? Nell’assenza di fiducia e nella mancanza di ascolto, gli interlocutori privilegiati restano i poeti amati. E, nonostante le disillusioni, rimane ad interloquire proprio la parola poetica con il suo sguardo rivolto agli altri. In questi versi umanissimi, dalla riflessione profonda sul senso della vita, anche quando prevale lo sconforto resiste un’autentica vicinanza. Nell’attenzione ai vinti, ai rifugiati, ai dispersi, condividendone lo stato di erranza e il dolente percepirsi: «we lost in All, noi perduti nel tutto».
E resiste «l’ossessione di scrivere. / Poesia? No, in cima c’è il romanzo: / quella prosa slabbrata ci descrive», scrive l’autrice, riponendo fiducia sulla possibilità della parola di delineare il sentire degli umani. Attraverso una prosa che, lacerata, riesca a tracciarne gli slabbramenti, rispecchiandoli nel proprio sguardo. Mentre la poesia pare necessitare di un confronto diretto con l’alterità, l’Altro-l’altro-gli altri. Con interlocutori imprescindibili, fossero anche lontani, assenti, non contemporanei. Se non ha interlocutori, la poesia come fa, come può? Da qui l’interrogazione: «poesia, sorella pazza / della prosa, / ancora, ancora, che ci stai a fare?». Tutt’altro che un abbandono del campo poetico, però, quello di Anna Maria Carpi. Che, nonostante i dubbi e i disincanti, riesce a trattenere l’incanto della parola. E, insieme, l’umanità del suo sentire. E una scrittura etica che non conosce resa.
Da: GIÀ RISIBILI I NOMI
1
PRIMAVERA NON SAI chi l’ha chiamata
sulla via fuori
dell’ufficio postale. Tra i semafori
esplodono i ciliegi giapponesi
come sessi di bimbe, rosa vivo.
Dai rari lembi d’erba cittadina
guardano in su delle faccine intente
di margherite e bocche di leone
e spilli azzurri – nontiscordardime,
e sulla piazza Sud
davanti alla stazione
è il trionfo dei grappoli maturi
erti potenti degli ippocastani,
una festa regale, pochi i rossi,
i bianchi abbondano, è il bianco delle nozze,
vergini restano solamente i glicini
all’imbocco del parco, nella via parallela,
e tre strade più in là:
esita il lilla pallido, ha paura
di affacciarsi
nell’assoluto di quel verde verde.
Non ti fermi a guardare?
Sì ma per qualche istante,
è così bello
che diventa un tormento.
La natura!
Lo so che io non c’entro.
Io non sono natura.
Da: L’ISOLA
11
IL MARE
qui sotto casa: ascolta,
ha come mani e dita,
sembra scartino e incartino – che cosa?
un messaggio, un regalo?
Di tanto in tanto un tonfo ed un singulto
e sullo scoglio l’onda
schiuma e si spande, poi ritorna indietro.
Che ci voleva dire?
Che è per lei la sponda?
Il senso è al largo, e intanto cala il buio,
e verso terra in fretta con un ultimo
volo prima di notte
anche i gabbiani cercano un rifugio.
Da: I RIFUGIATI
16
SULLA CITTÀ le stelle non ci sono,
qualche puntino in alto, sopra i tetti,
se stacchi gli occhi è subito scomparso,
ma oggi c’è vento, un annuncio di marzo,
e questa sera splendono dovunque,
guarda lassù, c’è Giove, per esempio.
È lo ‘stellato’ che non sa di noi.
“Bello” diciamo, e questa
è la più strana
delle parole umane che ci sia,
nessun altro vivente sa del bello.
Ma non è bello: è vero,
vero e deserto,
we lost in All, noi perduti nel tutto.
E i dispersi
sulle spiagge del mondo
quando viene la notte si domandano:
non era meglio
quando vi scorgevamo la dimora di Dio?
Da: NULLA È COME CREDEVO
44
POESIA: tu lo sai perché si scrive?
È la mano che interrompe la riga,
per impulso ancestrale e va daccapo?
Anche la mano avverte
che il tempo stringe e che non è più il caso
di farla lunga?
Dicono che si scrive per guarire.
Da che dolore? Non c’è più dolore,
solo incertezze
e non si sa a chi chiedere.
47
SUONA SEMPRE PIÙ STRANA la parola
letteratura, in inglese tre sillabe,
gli urli delle platee vanno alla musica
ma non muoiono i nomi –
i casti nomi saggio poesia romanzo
e mai fra noi fu tale
l’ossessione di scrivere.
Poesia? No, in cima c’è il romanzo:
quella prosa slabbrata ci descrive.
Anna Maria Carpi, di famiglia tosco-emiliano-irlandese, vive a Milano. Ha insegnato letteratura tedesca all'Università di Macerata Marche e a Ca'Foscari a Venezia.
E' autrice di saggi, racconti e romanzi (fra cui Vita di Kleist, Mondadori 2005, Rowohlt 2011, e Uomini ultimo atto, 2016) e traduttrice della lirica tedesca (tra cui Nietzsche, Rilke, Benn, Bernhard, Gruenbein), premio Ministero dei beni culturali (2011) e Città di S.Elpidio (2015), premio Carducci (2015).
Nella poesia esordisce con A morte Talleyrand (1993, premio Pisa 1993), cui seguono Compagni corpi(2004, 22005), E tu fra i due chi sei (2007), L'asso nella neve (2011, 2 edizioni), Quando avrò tempo (2013) e L'animato porto (2016). Da Hanser (Monaco 2015) è uscita l'antologia con testo a fronte Entweder bist du unsterblich e da Marcosymarcos, Milano 2016, il complessivo E io che ancora parlo.Sue poesie sono apparse su "Oktjabr' (Mosca,1998), "Akzente"(Monaco 2001 e 2011), e di recente su "Ulisse", "Nuovi argomenti", "Le parole e le cose".
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “Poesie scelte - Selected Poems 1990-2020”, di Marco Fazzini



Nel respiro del dire
In edizione bilingue, la selezione del trentennale percorso poetico di Marco Fazzini, Poesie scelte - Selected Poems 1990-2020, è un’opera ricca di rimandi e di dediche a poeti di lingue diverse. Richiami che, insieme alla traduzione, danno ai testi una connotazione di ampio respiro. Un respiro che già appartiene ai versi, dilatati tra il percepibile e il meditativo, il visibile e l’oltre. Nel movimento che, tra inspirazione ed espirazione, attira il campo vicino e, per contrasto, amplia il campo cosmico. Insieme ad un costante e progressivo allontanarsi da sé. Tanto da condurre alla domanda: «Ma chi è che parla adesso?»
Il connubio immagine-oltre, visibile-invisibile è già individuabile nei titoli interni alla prima sezione: sabbia, barche, ombre, muse. E nel contatto, lungo i versi, tra le percezioni sensoriali e lo sguardo riflessivo del pensiero. Ampliandosi nella seconda sezione, che cavalca la tempesta, dove prevalgono le tensioni emotive, la tristezza, il rimpianto, il disincanto: ed è così che le stelle «illuminano / per pochi istanti / l’oscurità del mondo / Suona sempre la notte / come un guscio vuoto». Per dilatarsi infine nella terza sezione, che musica il canto dell’isola, quando la riflessione si espande fino al respiro del cosmo e al rifranto e contrapposto pensiero del nulla. Tra «sistole e diastole / d’una sfera perfetta / che inala ed esala / l’eterno girovagare / di mille galassie» e il molo «dove si confondono / partenze e ritorni, / e dove tutto torna / in discussione, e nulla esiste».
Appare respirare e risuonare di canto, visivo e sonoro, tutta la parola di Marco Fazzini: «Così volevo la poesia: / materia bianca, accarezzata. / Piuma, petalo o carta / al limitare di un’alba». Nello stesso tempo, però, consentendo che la tensione lirica lasci spazio alla sua sospensione. Quando il pensiero crea quel senso di immersione, quasi una lieve apnea, per trattenere la leggerezza verbale nella profondità meditativa e spalancarne poi il respiro alla luce. Sottraendosi in modo fermo all’abbandono puramente lirico, facendolo sgorgare infine inaspettato. E riuscendo così a portare la poesia, senza soluzione di continuità, dall’affondo del pensiero razionale al suo riemergere, fino a guardare il cielo: «Il corpo d’un poema / bilancia a malapena / il carico di vita / all’altro piatto. // Solo l’inganno / dei pesi / pareggia il conto / con le stelle».
Da: 1. 24 POESIE / 24 POEMS
I
SABBIA
Deserto del Namib
Non rimane che l’attesa
a ora tarda di barcane
a mezzaluna sopra i rostri
d’un deserto inaspettato.
Di null’altro che il ricordo
è la vita un acumine di polveri.
III
OMBRE
È sullo specchio
(per Seamus Heaney)
È sullo specchio speleologico
d’un pozzo che m’affaccio, cercando
un segno del passato
che nel presente porti
luce e strada a futuri eventi.
Dal tuffo dentro il tempo strombato
in questa storia d’acque emerge
dunque il reperto favoloso,
onda, amore e sonda d’oltre i sogni,
un’era ormai a riposo.
Da qui lontano un bosco,
un volto, una cornice
amplificano l’oscuro enigma
sepolto dentro la pupilla della sera.
IV
MUSE
Così volevo
Così volevo la poesia:
materia bianca, accarezzata.
Piuma, petalo o carta
al limitare di un’alba.
In silenzio l’occhio nudo
qui vi splende, si pettina di luce,
perché il desiderio
s’infatui d’orizzonti.
Bilancia
Il corpo d’un poema bilancia a malapena il carico di vita all’altro piatto. Solo l’inganno dei pesi pareggia il conto con le stelle. Da: 2. A CAVALLO DELLA TEMPESTA / RIDING THE STORM Suona la notte Suona la notte come un guscio vuoto, come l’immensa conchiglia del mare che a noi di fronte ruggisce forte contro quella spiaggia abbandonata. I cani sono tutti calmi ormai, dormono forse nei cortili scuri. È la notte di San Lorenzo, e di certo le stelle non li svegliano. Come anime in rapido passaggio illuminano per pochi istanti l’oscurità del mondo. Suona sempre la notte Da: 3. CANTO DELL’ISOLA / ISLAND CANTO 6 Tutto questo, forse, non ha una vera consistenza, l’oscuro, come i fumi della mia esistenza – questo m’affanno a drenare, questi grumi di vita dissipati lungo i lustri vivi come lampi d’un faro dentro una memoria dormiente, una memoria da cui non mi separo, in nulla, io scrivente, altro da quella non essendo, da quella e dai suoi mostri. Marco Fazzini è nato nel 1962 ad Ascoli Piceno. Ha pubblicato diversi libri e articoli sulle letterature postcoloniali di lingua inglese, e ha tradotto alcuni tra i maggiori poeti contemporanei di lingua inglese, tra cui: Douglas Livingstone, Norman MacCaig, Philip Larkin, Hugh MacDiarmid, Douglas Dunn, Geoffrey Hill, Charles Tomlinson, Edwin Morgan. La sua storia della letteratura scozzese, Alba Literaria, è uscita nel 2005. Nel 2012 ha pubblicato un lavoro sulla canzone e la poesia per la libertà: Canto un mondo libero. Le sue maggiori interviste con poeti contemporanei di lingua inglese sono riunite nei volumi: Conversations with Scottish Poets (2015) e The Saying of It (2017). Le sue maggiori sillogi di poesia sono: Nel vortice (1999); XX poesie (2007); Driftings and Wrecks (2010); 24 Selected Poems (2014); Riding the Storm: Ten New Poems (2016); Canto dell’isola (2020). Insegna Inglese e letterature postcoloniali presso l’Università di Ca’ Foscari (Venezia), ed è l’ideatore e il direttore artistico del festival di poesia “Poetry Vicenza”. Risiede a Vicenza.
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “Andare per salti”, Arcipelago Itaca 2017, di Annamaria Ferramosca




Andare per voce, parola, poesia
Una trilogia, Andare per salti, dell’esistere. In cui Annamaria Ferramosca dispiega, nelle tre sezioni, un muoversi per salti, tumulti, spazi inaccessibili. Quasi in analogia ai moti della fisicità, del sentire e del pensare. Dallo spazio quotidiano allo spazio cosmico, dal visibile al metafisico. Tre modi per percorrere consapevolmente la vita. Per salti: nei balzi repentini tra i contrasti del quotidiano, «dalla giunglamercato» alle pagine «insperate di bellezza». Per tumulti: nel moto emotivo rapinoso, preso dal vortice di una «danzaturbine», come «osmosi in terra / inarrestabile destinoamore». Per spazi inaccessibili: nello slancio del pensiero in tensione verso l’oltre, tra «un foglio bianco di vertigine» e una «inattesa voragine luce divorata».
Una trilogia, anche, della visione. Di sé, della natura, del cosmo. Muovendo lo sguardo verso l’inatteso. Per schiudersi a dimensioni inconsuete, aprirsi a singolari rinascite. Quando l’agire contemporaneo porta in tutt’altre direzioni, come quello dell’attuale «homo insipiens / con l’ultimo ideogramma coltello-sulla-gola». E quando tutti noi «semiviviamo sotto cieli sbarrati». Così la visione personale si intreccia a quella sociale, la dimensione quotidiana a quella cosmica. E il pensiero, teso a risorgere, danza tra mito e scienza. Allora il movimento propulsivo e danzante richiede che non si interrompa il flusso con segni di interpunzione. E che la necessità di rinascere si esprima nella creazione di inedite forme del linguaggio. Nel fare fiorire nuovi sintagmi, per abbraccio di termini. E nel rovesciare i modi scontati della comunicazione ordinaria. Da «bla bla bla» in «alba alba alba».
Una trilogia perciò, anche e soprattutto, del dire. Creando subbuglio, «la poesia / può rinascere». In questo mostrando Annamaria Ferramosca una grande fiducia nelle parole poetiche che «non vanno per salti loro ma / per larghissimi voli». Si potrebbe allora azzardare che a muoversi per salti sia la voce umana, per «come s’affanna soccorre risponde chiama». A sussultare per tumulti, invece, l’insieme di «parole paradossali», inquiete e danzanti. E a prendere il volo per spazi inaccessibili, infine, la poesia, che osa andare verso l’oltre sconfinato così come nel misterioso «chiamarsi tra loro - pianissimo - delle cose».
https://www.youtube.com/watch?v=pmH8ZzY_7aQ La voce di Annamaria
Da: I SEZIONE – per salti
ora che mostro viso e braccia aperte
s’accendono i corpi le voci
più libero il pianto più intense le carezze
apro armadi nel petto e
vado per salti
dimentico zaino zavorra
virgole punti de-finizioni
tanto so che l’altrove
mi tiene d’occhio e
dorme la mia bambina delle meraviglie
ancora irrubata dal mondo
intatta nel suo pianeta
cosa devo farci io con questo spudorato pianeta
cosa devo farci con il terribile che infuria
con le solite frasi il solito sgomento
con quella spes ultima illusione
cosa devo farci pure con la poesia
tanto so che la nave
sta trascinando al largo
nel muto acquario dove ci ritroviamo
come all’origine nudi
finalmente originali miseramente
splendidi nel nulla
Da: II SEZIONE – per tumulti
sembra che cadano dall’alto le parole
della poesia - mi dici -
come da un tremito di stelle
sembra un bruciare di schegge fossili
lampi d’altra memoria che migra
hanno esili braccia come leve di luce
a sollevare la grave pietra umana
non vanno per salti loro ma
per larghissimi voli
sulla nostra laguna sconsolata
a intercettare il centro innocente
la forma fetale del cuore
è vero è un pulviscolo di parole
che invade l’universo lo informa lo plasma
se ti metti in ascolto puoi avvertire
le onde d’urto come nel bosco
il colpo secco dalla corteccia
il tuffo della rana di Basho
un chiamarsi tra loro - pianissimo - delle cose
e quella nostra stramba contentezza
nell’ascoltare
bla bla blaè urgente
capovolgere i suoni
alba alba alba capite?
se si sovvertono se le stanze
si mettono in subbuglio
dietro la porta può affacciarsi
la sempre sfuggente la poesia
può rinascere
incurante del rumore intorno del brusio
crescere con la sua fame adolescenziale
di cose vere sia pure materia rarefatta
di parole vive dai corpi
lungo tutti i meridiani pure
da territori dubbi come atlantide
o aldebaran o l’isola di ogigia
insomma – accidenti- da spazi
inaccessibili
provare solo deliri di sfioramento
farsene una ragione
Da: III SEZIONE – per spazi inaccessibili
nella luce che declina
fatemi luce non vedo più il percorso
brancolo sul mio profilo non mi riconosco
non ti riconosco
respiro cenere piove dal cielo
dove l’umano è in fumo
piove dal suo fumo
cenere di boschi e d’anime
piove tenace l’errore
arrivi a me dal mare
senza giustizia né perdono
confinato nel campo dove
tuo figlio non riesce a giocare
ha negli occhi domande raggrumate
padre perché questa rete
padre voglio tornare non m’importa morire
per fame o guerra o per indifferenza
homo insipiens
con l’ultimo ideogramma coltello-sulla-gola
t’immoli perfino
per un cielo del nulla
dilegua con te il nostro cammino millenario
si spalanca l’abisso
nella luce che declina
Annamaria Ferramosca, salentina di origine, vive a Roma, dove, in contemporanea con la scrittura poetica, ha lavorato come biologa nella ricerca e nell’insegnamento. Ha contemporaneamente ricoperto per alcuni anni l’incarico di Cultrice di Letteratura Italiana presso l’Università Roma3. Fa parte della redazione del portale poesia2punto0.com, dove dal 2010 cura la rubrica Poesia Condivisa, di cui è ideatrice.
É voce inclusa nell’Archivio delle Voci dei Poeti, Multimedia, Firenze.
É Voice Ambassador per Italia e Puglia della PoetrySound Library, mappa virtuale mondiale delle voci poetiche.
Ha curato la versione poetica italiana di testi del poeta romeno Gheorghe Vidican nel libro 3D – Gheorghe Vidican - Poesie 2003-2013, CFR, 2015, ricevendo il Diploma di Eccellenza dal Ministero della Cultura di Romania.
Ha pubblicato in poesia:
Andare per salti, Edizioni Arcipelago Itaca, Osimo-Ancona 2017, Premio Arcipelago Itaca 2016, introduzione di Caterina Davinio (nella rosa del Premio Elio Pagliarani, finalista ai Premi: Guido Gozzano, Premio Internazionale Europa in Versi, Premio Civetta di Minerva)
Trittici-Il segno e la parola, Edizioni DotcomPress, Milano 2016
Ciclica, La Vita Felice, Milano 2014, collana Le voci Italiane, introduzione di Manuel Cohen (finalista al Premio Alessandro Tassoni, e al Premio InediTo Colline di Torino)
Other Signs, Other Circles –Selected Poems 1990-2009, Chelsea Editions, New York 2009, collana Poeti Italiani Contemporanei Tradotti, introduzione e traduzione di Anamaría Crowe Serrano e Riccardo Duranti, (Premio Città di Cattolica; secondo al Premio Città di Sassari)
Curve di livello, Marsilio, Venezia 2006, collana Elleffe, a cura di Cesare Ruffato ( Premio Astrolabio, Castrovillari-Pollino, nella rosa del Camaiore, finalista ai Premi: Lerici Pea, Pascoli e Lorenzo Montano)
Paso Doble, Empiria, Spinea-Venezia 2006, raccolta di dual poems in italiano/inglese, coautrice Anamaría Crowe Serrano, traduzione di Riccardo Duranti
La Poesia Anima Mundi, con la silloge Canti della prossimità, serie Quaderni Poiein, monografia a cura di Gianmario Lucini, puntoacapo, Novi Ligure 2011
Porte/Doors, bilingue, Edizioni del Leone 2002, prefazione di Paolo Ruffilli, traduzione di A. C. Serrano e Riccardo Duranti (Premio Internazionale Fiurlini-Den Haag )
Il versante vero, Fermenti, Roma1999, introduzione di Plinio Perilli (Premio Opera Prima Aldo Contini Bonacossi).
Ha al suo attivo collaborazioni e contributi creativi e critici su riviste italiane (Poesia, La Clessidra, Argo, Punto, La Mosca di Milano, Le voci della Luna) e straniere (Gradiva, Italian Poetry Revue, Fire, Salzburg Revue, Poezia-Romania, Poiein-Grecia) e su siti e lit-blog (La dimora el tempo sospeso, Atelier, ArcipelagoItaca, L’EstroVerso, Blancdetanuque, Perigeion, Carteggi Letterari, Il Versante Ripido, portale di poesia poesia2punto0.com (con il Quaderno di Poesia n.67 ), Poetry-wave-Senecio, LaRecherche, Carte allineate, Fili d’aquilone, Carte sensibili, CarteAllineate, Viadellebelledonne, La Poesia e lo Spirito).
È presente nel portale di poesia Italian Poetry.org
Suoi testi sono inclusi nei volumi collettanei: Quando Il Poeta è Donna, Blu di Prussia Ed.ce,.2002; Pugliamondo, 2010 e La Versione di Giuseppe, entrambi per Ed.ni Accademia Terra d’Otranto-Neobar, 2011; POETI E POETICHE(1), con note critiche di Gianmario Lucini, Edizioni CFR, 2012; Cuore di preda, CFR, 2012; Cronache da Rapa Nui, CFR, 2013; Perché i poeti, L’Erudita, 2003; Un sandalo per Rut, Ed.ni Accademia Terra d’Otranto, 2014; Keffieh, CFR, 2014; Fil Rouge, CFR, 2015; Pane e Poesia, La Vita Felice, 2015; IL CORPO, L’EROS, Ladolfi Editore, 2018; Lido, Poezie italiana contemporana, Ed.Eikon, Bucarest, 2018.
È presente nelle antologie: L’altro Novecento; Appunti critici; Poeti italiani verso il nuovo millennio; Inverse; Tradizione e ricerca nella Poesia Contemporanea; Blanc de ta nuque – Uno sguardo dalla rete sulla Poesia Italiana Contemporanea I^ vol.(2006-2011) e II vol.(2011-2016); Evoluzione delle forme poetiche. La migliore produzione poetica dell’ultimo ventennio (1999-2012); IL FIORE DELLA POESIA ITALIANA, TOMO II- I CONTEMPORANEI,II ED.NE AGGIORNATA, puntoacapo, 2016; Annotando, a cura di Marco Ercolani, Biblioteca di Rebstein, 2017.
Per la poesia inedita ha ricevuto il Premio Guido Gozzano e il Renato Giorgi e nel 2017 il Premio Internazionale Naji Naamann Literary Prize, divenendo membro onorario della Maison Naamann pour la Culture in Libano. Suoi testi sono stati tradotti oltre che in inglese, in romeno, greco, francese, tedesco, spagnolo, arabo.
Hanno scritto sulla sua poesia: Sebastiano Aglieco, Franca Alaimo, Marzia Alunni, Giovanna Amato, Donatella Bisutti, Luca Benassi, Augusto Benemeglio, Roberto Bertoni, Cristina Bove, M. Grazia Calandrone, Grazia Calanna, Luigi Cannillo, Marcello Carlino, M. Teresa Ciammaruconi, Floriana Coppola, Manuel Cohen, Anamaria Crowe Serrano, Anna Maria Curci, Caterina Davinio, Mariella De Santis, Antonio Devicienti, M.Grazia Di Biagio, Donato Di Poce, Donato Di Stasi, Antonella Doria, Marco Ercolani, Narda Fattori, Ivan Fedeli, Fernanda Ferraresso, Mauro Ferrari, Francesco Filia, Silvana Folliero, Marco Furia, Giorgio Galli, Elio Grasso, Sandro Gros-Pietro, Stefano Guglielmin, Letizia Lanza, Maria Grazia Lenisa, Maria Lenti, Elisabetta Liguori, Giorgio Linguaglossa, Gianmario Lucini, Eugenio Lucrezi, Eliza Macadan, Dante Maffia, Loredana Magazzeni, Luigi Manzi, Sandro Montalto, Ivano Mugnaini, Gabriella Musetti,, Rita Pacilio, Alessandra Paganardi, Helene Paraskevà, Gregory Pell, Plinio Perilli, Gilda Policastro, Daniela Raimondi, Alfredo Rienzi, Merys Rizzo, Anna Maria Robustelli, Paolo Ruffilli, Marisa Papa Ruggiero, Rosa Salvia, Daniele Santoro, Fabio Simonelli,, Donato Valli, Juliet Wilson.
Ulteriori notizie, testi e materiale critico sono nel sito personale www.annamariaferramosca.it
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “Eccomi - Il sacrificio di Isacco”, Oèdipus 2019, di Oronzo Liuzzi



Una nuova nascita
In Eccomi - Il sacrificio di Isacco la poesia si fa audace. Nell’affrontare il testo biblico, Oronzo Liuzzi si misura con il sacro. Attraverso la rivisitazione della prova di Abramo, riscritta dal punto di vista di Isacco. Mettendone in evidenza il percorso dalle tenebre alla rinascita, dalla morte alla vita, dal dolore alla meraviglia. In un confronto tra le oscurità di Abramo, «l’uomo dalle molte tenebre e poca luce», «che smuove il fango dai fondali per trovare la fede» e la limpidezza di Isacco, la cui anima «fragile a volte giocosa sorrideva / indossava la luce del mondo» e, in questo modo, «in cerca dell’eternità originava il futuro». Quasi in Isacco si ritrovassero tutti i figli della terra a subire la perdita di idealità dei padri e a tentare responsabilmente di conquistare il proprio avvenire.
I passaggi, già profondamente analizzati a livello filosofico da S.Kierkegaard in Timore e tremore, sono molteplici: l’estraneità, il mistero, il sacrificio, la morte, la verità, la necessità, la libertà, la rinascita. Isacco non si sottrae alle prove che impongono. In un cammino, concreto e interiore, in cui sono rovesciati i rapporti tra la vita e la morte, il bene e il male. Tutta la raccolta è pervasa, attraverso la voce di Isacco, dalla sete di verità: «era il vivere che si muoveva incontro al mondo in cerca della verità / rincorreva l’indescrivibile il volto dell’ignoto la tensione». E per farlo, attraversa, con il suo protagonista, tutti i territori dell’estraneità e del mistero. Degli incubi e dei sogni. Della sofferenza e della speranza. Quasi a rendere possibile che la vita, pur nelle costrizioni imposte dal tempo e dal destino, possa commuoversi per la condizione umana e sostenere il valico della «soglia tenebrosa della morte per un mondo nuovo / come un amico fedele per mano ci conduce nella rinascita».
Anche la parola, pare dirci Oronzo Liuzzi, deve necessariamente passare da questa prova, da questo sacrificio, da questo stretto contatto con il mistero. Trascendere la convenzione del bene e del male, del «sapere non sapere». Varcare l’ignoto, il dubbio, la fragilità umana. Con un percorso simile a quello di Isacco: abbracciare il visibile e l’invisibile, andare oltre i limiti della conoscenza, percorrere territori estranei, rigenerarsi di bellezza, accogliere la meraviglia, affrontare il terrore e la sofferenza, farsi attraversare dalle tenebre e dalla luce. Verso una possibile rinascita. Con la tensione dell’attesa e, insieme, con una forte e «insaziabile sete di verità».
Da: Il risveglio
alzati figlio mio
era la voce ingarbugliata e suadente di mio padre Abramo
il timorato di Dio il vagabondo l’uomo dalle molte tenebre e poca luce
l’uomo che ha creduto in Dio e si è fidato del suo Dio l’uomo
che ha stretto con Dio l’alleanza della circoncisione
l’uomo che smuove il fango dai fondali per trovare la fede
la perla delle promesse spirituali
contemplava il mio il corpo nella veglia del sonno mio padre
il mio corpo mite sensibile innocente vivo
che ama gli animali e la luce della vita
festoso quel corpo contempla i villaggi dignitosi dei pastori
sogna con gli occhi di un bambino la meraviglia
accoglie con cuore aperto il cielo la luna la terra i segni del Signore
alzati figlio mio
***
l’aria fredda la faccia in silenzio lento il battito del cuore il dormire un sonno pesante riempito da sogni sanguinari dagli odori familiari dopo una notte selciata dall’incertezza sofferta e occultata da un evento segreto sogni ingombranti attraversavo una piccola porta entravo e uscivo dalla porta dei vivi dalla porta dei morti il nulla il vuoto l’amore trionfava il vivere la paura forze del bene e del male condizionavano la mia libertà di vivere percepivo nel sonno la mitezza della meraviglia
Da: Il viaggio
la nostra vita dominata dal tempo avvolta dalle forze cieche del destino
ascolta le ferite della umana condizione
ci domina
ci custodisce
svela all’uomo i segreti e gli incastri dell’amore
il creato
inesorabilmente cadiamo nel vuoto con il cuore arrugginito
inesorabilmente ricominciamo la salita con grazia
si lascia commuovere la vita
partecipa alle sofferenze
condivide abbandoni perduti dolori abbracci sorrisi gioie
le lacrime
valica la soglia tenebrosa della morte per un mondo nuovo
come un amico fedele per mano ci conduce nella rinascita
***
illuminato dai raggi del sole il padre mio era intento a spaccare legna per
l’olocausto
osservavo con meraviglia quell’anziano uomo dallo sguardo turbato
una voce interiore forse lo tormentava
non lo capivo
ombre dolore fragilità angoscia dimoravano in colui che mi aveva dato la vita
emergevano movimenti nervosi stanchi confusi imprigionati
il suo corpo teneva insieme tante forze che lo dividevano
timore
tremore
partoriva la sua anima
Da: Il sacrificio
la meta ci aspettava paziente
portavamo nel grembo dell’anima la forza dell’amore
solo il peso della legna dell’olocausto affaticava il mio corpo inerte
questa è la terra dell’alleanza pensavo
il nostro desiderio di infinito
tutto era inondato di fede
una forza superiore ci abbracciava
eravamo entrati nello spazio e nel tempo del sogno
nel mistero del vivere la vita
strisce di cielo azzurro incantavano i miei occhi
marciavo a fianco del padre mio ormai stanco
sangue innamorato mi scorreva silenzioso nelle vene
nutriva la purezza dell’amore per farmi rinascere nuovo
***
di sapere non sapere
il pensiero agonizzava il sono io il non sono io
il tormento
la paura
il fitto respiro che mi mordeva
l’aria velenosa che bolliva nello stomaco
ero un deposito di dolori
quelle terribili parole affogavano nella mia testa
vieni figlio mio
Isacco
sei tu l’agnello da immolare
conficcavo le unghie nella carne
ero ancora vivo
***
un ardente fuoco d’amore vibrava nel profondo del cuore
trafitto di luce divina
commosso
mi lasciavo filtrare da quel potere fuoco d’amore
mi ricuciva la pena il dolore la sofferenza l’umana fragilità
l’indomabile tormento del mio corpo pietrificato
sedotto dall’altissima gloria e dall’onore di ogni benedizione di Dio
abbracciavo in pace l’intenso amore per la vita
sottratto all’arida cenere della morte
trasformato e rigenerato
mi restituivo al tempo dell’attesa con dolcezza
con delicatezza al mondo intero
con una insaziabile sete di verità
Oronzo Liuzzi (1949), laureato in Filosofia Estetica, vive e lavora a Corato (Ba). Artista poliedrico, utilizza tecniche espressive diverse. Ha pubblicato una ventina di libri tra poesia e narrativa.
Tra gli ultimi volumi editi ricordiamo Plexi(Campanotto 1997), Via dei barbari (L’Arca Felice 2009), In odissea visione (Puntoacapo 2012).
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “nuove Letanie salentine e un Poema Manifesto”, LabOratorio Poietico '19, di Carmine Lubrano
L’ortica barocca
In un flusso magmatico che pare esondare dalla pagina, proprio di un’oralità senza fine, Carmine Lubrano dissemina le sue nuove Letanie salentine e un Poema Manifesto. Un flusso che accoglie tutto e che va contro tutto, assetato di vita e di esperienze e insieme antagonista e trasgressivo. Nella forma della litania, non nel significato religioso di invocazione liturgica, piuttosto in quello linguistico della parlata per antifrasi e contro-espressioni, dal tono percussivo e irriverente. In una partitura labirintica e pulsante, erotica e alchemica, sonora e vitale. Con passaggi continui dalla caoticità della materia e dall’eccitazione dei sensi alla riflessione sulla lingua e sulla poesia.
Dalla musica di strada, nel ritmo frenetico della pizzica o della taranta, al canto denso e rude «dove ogni parola prima dell’amore / è nuvole è ustioni». Dalla lingua popolare alle citazioni colte dei poeti dell’avanguardia e della poetessa salentina Claudia Ruggeri. Dalla percussività ossessiva del mondo, «Averno pro fondo» colmo di contraddizioni e di disperazioni, alla «melodia che s’esilia e si noda». Da «una rima accidiosa che osa tra sangue ed / orine il rosso heros politico subsulto il jazz lapillum di / un volcano mai spento» alla ricerca di «acqua dolce / per arginare la sete la posia sorgiva / la poesia sotterranea che percorre sentieri profondi».
Nell’amalgama di parlata popolare salentina e ricerca linguistica, di dialetto e neologismi, con frequenti allitterazioni, il verso ha il tocco che infiamma e la musicalità che trascina. E se l’autore ritiene che, considerato il contesto culturale odierno, sia il momento di dire «basta con la poesia», nel contempo evidenzia come, per contro e per necessità, sia anche l’ora di una «nuova poesia antagonista», una «novissima sillaba clandestina». Attuando la sperimentazione di un nuovo modo di dire, insieme barocco e innovativo, melodico e urticante. Poiché così si presenta l’autore: «il puteolano Carmine Lubrano: ricerca sempre quella rima antica / punge a suo modo più dell’ortica».
Da: nuove Letanie salentine
sarà a pagina cinque che riprenderò
il viaggio talentino da oriente a occidente
verso l’inferno e dopo il frontespizio
il giuoco dell’oca con rebus annesso
laborinthus interruptus tra litania trimalchionis
e novissima sillaba clandestina
[…]
e sono qui a Roca
i giovani ancora mi chiedono
e mi chiedo
tra lente lente deliranti et urgenti
nude ‘nchiavate letanie
mi chiedo dov’è l’acqua dolce
per arginare la sete la posia sorgiva
la poesia sotterranea che percorre sentieri profondi
canali navigabili per parole che hanno voglia di andare
lontano saltare i fossi esplorare anfratti e caverne nascoste
sarà questo segnino insieme di inchiostri
e cadaveri squisitamente composto
con l’ultimo verso a ritroso
dalla novantaquattro alla settantasette
in un coito con tamburello e chitarra battente
e per allegri lestofanti per amici e parenti
per oracoli ciechi per bizzoche e cornuti
per razziati e fottuti
il seme ed il canto nel tempo andato
tra pietre incustodite dove ogni parola prima dell’amore
è nuvole è ustioni
sarà un diario di bordo scritto sui bordi di carte lacerate
un flusso sapiente i linfa tra orto e genitali
distratto da un giuoco impervio indecente
che inseguo spassiunatamente
e col desiderio di una sola parola sola
nella ragnatela indolente fatta di stagioni
e lunghi capelli lacrime antiche dimentiche
sarà l’incanto caduto nel fango a divenire ingrediente
per un sonetto impassibilmente imposibile
per raccogliere tutto il sangue del mondo
e tra squilli di rosso fuggente
struggente bestemmia jattura con l’inganno
per la nuda e cruda crocifissione di tutti i santi molesti
che oscenamente avevano già dato la voce a briciole esplose
nel sudiciume
ora questa malcelata canzone
attratta dal calvario s’impiglia nell’esodo d’urne
nel coro dell’alterco dei vicoli al porto
strascina malumore di sera e matina
arina la giografia delle ombre l’immerso
odoroso ridisceso alla piazza
dopo la tempesta tradotta sol fetore di pisciazza
col catrame tra fette d’anguria e le ricette tutte
sedotte e abbandonate e fino a pagina quarantasette
poi ci saranno venture cesure e cesoie per finire in bellezza
le congerie della scrittura e per sporcare carezze
con mucose melodie tirate fuori dal pozzo
[…]
Da: per un Poema Manifesto
***
vedrai vedrai la melodia che s’esilia e si noda
s’allenta s’ammorza alla randagia dimora
vedrai il rantolo all’emporio eloquente
la vendemmia che non arrugginisce la carezza
vedrai la maraviglia depilata sul bordo della pietra
e sarà mai sazia opulenta parolA fabula dal ritmo ossessivo
a dirti la fine nell’esilio dal canto
vedrai il pallore imbalsamato da efelidi
e l’euforia di una ruga nei salotti dei cavadenti
vedrai l’eczema vedrai la lusinga e lo scempio del morbo
vedrai l’affanno l’indolenza il pa bagnato e la zavorra
e vedrai la demenza il demerito la de mo cra zia
***
[…]
e che dunque in questo senso almeno
la smorfia dell’arte ed il ritorno del pazzerello in piazza
tra pozzi di zolfo e latrine tra pupazzi e poetastri
puzzolenti di lirico piscio e che dunque
in questo senso almeno bel venga la macchia sul foglio
che uccide a ritroso l’imbroglio
l’inchiostro nei guizzi che insegue il verso
che danza avanza cerca lo spazio vuoto
il peccato bianco sulla pagina stanca
non si sazia nel segno non si perde nella carezza
con l’accento che graffia di lusso
vocale ch’allecca la nota stonata
col salto nel fosso nel rebus obeso d’oblio
ora ovulo ombroso d’una scorza cachera
e col fiato vileno fetori d’altre stagioni
fioritura d’una ferita col prurito d’ortica
tra orrido e schifo s’imbriglia nel collo
s’agghiaccia al taglio lento tremante
si posa sossopra al carnoso silenzio
dove riposa e che muta nel morbo trusco
nel fango guasto del giorno festo
in questa puzza grotta col pane tosto
nel sanguinato brodo e tra fetude lenzola
ora che la lingua deve inventarsi roghi di ostie in eccesso
[…]
Carmine Lubrano, nato a Pozzuoli in via Dante Alighieri vive e lavora al Parco Virgilio a Cuma tra l'Antro della Sibilla e l'Averno.
Poeta, operatore culturale, ha fondato l'Archivio della poiesis contemporanea "Poetry Market", ha fondato e dirige il Lab-Oratorio Poietico per le Arti, la rivista e le edizioni "TERRA del FUOCO", ha tenuto e tiene workshop e laboratori di decodificazione dei linguaggi contemporanei in numerose scuole,centri culturali,musei; è curatore di mostre, direttore artistico di eventi, manifestazioni e festival, in particolare nei Siti archeologici; ha pubblicato diversi libri di poesia con prestigiose sigle editoriali(Tam Tam,Altri Termini,Scheiwiller,Rai Trade...); dedicata al suo lavoro la Tesi di Laurea dal titolo: "poeti antagonisti e funzione-dialetto nel conflitto culturale del '900 a Napoli”, alla Sapienza di Roma; altre tesi attraversano il suo lavoro nell'ambito della poesia antagonista e della "Terza Ondata" delle Avanguardie, presso: Federico II di Napoli, la Sapienza di Roma, Accademia delle Arti di Napoli, DAMS di Bologna, Istituto Superiore del Design di Milano…; ha curato antologie didattiche,tra le altre: "POeSIA (giocare con le parole,poesia visiva,scrittura visuale…),"PHOTOgrafia (fotografia creativa e off camera), "il di-SEGNO Poietico" (contaminazioni e mode…), "la Città dell'Immagine" (parola e segno); ha partecipato come artista con reading e concerti di POESIA e MUSICA a Festival e manifestazioni da "Poliphonix" al Centro Pompidou e alla Maicon des Ecrivains di Parigi, a Poiesis Sinphone di Milano, dal Salone del libro di Francoforte alla "Scuola di Lettura in Biblioteca2000-Ministero per i Beni Culturali", al Festival dei Popoli Mediterranei, al Festival Ferre'; è presente nell'Archivio della Canzone Napoletana della RAI di Napoli e nell'Archivio "la memoire et la mer" di Parigi, per aver "tradotto" ed interpretato in Lingua Napoletana alcuni testi di Leo Ferre'; ha curato l'antologia "POETI contro BERLUSCONI",1994.
Nel gennaio 2019 : premio Trivio 2018 (alla carriera per la poesia)
Tra le sue opere ultime:
- "Scovera Jorda Pilosa",Scheiwiller,Milano,1997
- "Sulphitarie"(con Edoardo Sanguineti),Napoli,1999
- "PoemAverno"(libro+CD con le musiche di Rino Zurzolo),Napoli,2000
- "Lengua Amor Osa",D'Ambrosio ed. Milano,2003(premio di poesia Feronia 2004)
- "Stroppole d'Ammore" ( libro + CD ),RAI Trade-Suoni del Sud,2006
- "Serenata Napulitana al cabaret Voltaire", ed. la Ricotta,Canneto Pavese(PV)
-“Era de maggio - in viaggio tra ‘68 e dintorni” , JazzPoetry, 2008-2018
-“Letania salentina e altre Letanie”, Lab-Oratorio Poietico, Napoli,2018
-“riscritture antagoniste”, Eureka edizioni, 2018
-“nuove Letanie salentine e un PoemaManifesto “, Napoli, 2019
Finito di stampare nell’aprile 2020: “Le ragioni dell’avanguardia: la poesia di Carmine Lubrano” (scritti di: Allegrezza, Cudazzo, Bettini, Muzzioli, Aprile, Moscarelli, Pieri, Gennari, Sanguineti… con ipertesti di Carmine Lubrano da “vado via dalla poesia” )
Maggio 2020: in uscita “sono le undici e quaranta di questo santo venerdì santo - poesia in quarantena”.
Francesco Bellomi e Laura Caccia su “Le voci dei bambini (Poesie 2007-2017)”, Mursia 2019, di Margherita Rimi



L’arcobaleno del dolore
Arduo aggiungere parole ai versi dell’opera Le voci dei bambini, nella quale Margherita Rimi affida alla poesia lo strazio dei minori, fatti oggetto di violenze, abusi e sfruttamenti. L’autrice dà voce direttamente a loro, lascia che prendano la parola i «sassi nella testa», la «pietra qui nella gola», i «fantasmi negli occhi», le «paure nelle orecchie». Non trovando il dolore, quando viene raccontato dai bambini in prima persona, passaggi che possano affievolire la paura, il disagio, la rabbia, la solitudine. Nello stesso tempo, però, riuscendo a recuperare un po’ di quiete attraverso il mondo magico dell’infanzia, con la compagnia di una bambola o di una conchiglia. Diventando invece, quando viene espresso dalla voce narrante in terza persona, durissima cronaca dell’inaudito. Pur sempre, anche in questo caso, lasciando intravedere una speranza, una possibilità di parola, un barlume nel buio.
C’è infatti, in tutta questa sofferenza, una luce che tenta di farsi strada nella tempesta del vivere. Ed è il chiarore di un arcobaleno che si affaccia più volte nei testi. Ci sono i colori con cui è articolata la raccolta: il bianco dell’abuso, il nero della guerra, il blu del lavoro minorile, il rosso del matrimonio dei minori, il verde della violenza domestica. Che, insieme, trattengono e cullano gesti e stati d’animo drammatici: la paura e il senso di colpa, le grida di aiuto e il pianto, l’inutile ribellione e la disistima. E c’è, all’improvviso, «un arcobaleno // vicinovicino, troppo vicino // non si può andare // non sappiamo // dove atterra». Così come, nel grigio che domina, c’è «un bambino che ha visto l’arcobaleno di tanti colori».
La speranza è affidata però soprattutto alla parola. Al dire poetico, etico e civile di Margherita Rimi, che riesce ad esprimere l’indicibile della realtà più cruda. Togliendo maschere e coperture, anche linguistiche. Facendosi voce di chi subisce e che finalmente riesce a trovare la forza di dire, quando a lungo tutte le parole sono state trattenute, come nel disegno della bambola «dentro la sua pancia». Ed è la parola sola che può salvare. Una parola che dia un nome alla sofferenza. Che aiuti i bambini a dire. Come scrive l’autrice, a cui lasciamo voce: «se trovi la paura non trovi la parola // Una paura per dirla tutta deve avere un nome // Proviamo a chi gli mette il nome // Se c’è un nome / io posso già chiamare // Se c’è un nome // Insieme // Possiamo. Raccontare».
Da: BIANCO
La bambina non si spogliava più
vestiva le bambole
prima di addormentarsi
***
Ho preso i fantasmi negli occhi
le paure nelle orecchie
le mosche che ronzano nei miei capelli
I grandi è da troppo lontano che parlano
che non rispondono
Siamo arrivati qui:
se trovi la paura non trovi la parola
Una paura per dirla tutta deve avere un nome
Proviamo a chi gli mette il nome
Se c’è un nome
io posso già chiamare
Se c’è un nome
Insieme
Possiamo. Raccontare
Da: NERO
Non ci fanno uscire di casa. Le strade sono piene di bombe
Non possiamo giocare.
Se non scappo da qui posso morire. Ma dove vado
Trovateci. Venite a salvarci
Li ho sentiti piangere per tutta la notte
Sotto le macerie la mattina erano tutti morti
Come finisce la storia. Così: fine della storia
Da: BLU
Io sono Yasir il più grande dei miei fratelli
Ho 12 anni
Con questa macchina cucio i vestiti
Qui c’è tanto rumore che non si può parlare
non sento più nulla. Lavoro e basta
Quando finisce la guerra
voglio studiare
voglio fare il dottore
Da: ROSSO
Mi hanno venduta
Mio padre aveva bisogno di soldi
Sono venuti due uomini a prendermi
hanno chiesto il mio nome
Io non mi voglio sposare
voglio diventare una maestra
insegnare ai bambini
Da: VERDE
Ci sono tanti vermi
che mangiano i colori
Ci sono tante onde
altealte
così alte che rompono il cielo
E se il cielo si rompe
non c’è più il sole
e la notte
…
Come finisce?
Finisce che non lo so più come si spiega
Margherita Rimi è nata a Prizzi (Pa) nel dicembre del 1957. Laureata in Medicina presso l'Università di Palermo, svolge l'attività di neuropsichiatra infantile. Ha pubblicato una prima raccolta di versi dal titolo Traccia d'interiorità, Cultura Duemila, Ragusa 1990. Alcune sue poesie sono state inserite in AA.VV., Petali di sole, Mazzotta, Castelvetrano 1999 mentre la silloge Righe mancanti è inserita in AA.VV., Il volto dell'altro. Itinerari tra alterità e scrittura, Kepos, Castelvetrano-Palermo, 2001.
Ultima pagina, Francesca Marica: altri collages, una nota
La nuova serie "C'è questa donna che parla, parla tanto" nasce come evoluzione dei lavori risalenti al 2020 “D'ailleurs c'est la fête” e pone al centro della narrazione l’elemento femminile.
Vengono qui ospitati sei piccoli collage realizzati su carta bristol dove il bianco della pagina, il nero dell’acrilico e il rosso dello smalto creano una struttura che si fa elemento portante per volti e parole sempre al limite della reticenza.


Pur presentandosi le due serie in rapporto tra loro, al minimalismo e all’essenzialità dei lavori del 2020 - dove non c’era spazio per l’elemento figurativo e pochissimo spazio era riservato alla parola -; si contrappone la complessità dei nuovi che hanno deciso di aprirsi alla caoticità del mondo guardando le cose per come sono o per come accadono con il coraggio che è proprio della realtà delle cose. Alcuni dei versi usati in funzione didascalica (Ciò che non vedo/ vedo meglio; Lasciatemi l’estasi – vita – da vulcano; Portatemi via tutto) sono della poetessa Emily Dickinson nella traduzione italiana di Silvia Bre.
Francesca Marica, poeta e artista visiva, è nata a Torino e vive a Milano.
Tra gli ultimi suoi lavori in versi: Concordanze e approssimazioni (2019), Ti scrivo da dove sono (2022). È presente nell’antologia Babel, Stati di alterazione a cura di Enzo Campi (2022) e nell’opera collettiva Passaggi, a cura di David Watkins e Luca Chiurchiù (in corso di pubblicazione).
Gennaio 2023, anno XX, numero 53

La penombra che abbiamo attraversato (ricordando Lalla Romano), dopo l’incidente occorso a Flavio Ermini nell’ottobre 2019, ci ha imposto una profonda riflessione su tutta l’attività di Anterem, obbligandoci dopo 45 anni a un passaggio in terra incognita. All’improvviso messi di fronte, con la chiusura della rivista cartacea, all’esigenza di ridefinire scelte e indirizzi, anche dentro impoetici percorsi burocratici. Va da sé che tutte le energie sono state assorbite per riorganizzare i quadri della nostra associazione no-profit, per garantire la continuità del premio Lorenzo Montano, per immaginare e costruire la rinascita dell’editrice. Alla quale, oltre alle collane storiche e facendo perno proprio sul premio, è stata dedicata grande cura nello sviluppo di nuove linee editoriali, nella presentazione delle opere pubblicate e nella partecipazione alle fiere nazionali del libro.
Tutto questo ha di fatto rallentato, complice anche la pandemia, le uscite di “Carte nel vento”, che da un po’ ha finalmente ripreso con regolarità le sue pubblicazioni. Il presente numero conclude l’esperienza del Montano 2019.
A conferma che da sempre, per noi, nulla si esaurisce con gli esiti del premio, ma prosegue nel tempo, nel continuo dispiegarsi di una storia cominciata 37 anni fa.
Abbiamo scelto di prenderci cura della poesia. Pubblichiamo senza oneri per gli autori. E continuiamo a operare in totale gratuità in tutte le attività dell’associazione, del premio e dell’editrice, nelle connesse attività di recensione e presentazione delle opere e nella cura di Carte, sito e pagine social.
Consideriamo importante dare valore alle opere nel tempo, mettendo a disposizione di tutti un archivio permanente sul sito. Da febbraio riprenderemo su questo periodico le scritture segnalate, finaliste e vincitrici dall’edizione del Montano 2020 e oltre.
Desideriamo ringraziare tutte le autrici e gli autori che ci hanno pazientemente aspettato.
E grazie a Loredano Matteo Lorenzetti cominciamo questo numero riflettendo sulla parola, grazie a Zona Disforme lo sigilliamo con un salto, in realtà due, nell’immaginario.
Attendiamo nuovi testi, per lavorarci con la consueta passione, all’edizione del premio da poco lanciata.
Scarica il Bando della 37a edizione del Premio Lorenzo Montano (2023)
In copertina: fotogramma di Zona Disforme
La redazione
Loredano Matteo Lorenzetti, saggio: “La parola eveniente”
Esiste un dire della parola che, raschiate le incrostazioni del senso e lucidata l’opacità dell’usura del tempo, pronuncia il futuro, nel nuovo dell’eveniente?
Ascoltando Emily Dickinson, nella lirica intitolata “The future never spoke”, il futuro tace il suo diveniente accadere:
Il futuro – non ha mai parlato –
né mai – come fanno i muti –
rivelerà a segni – una sillaba –
del suo profondo avvenire –
Eppure la parola, come originario gesto vocalico mentale – all’udito sordo e alla trasduzione grafica estraneo –, nel suo invisibile e inudibile tenue germinare fonemico, appena rumoreggia per accennare, sommessamente, la possibilità d’un senso eveniente.
Si tratta d’una gestualità intima, d’un moto recondito, d’una azione nascosta non palesata all’esterno. Di un atto afono alle labbra, fintantoché alla soglia d’esse giunga. Che compaia, cioè, per danzare sillabe sonore sulla bocca, nello spazio intermedio fra interno ed esterno del corpo. In quella umida cavità vibrante in cui si compongono e decompongono i suoni delle parole.
Tale condizione di gestualità motorio-fonica possiede un carattere e un potenziale tra-s-f-orma(t)tivo: una forma attiva tras-formante, che contiene l’orma di sensi possibili. Suoni-sensi che fluidamente transitano nel luogo della mente, in articolanti gesti indefinitamente mutanti. Poiché nel mentre cercano una forma sonora che componga la parola, vengono in-formati d’ulteriori possibilità di forme. Sicché nel tentare d’essere gesto in sé concluso, de-finente, scopre quel che può divenire nel suo aperto eveniente. Sperimenta cioè lo stato provvisorio e precario dell’essere sul punto di divenire altro dal pensabile.
Prosegue Dickinson:
ma quando la notizia è matura –
la presenta – nell’atto –
prevenendo ogni preparazione –
fuga – o sostituzione –
La ‘parola futura’, nell’eveniente da cui trova forma e senso, non ha praeparatio, bensì paratio, quale aspirazione a, ricerca finalizzata a procurarsi qualcosa.
In altri termini viene a costituirsi come tentativo aspirante al ricercare quel materico suono che è da pronunciare per acquistare altro gesto-senso da quello che è stato scolpito nella parola. Scolpito dallo scalpello della discorsività e dal martello del tempo trascorso.
Né la parola eveniente fugge dalla sorte del consumarsi. Non si sottrae, non scappa dal logorarsi, che la corrosione dell’uso inevitabilmente le procura.
Neppure sostituisce altra parola, bensì aggiunge la propria significante sonorità perché è raggiunta da un inatteso senso sopravveniente, che inaugurando altro significato destina quel rumoreggiare a intonarsi all’eveniente.
Il ‘movimento mentale’, che aziona il generarsi della parola, equivale a una trasparente danza fonica che coreografa la ricerca di senso, attraverso le movenze articolatorie della voce ancora non detta. Perché appartata. E solo ri-suonante nell’intimità corporea. Non disposta, nell’immediato, a uscire nello spazio comune dell’altro. A lasciarsi co-abitare dall’altro.
È un gesto che inizialmente abita in noi per ‘esistenzializzarsi’. Per acquisire un senso esistenziale di vivezza, sperimentato nel legame con la storia di se stessi, con il suo svolgimento e con il vissuto del possibile diveniente. Il quale accenna a un addivenire – nella prossimità d’altro divenire – pro-seguente quel che si è già divenuti.
In tale situazione d’elaborate vicissitudini trascorse, si creano le premesse e le condizioni perché venga a strutturarsi l’eventualità della dimensione ritmico-sonoro-musicale della parola addiveniente che, proiettando la sua ombra al di là del presente, sconfina nel futuro: dal movimento, sommovimento, del vissuto che conduce a sorprendente ulteriore trama vocalica a venire.
Come se quel che l’esperito vibra sonoramente nella nostra mente-corpo abbisognasse d’un al di là della parola che esprime l’esperienza pregressa, la sua storia. Il passato che la condensa. Per dis-farsi e ri-farsi nella sostanza d’un suono in-audito. Il quale possa, dapprima come rumore delle cose e della vita, ri-umanizzare quel che va ri-pronunciato nell’oltre il pronunciabile. Al fine di trovare un senso altro da cui ri-cominciare a dire. Oltrepassando non solo il già detto e l’ancora da dire, ma avventurandosi nell’indicibile.
E’ là, nello sconfinato del possibile impossibile da pronunciare, che tende la parola poetica, quale vibrazione sospesa nel vuoto del tempo che l’attornia. Smarrita dalla distanza dalle cose, accecata dai significati nascosti nell’opacità gettata oltre la luminosità di quelli sfolgoranti, sui quali la quotidianità, nel suo distratto pronunciarla, abbagliata inciampa.
In questo non vedere del tutto la lontananza, l’intervallo, la differenza che separa la parola dall’originarsi del suono, nel suo allontanarsi dal luogo del silenzio – seppure cammino angosciante –, trova inizio una sorta d’estraneazione. D’erranza esule della parola poetica. Distaccata da ciò che la conduce e riduce al comune, al banale, al routinario di un’ormai nota sonorità, con cui ripete senso su identico senso del reale. Decretando la rottura con il legame quasi inscindibile, perciò morboso e nefasto, con la ripetizione. La quale consolida e pietrifica il significato. Segnando, in tal modo, il destino dell’indifferenza all’eveniente. Al venturo, al trasformato da ciò che giungendo reclama innovata sonorità, innovante ritmicità.
Spetta alla poesia, alla parola narrante, al gesticolare immaginante del vociare interiore, il sonorizzare ogni lemma nel codice della grammatica dell’intimità, per metamorfizzare la parola eveniente affidandole altra sonorità. Destinandola all’inatteso spazio sonoro che mette a disposizione il moto poetico, quale spazio inabitato dal senso già udito.
Spetta al silenzio che ante-cede il rumore del non ancora significato d’una espressione vocale a sostenere, coraggiosamente e trasognante, il suono eveniente che teme di non dire abbastanza. Che rimbalza dal cuore alla mente, senza sufficiente eco per materializzarsi.
Alda Merini sostiene che alle volte il silenzio dice quello che il proprio cuore non avrebbe mai il coraggio di dire.
Il suono silenzioso della parola poetica, in gestazione nella mente, e dal cuore effuso e nutrito, è al servizio dell’interpretare quel che il sopravveniente non ha ancora detto: l’assenza della parola che s-piegando l’avvenire lo piega al senso del presente. Privandolo, così, del patrimonio sonoro con cui può accennare ad altro dire. Quel suono che si rende cortese nella funzione poetica del lasciar risuonare il molteplice del senso di cui la parola cerca e immagina essere suo luogo – sognante – e destino.
Conclude Dickinson:
Indifferente per lui
– dote – e dannazione –
suo ufficio – solo eseguire –
il telegramma – del destino –
La parola eveniente ci raggiunge da una sorta d’aggrovigliata temporalità esperienziale unitaria – magmatica – di passato e presente. E dai dintorni della forma di vita che autenticamente, intimamente, ci appartiene storicamente. Nella memoria con cui gli abbiamo dato forma, sagome d’affetti, riverberi sonori e senso.
Essa irrompe in quel flusso vitale degli eventi, che assicura ciascuno della propria vitalità. Rassicurando la persona da un oltre che allude a una fine, con lo sconquasso della possibilità del venturo.
L’eveniente, pertanto – come emozione infinita del mutare, soprafacente la pena esistenziale del permanere nel pronunciare e sentire identici suoni del dire di sé –, si prospetta come tramite per la con-versione delle certezze di ciò che si è in una versione sorprendente, trasalente, di ciò che non si è. Se non nella forma informale dell’inatteso sopra-giungente. La quale – nel de-formare il noto di se stessi – ci solleva dall’oppressione dell’accertato e immutato di e in se stessi, pro-muovendo al contempo, ricerca e invenzione di nuova forma vitale del pensare, dire, essere.
E’ in tale possibilità, e altra versione di quel che si è stati, che s’annida l’esteticità-estaticità del senso e la dimensione poietico-poetica dell’intonarci a quel che ancora non siamo e, quindi, non possiamo dire. Se non in un’in-forme molteplicità di sordi suoni, di sommessi balbettii, di soffocati gemiti, di ripetute interruzioni foniche e silenzi.
Ed è dal silenzio che pervade l’esistenza che la parola pronuncia narrativamente la sua storia di-veniente. Nell’avventurosità del venturo. Poiché il silenzio non è soltanto la condizione stessa del pensare, ma pure intervallo, cesura, spazio vuoto in cui precipita l’esperienza comune e la parola ordinaria.
Scrive Dickinson in “I heard, as if I had no Ear”:
Sentivo, come se non avessi orecchio
finché una parola vitale
fece tutta la strada della vita a me
e allora seppi che sentivo.
Loredano Matteo Lorenzetti, docente universitario di psicologia, è direttore scientifico di quattro collane, per le edizioni FrancoAngeli, fra cui “Arte scienza conoscenza”. Recenti sono i romanzi Ripostes: La maiuscola di Osvaldo; Mastro Spadò; Un uomo qualunque; Sognare in due.
Maria Angela Bedini, incipit della prosa inedita “La sabbia, il fiume, la fine”; nota di Mara Cini
Da una scena dapprima “francescana” scaturiscono via via quadri barocchi, manieristi, sghembi, arricciati…
Tutte le forme, tutti gli alfabeti, i pattern, le icone dell’arte e della natura (armigeri & scudieri, sultanine & rampicanti, motivi decorativi multipli e cloisonnés) concorrono a dar vita a questo testo di Maria Angela Bedini, fiorito d’ogni essenza - dall’alpestre al beduino, dalle guazze del bosco alle luci cherubine – largo luogo letterario dove rintracciare la radice digiuna della terra / fiala dell’universo.


Piera Biondi, prosa inedita “Il pianista”, nota di Mara Cini
Come le Mani che disegnano di M.C. Escher, le mani del Pianista disegnano la loro storia, innaturale, tra luci e ombre minimali.
E’ una storia di suoni scuri, tracciati su un pentagramma di luci segrete e lattiginose. Ma forse non è neppure una storia.
Il Pianista vive e sogna e muore in una dimensione atemporale dove non c’è quasi niente da raccontare, dove la realtà ha un sapore sfuggente fatto di melodie elementari, ripetute, sovrapposte.
Le melodie di questo Pianista sono melodie afasiche e tra-sognate, Voci da tenere fuori dalla pelle.
IL PIANISTA
L’oceano. Schiuma sulla sabbia. Calma di mare. Cielo che comincia a schiarire. Ricordo di un freddo invincibile che addormenta in ibernazione.
I gabbiani -assolo alterni intrecciati sovrapposti- stridore di canti. Lieve brezza che si leva.
Mano sulla mia spalla, occhi interrogativi, bocca che solfeggia parole.
L’automobile raccoglie dal finestrino verde di campi, sfumate variazioni di alberi, pentagrammi di fili.
Improvvisa la chiara cacofonia cubica. L’ospedale. Sono dentro. Prevale il bianco. Ostile sedia di formica, tavolo innaturale. Odori depurati morti in disinfettanti. Luce schermata lattiginosa camuffata.
Dormire. Calore tanto calore, quello sì. Nascondere la testa sotto le coperte nel buio naturale. Protezione, silenzio. Le mani sugli orecchi. Dormire nel tepore. Sparire.
È notte. Silenzio. Clair de lune sommesso, discreto, dirama come un melo in fiore sulla coperta sul comodino per i corridoi. Io la sento quella vaniglia di luce segreta che avvolge e dissolve ogni innaturalità.
Dolcemente infine il buio assoluto del sonno.
Suoni metallici voci passi porte sbattute e fu mattino.
Mangiare a occhi bassi nelle voci. Sedere. Tacere. E fu sera e fu notte.
La luna scema lentamente ad ogni buio, si consuma e sparisce poi riappare sottile in un arco.
Vuoto. Voci da tenere fuori dalla pelle. Lontane.
Due mani increspate segnate poggiano sul tavolo foglio e matita.
Sulla carta ora il pianoforte a coda, i tasti bianchi e neri, il cerchio luminoso e l’ombra sotto il piano. È stata la mia mano chiara da malato a tracciarlo. Ma era come già ci fosse sul foglio. Quasi calamitata, la matita ha seguito invisibili contorni.
Nella cappella - penombra cangiante di vetri rossi verdi azzurri- le mani accarezzano il lucido rigore nero sopra il legno, la tastiera d’osso. Strumento annoso sapiente, vecchia polvere, aroma amaro di alberi mummificati.
Le mie mani. La tastiera me le ha prese, le attira su di sé. Vuole che peschi nel suo mare.
Com’è facile per me toccare i tasti d’avorio, che raccontano notti di luna, cigni, strazi e dolcezze del cuore.
Perché riesco a far questo? Tutto è buio dentro di me, ma vi escono strane cose, come questo destreggiare il pianoforte, suoni che mi consolano, occupano le mie giornate.
Mi hanno messo sul leggio dei fogli con righi dove riposano uccelli e io li fo cantare -non so come- sulla tastiera.
Mi hanno detto che sono un pianista e bravo. Mi hanno trovato all’alba sulla spiaggia, ma io non so chi sono. Quindi non posso pensare il tempo, come gli altri. Senza un passato non c’è futuro, non puoi dire domani, non conoscendo ieri. Quello che faccio, lo faccio senza sapere quando è stato che l’ho imparato. Leggo, scrivo anche, ma non ho niente da raccontare, semmai una parola: perché?
In questo vuoto mi appiglio al pentagramma e ai suoni, ma è l’inconsistenza. Senza una storia propria, suonare perde calore, il racconto muore.
All’inizio la musica, come un’eco, mi riportava o forse si era trascinata dietro una parte di me. Per ritrovarla, balenante appena con un sapore di realtà sfuggente, devo suonare ciò che mi viene, non so come, certo dal mio passato. Solo così la musica si scalda, ha un sapore d’amore. Dagli spartiti che mi mettono davanti, esce solo una serie di suoni senza vita.
Così suono sempre le stesse melodie, sperando che alla fine una nota, come una corrente o un vortice, mi risucchi dentro la mia storia.
Sono nata nel 1939 ad Altopascio (Lucca), antico asilo e ospedale nel medioevo per i pellegrini diretti a Roma. Da molti anni vivo a Bibbiena (Arezzo). Laureata in Lettere classiche, ho sempre insegnato con convinzione nella scuola media. Mi dedico da dilettante alla pittura. Ho sempre coltivato il teatro, come laboratorio, nella scuola e -per un lungo periodo- come regista di un gruppo amatoriale “Gli inesplicabili”, mettendo in scena anche testi di mia creazione.
Dai diciassette anni sino ai sessanta ho scritto solo poesie, poi mi è esploso questo filone della prosa. Forse la “musa” si è adeguata ai miei tempi. Stretti quando lavoravo, più ampi negli… ozi della pensione.
Opere pubblicate:
“Compagni di viaggio” Ed. Senso Inverso 2011 (Raccolta di racconti) Finalista al Concorso nazionale “Città di Fucecchio” 2013. Recensito da Giuseppe Novellino su “Bravi autori”
“L’enigma di una breve Primavera” Firenze Leonardo Edizioni (Ed. Clichy) 2017
(Romanzo breve)
Libro consigliato nel maggio 2017 dal circuito Unicoop Firenze.
-Seconda classificata per –Narrativa inedita- al Concorso nazionale “Città di Fucecchio” 2015
con il racconto “Notte di guardia”.
Giovanni Campi, dalla raccolta inedita "speculo imaginario", nota di Laura Caccia
Imago in-verso
Continue rifrazioni illuminano i sonetti di speculo immaginario: Giovanni Campi ci conduce “per specchî speculando”, in un intenso dire e contro-dire, dove tutto si altera e modifica.
Come per effetto di uno specchio deformante, che, da molteplici punti di vista, distorce il reale, ne fa finzione o più autentico rimando. O come per azione del pensiero immaginante che offre infinite possibilità di richiami. Tra riflessioni metafisiche e rimandi cosmici, tra “il vuoto pieno” e il “fininfinito”, tra speculazioni filosofiche e la ricerca di un senso “forse diverso, forse d’inverso”.
Soprattutto rifrangendo immagini legate alla parola, dove il verbo e il nome si sfaccettano nei loro molteplici e contrapposti significati. Ponendo in continuazione questioni di senso per la lingua. Fino a intravedere “come / finire il dire e il dare vita al nome” e a chiedersi: “il nome il nume?”. E concludere la raccolta con l’ultima interrogazione: “come dire / daccapo allora? forse da non dire?”.
Nel contrasto tra la forma stabile del sonetto, della rima, degli endecasillabi e l’instabilità di un pensiero che dissuona e diverge, rovesciando di continuo l’apparenza, lo specchio poetico di Giovanni Campi ci pone di fronte alle opposte, celate e insieme riverberanti, immagini del sé, del pensiero, del dire.
premessa
per specchî speculando, trovo corde sottese e tese come precordiali
ricordi di cordoni ombelicali:
il nodo, stretto e costretto, discorde
di vita dono – di morte diventa;
di morte in vece che di vita il dono
concorde in nodo s’inventa perdono:
l’imaginario, sí, l’imago tenta:
l’es il se vede – irriflesso riflesso
in sé, né di qua né di là, ma proprio
’n quel punto dello spunto, dove, flesso,
e tocca ed è toccato, espunto improprio
secante in curva la linea esemplare:
se vizio infine ridetto esemplare
speculo imaginario primo
virtú m’appare, sí, ma dir lo stesso
no, forse diverso, forse d’inverso
a poco a poco esemplare, fin verso
la copia, se copiosa, di sé stesso,
l’odiosa l’amata, non d’altro ancora
una volta único ma doppio inséme
il bianco goccia a goccia il nero seme
di chi di che se sempre, o mai, s’adora
insémina com’è chi ne dispare
o che – se in sé, o meno, la mina mínima
aggetta a ciò miniata qual traspare
la non implosa única – mente plúrima
esplosa se frangente e franta come
chi giunto o non, disgiunto allora al nome
speculo imaginario quarto
non piú di nulla pieno vuoto il tutto
né mai di tutto vuoto pieno il nulla
d’allora senza che ma d’ora in culla
di doni il nido quasi come un frutto
di nuovo avvolto ’n copia a l’un’imago
o l’altra, l’ali d’arti me l’artícola
in gioco il frullo il guizzo o disàrticola
qual fiocco fioco in fuoco di vago
la vena il ritmo in síncope che va,
e va e viene, líbera la mente
disvela il velo il gelo, se demente
immoto moto dal di qua al di là
finito l’infinito che è costrutto
senza costrutto l’essere distrutto
speculo imaginario terdecimo o ultimo quarto e ultimo
imàgina: lo spèculo la copia
che pàgina su pàgina sen muove
di moto immoto, rècita di nuov’e
d’antiquo insème, in esemplare copia
nesciente il nome il nume? nota a nota
scompàgina il dissenno in parte a parte
e lettra a lèttera la díssona arte:
dissémina, dai màrgini men svuota
la voce il suono, corda a corda, l’èssere
a niente il niente per esempio, o il tutto,
a niente anch’esso, quasi come un lutto
l’idèntico o la differenza, tèssere
andate perse, in fine, e come dire
daccapo allora? forse da non dire?
Giovanni Campi, non importa né dove né quando è nato, e neppure se, piú che scrivere, scribacchia, o viene scritto; taluni testi sono in rete (Carte Sensibili, La dimora del tempo sospeso, Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, Poetarum Silva, Versante Ripido, etc.), talaltri in antologie, sotto varî nomi, nel mentre il suo, di nome, compare sulla copertina d’un dialogo – “l’irragionevole prova del nove” – tra due men che personaggî da nulla, Simpliciter & Complicatibus, suo libro d’esordio edito dalla Smasher Edizioni nella collana "orme di teatro", maggio 2014, ormai fuori catalogo; vincitore della settima edizione del premio Mazzacurati-Russo con le prose de l’inoperosa opera “babbeleoteca minuta”, il volume poco voluminoso rimase però allo stato phantasmatico, tuttavia e se non altro alcune minuzie & minute di esso trovarono la voce di Marion D’Amburgo nel corso di Bologna in Lettere 2015; la sua seconda (irragionevole, inoperosa) opera è una raccolta di sonetti: “abbecedarj paralleli”, ebook edito in collaborazione tra larecherche.it & versante ripido.it, 1 marzo 2016, poi stampato in forma privata & fuori commercio a cura di Silvia Secco per le sue Edizioni folli.
Franco Falasca, poesia inedita “Aglio e malinconia”, nota di Ranieri Teti
“Aglio e malinconia” potrebbe essere il soggetto per una scena, di un ciac da film d’essai con quelle frasi, in questo caso versi, che resteranno nella memoria. Immagino una voce fuori campo che recita “quando suonavano non suonavano / ma ascoltavano”, oppure “quando ricordavano ignoravano”.
In questa poesia che, già dalla malinconia nel titolo si potrebbe definire “memoriale”, Franco Falasca riesce a mettere insieme nonsense e senso, a creare un luogo dove lo sguardo dell’autore è allo stesso tempo prossimo e distante.
In questo testo l’aglio è un dettaglio, potrebbe essere qualsiasi coltivazione portatrice di malinconia per chi sta scrivendo. Quello che inoltre sorprende è la capacità di Falasca di inventare situazioni poetiche astratte, sospese.
La chiusa, con “la storia contornata dai giorni”, può rappresentare una fusione tra metonimia e sineddoche rovesciata.
Quando entravano e uscivano
la poesia ne risentiva
quando suonavano non suonavano
ma ascoltavano
quando atterravano ricordavano
quando ricordavano ignoravano
quando la terra era solcata
da aglio e malinconia
sopportavano i momenti
in attesa dell’entrata e dell’uscita
come un colpo di fioretto
sui ricordi che ritagliavano
la vita
mentre la vita ritagliava
le ripercussioni emotive
avvolte nella carta dei poemi
grazie a te che mi seguivi
coerente nell’azzurro
della storia
contornata dai giorni.
Francesco Fedele, prosa inedita “Rassettare”, nota di Mara Cini
Poiché anch’io sono accumulatore ossessivo-compulsivo.
Poiché anche a me sfiora l’idea che potrei tirare fuori un romanzo epistolare da tutte le carte e lettere che ho conservato.
Poiché sono d’accordo: la mia casa e i miei oggetti parlano di me meglio di qualunque autobiografia che non scriverò mai.
Poiché, sebbene in anni ben più lontani, sono partita, come l’autore, da una frazione di paese per una capitale europea (e questo ha cambiato il nostro sguardo sul mondo) vorrei dire a Francesco Fedele che le sue partenze e i suoi ritorni sono forse troppo recenti perché la memoria, nel rassettare, si riassetti…
A volte occorre fa raffreddare i ricordi per farli riapparire scrittura, sulla pelle della pagina.
Rassettare
L'ho sempre trovata una azione catartica. Ѐ come mettere ordine nella propria vita. Sistemare l'anima. Oggi l'ho fatto nella vecchia casa dei miei. La mia stanza, quella in cui ho vissuto e che parla di me, meglio di qualunque autobiografia che non scriverò mai. Mi apre un mondo di emozioni. Ho trascorso una ventina di anni qui, quotidianamente. Poi sono andato via.
Qui ci torno quindici giorni d'estate, sette d'inverno. Sono cambiato irreparabilmente nei restanti dì dell'anno, quante metamorfosi subite, certe volte mi chiedo chi sono, e mi riconosco solo in parte.
Però queste quattro mura parlano e mi conoscono molto più di quanto possa pensare.
Per esempio ho sempre considerato di non essere una persona materialista, eppure sono pieno di cose. Sono anche un collezionista, questo mi rende un accumulatore ossessivo-compulsivo, ma il fatto che mi rimbocchi le maniche con la buona volontà di far fuori il superfluo, vuol dire che non sono ancora patologico.
Mettere in ordine non sarebbe così difficile, se non fosse che ogni oggetto mi ricorda qualcosa, un posto, qualcuno, una esperienza.
Mi fermo a dare un'occhiata, a leggere un foglietto, prendere un vecchio biglietto, un appunto, un disegno, libro, una foto o una cartolina, persino oggetti di uso quotidiano.
Dietro c'è una persona, con cui viaggiavo, o che cercavo di raggiungere.
Il biglietto di Fanny, mi ricorda il rientro a BCN dopo aver vissuto a La Coruña, si augura che sia stato bene e mi ricorda che ho una piccola famiglia anche lì.
Sono passati già sei anni, eppure mi sembra ieri.
I saluti in coreano di Boyun, di cui conoscevo la traduzione, ma di cui a malapena adesso riconosco il mio nome.
Quelli di Mathieu, la maglietta firmata da tutti gli amici erasmus della mia despedida, i bicchieri rubati in vari pub, monete e banconote globali, i pacchetti delle sigarette in varie lingue del mondo.
Ritrovo delle lettere. Persone che mi volevano bene, amiche di penna, alcune lettere di ex.
Che diventassi letterato lo si capisce da questo. Scrivere, mi piaceva già allora. Mi sfiora l'idea che potrei tirarne fuori un romanzo epistolare, ma il proposito scorre subito via. A chi interesserebbe nell'epoca di facebook?
Il problema principale, soprattutto con questo caldo sarà sistemare i miei circa mille fumetti.
Mi ripeto ormai da diversi anni che dovrei prima o poi farne un inventario, alcuni ormai hanno anche più di 20 anni da quando li ho acquistati, altri da collezione superano i cinquanta, potrebbero valere anche qualcosa dal punto di vista economico.
Mi conosco però, alla fine comunque non li venderei. Sistemo i testi. Dal fondo sbuca un libro, il primo in assoluto.
Mi vergogno come un ladro oggi, però l'ho messo in prima fila, accanto a Dostojevskij, Bukowski, Fante, Borges, Sartre, Calvino ed Hemingway. Una biografia. L'eroe di un bambino di 9 anni, di un bambino interista, che quando andava dal barbiere (nonostante il tempo trascorso e la moda si chiama ancora così qua), chiedeva che gli facessero un taglio con il ciuffo del suo beniamino.
Certo oggi la biografia di Nicolino Berti, non c'azzecca un granché con questi colossi, eppure è stato il primo libro che abbia letto di gusto e per scelta, e per simpatia ovviamente, sebbene ormai appartenga a un calcio scomparso e ormai dimenticato, ho deciso, con buona pace per l'ego di premi nobel e grandi letterati, avranno a fianco (almeno fino alla prossima rassettata) il faccione sorridente del centrocampista dell'Inter dei record.
Su uno scaffale spuntano i depliant della mia prima volta in Spagna, ormai quindici anni fa. Quando ancora non esistevano le compagnie low coast, ho conservato tutto di quel primo viaggio da maggiorenne all'estero, i biglietti aerei sembrano quelli degli anni cinquanta...
Negli ultimi anni ho spesso riflettuto sulla sfortuna di essere stato bambino negli anni ottanta, in quanto maturo lavoratore sfigato nel duemila, però da questo punto di vista, siamo fortunati.
L'idea di prendere un aereo verso una capitale europea, quasi tutte senza visti e senza cambi di valuta, e soprattutto che costi quanto una vecchia corriera Reggio Calabria–Catanzaro, è una grande fortuna. Non sarei stato quello che sono oggi senza il signore irlandese che ha dato inizio al tutto.
Le borse di studio che ho avuto all'università sarebbero state forse spese in treni di bassa categoria, però forse conoscerei meglio la Calabria anziché l'Europa, chi lo sa.
Sistemo anche qui e do una passata con la pezza, l'oblio è concretizzato dalla polvere, si deposita, come un velo che copre la memoria. Nell'angolo in fondo il basso elettrico è forse l'oggetto più impolverato.
Ho suonato in un gruppo, che io definivo grunge, Marco, il chitarrista, definiva progressive, Carmine, il leader, definiva punk melodico e Coci il batterista definiva ska con influenze funk. Ebbene, se ero confuso allora sul nostro tipo di musica, lo sono ancora più oggi. Non è rimasta nessuna traccia tangibile di questa esperienza sui palchi, allora internet dalle nostre parti era agli albori, nessuno aveva cellulari che fanno foto o video e noi stessi da veri rocker non ci eravamo mai posti il problema di farci immortalare.
Perciò niente di niente, se non il ricordo di quei pochi aficionados che ci hanno seguito alla festa del liceo 1999, in un paio di concerti nel reggino e nella storica saletta.
Qualcuno diceva che eravamo gente che spacca, ma hanno fatto presto a dimenticarci, chissà, se il chitarrista e il frontman non fossero partiti per il militare, se io non avessi cambiato aria, andando all'università e se non ci fossimo persi di vista con il batterista...
Già, se e se, era destino, anche se credo che sia, come dice un caro amico, il fato è la giustificazione dei perdenti. Semplicemente altri progetti avevano soppiantato i sogni di gloria rock 'n' roll.
Nello sportello sotto ritrovo vecchi schizzi, ho avuto un periodo di florida produzione artistica, tra il 2003 e il 2004 ho dipinto circa il 70 % della mia collezione personale.
Qualche schizzo, lasciato lì, dopo secoli non ancora trasformato in dignità di quadro, ne ho per 30 tele ma vincere l'inerzia della mia pigrizia è piuttosto arduo.
Dietro tra le tante cose, sbucano le targhe delle prime vittorie in concorsi letterari.
Passo sopra la mano come a lucidarle, poi le butto via, di getto.
Mi dico che ne verranno delle altre, magari più importanti.
Mi ricordano le prime emozioni, le prime soddisfazioni da giovanissimo autore.
Dopo qualche secondo ripesco solo la prima. Ѐ giusto che la tenga, mi ricorda una delle più belle serate della mia vita. Mi ci sono affezionato.
Io però sono stato pure questo, anzi tutto questo. Quanti sono gli "ho fatto" in questa stanza, e mi chiedo se il mio io del passato sarebbe orgoglioso di me.
Sono forse troppo cattivo con me stesso, dopotutto credo proprio di sì.
Francesco Fedele è nato nel 1981 a Reggio Calabria.
Cresciuto a Bagnara Calabra (RC), scrive e dipinge dall’età di quindici anni.
Dopo essersi diplomato nel liceo del suo paese, si iscrive alla facoltà di lettere moderne dell’Università degli Studi di Messina. È stato assegnatario di una borsa di studio Erasmus alla UAB di Barcellona nel 2006, dove ha appreso spagnolo e catalano.
Laureatosi nel 2007 con il massimo dei voti, ritorna in Spagna con uno stage retribuito del progetto Leonardo, lavorando presso la Biblioteca Provincial di La Coruña (imparando gallego livello A2) .
Tornato in Italia si è abilitato nel 2009 alla Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario di Messina classe 43/50.
Dal settembre dello stesso anno ha lavorato ad Asti, dove ha insegnato in numerose scuole della provincia partecipando nel 2010 al progetto europeo Comenius promosso dall’istituto comprensivo di Rocchetta Tanaro (AT) in Andalusia e Francia.
D’estate per più anni ha lavorato come GL (group leader, accompagnatore/animatore) per la Ih, Accademia Britannica, presso la sede dell’Anglia Ruskin College di Chelmsford (Essex, UK).
Ѐ stato tra i relatori del Salone del Libro di Torino 2013 e ha collaborato con un reading musicale/poetico da lui ideato alla manifestazione astigiana A sud di nessun nord.
Ha partecipato a mostre collettive e personali nei luoghi in cui ha vissuto. Vicolo Cielo, la sua prima silloge pubblicata nel 2012, ha vinto diversi premi in concorsi letterari nazionali.
Da settembre 2014 vive a Siracusa.
Giovanni Fontana, da “Discrasie”, Novecentolibri 2018, nota di Rosa Pierno
Un continuo spostamento strategico ove l’obiettivo è la trasfigurazione visiva e acustica. Con influenze, intersezioni, mescidazioni, Giovanni Fontana in “Discrasie” complica la linearità testuale. Ciò comporta una continua sfasatura, non solo riguardo ai significanti, ma soprattutto ai significati. La scrittura evade da un contenitore canonico, trasborda per invadere altri campi, utilizzare altri media. Esce dai binari. Elasticamente sfugge alla presa, decentrando ogni questione. Non è una fuga in avanti, sebbene Fontana non manchi mai di ironia. La sua scrittura è un processo che moltiplica e fa esplodere le contraddizioni, che spinge le parole lungo i bordi della pagina e, imprimendo loro direzioni impreviste, le libera da sistemi irrigidenti e le apre a una nuova progettualità. Fontana è molto attento a legare, inoltre, strettamente la sua scrittura a una corporalità che è garanzia di autenticità, ma soprattutto di superamento, fra le altre cose, dei limiti tra organico e inorganico, tra io e collettività.
da Partita doppia
dove nominar le cose è realizzare cose / e la composizione è per campi sonori / per fasce sovrapposte / e la scrittura d’azione e le pittografie salgono / così che entrambi i settori pongono attenzione alla gestualità / per cacciar via la musica / con i bambini che corrono nella stanza
è l’utilizzazione di fonemi / di testi poetici smembrati / di frammenti di parole / di brandelli testuali passati di voce in voce / affidati da musicisti a vocalità non impostate / a voci recitanti impegnate in ricerche radicali / a sonorità mai frequentate prima in campo musicale
rincorrendo dimensioni spazio-temporali attraverso il movimento / l’immagine / la presenza del corpo e degli oggetti / il gesto / allora / si spinge oltre il suono / per considerarlo un puro e semplice residuo / le partiture ricche di indicazioni di comportamento dicono notazioni assai speciali.
Giovanni Fontana è poliartista, performer, autore di numerose pubblicazioni in forma tradizionale e multimediale, noto in campo internazionale; è architetto, nato nel 1946 a Frosinone, vive e lavora ad Alatri. È tra gli autori storici della poesia visiva e sonora internazionale e teorico della poesia pre-testuale e della poesia epigenetica. Tra le sue più recenti opere, la pièce radiofonica Strategie sonore sull’alcova dannunziana (Paris 2017) e Poema Bonotto, videopoema pubblicato in USB per drive dalla Fondazione Bonito, Molvena, 2017. La sua produzione sonora è documentata in una vasta discografia. Tra le più recenti scritture creativesi collocano Déchets, Dernier Télégramme 2014 e Questioni di scarti, Polimata 2012 Premio Feronia2013. Ha scriTto numerosi saggi. Ha collaborato con numerose riviste italiane ed estere. Ha fatto parte della redazione di Tam Tam, Baobab e Altri termini. Ha fondato la rivista di tecniche multimediali La taverna di Auerbach e l’audiorivista Momo. È direttori di Territori. Rivista di architettura e altri linguaggi. Ha al suo attivo oltre Seicento mostre di poesia visuale.
Daniele Gorret, da “Amaro sol per voi / m’era il morire”, Raffaelli 2017, nota di Rosa Pierno
Una vera e propria lode agli animali (“Sulla tomba dei propri cani” è il sottotitolo della raccolta) i quali divengono la voce dialogante privilegiata, quella rispetto alla quale verificare tutte le posizioni, da quelle filosofiche a quella politiche, da quelle poetiche (e il cane Bobi “più che poeta, è la Poesia”) a quelle storiche. Le lodi agli amati compagni non hanno interruzioni nel libro di Daniele Gorret “Amaro sol per voi / m’era il morire”. La voce del poeta innalza una contrapposizione solo apparente con gli animali, giacché il suo scopo è la riduzione della contraddizione a similarità, ma il suo è anche un modo per smantellare i rigidi luoghi comuni, per ridurre gerarchie pretenziose a un più sano livellamento. La poesia di Gorret apre, dunque, a una verifica della distanza tra essere umano e animale, riducendola, consigliando “di far più l’animale e meno l’uomo”, ricercando un modo “d’essere un altrove” e invitando a non considerare limitate le capacità espressive degli animali per l’assenza di linguaggio verbale, di cui il libro stesso è, d’altra parte, un simbolo con la sua esibita specificità linguistica e poetica.
Entrando con te in casa l’innocente
anzi entrando di persona l’Innocenza,
disordinasti non poco la famiglia:
padre e madre ormai già poco amanti,
fratello e sorella ormai Caino-Abele,
e tu, semplicemente, che vivevi.
Come si fa, essendo differenti
(non di dettaglio, non di superficie
ma di statuto, sostanza ed esistenza),
a vivere insieme le stesse primavere
gli stessi autunni gli stessi capodanni,
condividere le nevi e le calure,
dire che si fa, più o meno una famiglia?
Chiaramente non si può, per nulla al mondo.
Ecco perché nel mentre t’accasavi
– i giorni si facevano mesi ed anni i mesi –
tu rimanevi comunque un’extraumana,
qualcosa che è così e non diventa un altro:
se mai eravamo noi – gli umani ed i borghesi –
a farci un po’ di meno di uomini o di donne,
un po’ più inclini ad essere di terra,
Un po’ meno di società e di denaro.
Daniele Gorret (Aosta, 1951) ha esordito come narratore nel 1984 con Sopra campagne e acque (Guanda) cui ha fatto seguito una quindicina di testi in prosa. Nel 2003 ha pubblicato il suo primo libro in versi: Ballata dei tredici mesi (Garzanti) seguito nel corso degli anni da altri otto volumi tra cui ricordiamo Cantata di Denaro (Mobydick, 2006), Compendio di Retorica (Campanotto, 2008), Che volto hanno (LietoColle, 2011, Premio “Guido Goz zano”) e Quaranta citazioni per Anselmo Secòs (LietoColle, 2015, Premi “Carducci” e “Rubiana-Dino Campana”). Suoi testi sono compresi nelle antologie Narratori delle riserve (Feltrinelli, 1992) e Racconti italiani del Novecento (Meridiani Mondadori, 2001). Per il teatro ha scritto Collasso (1999), Carie (2000) e il radiodramma di RadioTre Due (1998). Studioso dell’opera dell’Alfieri e traduttore di testi francesi del Sette e del Novecento, da Sade a Céline, da Caillois a Ponge, Malraux e Blanchot.
Maria Grazia Insinga, da “Tirrenide”, nota di Giorgio Bonacini
Una delle caratteristiche proprie della poesia è l’andamento sonoro che ne scandisce il tracciato, qualunque esso sia: lineare, accidentato, spezzato, in una struttura lirica o poematica. Ma questo, che sembra un’evidenza naturale, implicita e assodata del “dire in versi”, in realtà non è affatto scontata nella sua valenza profonda. Ed è proprio questa difficoltà (felicemente attiva, possiamo dire) a dare, con i suoi tratti distintivi mai univoci, particolari e indefiniti sensi a ogni esperienza di scrittura. La raccolta di Maria Grazia Insinga nasce e si sviluppa dentro un’architettura che non disgiunge suono e senso: anzi, li incrocia e li annoda in un movimento che porta la parola a “precipitare” dal “dirupo fonetico”, dove il corpo-fonema (così l’autrice sembra indicare la poesia che si fa verso anche dal nulla) senza mai distruggersi, si disgrega e si riforma, aggiungendo continuamente, all’intimità dei suoni, un accadimento impensato: l’apparizione pura e vitale di qualcosa che sembra inidoneo o sbagliato, mentre è, nella sua essenzialità, un refuso mistico. Un ritmo incongruo che nel suo errare (a volte in linea, a volte claudicante) all’interno del poema, arricchisce un dire che tende alla non-perfezione. A un’esistenza, cioè, in continuo cambiamento inaspettato, dove “il vero pensiero è...cedere al sogno” la sua forma e la sua facoltà. Perché la poesia è sempre discontinuità. Non è mettere ordine nel caos, bensì attingere da questo modulazioni e sommovimenti per “incendiare la voce”.
dalla sezione LE TUFFATRICI
*
l’altra cavalca su posidonie
in una regione del cervello piena d’acqua
e cavallucci microscopici non è udibile l’udibile
di questa musique à boire rumore bianco e bianco
mangiare la parola è qui cosa è presenza non quella
giusta né la soluzione né idea di luce perché qui
tutto è nuovo nulla ripete e nulla è in vita grazie a dio
*
e dall’infinito areale un corteo di posidonia sbuca
mostruose evoluzioni di unicorni e sirene in miriadi
di ippocampi la cui polvere è cura è linea di flusso e luce
tra opera viva e opera morta pinne dorsali disseccate
rapidissime farfalle cavalcatura e guida dei mostri
*
tutto di mala faccia da per tutto
ingoiare la gola a imbuto e lei
ci passeggia sopra su in strada
per tirrenide il viaggio è già
compiuto e alza lo scirocco e
il pianeta è perfetto sto per
sto per morire e tu parli parli
dalla sezione IL SONNO
*
si fa parte da svegli
dello stesso sonno
e al risveglio tutto è lì e tutto è
come sembra e ripopola tirrenide
o era insonnia? e il sonno
si appropria di tutto anche nulla
e del tempo insonne in tempo
sempre il tempo va a tempo
*
fa parte almeno da dormienti
del tuo stesso sogno? non credere
ognuno va a credere di nominare
ma non è non è per nulla il caso
Maria Grazia Insinga, siciliana (1970), dopo la laurea in Lettere moderne, il Conservatorio e l’Accademia musicale si dedica all’attività concertistica. Nell’ambito degli studi musicologici censisce, trascrive e analizza i manoscritti musicali inediti del poeta Lucio Piccolo. È docente di ruolo presso l’Istituto “G. Verga” di Acquedolci dove insegna Pianoforte. Nel 2014 idea La Balena di ghiaccio, il premio di poesia per i giovani in memoria del poeta Basilio Reale. Nel 2019 idea il Premio Lighea – sostenuto dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella – per fare poesia con gli studenti delle scuole. Ha pubblicato libri di poesia: Persica, vincitrice del concorso “Opera prima” (Anterem, 2015); Ophrys, finalista al XXX “Premio Montano” (Anterem, 2017); Etcetera, leporello in versi illustrato da Alessandra Varbella (Fiorina, 2017); La fanciulla tartaruga, carnet de voyage illustrato da Stefano Mura (Fiorina, 2018). Alcuni testi in versi si trovano in riviste e antologie: Il rumore delle parole a cura di Giorgio Linguaglossa (Edilet, 2014); Blanc de ta nuque vol. II a cura di Stefano Guglielmin (Le voci della luna, 2016); Umana, troppo umana a cura di Fabrizio Cavallaro e Alessandro Fo (Aragno, 2016); Punto. Almanacco di poesia a cura di Mauro Ferrari (puntoacapo, 2017); Osiris Poetry n. 84 (Andrea and Robert Moorhead, 2017); Trivio. Polesìa vol. IV a cura di Ferdinando Tricarico (Oèdipus, 2017); Il corpo, l’eros a cura di Franca Alaimo e Antonio Melillo (Ladolfi, 2018); Fuochi complici. Saggio di critica letteraria di Marco Ercolani (Il Leggio, 2019); Sicilia. Viaggio in versi a cura di Lorenzo Spurio (Euterpe, 2019). Nel 2017 con Historica edizioni pubblica in Itinerari siciliani (a cura di M. A. Ferraloro, D. Marchese, F. Toscano) un saggio, “L’ondina siciliana e il sortilegio della voce”, sulle sirene viste attraverso il racconto di G. Tomasi di Lampedusa, La sirena. Nel 2019, la raccolta in versi Tirrenide vince la XXXIII edizione del Premio Lorenzo Montano.
Vincenzo Lauria, dalla raccolta inedita "L’in/cubo di Rubik", nota di Laura Caccia
Nel faccia a faccia
Come si può leggere e interpretare la prima parte del titolo della raccolta di Vincenzo Lauria, L’in/cubo di Rubik? L’in/cùbo, con cesura indicata dal segno grafico, come farebbe pensare il richiamo a Rubik, una ricerca di sé definita dall’acrostico “Indovinarsi Naufraghi Cercare Universi Balenanti Oltranze”, o l’ìncubo al quale non si può non riferirsi entrando nel vivo del testo in cui “smisurata/mente infinito - / finito / perso, perso l’ordito / l’ordigno è tra le mani”?
Nel capovolgimento continuo delle visioni, nel moltiplicarsi delle sfaccettature, “nel corpo a corpo / nel faccia a faccia”, quello che si intravede, è l’immagine a pezzi di un’identità perduta e disgregata. Quale compito si prospetta allora di fronte al cubo scomposto di sé?
La scelta di Vincenzo Lauria non è quella di tentare una ricomposizione omologante dell’apparenza, bensì del riconoscersi nelle “dis/identità”, nel massacro delle facce, come “un urlo di Munch a ripetersi”, nel naufragare, nello spalancare attraversamenti d’oltranze.
Quale spirito maligno, vero e proprio incubo, vorrebbe portarci invece all’omologazione, al rifiuto della frattura identitaria, alla negazione dell’altro e dell’altrove che ci portiamo dentro? E quale spirito, poetico, al contrario, ci consente di naufragare per trovare approdo in un’oltranza che si intravede balenare, di incontrare l’Altro, di riconoscerci altro?
Indovinarsi 1
La disputa dei colori,
nel tentare un risolutivo allineamento,
racconta di un divenire alterno,
dell’incastro di facce:
finestre/quadri nell’infinito prospiciente
in successioni di bellezze disarmanti.
Cronaca di una resa annunciata:
vittoria del marchingegno sull’ingegno
dell’ingenuità di perdersi nel perdersi.
È l’elemento - disgregato dall’insieme -
figura a sé a margine dello scomposto gioco,
dado privato della magia del numero
lanciato per un andar nel fuor di sé.
Oltranze 2
Il confine - mobile - con l’Altro
coincide con l’inizio del Se stesso
mentre l’in/cubo del doppio
si sovrappone alle sovra/esposizioni
e le prospettive si moltiplicano
in rotazioni di quadri e di ri/quadri.
La ricerca - in facce concomitanti - di una monocromia
risponde al purismo estetico,
riporta alla memoria logiche aberranti
in fondo al gioco delle possibili soluzioni
del rompiKapo.
Universi 3
In dirittura d’arrivo
la luce si smembra in spicchi
per un’ennesima rifrazione del troppo,
per un’altra mancanza del niente.
E qui - nel raccogliersi interno -
ha luogo un ricomporsi composto,
un rinsaldarsi del cosciente
un combaciare - sghembo - di frammenti.
In un colar di colle
l’immagine del sé si scornicia
e nell’imbiancar se stessa
- alla parete di là dal qui -
sanno di blu le nuvole di un nuovo mondo,
della possibilità dell’impossibile.
Naufraghi 8
È nelle massacrate facce l’in/cubo in enne copie
un urlo di Munch a ripetersi,
in pareti devastanti
lucide cornici intorno al vuoto.
Nel non appiglio sprofonda l’ossessione del vedersi
per il tramite dei quadri
per un cader del limite a contenere
per il raggirar se stessi.
L’amor proprio
solo ci scompone
refrattari alla risoluzione.
Vincenzo Lauria, nato nel 1970, inizia la condivisione del suo percorso nel 2001 all’interno di “Stanzevolute” gruppo di 11 poeti selezionati da Domenico De Martino (collaboratore storico dell'Accademia della Crusca e docente universitario di Filologia Dantesca a Udine).
Dal 2010 collabora con Liliana Ugolini ai progetti multimediali Oltre Infinito, Oltre Infinito 2.0, OL3 Infinito, Oltre Infinito 4 (Le stanze della mente). Dal 2012 Collabora con l’Associazione Multimedia91- Archivio Voce dei Poeti.
Ha partecipato a più di 40 reading e stampato in proprio 4 sillogi.
“Teatr/azioni” è stata pubblicata, con nota di Giorgio Bonacini, da Puntoacapo nel 2018.
Riconoscimenti:
Mar 18: Premio “I Murazzi” 7° edizione è tra i 26 selezionati con la raccolta inedita “L’In/cubo di Rubik”
Lug 17: Premio Lorenzo Montano 31° edizione è tra i 5 finalisti con la raccolta inedita “Teatr/azioni”
Giu 17: Premio Letterario Casentino 42° edizione è tra i finalisti e riceve il Premio Speciale della Giuria con la raccolta inedita “Alberi Improbabili”
Set 16: Premio Casa Museo Alda Merini I edizione è tra i 20 finalisti con la raccolta inedita "INF – INFernità IN Fieri”
Lug 16: Premio Lorenzo Montano 30° edizione segnalazione per la raccolta inedita "Oltre Infinito” scritta con Liliana Ugolini
Giu 16: Premio Nazionale Elio Pagliarani II Edizione - la silloge inedita “Teatr/azioni” è tra le 9 semifinaliste.
Giu 16: Premio Internazionale Città di Como – III Edizione: la videopoesia “FEDRA” (in 3 minuti) è tra le 3 selezionate (video: Vincenzo Lauria, musiche: Tommaso Pedani, testi: Liliana Ugolini, voce: Gaia Nanni)
Mag 16: Festival Visioni Shakespeariane 2016 selezione e proiezione del video blob “OFELIA – (Rilettura)”, testi poetici di Liliana Ugolini, Montaggio video: Vincenzo Lauria.
Nov 15: Premio Lorenzo Montano 29°edizione segnalazione ricevuta per la raccolta inedita "Le stanze della mente” scritta con Liliana Ugolini
Stefano Marino, dalla raccolta inedita “un amore. uno squarcio. uno strascico...", nota di Laura Caccia
Stefano Marino, dalla raccolta inedita “un amore. uno squarcio. uno strascico. una sensazione di vulnerabilità. un senso di lutto”, nota di Laura Caccia
L’intreccio di tutto
Un dire senza respiro, che non riesce trovare sintesi, a partire dal titolo che dispiega un amore. uno squarcio. uno strascico. una sensazione di vulnerabilità. un senso di lutto, quello di Stefano Marino. Un dire senza tregua, altalenante e omnicomprensivo. In un intreccio complesso e drammatico tra tutto e il contrario di tutto, tra la vita e la morte di un’esistenza, tra l’inizio e la fine di un amore.
In quattro testi lunghissimi, dal ritmo serrato, la scrittura si muove da direzioni opposte, occupando con movimento alterno le due parti laterali dei margini: tra il dire e il suo riflesso, tra il sé e il non-sé, tra l’io e il tu. In un monologo fitto che vorrebbe farsi dialogo, ma che pare restare alla fine confinato sulla pagina. O, meglio, affidato alla pagina.
Un amore difficile colma l’interrogazione esistenziale che i testi delineano in superficie e nel buio del sommerso: sentimenti di desiderio e di disintegrazione, di passione e di vulnerabilità, di affetto e di lutto, in una “squilibrata scomposta alternanza di stati d’animo opposti”.
Con la fiducia, però, che Stefano Marino, nonostante tutto, ripone nella poesia, che consente di affrontare, con la forza della parola, una dolente e drammatica interrogazione esistenziale. Dove “è tutto qui l’esistere l’esserci il sanguinare”. Dove si tratta di “morire di vita”.
Da: 2.
scariche di lampi violenti, tormenti, coraggio
è ciò che manca qui,
dove il tempo sembra essersi fermato e
le parole i silenzi i suoni i rumori i piaceri i dolori
non bastano più a ricucirmi intero.
note di una canzone finita
deserto rimpiazza la vita
fili di aghi sospesi in cielo non colmano la distanza,
così forte la lontananza:
un amore uno squarcio uno strascico un senso di lutto,
mi apri da dentro mi scardini mi nascondi mi disveli,
e lacrime sono sangue, caldo e rosso e scuro,
come sentimento d’amore obliato ormai andato ma
mai cancellato
Da: 3.
un balbettio montaliano e un cuore dislessico
mi guidano e insieme mi sviano
nel mio procedere avanti e indietro
e attraverso e ovunque e in nessun luogo e soprattutto
ora e sempre e mai.
e tutto, m’accorgo a posteriori, nasce solo
dall’interrogazione di un viso,
dal non saper cosa celano
occhi e mani e orecchie e labbra, silenzi e sillabe,
scambi di opinioni e attimi sfiorati e sfioriti,
dal credere di intuirlo,
dal comprender poi d’aver frainteso,
dal soffrire immancabilmente ingannandomi e smarrendomi.
un cuore dislessico e ali inadatte al volo e
piedi inadatti al suolo e mani incapaci di presa e
cuore troppo gonfio d’amore per poter odiare realmente
e così trionfare: sto morendo ma non me ne avvedo, mi rendo conto
troppo tardi di non-essere ed esser-stato:
non più? mai più? e perché poi?
nulli i miei meriti, usurpato
ciò che ho ottenuto, a partire dal
primo respiro e vagito, dall’ultimo sorriso
prima del pianto quando finalmente ti ho capita.
Da: 4.
ti temo infinitamente, mostro, sentimento complesso
in cui morte e vita s’intrecciano s’amano s’odiano s’estenuano
con esito nullo infine ogni volta e sempre così:
sia maledetto ciò e chi lo originò nell’infanzia,
la natura la pulsione la vita-morte che
vuole tutto questo vuole me e non-me:
capace di nolontà sarò forse un giorno
o forse no, o forse sì, o forse è un no ch’è anche un sì.
Stefano Marino, Professore Associato di Estetica all'Università di Bologna dal 2019, svolge le sue ricerche nell'ambito dell'estetica. Gli interessi di ricerca sono rivolti in particolare alla fenomenologia e all'ermeneutica filosofica, alla teoria critica francofortese, al pragmatismo, alla filosofia della musica e alle teorie della moda. Autore di numerose pubblicazioni (monografie, traduzioni di libri dal tedesco e dall'inglese, volumi e fascicoli monografici di riviste come co-curatore, articoli, capitoli di libro, recensioni), ha partecipato a numerosi convegni, seminari e workshop in Italia e all'estero.
Giulio Marzaioli, da “Il volo degli uccelli”, Benway Series 2019, nota di Rosa Pierno
Giulio Marzaioli in “Il volo degli uccelli” scrive la sua enciclopedia: tutto lo scibile possibile sul tema. La descrizione è naturalmente la modalità principe, ma venata da un’ironia lieve e giocosa, anche se il tema è un tema universale, giacché ne va del mondo e della nostra presenza in esso. Certi riferimenti stilistici francesi (Ponge, Quenau) sostengono da lontano l’apertura a ventaglio che Marzaioli effettua con la sua capacità di investigare tutti gli aspetti umani a partire da un solo interesse. Inoltre, invertendo spessissimo la centralità umana in favore di quella animale, l’ironia prodotta da tale oscillazione procura una messa in discussione di credenze e percezioni mostrando come, proprio a partire dalla descrizione, possano aprirsi baratri in quello che crediamo di conoscere. La cultura contribuisce spesso a un’omologazione e alla perdita del sé. Niente di meglio che il desiderio di volare e, senza paura, di ricominciare dalle cose che consideriamo più scontate.
*
“Lo studio del volo degli uccelli non può essere in alcun modo considerato un lusso. I tentativi dell’uomo di costruire marchingegni che permettano il volo non possono essere considerati un lusso. I disegni di quei marchingegni sono stati necessari all’uomo più di qualsiasi opportunità di volare da un luogo a altro luogo.
I disegni dei marchingegni di volo sono stati necessari fino a quando non hanno consentito realmente all’uomo di volare. Poi sono diventati utili.
Quando si conquista il cielo si perde la leggerezza racchiusa nel disegno e non c’è recupero nell’atterraggio, poiché si è mantenuto il peso. Tanto vale non illudere la gravità e rassegnarsi all’assenza di propulsione.
Nel battito d’ala la propulsione è provocata dai vessilli interni, più larghi di quelli esterni, nell’alternarsi delle battute verso l’alto e verso il basso affinché siano piegati i vessilli interni verso l’alto, nella semi-battuta dorso-ventre, e venga così spinta indietro l’aria; o verso il basso, nella semi-battuta ventre-dorso, per assicurare comunque la spinta indietro dell’aria. In tal modo il corpo dell’uccello è spinto in avanti. Osservando un uccello volare è innegabile considerare come l’aria costituisca un elemento imprescindibile del volo stesso.”
Giulio Marzaioli (Firenze, 1972) vive a Roma. Suoi testi, contributi fotografici e video appaiono su riviste cartacee e telematiche, plaquettes, opere collettive e antologie e sono tradotti in Francia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Svezia. In poesia ha pubblicato varie raccolte, tra cui In re ipsa (Premio Lorenzo Montano 2005, Anterem Edizioni), Trittici (Premio Giancarlo Mazzacurati e Vittorio Russo 2007, Edizioni d’if), Suburra (2009, Giulio Perrone Editore, collana ‘inNumeri’ diretta da G. Alfano). In prosa è stato pubblicato il testo Quadranti (2006, Edizioni Oedipus; 2010, Mix Editions,). Ultimamente alla scrittura unisce la ricerca per immagini. Determinante, in tal senso, la decennale collaborazione con il centro culturale La Camera Verde, presso le cui edizioni ha realizzato plaquettes, cartoline, libri d’artista, pubblicazioni di vario genere. È stato curatore di eventi letterari e teatrali e ospite di università e festivals in Italia e all’estero.
Dimitri Milleri, dalla raccolta inedita "Sistemi", nota di Laura Caccia
Prove del dire
Come in una trama scenica, che rende fragile il confine tra reale e finzione, si sviluppa la raccolta Sistemi. Dimitri Milleri dà voce a situazioni difficili tra ombre e luci, sale d’attesa e sale prova, campi e fuori campi. Tra “schegge di sceneggiatura” e “l’abisso dietro l’angolo”.
Sullo sfondo, la trama poetica evidenzia la distanza tra desiderio e sospetto, attesa e finzione, dolore e approssimazione, in tutte le varie condizioni del vissuto. Tra i sistemi, nervosi e complessi, che danno titolo alle parti interne, e gli elementi discordanti che li mettono in crisi: l’inatteso a spezzare la scena o un impulso desiderante a insediarsi nel reale.
In primo piano trovano allora evidenza l’inciampo, l’incerto: “Se sia una morte o cosa”. A creare dissonanze, ma anche prodigi disvelanti, da cui si viene comunque esclusi: “quando / l’aspettativa prende posto nel reale, / è sempre un terzo, vedi, a rivelarlo, / restando escluso dal miracolo non meno / di chi lo vive senza nominarlo”
Cosa può fare allora la parola? Cimentarsi comunque con le prove del dire? Di fronte all’ineluttabile della vita e ai suoi ossimori, quando “d’un tratto / non serve più cercare / parole complicate o gravi toni / di voce”, Dimitri Milleri trova spazio per inedite invocazioni e intonazioni, corrispondenze nel buio e nel fiorire dell’esistere: un desiderio, forse, di “entrare / senza sospetti in detta fioritura”.
Da: NERVOSI
La sera di nuvole è scesa presto,
con la sua calca di molecole d'acqua
che nella corsa scanso.
Di certe conifere basse è rimasto
un grumo d’aghi, l’odore del polline
che batte quello del pulviscolo.
Il buio si è aggiunto alle nuvole
e le nuvole al buio.
Tutto è sbocciato dolcemente,
come una scena provata da tempo,
finché qualcosa si è spezzato
in una pioggia intensa:
troppo, per non chiedersi
che cosa accada quando impari a trattenere.
Se sia una morte o cosa.
Da: COMPLESSI
L’INTONAZIONE
I
Tavole nere, un’araldica
fissa sul segno meno, un giustapporsi
di cuspidi contrarie, come sai:
geni monotoni, che poi significa
magre combinazioni.
Se anche non chiedessi niente, il corpo
abbarbicato in dure geometrie,
sarebbe già messaggio — tu comunque
non ti sei mai sottratta. Quanto ti costi trovare i pigmenti
in questo nero, davvero non so
se tu lo sappia o meno,
né so cosa sperare, ma ho imparato
come i pronomi si confondano nel rito
che non si dà deviare —
la frase ripetuta a scongiurare
che l’ansia di servirti non sia peso
che sogni allontanare.
[… ]
Ne siamo usciti male: solo questo
vorrebbero scambiarsi, e non lo fanno.
La sanno e non lo dicono il fantasma
di aver potuto essere altrimenti:
sanno che passa, raramente appare
come un Saturno, un astro innominato.
In ogni modo l’hanno preservato
dai moti centrifughi della lingua
con gli anni luce e mille palliativi,
posticipando morti, collisioni
già consumate altrove, mentre sotto
come una velatura, mollemente
nidificava il parassita, l’evidenza
che certe volte non puoi fare niente
Dimitri Milleri nasce a Bibbiena nel 1995. Dopo aver frequentato il liceo musicale di Arezzo si iscrive alla scuola di musica di Fiesole, dove frequenta il triennio di chitarra sotto la guida del Maestro A. Borghese. Esordisce nel 2017 con la silloge Frammenti Fragili, pubblicata dalla “Casa Editrice Rocco Carrabba” di Lanciano (Premio Tagete 2017). Suoi testi sono stati ospitati dai siti “Pioggia Obliqua” e “Inchiostro”, oltre che dal blog “Interno Poesia”. Sei poesie inedite si trovano all’interno dell’antologia Poeti italiani degli anni ’80 e 90’ edita da “Interno Poesia” e curata da Giulia Martini.
Marco Pacioni, da “Lo sbarco salato del risveglio”, Interno Poesia 2018, nota di Rosa Pierno
Il paradossale Mediterraneo che dovrebbe unire le genti che si affacciano su di esso, diviene il luogo di una separazione invalicabile soprattutto culturalmente. E che proprio la cultura possa essere luogo di separazione è la questione cruciale affrontata dal poeta. Quel mare che Marco Pacioni naviga, soprattutto attraversando la lingua. Al suo interno, le assonanze, le cesure, il rimosso o il manifesto costruiscono le traversìe sulle onde di una navigazione in balìa del vento come del suono: “che le parti sono un parto”, “il corpo giù verso un altr’alto “. Ma anche materiali di risulta, come quelli lasciati dalle onde sulla riva memoriale: ”smeraldo sui depliant in vetrina / all’agenzia Conrad” o “rimmel d’albe boreali su velieri fotomontati”. Sullo sfondo mobile del mare, anche le poesie dedicate a varie persone procedono “da logos a logos”, mostrando la centralità di un linguistico ondeggiare per recuperare l’altro, l’escluso.
*
sbanda gronda
che non puoi tenere il nome al logo
dare corda allenta il nodo
e continui a scorrere il palmo
cercare il capo con le dita
finire per iniziare
poi la risacca moto d’Orfeo
ti fa scordare
e la parola è già al largo
prima di girarti da verso
una lingua è salpata
*
ammaini a vista dello scoglio
per il dormiveglia nello sciabordio
spoglie sparte
sul pelo dell’acqua
invece del sonno
appaiono quattro rime smisurate
còria di squartamento a largo
lapidi a galla
amari ammari
amare ammare
Marco Pacioni, insegna Storia del rinascimento nel programma USAC dell’Università della Tuscia (Viterbo) e per l’University of Alberta (Canada). È autore di Modernismo e condizione postmoderna (2005); Terrore, territorio e mare (2015), co-autore del libro su Proust Dalla parte di Marcel (2014); ha inoltre curato di Michele Ranchetti, Poesie edite e inedite (2008) e di Luca Della Robbia, La condanna a morte di Pietro Paolo Boscoli (2012). Collabora con “il manifesto” e “Alfabeta 2”. Ha contribuito al catalogo della mostra “La forza delle rovine” (Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Roma, ottobre-gennaio 2016).
Stefania Pastori, poesia inedita “Alda nel cuore”, nota di Ranieri Teti
Stefania Pastori riesce a dire di una cosa tremenda, come indica nel breve testo che precede questa poesia.
Riesce a dire di una violenza subita senza commiserazione, non pensando a se stessa ma a due altre viscerali presenze.
Un grande gesto d’amore è scritto in questa poesia dove il dolore si trasforma, quando si prende in mano la penna, quando finalmente è possibile scriverne.
Scriverne non è un atto consolatorio, non è denuncia.
Sorprende nel testo una lucidità estrema, filo teso tra i fatti e i sentimenti. Su questo filo cammina con passo sicuro l’autrice, senza guardare il vuoto. Gli abissi vengono tenuti a distanza dalla poesia, lo testimoniano i versi finali ripetuti non come cantilena, non come litania, piuttosto come mantra: “scrivere una poesia è riparare la ferita fondamentale” ci ha detto Alejandra Pizarnik.
*
"Partorii la mia secondogenita Sofia nel 2006. Nulla lasciava presagire la sua grave disabilità.
Combatto per lei da quando nacque. Per questa nascita (infausta? fortunata? Non so ancora) fui pestata a sangue dall'allora marito non più marito. Ecco perché mi fregio del nick Gloss, Gruppo di Lavoro e Osservatorio Sessismo e Stalking.
ALDA NEL CUORE
Difficile scrivere con Alda nel cuore
se il cuore si è infartuato proprio ieri
un dolore pugnale infisso nello sterno
un altro piantato tra le scapole
il respiro manca per il male simile
solo a quello del parto, del parto
della mia cucciola per sempre.
Sofia nata per filo, non crescerà mai
la sua disabilità si ingrandirà con lei
mi spacca il cuore e non per diletto
mi spacca il cuore e non per diletto
mi spacca il cuore e non per diletto
mi spacca il cuore e non per diletto
a letto sto. E buonanotte ai sognatori.
Noi non sogniamo più."
BIOBIBLIOGRAFIA DI STEFI PASTORI GLOSS
Sceneggiatrice nei Novanta per Benvenuti, Verdone, Brizzi, selezionatrice di opere letterarie sotto contratto, redigo un blog di recensioni e un podcast radiofonico. Grazie ad un ex partner, mi posso fregiare dello pseudonimo di Gloss, Gruppo di Lavoro e Osservatorio Sessismo e Stalking. Nel 2013 esce CORPI RIBELLI, resilienza tra maltrattamenti e stalking. Poi due libri, un saggio sociologico STANDING OVULATION, le donne sono superiori agli uomini (anche nella violenza), e la silloge poetica MICA VAN GOGH, ispirata ai testi di Caparezza. La rivista online Dol's vara la mia carriera da novellatrice contro l'uso improprio degli stereotipi di genere. Sto approntando una nuova silloge di POESIE SPOLLICIATE, neologismo che riguarda lo scrivere coi pollici sullo smartphone, e un’ulteriore raccolta di RESISTERE PER SOPRAVVIVERE, racconti della Resistenza durante la II Guerra Mondiale a sfondo erotico. La raccolta di racconti STEREOTIPI A BAGNOMARIA, già sotto contratto di casa editrice fallimentare, è da marzo ‘19 al vaglio di altro editore.
Edoardo Penoncini, dalla raccolta inedita "Poesia compagna dell’essere", nota di Laura Caccia
Come eco in una conchiglia
Poesia compagna dell’essere di Edoardo Penoncini non mette in versi richiami metafisici, come il titolo parrebbe annunciare. I testi sono impregnati piuttosto di riflessioni esistenziali, dove predomina un sentire meditativo e sofferto sul trascorrere impietoso del tempo e sul senso contemporaneo del vivere e del dire.
Sulla perdita di parole nella comunicazione odierna. Sul linguaggio della citazione in rete, dove “tutto si dà per letto e introitato”. Sul celarsi della poesia “fuggita dai caffè e dalle piazze / per andare chissà dove”. Sulla forza tuttavia del dire, degli antichi ritmi, della “sapienza / delle parole rotte e ricomposte; // parole/stirpe semenza/parole”.
E se il tempo è considerato dall’autore come l’amante che non ascolta più le “suppliche a rinegoziare / i termini ormai stantii della / relazione”, resta la possibilità di un esistere desiderante, benché sofferto, cercando di “assecondare voglie d’avventure / salire sempre per restare qui / con tutte le paure dell’abisso / e le distanze dai confini assenti”.
Un’eco densa di nostalgia abita i versi: mentre in superficie la navigazione scorre sospinta dalle burrasche dell’esistere, la poesia, compagna dell’essere con cui condivide l’unità originaria, resiste in sottofondo. Sui fondali dove ne custodisce il suono. Quel suono che attende un ascolto, racchiuso come l’eco del mare in una conchiglia.
A Virgilio Giotti
era un deserto la vita al confine
tra i dolori di un’etnìa negata
diseredata dentro nere bocche
che spegnevano luci intermittenti
a poco a poco di voci infiochite
appena passaporto letterario
la poesia con i suoi progetti
fuggita dai caffé e dalle piazze
per andare chissà dove a Padova
o a Parigi, con i bastimenti
dell’Adriatica alla Terra dei Padri
ancora bastimenti riportavano
nel Golfo dal Golfo di Botnia i sogni,
nuove baldorie al caffè Rossetti
mentre la Bora portava il suo gelo
dalle innevate campagne di Russia
e nuove bocche a straziare la terra.
L’ora di notte
Cosa faccio in quest’ora della notte
amico del silenzio appena rotto
dal lento incespicare della stilo
scompaginando ogni mia certezza?
E passerà, lo sento passerà
anche il rovello dei pensieri cupi
in fondo porto ancora la sapienza
delle parole rotte e ricomposte;
parole/stirpe semenza/parole
rinnovando ogni cosa ogni radice
l’insonnia di notte restituisce
la direzione e i sogni della vita.
Sulla “rete”
si vive il tempo del citazionismo
dono e magia che scioglie parole
di Rilke e Lorca e dello Zibaldone
in una rete di nuvole e stelle
tutto si dà per letto e introitato
anche di lingue bevute a bizzeffe
vale la pena tacere del resto
la millantata lettura si sa
non è reato in questo firmamento
dove la lingua perde le parole
Leggendo E. Dickinson
Dicono che muore appena detta
appena nata lungo una strada
davvero, non muore appena nata
e certe parole anche a non sentirle più
sono marcate a fuoco nei nostri occhi
nascosti dietro due fette di salame
ma il suono della fame batte
come sempre a mezzogiorno e sera
alla porta di chi non parla mai
e li accompagna sorella fino alla morte.
Edoardo Penoncini nasce a Copparo (Fe) il 20-12-1951, laureato in storia medievale presso l’Università degli studi di Bologna, è stato assegnista per quattro anni presso l’Istituto per la Storia di Bologna, redattore per tre anni della “Rivista di studi bizantini e slavi”, collaboratore per 25 anni della rivista “Scuola e didattica”, ha insegnato Lettere nella Scuola secondaria fino al 2011.
Suoi lavori di storia medievale e di didattica della storia sono apparsi su riviste e in volumi collettanei.
In versi ha pubblicato: L’argine dei silenzi, Este Edition, Ferrara 2010; Un anno senza pretese, Ibiskos-Ulivieri, Empoli 2012; La spesa del giorno, Ibiskos-Ulivieri, Empoli 2012; Qui non si arriva di passaggio. Ferrara,musa pentagona, Ibiskos-Ulivieri, Empoli 2012; Poesie scelte e dodiciinediti, Punto@capo, Pasturana (AL) 2013; Lungo è stato il giorno, Ibiskos-Ulivieri, Empoli 2012; Quell’aria, Ed. Giovane Holden, Viareggio (LU) 2015; Vicus felix et nunc infelix. La luce dell’ultima casa, Al.Ce., Ferrara 2015; L’occhio profondo, Al.Ce., Ferrara 2018; le raccolte dialettali Al fil źrudla (Il filo srotolato), Al.Ce., Ferrara 2015; in corso di stampa, Scartablàr int i casìt, Al.Ce., Ferrara 2015; Al paréa uŋ fógh adpàja.
Guglielmo Peralta, prosa inedita “L’essere e il nulla: il superamento del nichilismo”, nota di Mara Cini
Il nulla è l’impensato
Il sogno è l’altro nome…del nulla
Tra l’impensato e il sogno c’è un mondo di qualcosa, di ritorni, dove l’essere che si rappresenta dice.
Dire dice sembra allora negare il nulla, poiché dicibile e detto.
Il nulla esiste: nella sua figura di parola scritta, nella sua traccia grafica, nel suono dei fonemi e del vocabolo pronunciato, nella configurazione della sua parola pensata e, con un altro nome, nel sogno.
L'ESSERE E IL NULLA: IL SUPERAMENTO DEL NICHILISMO
La creatio ex nihilo non ha altro principio se non in sé stessa e cioè in quel nulla che le garantisce l'esistenza eterna, in piena corrispondenza con l'aseità1 di Dio.
Il nulla non è l'affermazione e il trionfo del nichilismo, la negazione dell'essere; non è il precipitare della vita nel gorgo della morte, ma è l'assenza di un qualcosa, cui si possa fare risalire la nascita del mondo; cioè preesistente alla Creazione, al Creato. In questa accezione, il nulla è quel Principio che ha nella Creazione la sua affermazione, in quanto essa è creatio ex nihilo. Il nulla è l’essere in sé, “in potenza”, che si fa atto, cre-azione, dunque, Essere, Verbo, Voce, Parola divina. L'identità tra l'essere e il nulla è la risposta alla finitudine dell'umana esistenza, di cui costituisce il superamento. Perché il nulla, in quanto è l’essere eterno, assicura la sopravvivenza oltre la morte. Dobbiamo allora ripensare col nulla il nichilismo. uestoQuesto, dopo i suoi primi esordi in campo filosofico con Gorgia, per il quale «nulla è, se anche qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile, se anche qualcosa fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile agli altri»2, s’impone alla fine del secolo XVIII come dottrina negatrice degli ideali e dei valori tradizionali, nonché della stessa esistenza della realtà oggettiva, considerata solo una vacua e illusoria apparenza. Se il nichilismo, successivamente, ha in Nietzsche il suo più grande teorico, assertore e referente, se con lui si afferma e acquista notorietà e finisce per essere identificato, tuttavia, è in questo nostro tempo che esso, da semplice teoria, da pura visione del mondo si fa “pratica” corrente, dottrina viva, azione demolitrice quotidiana. Dissipati i valori tradizionali, tutto oggi sembra precipitare in quel nulla che il pensiero filosofico dell’Occidente, all’inizio della sua storia, ha definito come «ciò da cui le cose provengono e in cui alla fine ritornano». È questa un’affermazione vera, alla quale i nichilisti assegnano un valore negativo, in quanto essi negano l’esistenza di un «oltre» dopo la morte. L’asserzione assume il carattere di verità solo se diamo al nulla una connotazione diversa, positiva. Se il nulla è l’origine di Tutto non è possibile ammettere un oltre che l’oltrepassi, che sia prima di esso; dunque, il nulla è l’«oltre» invalicabile in cui Tutto già «è» e torna ad «essere». L’esistenza stessa non si pone tra la nascita e la morte, ma tra la venuta e il ritorno, rispettivamente, dell’essere «come» ente e dell’ente «in quanto» essere, ossia, tra il tempo dell’essere e la sua eternità. L’esistenza, allora, è la prova eclatante e miracolosa che il nulla esiste ed è l’essere trascendente e immanente al tempo stesso, in quanto esso è l’«oltre» invisibile e l’«ente» visibile col quale costituisce un essente: unione di anima e corpo, di spirito e materia. Alla fine della sua esistenza terrena, l’essere, scisso dall’ente, ascende alla sua dimora originaria. L’immanenza dell’essere è l’esistenza (ex-sistenza), o il «non essere» che non è la negazione dell’«essere», ma il modo diverso di quest’ultimo di essere, cioè il suo stare fuori come essente, nella forma, nella natura e nella condizione degli enti. L’esistenza, dunque, è la buona novella, l’annuncio dell’essere e la sua manifestazione; è il Significato che dobbiamo interpretare e riscoprire, perché esso è l’essere che si cela negli enti, che sono il suo modo di apparire.
La venuta e il ritorno costituiscono un movimento circolare e infinito, “l’eterno ritorno dell’uguale”, che non è, come per Nietzsche, il ripetersi di ciò che è stato, non è “dire sì alla vita”, nel senso di riconsegnarsi ad essa innumerevoli volte, come l’abbiamo già vissuta. Uguale è l’Essere, e non è il modo in cui si ri-presenta ma la sua immutabilità, l’identità che esso conserva nel suo divenire e apparire come altro da sé. Il nulla eterno, dunque, è da riferire alla natura dell’essere, non è il precipitare di tutte le cose nel nulla, di cui la morte sarebbe solo l’immagine vuota. Il nihilismo, nella sua svolta radicale, “mostra” il volto buono del nulla: la sua natura ontologica e il suo circolo vitale.
Se il nulla è l’essere, il pensiero del nulla è pensiero dell’essere, di qualcosa che «è» e attende di essere pensato, svelato. Dunque, il nulla è l’impensato. Quando il pensiero irrompe nel nulla, un non-essere si manifesta. Ogni ente è l’improptu del pensiero che pensa il nulla, il quale lascia sempre dietro di sé qualcosa d’impensato. L’impensato, in quanto attiene al pensiero e ne garantisce l’inesauribilità, è il pensiero che pensa infinitamente sé stesso. Il nulla, dunque, è l’infinito del pensiero che, sconfinando oltre il visibile, squarcia la caliginosa coltre e lascia che dall’assenza sorga un ente, una forma. Creare è sognare l’invisibile che da infinita distanza si svela e si dona all’Aperto. Così, nel flusso di luce dimora un’altra vita, nel frutto che matura si schiude l’increato. E nello specchio del mondo il sogno è l’altro nome e il volto buono del nulla. Il nichilismo, quale lo abbiamo qui rivalutato, è l’affermazione e il trionfo del nulla come principio ontologico, garante dell’essere assoluto e della sua eternità.
Poiché tra l’essere e il nulla c’è identità, affermare o negare l’esistenza dell’uno significa affermare o negare anche l’esistenza dell’altro. Paradossalmente, ma secondo la logica contraria al principio di non contraddizione, che giudica falsa la proposizione dove sussista un’opposizione tra termini, l’affermazione dell’essere è possibile solo attraverso la sua negazione, cioè il nulla. Non nel senso che l’assenza del nulla è la condizione necessaria per l’esistenza dell’essere - affermazione, questa, consona a quel principio perché priva di contraddizione - ma perché il nulla, in quanto è origine di tutte le cose, è l’essere necessario ed eterno che non rimanda ad altro essere all’infinito. Il nulla, dunque, non può essere negato, perché con esso si negherebbe la creazione stessa. Pertanto, la sua esistenza è vera perché vera è la creatio ex nihilo. La morte non è la negazione dell’essere ma il ritorno dell’ess-ente all’essere, così come la vita, l’esistenza, è la venuta dell’essere. E il morire è anche un non-essere, un “ex-sistere”: lo stare fuori dell’essere (spirito, anima), il suo distacco dall’ente (corpo, materia) per ritornare all’Unità del Tutto, all’Essere o al Nulla, il quale non è ciò da cui tutte le cose provengono, ma è Esso stesso il Tutto che pro-viene, si manifesta al pensiero lasciando fuori di sé «sempre» qualcosa d’impensato, che ne garantisce l’infinitezza. Ed è quel ritorno tramite la morte, la quale non è, perciò, annichilimento ma l’apertura sull’infinito, che non può avere una fine. Nel grande teatro del mondo, dove l’essere si rappresenta, il sipario resta aperto, perché lo spettacolo della vita sempre ricomincia.
Guglielmo Peralta vive a Palermo. Ha pubblicato quattro sillogi poetiche: Il mondo in disuso, I.L.A. Palma, Palermo1969; Soaltà, Federico editore, Palermo 2001; Sognagione, The Lamp Art Edition, Palermo 2009 (pubblicata anche in versione e-Book da LaRecherche.it); Sul far della Poesia, SCe edizioni, febbraio 2022. Nel dicembre 2004 ha fondato la rivista monografica “della Soaltà”. Nel 2011 è uscito il romanzo H-ombre-S, pubblicato da Genesi Editrice. Ha vinto il Premio Cesare Pavese 2012 per la saggistica inedita con un saggio sull’Autore. Nel 2015 è uscito il saggio La via dello stupore nella visione est-etica della soaltà per le edizioni Thule; nel 2017 ha pubblicato Filigrane (saggi, critica letteraria e prose poetiche), Genesi editrice, e nel 2018 il saggio La società felice, Aletti editore. Per i tipi della Youcanprint, la versione teatrale del romanzo H-ombre-S col medesimo titolo.
1 - Nella teologia medievale, è la condizione di Dio, la cui perfezione consiste nell'avere in sé stesso il principio della sua esistenza.
2 - Gorgia, Sul non essere o sulla natura
Ivan Pozzoni, poesia inedita “L’epatite IVA”, nota di Ranieri Teti
Ivan Pozzoni propone una poesia invettiva di argomento finanziario. A tratti istrionica (l’epatite IVA, i ricorsi stoici, il catetere senza ipotenusa), a tratti con rime inaudite e con termini che probabilmente non abbiamo mai letto in un testo poetico, come lo “spread”.
D’altronde, “faremo poesia con tutto” ha scritto Pablo Neruda. E Pozzoni lo conferma.
Questa poesia si fa leggere volentieri nella sua velocità, il verso lungo soccorre il dettato, l’autore con ironia entra in temi che sono oggetto di storiche analisi. Come un flash, un blitz, un raid, un’incursione in versi entro un tema macroeconomico che rappresenta allo stesso tempo il piccolo cabotaggio di certa politica.
L’EPATITE IVA
Il contribuente italiano medio tra tasse, imposte e accise
subisce morsi e ricorsi stoici peggio che alla Corte d’Assise,
navigando sempre in cattive acque, lo hanno dichiarato santo
e contro le scottature da cartella esattoriale usa la tuta d’amianto.
L’epatite IVA è una malattia altamente contagiosa,
il cuneo fiscale ha la funzione di un catetere senza ipotenusa,
drenare liquidi dai buchi neri dei conti correnti non millanta
l’idea di far chinare concittadini sofferenti a quota Novanta.
La metafora del drenaggio, verso lo Stato italiano, non è balzana,
l’Agenzia delle Entrate ci rivolta i calzoni come indomita mezzana,
la malattia è ormai cronica, come terapia sedativa resta la flat tax
la calma piatta dei mercati internazionali non ci facilita il relax,
tra salvare 5.000.000 di italiani o incrementar lo spread
la scelta è tanto semplice che non ci vorrebbe un Dredd,
speriamo solo che un nuovo dottor Sottile non emetta prelievi forzati
sul 6‰ dei conti correnti dei soliti disgraziati.
Ivan Pozzoni è nato a Monza nel 1976. Ha diffuso molti articoli dedicati a filosofi italiani dell’Ottocento e del Novecento, e diversi contributi su etica e teoria del diritto del mondo antico; collabora con numerose riviste italiane e internazionali. Tra 2007 e 2018 sono uscite varie sue raccolte di versi: Underground e Riserva Indiana, con A&B Editrice, Versi Introversi, Androgini, Mostri, Galata morente, Carmina non dant damen, Scarti di magazzino, Qui gli austriaci sono più severi dei Borboni, Cherchez la troika e La malattia invettiva con Limina Mentis, Lame da rasoi, con Joker, Il guastatore, con Cleup, Patroclo non deve morire, con deComporre Edizioni; tra 2009 e 2018 ha curato una cinquantina di antologie di versi. Tra 2008 e 2018 ha curato cinquanta volumi collettivi di materia storiografico filosofica e letteraria; tra il 2009 e il 2018 sono usciti i suoi: Il pragmatismo analitico italiano di Mario Calderoni (IF Press), L’ontologia civica di Eraclito d’Efeso (Limina Mentis), Grecità marginale e suggestioni etico/giuridiche: i Presocratici (IF Press), Libertà in frammenti. La svolta di Benedetto Croce in Etica e politica (deComporre) e Il pragmatismo analitico italiano di Giovanni Vailati (Limina Mentis). È con-direttore, insieme ad Ambra Simeone, de Il Guastatore – Quaderni «neon»-avanguardisti; è direttore de L’Arrivista; è direttore esecutivo della rivista internazionale Información Filosófica; è, o è stato, direttore delle collane Esprit (Limina Mentis), Nidaba (Gilgamesh Edizioni) e Fuzzy (deComporre Edizioni).
Sofia Demetrula Rosati, dalla raccolta inedita “Aphaia, di colei che svanisce”, nota di Giorgio Bonacini
Poesia dell’inizio, potremmo definire questo poemetto, che mette al centro la nascita della lingua, nella consapevolezza di sé e del mondo, affinché non si debbano “lasciare parole prive di storia”. Così lo sguardo dell’autrice si colloca nel tempo mitico (ma ancora ben vivo nella sua dimensione di svolgimento, crescita e anche inabissamento) delle antenate: madri e figlie che sviluppano la tela della conoscenza come punto di pensiero poetico iniziale e finale. Un intreccio extra-ordinario di sensi che crescono in sinestesie vere e reali. Perché in questo movimento “la veggenza”, scrive Rosati, “percorreva la trama e l’urgenza era l’ordito”. Dunque una parola di sensi plurali, dove il linguaggio prende vita dagli occhi, poi dal suono, per dare voce a una poesia intrisa di colori e lampi mobili nel canto.
dalla sezione, οι μητέρες - e l’inizio era svolto nel suo nome
*
ci rivolgevamo agli alberi quando
le ossa perdevano il sostegno della tenerezza
mulinelli d’acqua sorgiva
si annidavano nel midollo spinale
la massa scheletrica appariva fluorescente
con piccoli coni di luce che
stillavano dai pori cutanei
eravamo pura meraviglia e non
somigliavamo a nulla
ci coglieva lo stupore quando
potevamo sfiorarci ed emettevamo
leggeri suoni bluastri
dal vago sapore di felci
il verde non era ancora stato codificato
vagavamo tra il giallo sole e il blu acqua
*
quando i suoni divennero parole
conoscemmo la memoria e la dimenticanza
le grosse maglie del tempo scesero fra noi
imparammo a tessere dai ragni
la veggenza percorreva la trama
l’urgenza era l’ordito
iniziammo a costruire templi e coltivare grano
piccole sfere di storia si andavano disponendo
οι κόρες - le figlie della narrazione non diventano madri
*
ma la mia gola non narra
e non si nutre
le parole scritte assumono la
forma paradossale di una verità
cosi antica che ormai non
importa piu a nessuno e tutto
e coperto di polvere
e non c’e piu un corpo a
testimoniare o ad accusare
tutto e diventato antenato
e io sono qui costretta nel
mio ruolo perche un varco
almeno si apra e possa
iniziare a nutrirmi
Sofia Demetrula Rosati vive a Roma. Collabora con varie riviste, tra cui “Poesia”, ed è presente con suoi testi su vari siti online. Ha pubblicato su svariate raccolte antologiche e partecipa a reading di poesia. Traduce poesia dal greco moderno.
Ha pubblicato il volume L’azione è un’estroversione del corpo, edito da Cierre Grafica nella collana di poesia Opera Prima, diretta da Flavio Ermini.
Giancarlo Stoccoro, dalla raccolta inedita "L’intuizione dell’alba", nota di Laura Caccia
La parola allo sguardo
Un distillato di pensiero, visione e parola nutre i testi della raccolta L’intuizione dell’alba di Giancarlo Stoccoro. Nei dialoghi sospesi tra luce e buio, voce e silenzio, finito e infinito, mondo e orizzonte, realtà e sogno. Che trovano un punto di contatto dello sguardo. Nel rispecchiarsi di visione e di sogno.
La visione: lo sguardo verso l’esterno, sul reale percepibile e proiettato oltre, su ciò che sta di fronte e al di là dell’orizzonte. Il sogno: lo sguardo verso l’interno, sul buio e sul silenzio, sull’ombra e sui gesti interiori, nel tentativo di “raccordare i giorni alla verità del sogno / accendere silenzi dove le parole divorano sguardi”.
In uno sguardo che non conosce divieti il desiderio si incunea come una breccia. E, insieme al desiderio, l’esercizio, per riuscire a tenere alta la possibilità di mantenere viva la visione sul buio e sull’oltre. E per riuscire, inseguendo l’oscurità, a non dimenticare il chiarore, così come, penetrando il visibile, a non scordare il principio.
Dalle parole che dominano e divorano sguardi, da portare a silenzio, Giancarlo Stoccoro sposta la sua visione e il suo sogno dando vita a parole poetiche che, sottovoce, si fanno sguardo: “Le parole sono occhi / con passo ebbro // non hanno voce spessa / seducono fessure minime”. Fessure che lasciano intravedere la realtà altra, barlumi che, nel buio, consentono di intuire l’alba.
Da: L’esercizio del mare
Negli abissi del cielo
raggiungi
la forma eterea del buio
Cicatrici di luce
richiedono attenzione
-----
Insegui l’esercizio del mare
quando esce dallo sguardo
le palpebre chiuse sotto il sole
conoscono la nebbia incollata al cielo
senza pratica di volo
Fai strage di passi
Salpa
-----
Come raccordare i giorni alla verità del sogno
accendere silenzi dove le parole divorano sguardi
modulare la bocca alla lingua dei baci
Occorrono temperature miti
sentieri contigui passi disciplinati
un orizzonte che carezza gli angoli
senza perdere l’intuizione dell’alba
Da: Fessure minime
Non so consigliare l’alba
c’era una volta dedizione
maggiore per l’incanto
Ora le luci si accendono
in qualsiasi anfratto
non resta che sposare radici
-----
Le parole sono occhi
con passo ebbro
non hanno voce spessa
seducono fessure minime
-----
Il mondo è uscito dallo sguardo
ma ti ostini a inseguirne l’ombra
Con una torcia fermi la via
dei gechi sul muro
-----
Nei territori dello sguardo
insiste il desiderio
una traccia verticale
scopre la breccia
dove l’infinito si distanzia
Giancarlo Stoccoro, nato a Milano nel 1963, è psichiatra e psicoterapeuta. Studioso di Georg Groddeck, ne ha curato e introdotto l’edizione italiana della biografia: Georg Groddeck Una vita, di W. Martynkewicz (IL Saggiatore, Milano, 2005). Da parecchi anni, oltre all’attività clinica, si occupa di formazione e conduce incontri sulla relazione medico-paziente secondo la metodica dei Gruppi Balint. Ha pubblicato diversi lavori su riviste scientifiche. Suo è il primo saggio che esplora il cinema associato al Social Dreaming (sognare sociale/ sognare assieme) che ha applicato in ambito sanitario, scolastico, nelle carceri e direttamente nei cinema: Occhi del sogno (Giovanni Fioriti editore, Roma, 2012).
Ha partecipato al premio Lerici Pea 1988, vincendo la medaglia nati dopo il 1958, con la poesia L’ombra dell’aquilone premiata da Giorgio Caproni. Sono state segnalate poesie su Lo Specchio della Stampa (2/12/06) nella rubrica “Scuola di Poesia” e in “Dialoghi in versi” (17/08/2007) da Maurizio Cucchi.
Per le edizioni Gattomerlino/Superstripes è uscito nel 2014 Il negozio degli affetti e in ebook, presso Morellini, Note di sguardo, tra le opere vincitrici del concorso internazionale Lago Gerundo 2014. È dell’aprile 2015 Benché non si sappia entrambi che vivere per Alla chiara fonte editore di Lugano. Nel settembre 2015 è uscito I registi della mente (Falsopiano, giugno 2015), curato da Ignazio Senatore, contenente il lavoro Ciak. Si sogna! L’esperienza di Kiev.
Nel novembre 2015 è arrivato tra i finalisti del 29° Premio internazionale Lorenzo Montano con la poesia inedita Non hanno scuse. Nel marzo 2016 si è classificato al secondo posto al Premio Torresano 2016 con la raccolta inedita La dimora dello sguardo, che otterrà la segnalazione speciale della giuria al Premio letterario Nazionale Scriviamo insieme (ottobre 2016) e la menzione al merito al Secondo Premio Internazionale Salvatore Quasimodo.
Parole a mio nome, è la silloge, edita c/o Il Convivio Editore, vincitrice del Premio Pietro Carrera (aprile 2016) e successivamente finalista del Premio Gozzano 2016 e al Premio Letterario Internazionale Indipendente (PLII) 2017 per l'opera edita.
Sempre del 2016 è il saggio da lui curato, Pierino Porcospino e l’analista selvaggio, con scritti inediti di Groddeck e di Ingeborg Bachmann e il contributo di autori vari per ADV Publishing House di Lugano.
Ha collaborato al secondo numero della rivista Poesia e conoscenza di Donatella Bisutti con il lavoro: “Brevi considerazioni sull'inconscio e la scrittura poetica”.
È vincitore del terzo premio Hombres Itinerante “Ignazio Silone” (giugno 2016) con la poesia inedita Si sommano i luoghi ai gesti alle frasi. E' finalista del Premio Museo Casa Alda Merini 2016 con la silloge inedita Luoghi ligi.
Ha ricevuto ancora nel 2016 una menzione speciale al 30° Premio Lorenzo Montano, per la raccolta inedita Luoghi d'ombra, poi riproposta con alcune variazioni e classificatasi terza al Premio Subiaco Città del Libro IV edizione, prima al Secondo Premio Internazionale Salvatore Quasimodo (1 aprile 2017), finalista al Premio Salvatore Piccoli 2016 e segnalazione al Premio Poetika 2017.
Nel gennaio 2017 è uscita l'ampia raccolta poetica Consulente del buio (1983-2013), con prefazione di Giovanni Tesio (L'Erudita, Roma, 2017), finalista al Premio Europa in Versi 2017.
Ha ricevuto la segnalazione della giuria del XIII Premio Hombres Itinerante 2017 per la silloge inedita “Estate autunno inverno” e la Segnalazione Particolare della Giuria del 42° Premio Casentino nella sezione poesia inedita.
È stato pubblicato per AnimaMundi di Otranto (settembre 2017) Alla corte dell'Es Poeti e prosatori, saggio da lui curato con il contributo di Donatella Bisutti, Franco Buffoni, Milo De Angelis, Alessandro Defilippi, Maria Grazia Calandrone, Laura Liberale, Franco Loi, Franca Mancinelli, Umberto Piersanti, Fabio Pusterla, Giovanna Rosadini, Francesca Serràgnoli, Miro Silvera, Giovanni Tesio.
È presente con 14 poesie e una prosa breve nell’antologia Mai la parola rimane sola del circolo letterario Acarya di Como (2017) ed è antologizzato ne Il segreto delle fragole 2018 e 2019 dell’editore Lietocolle (2017, 2018).
Ha ricevuto la menzione speciale per la raccolta inedita Incompiuti silenzi al 31° Premio Lorenzo Montano.
È vincitore assoluto della 5^ edizione del Premio Internazionale di poesia inedita “I colori dell’anima” (agosto 2017) con la silloge Forme d’ombra, pubblicata poi dall’associazione Mondo Fluttuante come plaquette e pubblicata in versione ampliata c/o Alla Chiara fonte editore di Lugano nell’aprile 2018. Ha ricevuto la segnalazione per la poesia inedita Pochi luoghi al Premio Guido Gozzano 2017.
Ha ricevuto la menzione d’onore al Premio Pier Paolo Pasolini – Il canto popolare 2017. È vincitore del secondo premio per la poesia singola e del terzo premio per il Sublime in luce al Premio Il Sublime 2017, poi inserite nell’antologia Il Sublime in versi e in prosa (Il Mondo Fluttuante, dicembre 2017).
Ha vinto il primo premio “Narrapoetando” con la silloge “La dimora dello sguardo”, edita da Fara Editore (aprile 2018), successivamente finalista al Premio Guido Gozzano 2018 e al Città di Como 2018, vincitore del secondo premio sezione poesia edita al Premio Internazionale Energia per la vita 2018. È finalista al Premio Letterario Internazionale Indipendente (PLII) 2018 per l'opera edita.
Ha ricevuto la menzione speciale per la raccolta inedita al 32° Premio Lorenzo Montano 2018.
È vincitore del concorso internazionale di poesia Altino 2018. Ha vinto il primo premio nelle sezioni B e C della 6^ edizione del Premio Internazionale di poesia inedita “I colori dell’anima” (agosto 2018). Ha ricevuto una menzione speciale per la raccolta inedita “la disciplina degli alberi” al Premio Lago Gerundo 2018, successivamente vincitrice della 4° edizione del Premio Nazionale Editoriale di Poesia “Arcipelago Itaca”, di prossima pubblicazione con la prefazione di Paolo Steffan presso l’editore La vita felice.
Ha partecipato al progetto di Poesia e Death Education “Inside (Me)” a cura di Laura Liberale, con 49 poeti italiani: http://endlife.psy.unipd.it
Versante Ripido, quadrimestrale di cultura poetica e letteraria (numero 3 settembre 2018), ospita “Esclusi dal palcoscenico” 6 poesie sul cinema e lo spettacolo. Collabora con la rivista trimestrale internazionale di cultura letteraria e poetica “il Menabò” di Stefano Iori per le edizioni Terre d’ulivo.
È vincitore del primo premio per l’insieme di poesie e dei secondi premi per le sezioni F e H al Premio Il Sublime 2018, poi inserite nell’antologia Il Sublime II^ (Il Mondo Fluttuante, dicembre 2018).
Ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Premio Ossi di Seppia 2019 (25° edizione) e sue poesie sono inserite nell’antologia Ossi di seppia 2019 Gli speciali I premi (Il Mondo Fluttuante, febbraio 2019).
È stata appena pubblicata, presso l’editore Oèdipus, la silloge Prove di arrendevolezza (febbraio 2019).
È attualmente finalista per l’opera edita al Premio Alda Merini di Brunate (7ma edizione) e tra i selezionati al Premio Bologna in lettere 2019. La raccolta inedita Forme del dono ha ricevuto la segnalazione presso la sezione B del Premio Bologna in lettere 2019.
Ultima pagina, Zona disforme: due trailer, una nota, le bio di Carlotta Cicci e Stefano Massari
DISFORME vuole affermare, ricordare, che viviamo in un incessante movimento, in un tempo relativo, dentro innumerevoli forme e dimensioni che non possono essere definite, concluse e sigillate, ma possono essere ininterrottamente percorse, accolte, congedate
DISFORME vuole scavare dentro l’altro lato delle cose, cercare le forze che si nascondono dietro le apparenze, e dietro la confortevole e ingannevole illusione di poter nominare qualsiasi cosa
DISFORME vuol dire ascolto, sguardo, possibilità, flessibilità, attenzione e sentimento di fronte alla forma, visibile e invisibile
DISFORME vuole sganciare le catene di ogni ordine, orizzontale o verticale che sia, per tornare nella pace del caos e dei suoi elementi, e rassicurare le anime che le origini di ogni singolo 'sentire', non sono un errore, un pericolo, un'anomalia, ma un nutrimento, di sé e dell'altro da sé
DISFORME il segno che vogliamo tracciare seguendo le tensioni di tutto ciò che dall'uno tende al molteplice, e che dal molteplice tende all'uno
in un continuo urto e flusso, in un ininterrotto incompiuto divenire
DISFORME cerca la prima nudità dello sguardo, davanti al nulla, davanti al tutto, davanti a specchi incrociati, davanti alla luce e al buio di ogni singolo giorno, interroga la circolarità dei sensi dentro la quale tutto sembra possibile
DISFORME è la prospettiva che nasce dai nostri sguardi uniti in questo piccolo luogo da dove abbiamo deciso di partire per attraversare insieme gli infiniti lati di questo mondo, generando tele esistenziali, cercando e scavando la preziosità di ogni forma possibile, visibile e invisibile, piccola e grande che sia
DISFORME è la scelta, il desiderio, l'inevitabilità di dover entrare nella tensione intima che muove ogni forma, che muove il prima e il dopo di ogni cosa, che genera il punto dove evento e essenza delle cose per un attimo coincidono
DISFORME è il nostro punto di vista, la nostra mutevole empatia con l'esistente, il costante tentativo di interrogare il destino, individuale e collettivo, è il nostro punto di estinzione, il nostro rinascere continuo.
Qui le bio degli autori Carlotta Cicci e Stefano Massari:
E qui una bella intervista di Francesco Tomada:
Novembre 2022, anno XIX, numero 52

Apriamo questo numero con una nota di Laura Caccia sul primo libro della nuova collana di Anterem edizioni, Piccola Biblioteca: “Anacronia / Blood” di Allì Caracciolo.
Mentre qui in premessa citiamo un pensiero ancora inedito di Flavio Ermini: “La parola poetica è determinata dal pericolo che essa affronta più che dal servizio alla vita. Il carattere della sua figura è del tutto astorico, e come tale annuncia un guardare senza io e un amare senza oggetto; annuncia ciò che crea durata senza misurazione, l’intrecciarsi prodigioso del grido con l’ammutolire”.
Senza misurazione, e nella durata della poesia che vale, nel presente numero di “Carte nel vento” riapriamo libri di anni fa, protagonisti al “Montano” 2019, e testi allora inediti (alcuni nel frattempo pubblicati): Leopoldo Attolico, Claudia Azzola, Franca Maria Catri, René Corona, Gerardo De Stefano, Carlo Giacobbi, Angela Greco, Fernando Lena, Carmine Lubrano, Andrea Marinucci, Paola Nasti, Paola Parolin, Antonio Pietropaoli, Federico Edgar Pucci, Alessandro Ramberti, Giovanna Cristina Vivinetto sono oggi con noi.
La copertina è dedicata ad Alberta Pellacani, sempre al lavoro sul versante visivo, e da molti anni attiva anche con il “nostro” Giorgio Bonacini: la loro collaborazione ha portato, nel 1998, allo splendido volume Falle Farfalle. Qui una loro precedente produzione.
Tra non molto avremo il bando della nuova edizione del “Montano”, che porterà altri libri da pubblicare e testi sui quali lavorare con molto piacere.
In copertina: Alberta Pellacani, In-con-sistenze (1990, con Giorgio Bonacini)
Ranieri Teti
Laura Caccia su “Anacronia / Blood” di Allì Caracciolo
Il silenzio e il sangue della parola


Cercare una lingua oltre. Lasciandone affiorare la potenza intrinseca nella sospensione del dire, nell’omissione della parola. Attraverso, potrebbe apparire un ossimoro, una scrittura fitta e compressa che nulla tralascia, in ogni sua metamorfosi, della realtà della vita e della violenza umana. Esponendone il verso e il sommerso. Una parola oltre. Che penetra nei corpi smembrati e nel corpo, anch’esso smembrato, della scrittura. Misurandosi con l’anacronia, il silenzio, la morte. Una lingua per il sangue e per la morte, impregnata di tonalità che si spatolano dal rosso vivo al nero. Una lingua per il silenzio, che irrompe all’improvviso con il suo chiarore, la sua luce superstite. La mestica della scrittura di Allì Caracciolo in Anacronia-Blood appare intrisa di scarlatto e carminio, con qualche muto biancore. La stesura, in parte fluida e serrata, in parte densa e lenta, asseconda l’imprimitura della pagina. Dal tono di un’apocalisse. Di un disvelamento. Con la premessa della sua inarrivabilità. Poiché «Ineffabile è il sangue. La parola che lo scrive si cancella per non venire pronunciata».
Inaugurare la nuova collana delle edizioni Anterem con Anacronia-Blood di Allì Caracciolo è come dare voce, insieme, al silenzio e al sangue della parola. Testimoniare la ferita da cui l’inchiostro attinge le radici, la lacerazione che ne connota il verso. E, insieme, il silenzio e il vuoto che si fanno luoghi di raccolta del senso. Il corpo, il sangue, la carne nella loro esposizione e decostruzione. Come la scrittura. Poiché scrivere, ne è convinto Jean-Luc Nancy, tocca il corpo: un corpo organico di carne e sangue che si muove nella tensione tra il suo essere dentro e il suo esporsi al fuori, fino a fare del corpo teatro. Qui, tuttavia, alla fisicità del corpo e del sangue fa da controscena il silenzio. Il sangue del silenzio. E il silenzio del sangue. Come leggiamo in Blood: «Solo il silenzio stabilisce la misura del sangue. Il silenzio del sangue è la estrema vicissitudine della morte». E, a specchio, in Anacronia: «Riflettere sulle parole che la scrittura pronuncia, ascetica declinazione affettiva della Phoné, è fare della morte qualcosa che può esprimersi anche in altra forma; è l’atto estremo, e massimamente pericoloso, di silenzio».
In Blood il sangue pervade tutto: la vita e la morte, la parola e il silenzio, la conoscenza e il vuoto. E ognuno di questi elementi si fa pervasivo da un altro punto di vista, facendosi sangue e il sangue, a sua volta, coincidendovi. La distinzione, nell’etimo, del sangue fluido e sottile, sanguis con radice sanguĕn, da quello denso, cruor, invece raggrumato poiché sgorgato da una ferita, dà conto della pluralità delle coloriture di questa scrittura. Il rosso e il nero, la vita e la morte. Dipinte di rosso sono le ombre vermiglie, la colatura di sangue, la notte scarlatta, il tramonto, l’oceano. Di nero le parole oscure, il corpo del buio, le teste nere, i rantoli scuri. Mentre inattesa una luce improvvisa si affaccia su un petalo galleggiante, nel chiarore del margine del foglio, su una mano che sbianca. La tavolozza suggerisce visioni caravaggesche, la pervasività del sangue immagini shakespeariane del Macbeth. Qui, però, insieme al trattare una materia cruenta e sanguigna, la scrittura mette in scena se stessa. La rappresentazione la riguarda. Senza preoccupazioni metalinguistiche. Decostruendo, in un duplice scenario, le trame di un muto invisibile e di un brutale visibile. Il corpo a corpo tra il poetico e l’impoetico.
Mentre in superficie la fenomenologia del sangue pervade la pagina nei suoi novantanove quadri fino all’Uno, non messo in atto, che la farebbe traboccare, la tensione tra le due polarità non smette di pulsare. Mantenendo, sulla «soglia di opposti simultanei, l’indistinguibile differenza, figure d’inaccessibile indifferenziato». Nella scrittura leggibile la cognizione, assillante, del sangue se pure «avversa la dissuasione a far poesia (su argomento tanto oscuro e bestiale) perviene a una sospensione (perplessa e inquietante) ove tutto si azzera: la condanna del male la ricerca del vero la sapiente perizia l’impellente misura». Nella scrittura latente la poesia continua a pulsare. Insieme al vuoto in cui trova voce. Insieme al silenzio con cui scorre carsicamente nel profondo. Un profondo che attiene al sé più intimo, legato strettamente, da un lato, agli aspetti vitali e pulsionali e, dall’altro, al silenzio e alla morte. Dove la parola poetica affonda le radici. Il sangue e la poesia: se da un lato «la poesia non riscatta il sangue», dall’altro anche «la poesia è un sangue Da non vendicare Da rivendicare soltanto».
Uno scarto tra la realtà e il reale, tra il tempo misurato e l’assenza di un ordine temporale, tra l’insensatezza della violenza umana e la ricerca di un senso dell’esistere. Andando letteralmente a pezzi. Attraversando eccidi, corpicidi e pensiericidi, corpi e paesaggi smembrati, pensieri e inchiostri sembrati, seppellimenti e memoria dei defunti. Quadri, alcune volte trittici, di sangue e di morte che si susseguono per dare forma a quanto non ha forma o della forma è stato fatto strazio. Alla ricerca di una consapevolezza di morte e, grazie alla stessa, di essere. E di una possibile rinascita: «Adattarsi ai passaggi è la cosa maggiormente estenuante del nascere del morire del rinascere se c’è, del risorgere se si risorge». Attraversando una metamorfosi difficile, una dura trasformazione, nel disgregarsi di materia e pensiero. Così, in Anacronia, dove i passaggi si fanno sfumati tra «l’incomparabile dissolvenza nel deessere senza mai pervenire a nonessere» e «la parallela distanza tra vivere nonvivere, essere indistinguibilmente entrambe le realtà senza esserne alcuna, il vuoto». E in Blood dove, al termine delle terribili mutazioni richieste dal duro confronto con il sangue e con la morte, si trova alla fine un modo di risorgere, nell’«attendere alla vita con la leggera movenza l’avveduta scienza di nascere ogni giorno con stupore».
La scrittura, da un lato, asseconda il sangue nel suo espandersi diversificato, a fiotti, ininterrotto, raggrumato, dall’altro crea scena al silenzio. Nel suo teatro del visibile e dell’invisibile. Scenografie destrutturate per dare luce al sommerso. Quanto in Anacronia, prosa vincitrice nella relativa sezione del premio Lorenzo Montano XXXV edizione, viene evidenziato, rispetto alla discrepanza tra la temporalità apparente e l’aleatorietà sottostante, in Blood viene messo in atto in una decostruzione della scrittura dove l’imprevedibilità consente al sotterraneo di manifestarsi, pur in una trama fittissima e compressa. E al silenzio di farsi udire. Non solo e non tanto in quello che viene esposto e messo in scena. Quanto attraverso il non verbale, a partire dalla grafica: «Ciò che conta è la grafica: potente esce fuori dal foglio schizza di sangue il volto di chi legge». E, a fondale, attraverso la pagina: «Poi il sereno margine finale, immacolato e bianco, ignora gli altri tre quarti di foglio, la storia che a calde macchie il disegnatore vi ha versato». Soprattutto, però, attraverso i paragrafemi, le irregolari interpunzioni, gli spazi diversificati tra le parole. Nel vuoto in controscena al clamore. Nel luogo non-luogo della scrittura poetica. Che dà spazio al silenzio. E, insieme al silenzio, all’essere. Poiché come viene sussurrato, tra parentesi, in Anacronia, «solo la scrittura rasenta l’essere».
In questo esporsi. Porsi fuori. Porsi oltre. In una scrittura che ha a cuore l’essere e la parola. E, massimamente, il silenzio. Superando le distinzioni di genere, in una ricerca che nulla concede al sollievo, Allì Caracciolo crea spazio in queste prose al pulsare muto della parola poetica. Una parola che nasce dal sangue di una ferita e rinasce nelle mutazioni che ne vengono generate. Una parola che trova luogo dove la scrittura concede lo scenario al vuoto, pur nel fitto estremo del suo dire. Potrebbe sembrare un ossimoro, si è detto in premessa. Piuttosto appare la condizione necessaria di fronte alla violenza e alle contraddizioni umane che fanno strazio, insieme ai corpi, della parola. Nella ricerca di una lingua che rivendichi un luogo per la parola poetica. Una lingua che ne metta in luce la linfa sanguigna e vitale. E, insieme, il suo dire muto, anacronico.
Leopoldo Attolico, da “Si fa per dire” (Tutte le poesie 1964-2016), Marco Saya 2018, nota di Mara Cini
Note brevissime per un volume che raccoglie oltre cinquant’anni di lavoro di Leopoldo Attolico. Un volume “importante” dove si trovano riunite molte raccolte pubblicate, diversi inediti, una notevole bibliografia critica…
Note brevissime allora, come un sorvolare sulle pagine. La veloce cattura di suggestioni trovata nelle prime poesie di “Piccolo spacciatore” dove la parola appare, anche, come cosa da celare, da serbare in un vano, eternamente. In quel rifugio, in quel rifiuto di un dire esplicito, ci si potrà trovare, ancora, tesori. Tra accenni a certe fisicità percettive, a comuni, feriali, vicissitudini o a più private esperienze, ci si potrà ritrovare in una gemma nera.
E’ questa offerta di un mistero non chiarito il senso della parola e, di più, della parola di poesia (la gemma nera, appunto). Il concentrato di significati che sta nell’ambra di un ricordo non è però soltanto messaggio cifrato se si è impegnati, con ironia, anche, a farlo ritornare sillaba sulla terra. Con la consapevolezza, comunque, di essere sempre in bilico tra quello che si riesce a dire e quello che accade, improvviso, unico, inafferrabile, tra scintille di memorie e oro del presente.
ETERNAMENTE
Incagliata nel tempo
c’è una gemma nera,
un’eco che non ritorna,
un’offerta di mistero non chiarito.
Nella fisicità felice di un volo
e nell’ambra di un ricordo
la percezione dell’immenso,
del tempo, della vita.
Nella speranza di sole
la necessità di non morire,
di non morire più,
di restare eternamente giovane
I VERSI
C’è dentro
l’abitudine calata a perdifiato
nel chiamarsi per nome,
storia grande di occhi e di stupore
in visita a un diario affogato nel mare.
Dal fondo si contrae sempre una nota
e ogni volta si scorda del suo peso
per ritornare sillaba sulla terra.
Non ha più nulla:
persuasione, durata, vento di vittoria;
chiede soltanto di non essere delusa.
Non più di tanto
nel lasciarla andare
gli ha promesso
tutelare
l’innocenza
TOCCATA E FUGA
Nella pietra serena scaldata dal sole,
nel pianissimo andante del vento
a capofitto le mie parole
Basta una fredda scintilla alla memoria,
che come ape infreddolita si posa per terra,
per riscaldarsi tutta
Ma l’ape beve la sua pace e non si pente.
Le parole sono solo una folla curiosa e satolla,
toccata e fuga nell’oro del presente
Leopoldo Attolico vive a Roma. Dalla seconda metà degli anni 80 si è occupato di poesia performativa antistress, nutrita di leggerezza lessicale, giocosità, ironia/autoironia e senso del paradosso. Suoi interventi sono apparsi in antologie, repertori, quotidiani e nelle principali riviste letterarie italiane. Una scelta significativa dei suoi testi è stata pubblicata presso Chelsea, New York, 2004. È stato tra i redattori di Poiesis e lo è attualmente di Capoverso.
Claudia Azzola, da “Il mondo vivibile”, La Vita Felice 2016, nota di Mara Cini
Mi piace rintracciare nelle stesse parole dell’autrice, in ciò che lei ha versato sul foglio come atto di vita, qualche nota di ciò che la poesia è: una carta istoriata, una terra di confine, materia da rammendo…
Claudia Azzola, sulla pagina bianca aperta alla scrittura, ripercorre l’interrogarsi del poeta sul significato del proprio lavoro, questo atto “friabile” come lo sbriciolarsi della carta nel tempo che pure, nel tempo appunto, connette elementi della nostra memoria antropologica, di civiltà e di pensiero.
Così come è stata individuata una “storia con la s minuscola”, c’è, forse una “parola con la p minuscola”. Al canto alto della parola letteraria si accompagna una parola “approssimativa” ma altrettanto vitale poiché, dice Azzola, non vi sono cose estranee alla poesia.
Perché il gesto del poeta, attento ad ogni vibrazione, scruta e accompagna la curvatura del reale.
GIARDINO A HAMMERSMITH*
Fin dai tempi (operanti) delle streghe,
witches, healers, guaritrici, sono
i fatti avvenuti ai confini: metto
me stessa in questa terra, del confine,
breccia di giardino scavata per la tortora,
per la gazza, le rose,
percorsa dalle granulari formiche,
istoriata terra come di magna carta
su papiri, pergamena e cearlacca,
non c’è giardino
senza nascosto suono d’acqua,
there is no garden void of sound
of hidden water: sono venuta qui
per questo verde.
Non c’è giardino
dei nichilisti, non c’è verde di afasia.
Non c’è giardino senza il verde dell’esilio.
Tanto è preparato,
tanto avviene nell’esilio.
*Londra, mese di luglio, anno su anno.
NELLA DISPERSIONE DEL SEME
Nicchiare, essere dei morti,
rimpinguare le casse: mancano
i giardini, gli orti dorati,
male pagato il lavoro umano,
sparato dalle bocche di fuoco,
nella dispersione del seme,
ma se traboccavano i cuori! era
il progetto, era riconoscimento,
il lavoro è disperso, nel vento,
perdere il senno, il foro interiore,
cuore insonne, materia da rammendo.
TRE PASSI
Tre passi per allontanarmi
dalle bottiglie dai bicchieri
della mensa, dai tavoli di fòrmica,
trecento passi per la distanza
dalla fabbrica, dai manufatti esausti,
dal fatturato, dal posto fisso,
dal pensiero sfiorito, abito stretto,
svestito nel freddo, mesto lavoro,
e pongo domande: quali sono coloro
che hanno la faccia che sia la loro,
che la riconoscano da dentro
l’ingranaggio meticoloso,
delle tue ore dei sacrosanti minuti,
nei passi che sono il tuo giardino.
Oggi è una domenica, una sapienza
per chi sa formulare un dire,
ma sto tra due oscurità,
della lingua e dello stretto sentire.
Claudia Azzola, scrittrice e traduttrice. Tra le sue pubblicazioni Il poema incessante (2007), La veglia d’arte (2012), Parlare a Gwinda (2014). Azzola edita da oltre un decennio l’annuario plurilingue Traduzionetradizione.
Franca Maria Catri, da “Ti chiedo al vento”, Cierre Grafica 1017, nota di Mara Cini
Fra il tempo quotidiano degli orologi e il tempo ciclico, sacro, delle stagioni, con passi di sola andatastrong>, si dipana la nostra esistenza terrena.
La scrittura di Franca Maria Catri esplora questi diversi tempi e le loro differenti coloriture, che ci trovano sempre strong>dove non siamo.
Con precisione Flavio Ermini parla a proposito di questi testi di “…ricerca dell’essere che tra la vita e la morte si distende e lì permane, irraggiungibile ad ogni richiamo che non sia quello poetico”.
Nel pugno della materia e dei giorni, forse, strong>il nero vincestrong> … ma è un nero/bruno di terra che germoglia di domande, di ricordi, di odori e di stupori che sempre ci interrogano.
sarà che insonnia
cova scartate storie
arrugginiti arnesi di memoria
ecco che il sogno
entra nel gioco
forza barriere chiama
zitte parole in grazia di note
spazi arroganti di insolente vero
a fermo immagine
oscilla segni il piano perfetto
– in onda è quasi chiaro
asciuga pianti il mare
gocce di sale
e petali di sole tra le ciglia
nel pugno
in fondo al giorno
mangia colori
la penombra degli occhi
(chiedi alla gatta)
per dolce sordità
mi riconosco
in sillabe di fumo
e malincuore
oltre la stanca opacità delle tende
resiste la rosa sopita
nella sera dell’orto
è l’ora delle ortiche
ti chiedo al vento
ti chiedo al vento
respiro gentile che sfiora il mare
scioglie le onde in farfalle di sole
in campo azzurro
pascola nuvole piccole
innamorato accarezza
la luna d’agosto
va sui pini e le rose
si culla sui prati
allaccia case
in confidenza di finestre
odore di pane
e favole antiche
ti chiedo al vento
generoso che lega terre e distanze
racconta voci e silenzi
a medicare sconfinate solitudini
Franca Maria Catri è nata nel 1931 a Roma. Scomparsa nel 2021, ha lavorato per molti anni come medico. Ha ottenuto autorevoli giudizi critici, presenze in antologie e testi di poesia contemporanea, premi di poesia e saggistica a livello nazionale e internazionale. Tra le pubblicazioni più recenti: strong>Uccelli di passostrong>, Gazebo 2013; strong>Ti chiedo al ventostrong> (2018).
René Corona, da “Compitare nei cortili”, puntoacapo 2019, nota di Rosa Pierno
Nulla esiste nel presente che non rechi traccia di ciò che è passato e che pure, resta lì infitto, a dare profondità all’insignificanza, valore al transeunte. Anzi sembra fornire un’incrollabile sicurezza la polvere che si accumula e che testimonia della possibilità di leggere, negli eventi più insignificanti, il valore che assumeranno nella totalità di ciò che è trascorso. Tale garanzia si estende al punto che diventano riscontrabili “le stesse malinconie/ la stessa acqua”. Il movimento della raccolta coincide con quello di un tango, ove la passione è un movimento di risulta, un reperto che va alla deriva. E via via è il linguaggio che assedia la scena fino a risultare l’unico convenuto: “ossimoro / e sfuggevoli metafore/ chiamarti dalle terre lutulenti”. Nulla risponde al richiamo, se non le parole con le quali il passato ritorna. Ritessuto. D’altra parte, il passato è una ricostruzione che con la realtà condivide sempre meno, con l’aumentare del tempo. È sull’onda del linguaggio che Corona, sulle orme di Baudelaire, riserva il suo sguardo ad alcuni risvolti della contemporaneità, non mancando di offrircene una critica serrata e tagliente, in un tentativo di recupero di alcune valenze che non può che naufragare, ma che non si può nemmeno evitare di compiere.
certami
le tue pantraccole da sgherro vigile
fanno scompisciare dalle risate il mio animo peritoso
ma alla mia musa non arrivi nemmeno ai talloni
figurarsi ai suoi stivali gatteschi
la tua mente fumida
certo si può rallegrare di tale ferace
vigilanza notturna
ma sappi che
il mio sonno è irenico e le mie notti portano sempre consigli
è questo il vero riposo del guerriero
raumilia anche i cuori più tortuosi di una viottola bagascia
come il tuo
vita vissuta nel tentativo di fermare il tempo
tagliaborse attaccabrighe perditempo
cavadenti strizzacervelli
fannulloni bighelloni scansafatiche perdigiorno
stracca piazze
tirapiedi leccapiedi baciapile pinzocheri bacchettoni
bigotti
capibastone magnaccioni mangiapreti
mangiacrauti mangiarosbif mangiarane macaroni
mi attaccavano bottone per un nonnulla
io avevo altri grattacapi
bancarotte sentimentali
disfunzioni poetiche
rendiconti inutili da stilare
ma non trovavo le parole giuste
per mandarli a quel paese
presi così l’ultimo treno della sera
e al primo passaggio a livello
attraversai e me ne andai
nel frattempo le rose morivano sui marciapiedi
e nel grande vaso annegato nell’acquaio
alcuni tulipani sbocciarono
appena in tempo per il grande rientro
dell’autunno
con anemoni e azalee nella cartella
(e voti di condotta pessimi)
e una matita spezzata per chiudere
con un tratto longilineo obliquo
indeciso
ma preciso
come una freccia nel batticuore
René Corona è docente di Lingua e traduzione francese, presso il Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell’Università degli Studi di Messina. Ha pubblicato saggi che riguardano la poetica, la storia della lingua francese, la traduzione, la sinonimia, la letteratura, la sociolinguistica e la lessicografia. È autore di due romanzi e di diversi libri di poesia.
Gerardo De Stefano, poesia inedita “Anadioménon”, nota di Ranieri Teti
Gerardo De Stefano si misura con un verso lunghissimo di difficile fattura: tanto è enorme, debordante e ipertrofica la materia testuale, quanto è levigata all’inverosimile, curata in ogni minimo particolare, la parola che la sostiene. Siamo di fronte a un testo che mentre lo leggiamo ci guarda dal passato, ci guida nel presente, ci porta verso il futuro; siamo di fronte a un testo che non si risparmia e non risparmia digressioni nello sconvolto ambiente naturale, quasi celate nei versi e allo stesso tempo manifeste. Tutto è coerente con l’impianto verbale.
Gli inserti da altre lingue, che contribuiscono a rendere universale il testo, sono citazioni originali di grandi autori; come il titolo, che riprende quello di un saggio sull’arte di Alberto Savinio. Alcuni scarti testuali, repentini cambiamenti di senso, inserimenti stranianti, aprono la porta e rendono omaggio a tanta arte e a tanta poesia di inarrivabile grandezza del novecento.



Gerardo de Stefano nasce a Napoli nel 1976.
Nel 2012 esce, per la Thauma Edizioni di Pesaro, la sua prima raccolta di poesie: “Stigmate & Stilemi”. È il curatore della collana RigorMortis (Memoranda Editore, Massa).
Carlo Giacobbi, da “Veramente quest’uomo”, Arcipelago Itaca 2018, nota di Rosa Pierno
Una riscrittura del Vangelo che è volontà di vivere l’esperienza diretta del discepolo, assumendo varie vesti, volendo sperimentare la potenza della parola nell’animo umano, non solo ripercorrerla, ma anche ricrearla. Ecco, perché se la voce autoriale sembra esterna, lo è solo artificiosamente. Ogni quadro è un prezioso cesello, una calibrata scelta di lessemi astratti che configurano la flagranza tra la miseria del reale e la spiritualità: “la tua cura è clemenza”. Fra mensa ed Eterno, tra caduta e fede, ancor più che l’oscillazione tra concreto e astratto, si deve mettere in rilievo il moto tra “non invoco e non dispero” che è in qualche modo lo stato dell’incredulità rispetto a ciò che appare una sfida che si desidera accettare pur non sentendosene le forze. La richiesta di perdono si pone come un ulteriore movimento nel testo che si disloca secondo un dialogo complesso. Se la Grazia non si riesce ad arginare, non si può nemmeno comunicare ad altri, affinché lo condividano. Resta il baratro fra ciò che Giacobbi sente come potenza infinita della parola di Cristo e limiti di coloro che ascoltano.
Peregrinazioni apostoliche
(Mac 1, 35-39)
È ancora buio
ma muovi il passo
a lungo appartato -
in ascolto.
Non presti adesione
all’invito dei tuoi -
sei già altrove
rifuggi delle folle il plauso
ti sottrai
per fugare del ministero
la mistificazione.
Guarigione di un sordomuto
(Mc 7, 31-37)
Parola non fa ingresso
né s’esterna.
Starà chiedendo accanto
la tua mano
chi mi porta.
Mi conduci lontano -
ed in me ripeti
la creazione
con un fiato al cielo
che spalanca.
Carlo Giacobbi (1974) lavora a Rieti come avvocato, ma fin dalla prima giovinezza ha manifestato interesse per la poesia, la letteratura, il teatro, la musica ed il canto. Scrive canzoni di musica pop e ha collaborato insieme al Maestro Massimo Di Vecchio alla realizzazione di diversi cd musicali di musica leggera anche a tema religioso. Ha partecipato due volte al Festival di Castrocaro Terme, giungendo alle semifinali. Ha pubblicato quattro libri di poesia: L’Angelo Dannato (Hobo Editore, 2006), Albe notturne (Serarcangeli Editore, 2015), Confidenze (Il Convivio Editore, 2016) Essere qui (Il Convivio Editore, 2017) e nel 2018, con Arcipelago Itaca Editore, Veramente quest’uomo (poesie sul Vangelo di Marco) di cui, alcuni estratti, sono stati letti alla presenza del vescovo Domenico Pompili in occasione dell’incontro pastorale del 2018.
Angela Greco, dalla raccolta inedita "Claire (della solitudine e altri ritorni)", nota di Laura Caccia
Della poesia e altri oltre
Nome colmo d’aria, un soffio, un vento, una voce. Nome intriso di luce, un chiarore, un foglio bianco. Chi è Claire, personaggio dell’omonima raccolta di Angela Greco?
Tra solitudini e presenze, affetti lontani e vicini, oltranze e “profumo di pane”, memorie e ritorni, Claire distende la sua figura luminosa, dai movimenti reali e irreali, nei sedici testi dall’accento visionario, con distico finale spesso di tono meditativo.
Il linguaggio è ricercato e straniante. La narrazione procede tra reale e surreale, presenza e solitudine, ricordo e abbandono. Leggiamo che “Claire è soglia e attesa. Di una voce che / tarderà nei suoi desideri” e il racconto si illumina nel suo rarefarsi, quasi favola, quasi mito. Non dimenticando riflessioni concentrate e inquiete sulla realtà, in cui “Siamo canti alternati a idi di marzo”.
E se Claire fosse la poesia? Che si aggira “tra le parole non dette” e che “vorrebbe esserti foglio bianco”? Compagna della solitudine che la scrittura richiede, forse. O incarnazione del dire poetico che Angela Greco dispiega nei suoi versi insieme luminosi e dolenti. Dando vita a figure che l’attraversano e ne vengono attraversate. Designando con nomi nuovi le cose. Portando il quotidiano al suo oltre, dove “rette parallele s’incontrano e s’intersecano / in un territorio di confine, oltrepassando il noto fin qui”.
§1
Il pomeriggio è un talismano di ferro e ruggine;
lo raccolgo in un silenzio surreale e sei con me.
Un caso e “Claire” torna a passi lenti, attraversando
la cicatrice che taglia in due la città. Il paese vecchio
la abita ad ogni casa a calce e la piazza ha ancora
il profumo buono di tortine alla ricotta e biscotti
grandi, da immergere, senza troppo pensarci,
nella merenda a ginocchia scoperte di cadute
in bicicletta. Dall’altra parte della strada,
con anni d’anticipo, già sapevi che domani
l’avresti incontrata, per caso, sulla stessa strada.
Il nome non ha importanza; hai sempre pensato
si chiamasse alla francese, forse per via di sua madre.
§2
S’aggira Claire tra le parole non dette, tetti di vecchie
memorie silenziate per antica abitudine; stringono,
i vicoli del quotidiano incedere, gli occhi che anelano
all’azzurro di quando si era fili tra i fili d’erba, acque
di gocciolanti gravine nascoste agli occhi dei più.
Vorrebbe esserti foglio bianco a cui affidare le ombre,
inchiostro che inciti i cavalli di fuoco, perché sia sole,
anche tra le tue nuvole. T’affianca, nell’attesa, nei vuoti
della piazza dove s’allungano le ombre; mulinellano
pensieri sulla soglia di casa. Nel pacco regalo, una clessidra
dice che si può capovolgere questo momento.
Due rette parallele s’incontrano e s’intersecano
in un territorio di confine, oltrepassando il noto fin qui.
§5
Miriadi di stelle a trafiggere una solitudine;
questo incavo incolmo che occupa il petto,
dissonanti sere racchiuse in una fotografia e
poi mattini di ritrovato senso. Claire ha pianto,
ma tu ne hai sentito la risata, invece, poco pima
che crollasse il tempo e s’affacciasse ancora la corsa,
la sabbia troppo veloce nella strozzatura, lo scadere
della concessione a noi dedicata. Il resto è stato cielo
a più strati di piombo. Sei involontariamente bello,
quando non ti accorgi dell’occhio, lontano, nel tuo
mare di bambino senza onde a sconvolgerti.
Lo specchio rimanda a data da destinarsi le parole;
adesso il ricordo è soltanto per carezze lontanissime.
§16
E, quindi, cosa lascio di questi miei trascorsi?
Un’addolorata sbiadita al crocevia, un cancello
chiuso che ha ceduto alla ruggine e una fenditura
d’asfalto fiorita di parole in un giorno di febbraio.
Claire si ferma e guarda la tramontana che azzurra.
Il vento arriccia il tufo e lame di luce seguono
diagonali di pensieri e facciate divise a metà.
«Portami una bocca di leone dal tetto più alto,
scala questa torre di quotidianità per un pezzo di
mondo da mordere a sera, quando la voce va via e
rimaniamo pensierosi sul rosa e sulla nuova luce».
Siede al tavolo l’attesa; dalla finestra il paese vecchio
si svuota persino di preti e campane.
Angela Greco è nata il primo maggio del ‘76 a Massafra (TA). Ha pubblicato: in prosa, Ritratto di ragazza allo specchio (racconti, Ed.Lupo, 2008); in poesia: A sensi congiunti (Ed.Smasher, 2012); Arabeschi incisi dal sole (Terra d’ulivi, 2013); Personale Eden (La Vita Felice, 2015; prefazione di Rita Pacilio); Attraversandomi (Limina Mentis, 2015); Anamòrfosi (Progetto Cultura, Roma, 2017; prefazione di Giorgio Linguaglossa); Correnti contrarie (Ed.Ensemble, Roma, 2017); Ora nuda, antologia 2010-2017 (Quaderni di RebStein LXVII, 2017); Ancora Barabba (Collezione Bocche Naufraghe, YCP, 2018); All’oscuro dei voyeur (YCP, 2019, prefazione di Franco Pappalardo La Rosa).
È ideatrice e curatrice del collettivo di poesia, arte e dintorni Il sasso nello stagno di AnGre (http://ilsassonellostagno.wordpress.com/). Commenti e note critiche sono reperibili all’indirizzo https://angelagreco76.wordpress.com/.
Fernando Lena, da “La profezia dei voli”, Archilibri 2016, nota di Rosa Pierno
La necessità di esporre l’irrapresentabile di una esperienza durissima trova un valido aiuto in uno stile preciso e in una sintassi piana e ferma, come se con tale armamentario stilistico si potesse guardare con maggior fermezza nelle pieghe purulente di una realtà che ha pochi confronti. Lena punta il timone con decisione verso il dolore per affondarvi il suo sguardo. Ma il suo sguardo non diviene mai un cliché, non è mai pietistico, avendo dalla sua la ragione di colui che parla del dolore poiché vi è immerso. Forse non è inverosimile che si possa superare qualcosa soltanto toccando il fondo. Il poeta riesce a darsi magnifici colpi di reni con sinestesie e metafore che rilanciano la possibilità di agganciare significati che riequilibrano una realtà che Lena sa esistere al di là del muro. Come Ulisse legato all’albero, affronta il terribile silenzio “incomprensibile” che tanta poesia odierna, immotivatamente invoca. Vedere la realtà frantumata, in zolle, come se un vomere vi avesse affondato la lama, va di pari passo con il vederla reintegrata attraverso la capacità autoriale di modellare uno stile che riesce a cogliere le drammatiche oscillazioni di una condizione esistenziale difficilissima.
XVII
Suor Adelaide da vent’anni
aspetta un miracolo
ne parla spesso con Dio
invocando una deriva dolce
per queste cavie
qualche anno fa
ha rischiato di morire
dopo essere stata aggredita
dal suo discepolo più giovane.
Per giorni è rimasta in coma
poi appena sveglia…con un sorriso
ha esclamato che Aversa
non sarà mai
il capoluogo dell’inferno.
XXI
Neppure una parola,
sono ormai cinque anni che Lisa
ha smesso di dirci
quello che la schizofrenia
mette in bocca a donne
fragili come lei.
Il suo tacito presente
fai fatica a comprenderlo
appena sai che è stata
in adolescenza un tenore,
se poi trema quando la musica
dei miei sguardi sfiora
i suoi ricordi … allora capisci
come mantenere l’ equilibrio
sul rasoio della creatività
diventa a volte una ferita corale.
Fernando Lena è nato a Comiso in Sicilia nel 1969 dove da un po’ di anni vive e lavora. È diplomato all’istituto d’Arte. Ha pubblicato diversi libri di poesia, il primo risale al 1995 con il titolo “E Vola Via”, edizioni Libro Italiano. Dopo un silenzio di quasi dieci anni ha pubblicato una piccola suite ispirata da otto tele del pittore Piero Guccione edita dalla Archilibri di Comiso e successivamente, sempre con lo stesso editore, una raccolta dal titolo “Nel Rigore Di Una Memoria Infetta”. Del 2014, per i Quaderni Dell’Ussero, è “La Quiete Dei Respiri Fondati”, edizioni Puntoacapo. “Fuori dal Mazzo”, libro d’arte, Edizioni fuori commercio, dell’anno 2016. Suoi testi e recensioni sono ospitati in diversi blog e riviste di poesia. Partecipa spesso in festival dove la contaminazione poetica si incontra con altre discipline artistiche.
Carmine Lubrano, Letania salentina e altre Letanie, JazzPoetry 2018, nota di Ranieri Teti
Balza per prima agli occhi l’inconsueta dimensione, esageratamente grande per un libro di poesia. Allo stesso modo era enorme il formato della storica rivista che veniva pubblicata da Carmine Lubrano sul finire del secolo scorso, “Terra del fuoco”.
Pensare in grande richiede adeguati supporti, pretende un ordine logico a prescindere.
Tutto questo trova un senso precisissimo non appena si apre “Letania salentina e altre Letanie”: la fantasmagoria linguistica è trascinante, le parole sono battenti, il ritmo fende il silenzio della pagina senza pause, lo trascende, come se le parole ne uscissero innervando l’aria della stanza con il loro impatto sonoro. Nell’ipertrofia del testo non solo non intervengono pause, non ci sono nemmeno cedimenti né cadute, tutto è strettamente sorvegliato.
Lubrano inaugura un uso felicissimo della lingua, riuscendo, con apparente naturalezza e in maniera mirabile, a fondere in molti testi l’italiano con il latino e con il napoletano. Siamo di fronte a un’opera che, anche se ci immette in un infinito eccesso verbale, si fa cogliere interamente. La direzione è chiara: poesia antilirica, talvolta irridente, a tratti carica di sdegno, in generale colma di letizia, anche nei momenti dolenti: “ma la poesia la poesia / (…) / è lingua inaudita che scopre le sue ferite”.
Il volume contiene inoltre molti inserti grafici che richiamano la straordinaria epoca, attraversata dall’autore, della poesia visiva: queste pagine, frammiste al testo poetico, offrono l’altro lato della poesia lineare, un’estensione di possibilità, uno straniante prolungamento dei versi.



Andrea Marinucci, dalla raccolta inedita “Case di passaggio”, nota di Giorgio Bonacini
Questa raccolta poetica avvolge il lettore dentro un percorso lentissimo di ondulazioni malinconiche. E lo fa con versi attraversati da un filo costante di leggera nostalgia. Il tema è il luogo dell’abitare: dunque dello stare ma contemporaneamente anche dell’abbandonare. E’ la ricerca di un ascolto a muovere l’andamento del poema: anche un semplice suono in ciò che si disabita. Marinucci compone un canto compatto, ma non forzato; aderente al sentimento ma non rigidamente legato. Un movimento tenuto insieme dalla parola, una visione dei luoghi visitati e dei ricordi sottovoce; uniti tutti da quella speciale sensibilità contenuta in un dire poetico affidato a un tempo senza tempo, a “un dove libero di storie”. Abitare è libertà di andare o di restare, liberando e illuminando ogni intima ombra.
Dalla sezione Elegia del trasloco
***
Si direbbe immancabile tornare accanto
familiare come è colta per caso una voce amica,
nella polvere altre volte raccolta in altre stanze
o in quella opaca avventura di stanze che fuori,
di questo abitare, nutre e trattiene
come un rifugio paterno, un dove libero di storie.
Iniziare da qui nel viaggio la cura d'intorno.
Cercarlo conosciuto più spesso nei giorni
in una cautela di luoghi nostri tra gioie disarmate
di nomi da perdere e senza riconoscere niente
restituire. Eppure dispongo ogni pacco
e al tuo ritorno il mio si accorda
al tuo seguirmi prezioso di passi
tra i mobili vuoti nelle stanze tra noi
tesi e determinati a far bianco il tempo
di un qualche gesto che cancelli
il rimorso di ciò che è nuovo.
Dalla sezione Intorno alla casa
Abitare distanti
Alcuni bambini, com'ero io,
imparano più che altro la distanza.
L'impressione che dietro l'incresparsi
rabbioso di un orizzonte di sassi
come nel fondo gonfio dell'onda di
quando è già troppo tardi per ritrattare
e nascondersi tra i cigli infantili
di una inguaribile colpa da nulla,
ci sia davvero la casa che ti
riconosce suo e che non credevi
potesse chiederti da allora.
Oggi, che cerchi stancamente
il ricordo di com'era, la protesta
muta nella prima ferita della vista
ferma di bambino, scopri viva
quella felicità che sai tradire
in uno stupore
a cui quasi non credi.
Dalla sezione Sulla porta
***
A volte, potendo raccogliere
il delicato istinto nel tempo
di porre all’aperto un angolo intatto
di intimo riparo, ascoltando con la cura
di una mano l’interno stupefatto
di una casa vuota, abitata,
come il dorso caldo che trattieni
quando non vorresti altro che il mio corpo
quando non chiedi che il mio destino,
ti sento in un modo nuovo, più pietoso
di ciò che lentamente si consuma
della nostra memoria e arrende
il colmo del desiderio a nutrire
di noi quel che non sapremo
Andrea Marinucci, nasce in Abruzzo (1983) e, dopo gli studi scolastici, si forma dal punto di vista accademico all’Università di Bologna, dove affina la passione letteraria laureandosi al termine del percorso con una tesi di poetica. Vive e lavora attualmente a Verona. L’opera Case di passaggio è da intendersi come un’opera prima.
Paola Nasti, dalla raccolta inedita “Contro l’angelo”, nota di Giorgio Bonacini
In due parti si divide questa raccolta: che hanno però in comune la considerazione di ciò che è l’altro, come figura o come condizione esistenziale. La prima (che dà il titolo) è dedicata alla materia in cui la metafora dell’angelo si incontra e si scontra. E’ una figura estrema, disgregante per il troppo fulgore, che sembra rappresentare ciò che tende alla perfezione: dunque umanamente perturbante, perché si angelizza “credendo/di sfuggire alla sporco e all’ingiustizia”. La seconda parte riguarda la fuga, l’allontanamento, la sparizione. Cose, animali, persone che diventano ciò che sono quando se ne vanno. E’ il movimento che esercita la distanza, con momenti in cui le “prove di sparizione” arrivano dai due estremi del poema: angeli indifferenti e particelle atomiche in fuga in un unico tunnel.
dalla sezione Contro l’angelo
*
si ritrovò cadavere
senza targhetta di riconoscimento
a pezzi spiattellato splitterato
diviso
in decine di stanze
migliaia di caratteri le cellule
sparse sul pavimento
*
adesso furibondo sventoli le ali
sei un immenso elicottero di luce
impossibile rimanere in piedi
nei tuoi paraggi
i nugoli di piume
oscurano ogni cosa
aggiunti all’infinito
fulgore che promani
non c’è spazio per nulla che non siano
le tue ali crudeli
dalla sezione Escapologie
*
ogni tanto facciamo
prove di sparizione
prima le dissolvenze colorate,
lampi di neon scontornano
l’evanescenza che innesta i profili
i tratti umanizzati delle mani
i volti prensili sul nero dello sfondo
non ci accorgiamo mai
dell’attimo che ci rende invisibili
sciolti da ogni abbraccio, le dita
che nel buio non si tengono, ma noi
non lo sapremo
Paola Nasti è nata a Napoli nel 1965, dove vive e insegna filosofia nei licei. E’ fondatrice e redattrice della rivista di poesia Levania. I suoi testi – poesie e racconti - sono pubblicati in antologie, riviste e blog. E’ stata finalista nella XXXI edizione del Premio Montano 2017 con “Cronache dell’Antiterra”, edito da Oédipus nel 2018. Nel gennaio 2019 ha pubblicato per Eureka Edizioni, nella collana CentodAutore, la plaquette “Poesie dello yak impigliato per un pelo della coda”.
Paola Parolin, poesia inedita “Senza titolo”, nota di Ranieri Teti
Il testo di Paola Parolin dice la distanza che intercorre tra la realtà e il desiderio; o meglio, sente il desiderio ma vede la realtà. Rappresenta un narrato che non è, né vuole essere, profezia, ma che si pone al confine tra astrazione e concretezza. Parolin produce un flusso breve, come può essere il volo di “un’ala su spalle cadenti”, oppure il viaggio di una vela intatta issata su una barca ormai in rovina.
Appare il mondo che si rovescia nel suo contrario. Fatto di freddo, giorni consunti, chiodi, pietre.
E poi c’è l’ostinazione del poeta che racconta quell’attimo attraversato dalla grazia che è la chiusa dell’idea, il finale di un momento: non solo parole che aprono superfici, non solo parole come pietre, ma soprattutto parole che possono essere insieme occasione e baratro, destino.
è un’ala protesa su spalle cadenti di peso e di freddo non avvolge
imprigiona il piumaggio cedevole all’acqua inefficace natura di
uomo diverso nel cuore e ora non vola vede il mondo all’inverso
giorni e giorni consunti di niente chiodi nel muro bianca
superficie aperta a parole le prime in bocca innocente parole le
prime dure pietre miliari e di inciampo
Paola Parolin è nata a Verona nel 1952. Medico in Verona, è sposata con due figli.
Ha partecipato ad alcuni laboratori poetici coordinati da Ida Travi negli anni 1998-2008. Ha pubblicato nel 2003 la raccolta in versi Interni Esterni Interni. Nel 2007 ha pubblicato con altri due autori la raccolta poetica Trittico della sera di carta (Cierre Grafica). Nel 2011 ha pubblicato il libro Parola Corale (Anterem Edizioni, collana Via Herákleia), con prefazione di Gio Ferri. Del 2018 è l’ultimo libro di poesie E uscire alfine (Anterem Edizioni, collana Via Herákleia), con postfazione di Rosa Pierno, recensito da parte di Giorgio Mancinelli sul sito della rivista letteraria libera La Recherche.
Dal 2006 al 2017 è stata segnalata più volte al Premio Lorenzo Montano. È entrata nella selezione dei finalisti al Premio Elio Pagliarani 2020. Ottiene il premio speciale della giuria al concorso Bologna in lettere 2021. È inserita nell’elenco dei poeti italiani del sito web Italian Poetry.
È cofondatrice dell’associazione culturale Spazio Cordis, attiva dal 2018 in Verona, che si prefigge di valorizzare e supportare il lavoro di giovani artisti di arte contemporanea italiana e internazionale presentando mostre monografiche.
Antonio Pietropaoli, da “Tomoterapia e altro” Oèdipus 2017, nota di Rosa Pierno
Una straripante girandola di concatenazioni semantiche capeggiate da significati assonanti serve come viatico al lettore per insediarsi comodamente nel libro di Pietropaoli, dove già il titolo “Tomoterapia e altro” indica che siamo in un regime di terapia verbale. Il sapore è quello delle parodie o riscritture sanguinetiane che vale anche come argine alla stessa massa di detriti memoriali e culturali. D’altra parte, ogni nuova riscrittura rilancia e conferma, riapre e frattura. Il sanatorio letterario sarà dato proprio dalla possibilità di ricombinare nuovamente le medesime pedine. Il nuovo si costruisce con mattoni vecchi, i quali altrimenti resterebbero inutilizzati e ciò riveste un carattere valoriale di forte impatto. Seppure, proprio l’ironia risulti essere la calce più efficace per tenere insieme il costrutto linguistico. Si veda il piano congetturale per allestire il proprio estremo saluto che nella chiusa si risolve con un “ciao”. La salvifica medicina verbale vagabondando trova, del tutto casualmente oppure condotta solamente dalla guida sonora delle parole, nuovi sensi, nuovi rilanci, anche beffardi.
Nota dell’Autore
A causa di un tumoretto (d'un soffio malignetto) alla prostata, l'autore si è sottoposto a un ciclo di trattamento tomoterapico per ventotto giorni. Ne ha tratto questa suite di poesiole (una al giorno: allo scopo, propriamente terapeutico, di togliersi i medici di torno) che volentieri condivide con i suoi undici (possibili) lettori, malati o sani che siano – sebbene, certo, i primi si sentiranno più in sintonia con il sostrato realistico del testo, mentre i secondi, forse, ne proveranno un po' d'invidia. Ha infine devoluto (a intermittenza) alla terza persona il compito di preservare quella goccia di pudore che gli è rimasta, peraltro divertendosi non poco a giocare a rimpiattino con la sua proiezione cartacea.
1
mani intrecciate dietro la nuca
freddo alle gambe metà dentro metà fuori
ginocchia sollevate piedi ingabbiati
immobile fino allo spasimo
decerebrato devitalizzato
sotto aliti e ronzii di vento furibondo
al frastuono assordante dei rumori di fondo
eccoli partono gli eserciti in marcia della tomo
terapia
tarata-tarata-tarata
sarà quello dell'arrivano i nostri
o le falangi della morte?
6
è litania è cantilena
sono lamelle che si sfregano
mi spiegano
come elitre di una immane mostruosa
macchina-cicala che pertanto frinisce
scoppietta raddoppia s’infoia
spalanca la bocca e m’ingoia
mi mangia o mi arrangia?
oppure nacchere nacchere strepitose
che una mano pietosa misteriosa
agita furiosamente
esclusivamente per noi vitabondi.
Già ordinario di Letteratura italiana contemporanea all'Università di Salerno, Antonio Pietropaoli ha pubblicato numerosi volumi sulla poesia italiana del Novecento, tra cui “Le strutture dell'anti-poesia” e “Fra retorica e metrica. Saggi sulla poesia italiana contemporanea” (Guida, Napoli, 2013 e 2014). La sua attività poetica è raccolta nel volume-omnia “Cartastraccia” (Oèdipus, Salerno-Milano, 2014). Dirige infine «Trivio», rivista semestrale di poesia, prosa e critica (Oèdipus), è presidente di giuria dell'omonimo premio letterario ed è direttore di due collane di poesia presso l'editore Guida (“I segni del destino” e “Resilienze”).
Federico Edgar Pucci, dalla raccolta inedita "Tiro ad anticipare", nota di Laura Caccia
Un arco dissonante
Un linguaggio straniante, contro-verso, colma le pagine di Tiro ad anticipare, in cui Federico Edgar Pucci snoda i suoi temi in un serrato esercizio tra vertigini e aporie, passioni e trasgressioni. Dove “Il peso del mistero gira il capo”. E dove il corpo e l’anima hanno la parola. Tra carnalità e perdizione, dissacrazione e pietà.
Con un’ambivalenza lasciata in sospeso nei testi: sentirsi sotto tiro o, propriamente, tirare ad anticipare? Rassegnarsi ad essere bersaglio o farsi arciere che tenda la parola verso il suo obiettivo?
Tutto il contesto della raccolta, a partire dal titolo, evidenzia il desiderio di ribaltare la situazione: nel tiro dissacrante, nella “indisciplina del cammino”, nel “Trasgredire come altissime orchestre / l’ampiezza del deserto”. Bersagli sono via via molteplici aspetti: imbarbarimenti, atteggiamenti su cui ironizzare, la commercializzazione dello spirituale da mettere a nudo.
E la parola? Da una lingua anch’essa sotto tiro, ridotta all’espulsione, alla possibilità di recuperarne, fisicamente, senso e ardore: “È stato nel tuo nome carnato / invocato un alfabeto di bruciature”, come leggiamo. In uno scardinamento lessicale e semantico che Federico Edgar Pucci mette in atto per fare, del suo arco linguistico dissonante, un nuovo dire.
Da: Quaderno dell’inverno (o la doppia presenza)
Il segno del rosario sul silenzio.
Il tempo cerca luce dilettante.
La strada sale in una pozza d’alberi.
L’uomo invisibile riceve l’ordine
di restare fedele.
Rasenta sponda di ritorno fatta
in due tra voci d’ombra parallele.
-----
Si stacca e svirgola dal foro
finché scende a rilento dentro altro da quello
che gonfia il suo mistero. Forse un uovo
dai colori del fuoco.
Diresti che uno sguardo ti controlla
da dietro un lungo seghettato scudo di foglie.
Marciando separato, in seme solo
per metà, indefinito suona il passo
rimasto indietro senza impronta ma
rintocca in una cava d’aria o trova
rimpiatto in una venula pneumatica.
Un’eco rasoterra
ammicca al genio soprannaturale.
Il peso del mistero gira il capo.
C’è una pietra promessa sottosopra.
La lingua trasferita insegue le ombre:
parola in ombra estranea con sé sola
irrevocabilmente espulsa.
La ventata non perde il contatto
con lo sfratto alle spalle del reale.
Tutto contiene il tempo e dal nulla è contenuto.
Sul quaderno invernale annoti nomi e linee:
loro curano il sacco trasparente
molto garbatamente.
Pulizia e pietà si rassomigliano.
Da: La buia voliera
Anche l’erba si slega per assaggiarsi.
Ciò che procede soltanto all’indietro
sa di santo e d’oblio.
Sa di salvezza al mai più darsi corpo e anima.
-----
Che ti è servito suggere dal poro
più ricco della sagoma da tiro?
Da: Perfetta aporia
È stato nel tuo nome carnato
invocato un alfabeto di bruciature.
-----
Trasgredire come altissime orchestre
l’ampiezza del deserto.
Federico Edgar Pucci è nato nel 1986 a Bagno a Ripoli, dove attualmente risiede. Dopo essersi laureato in Filologia Moderna presso l’Università di Firenze, si occupa, come critico letterario, prevalentemente di letteratura italiana del Novecento. Suoi articoli e poesie sono stati pubblicati sulla rivista «Gradiva», edita dalla Casa Editrice Leo S. Olschki di Firenze. Da due anni insegna Letteratura italiana e Lingua italiana presso la Scuola Internazionale Blyth Academy Florence.
Alessandro Ramberti, da “Vecchio e nuovo”, Fara editore 2019, nota di Giorgio Bonacini
Leggendo queste pagine si comprende la capacità della’autore di essere poeta dal sentire totale. Tutto ciò che è il nostro essere – come natura umana, ma proiettata in una dimensione che unisce e fonde stati di materia diversi,”volti mani sensi/si fanno luoghi” – si presenta al mondo dando con un sentimento del senso distillato in parole che hanno il segno di una necessità unica: che non è quella di dire per insegnare (“siamo senza formule”, precisa Lamberti), ma dire per avvolgere ed espandere il canto.. I brevi, ma concentrati testi, con precisa metrica, invitano a una lettura lenta, per poterne vedere e udire il riverbero nella voce di una sapienza discreta, quasi nascosta: in verità lucida e centrale. I concetti sono conseguenze intime che si aprono al desiderio, sfiorando l’oscurità dove tutto è immaginabile: un transito, verso ciò che ha vocazione di silenzio, di pura meraviglia. “Note mute” ma riconoscibili, se solo ci si dispone ad accogliere il loro pulsare. Un percorso di pensiero, allora, dove solo la poesia riesce a cogliere, per subito donare, l’indeterminata contemplazione nella saggezza di quell’atto etico che diciamo scrittura: che ci accoglie e ci cambia con leggerezza assoluta.
![]()
BASTA QUASI UN NIENTE
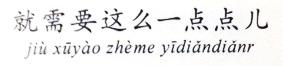
Basta quasi un niente
per incrinarti l’universo
cammello e cruna
diaframma e apnea
dare mezzo manto
Martino agisce prontamente
respiro empatico
performativo
siamo senza formule
desiderando l’assoluto
restiamo in bilico
concetti sfumano
INIZIAMO UN DISCORSO
![]()
CI TROVIAMO A UN BIVIO

Ci troviamo a un bivio
disorientati e il vento spira
fumoso e asfittico
deprime e affloscia
sorvoliamo il mondo
con piccoli atti vuoti e frusti
restiamo inerti
demotivati
Rut ha avuto fegato
non è lasciata sola in terra
a lei straniera
si è affidata
DALLA TERRA DI MOAB
![]()
VIENE INESPLORATA
![]()
Viene inesplorata
la svolta e porta gli occhi vigili
a contemplare
frontiere insolite
anche tu sei altrove
in quel momento preziosissimo
magari instabile
degravitato
brami un nuovo centro
ma è sempre stato lì vicino
un fluido rosso
respiro-sangue
PANORAMA SPIAZZANTE
Alessandro Ramberti (Santarcangelo di Romagna, 1960) è laureato in Lingue orientali a Venezia, ha vinto una borsa (1984-85) per l’Università Fudan di Shanghai. Nel 1988
consegue a Los Angeles il Master in Linguistica presso l’UCLA e nel 1993 il dottorato
in Linguistica presso l’Università Roma Tre. Ha pubblicato qualche saggio, Racconti
su un chicco di riso (Pisa, Tacchi 1991), La simmetria imperfetta con lo pseudonimo
di Johan Thor Johansson (1996) e alcune sillogi: In cerca (2004, Premio Alfonso Gatto
opera prima), Pietrisco (2006, premi Poesi@&Rete e Cluvium), Sotto il sole (sopra il cielo)
(2012, Premio speciale Firenze Capitale d’Europa) e Orme intangibili (2015, Premio
Speciale Casentino, II class. Tra Secchia e Panaro) Con l’Arca Felice di Salerno
ha pubblicato la plaquette Inoltramenti e tradotto 4 poesie di Du Fu.
Giovanna Cristina Vivinetto, da "Dolore minimo", Interlinea 2018, nota di Laura Caccia
L’altro da sè
Di quale sofferenza non comune è interamente impregnato il dire di Giovanna Cristina Vivinetto in Dolore minimo? E, insieme al dire, il corpo che vive realmente in sé la frattura della diversità e che nella parola riesce a trovare la possibilità di un’ulteriore nascita?
Certo, un dolore non comune, in questo trittico del pianto, della morte e della rinascita. Sperimentando nella carne, negli organi e nei desideri del proprio corpo quanto filosofi e poeti hanno assunto come paradigmi di riflessione e di versificazione: l’altro, il doppio, l’enigma che si cela dietro l’apparenza, l’invisibile, l’indicibile.
L’autrice ci mostra, in tutti i suoi dettagli fisici ed emotivi, il crescere della percezione dell’alterità che si fa concreta “nel dolore bambino / di avvertirmi a un tratto / così divisa”, nel riconoscimento dell’altro da sé, del “mistero che non si può dire”, del conflitto che ne scaturisce e quindi dell’esigenza di farsi madre dell’altra che chiede voce. In una lunga e sofferta gestazione: nella carne, nel pensiero, nella parola.
Poiché anche i nomi, che “ci scelgono / prima ancora di pronunciarli”, che “legano in nodi / di verità strette da calzare” marcano a fuoco il conflitto e poi la nuova nascita. Dopo la seconda, avvenuta nel dare vita a una figlia da sé, Giovanna Cristina Vivinetto ne mette in versi una ulteriore: portando alla luce il suo essere nascosto, dando nomi alla verità a lungo celata. Del resto, non è proprio questa tensione al vero a rendere autentico, tra indicibilità e apertura, mistero e svelamento, ogni dire poetico?
Da: CESPUGLI D’INFANZIA
A quel tempo ogni cosa
si spiegava con parole note.
Sillabe da contare sulle dita
scandivano il ritmo dell’invisibile.
Tutto era a portata di mano,
tutto comprensibile
e immediatamente dietro l’angolo
non si annidava ancora l’inganno.
La poesia era uno scrupolo
d’altri tempi, un muto richiamo
alla vera natura delle cose.
Così dissimulata da confondersi
con i palloni, con le bambole
dell’infanzia.
In quei tempi non c’erano disastri
da centellinare, difformità
da curare dentro abiti larghi,
padri da rifiutare e nomi
da pedinare in fondo agli stagni.
Finché non è arrivato il transito
a rivoltare le zolle su cui il passo
aveva indugiato, a rovesciare
il secchio dei giochi – richiamando
la poesia invisibile che mi circondava.
Non mi sono mai conosciuta
se non nel dolore bambino
di avvertirmi a un tratto
così divisa. Così tanto
parziale.
Da: LA TRACCIA DEL PASSAGGIO
La verità è che i nomi ci scelgono
prima ancora di pronunciarli.
Sulle pareti, a ridosso delle strade,
nei vasi di garofani e ortensie,
sulle strisce d’acqua che rigano
le finestre al mattino, sulle
scarpe allacciate, sui pulsanti
dei campanelli, nelle stazioni
in disuso. Su tutto si coagula
un nome. Tutto ne risplende.
E chi fugge dai nomi sappia
che non si sfugge alla nominazione
perché i nomi legano in nodi
di verità strette da calzare,
costringono in sillabe da pronunciare
a detti stretti. Da far male.
I nomi che mi hanno scelta
non trovarono angoli da rischiarare.
Cessarono presto i significati
mentre ero intenta a scavare in ogni
lettera. Speravo nelle eccezioni,
in costrutti arcani da indagare
per darmi un senso.
Ci rinunciai e con loro
all’arroganza della definizione.
All’insensatezza di attenersi
alle parole per vedere la realtà.
La verità è che la realtà
dormiva a un palmo dal naso
sepolta da un cumulo muto
di nomi.
Da: DOLORE MINIMO
Per acquietare il male che lo assale
il poeta lo canta. Ne fa bella
mostra nei suoi versi per sbugiardarlo,
quasi a gridargli in faccia l’infinita
piccolezza della sua minacciosità.
Il poeta ha per sé l’arma della luce
a rischiarare i vuoti d’ombra,
le fessure dove s’annida, il male.
Potrai dirmi che si è deboli
mettendo a nudo i vasi incrinati.
La tavola di legno che balla.
Il punto del muro che non regge.
Nessuno – mi sembra udirti – è disposto
a indossare i tuoi dolori come perle
o a portarli in giro come docili
cani al guinzaglio. Eppure è proprio
del poeta indicare col dito
la ferita. I lembi ammalati
che non chiudono. Anche se tu
non assisti, ti sussurra comunque
un segreto che non puoi avere.
Così il mio male si estingue
su ogni mio verso. Lo canto,
lo urlo per liberarlo dal groviglio
di pelle che ha contagiato.
Non voglio che tu lo colga
per salvarmi. Mi aspetto
che lo guardi crescere. E appassire.
Rannicchiarsi sfinito fino a non esigere
più nulla. Mi aspetto che il mio male
non ti faccia più male.
Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994. Laureata in Lettere, vive attualmente a Roma, dove è laureanda alla specialistica in Filologia moderna all’Università La Sapienza. Dolore minimo (Interlinea, 2018; Premio Cetonaverde Poesia Giovani, Premio San Domenichino, Premio Europeo Massa, Premio Lord Byron, Premio Senghor) è la sua opera prima, nonché primo testo in Italia ad affrontare in poesia la tematica della transessualità e della disforia di genere. Con prefazione di Dacia Maraini e postfazione di Alessandro Fo, il libro è apparso ed è stato recensito sulle maggiori testate giornalistiche nazionali, tra cui «Il Fatto Quotidiano», «La Repubblica», «La Stampa», «Il Messaggero», «Il manifesto» (Alias, Le Monde Diplomatique), «Il Sole 24 ORE», «Panorama», «Il Corriere della Sera», «La Sicilia» e altri.
Ultima pagina, Alberta Pellacani: altre opere, biografia



Alberta Pellacani (Carpi 1964), studia pittura a Bologna all’Accademia di Belle Arti, e si laurea in Arti Visive al DAMS. Dagli esordi artistici degli anni ’80 conduce una ricerca per sconfinamenti, tra pittura e fotografia, video arte e operazioni d’arte partecipata, documentario, disegno, azioni. Ha esposto in mostre e festival in Italia e all’estero tra le ultime partecipazioni nel 2019 ‘ONDE’, performance di video e musica per ‘Volo IH 870’, a cura di Silvia Grandi, a Bologna al Museo della Memoria di Ustica; ‘Promessa’ mostra personale a cura di Lucia Biolchini e Piero Deggiovanni, presso Dislocata, Vignola; nel 2022 VISIBILIA al Palazzo Ducale di Gubbio.
Marginali accadimenti, minimi movimenti colti nel contatto diretto con le cose per ri-vedere l’ordinaria o straordinaria normalità, è ciò che emerge dalla recente ricerca video, che nelle installazioni affianca al disegno.
Ispirata dalle poesie di Giorgio Bonacini, ha disegnato per ‘Falle Farfalle’, Anterem ed. 1998
Quarta di copertina: Autori di “Carte nel vento”
Sebastiano Aglieco, Nadia Agustoni, Alessio Alessandrini, Pietro Altieri, Viola Amarelli, Angelo Andreotti, Marcello Angioni, Cristina Annino, Gian Maria Annovi, Lucianna Argentino, Davide Argnani, Giuseppe Armani, Paolo Artale, Gianluca Asmundo, Alessandro Assiri, Daniela Attanasio, Leopoldo Attolico, Dino Azzalin, Claudia Azzola
Luigi Ballerini, Paola Ballerini, Daniele Barbieri, Bianca Battilocchi, Maria Angela Bedini, Carlo Gregorio Bellinvia, Daniele Bellomi, Primerio Bellomo, Franco Beltrametti, Mario Benedetto, Dario Benzi, Riccardo Benzina, Pietro Antonio Bernabei, Armando Bertollo, Vanni Bianconi, Nicoletta Bidoia, Ilaria Biondi, Giorgio Bona, Giorgio Bonacini, Leonardo Bonetti, Simone Maria Bonin, Vito M. Bonito, Doris Emilia Bragagnini, Silvia Bre, Andrea Breda Minello, Fabrizio Bregoli, Luca Bresciani, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani, Simone Burratti, Giusi Busceti, Antonio Bux
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Giuseppe Calandriello, Maria Grazia Calandrone, Giovanni Campana, Mario Campanino, Enzo Campi, Giovanni Campi, Martina Campi, Emanuele Canzaniello, Maddalena Capalbi, Michele Cappetta, Roberto Capuzzo, Allì Caracciolo, Alessandra Carnaroli, Lorenzo Carlucci, Anna Maria Carpi, Peter Carravetta, Alberto Casadei, Mauro Caselli, Guido Caserza, Marosia Castaldi, Davide Castiglione, Paola Casulli, Alessandro Catà, Franca Maria Catri, Elena Cattaneo, Alessandra Cava, Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Alessandro Ceni, Rossella Cerniglia, Maria Benedetta Cerro, Marilina Ciaco, Viviane Ciampi, Gaetano Ciao, Antonella Cilento, Laura Cingolani, Mara Cini, Gabriella Cinti, Domenico Cipriano, Sonia Ciuffetelli, Roberto Cogo, Gabriella Colletti, Osvaldo Coluccino, Tiziana Colusso, Silvia Comoglio, Federico Condello, Nicola Contegreco, Antonino Contiliano, Morena Coppola, Giorgiomaria Cornelio, Marina Corona, René Corona, Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto, Lia Cucconi, Miguel Angel Cuevas, Vittorino Curci
Mauro Dal Fior, Anna Maria Dall’Olio, Chetro De Carolis, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Adriano De Luna, Lella De Marchi, Daria De Pellegrini, Annamaria De Pietro, Evelina De Signoribus, Gerardo De Stefano, Riccardo Deiana, Silvia Del Vecchio, Fernando Della Posta, Pasquale Della Ragione, Stefano Della Tommasina, Aurelia Delfino, Tino Di Cicco, Danilo Di Matteo, Vincenzo Di Oronzo, Bruno Di Pietro, Stelvio Di Spigno, Letizia Dimartino, Paola Silvia Dolci, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria, Patrizia Dughero, Giovanni Duminuco
Marco Ercolani, Flavio Ermini, Franco Falasca, Mario Famularo, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina, Silvia Favaretto, Francesco Fedele, Federico Federici, Annamaria Ferramosca, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Luca Ferro, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory, Zara Finzi, Antonio Fiori, Raffaele Floris, Rita Florit, Ettore Fobo, Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Valentino Fossati, Biancamaria Frabotta, Kiki Franceschi, Tiziano Fratus, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Gabriele Gabbia, Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Maria Grazia Galatà, Marinella Galletti, Carmen Gallo, Gabriella Galzio, Guido Garufi, Paolo Gentiluomo, Mauro Germani, Fabia Ghenzovich, Alessandro Ghignoli, Gianluca Giachery, Carlo Giacobbi, Anna Maria Giancarli, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Patrizia Gioia, Carolina Giorgi, Sonia Giovannetti, Marco Giovenale, Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Llanos Gomez Menéndez, Michela Gorini, Giuseppe Gorlani, Alessandra Greco, Angela Greco, Cesare Greppi, Lino Grimaldi, Maria Grimaldi Gallinari, Iria Gorran, Giovanni Guanti, Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini, Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin, Andrea Guiducci
Giovanni Infelìse, Maria Grazia Insinga, Carlo Invernizzi, Stefano Iori, Francesca Ippoliti, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Sonia Lambertini, Michele Lamon, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Leandro, Ferdinando Lena, Alfonso Lentini, Laura Liberale, Nicola Licciardello, Tommaso Lisa, Oronzo Liuzzi, Domenico Lombardini, Andrea Lorenzoni, Francesco Lorusso, Carmine Lubrano, Ghérasim Luca, Antonella Lucchini, Eugenio Lucrezi
Loredana Magazzeni, Giulio Maffii, Franca Mancinelli, Danilo Mandolini, Francesca Marica, Marianna Marino, Andrea Marinucci, Emanuela Mariotto, Attilio Marocchi, Raffaele Marone, Francesco Marotta, Giuseppe Martella, Giulia Martini, Giulio Marzaioli, Vincenzo Mascolo, Stefano Massari, Mara Mattoscio, Ugo Mauthe, Alessandro Mazzi, Luciano Mazziotta, Daniele Mencarelli, Tommaso Meozzi, Manuel Micaletto, Emiliano Michelini, Roberto Minardi, Marco Mioli, Stefano Modeo, Francesca Monnetti, Daniela Monreale, Gabriella Montanari, Emidio Montini, Marcel Moreau, Romano Morelli, Umberto Morello, Sandra Morero, Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Chiara Mulas, Gregorio Muzzì
Luigi Nacci, Clemente Napolitano, Paola Nasti, Giuseppe Nava, Stefania Negro, Giulia Niccolai, Davide Nota, Mario Novarini, Marco Nuzzo, Riccardo Olivieri, Francesco Onìrige, Margherita Orsino, Cosimo Ortesta
Luca Paci, Marco Pacioni, Adriano Padua, Alessandra Paganardi, Cristiana Panella, Carla Paolini, Alice Pareyson, Paola Parolin, Giovanni Parrini, Angela Passarello, Sandro Pecchiari, Giuseppe Pellegrino, Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Daniela Pericone, Roberto Perotti, Anna Maria Pes, Serge Pey, Mario Pezzella, Luisa Pianzola, Antonio Pibiri, Renzo Piccoli, Rosa Pierno, Antonio Pietropaoli, Roberto Piperno, Pietro Pisano, Stefano Piva, Marina Pizzi, Daniele Poletti, Gilda Policastro, Chiara Poltronieri, Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Stefania Portaccio, Claudia Pozzana, Ivan Pozzoni, Chiara Prete, Loredana Prete, Rossella Pretto, Federico Edgar Pucci, Maria Pia Quintavalla
Alessandro Ramberti, Jacopo Ramonda, Giuseppina Rando, Andrea Raos, Beppe Ratti, Filippo Ravizza, Luigi Reitani, Vittorio Ricci, Jacopo Ricciardi, Alfredo Rienzi, Giuliano Rinaldini, Alfredo Riponi, Massimo Rizza, Gianni Robusti, Marta Rodini, Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa, Sofia Demetrula Rosati, Lia Rossi, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti, Greta Rosso, Enea Roversi, Anna Ruchat, Paolo Ruffilli, Gianni Ruscio
Irene Sabetta, Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Claudio Salvi, Lina Salvi, Rosa Salvia, Lisa Sammarco, Massimo Sannelli, Irene Santori, Patrizia Sardisco, Francesco Sassetto, Marco Saya, Viviana Scarinci, Antonio Scaturro, Evelina Schatz, Giuseppe Schembari, Fabio Scotto, Massimo Scrignòli, Beppe Sebaste, Loredana Semantica, Luigi Severi, Sergio Sichenze, Ambra Simeone, Stefania Simeoni, Roberta Sireno, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Marco Sonzogni, Pietro Spataro, Fausta Squatriti, Giancarlo Stoccoro, Stefano Stoja, Maria Paola Svampa
Antonella Taravella, Gregorio Tenti, Diego Terzano, Italo Testa, Ranieri Teti, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato, Carlo Tosetti, Eros Trevisan, Silvia Tripodi, Luigi Trucillo, Guido Turco, Gian Maria Turi, Giovanni Turra Zan
Liliana Ugolini, Tonino Vaan, Adam Vaccaro, Luca Vaglio, Roberto Valentini, Camillo Valle, Sandro Varagnolo, Francesco Vasarri, Matteo Vercesi, Cesare Vergati, Maria Luisa Vezzali, Massimo Viganò, Pasquale Vitagliano, Nicola Vitale, Ciro Vitiello, Giovanna Cristina Vivinetto, Annarita Zacchi, Simone Zafferani, Paola Zallio, Claudio Zanini, Claudia Zironi, Aida Maria Zoppetti, Marco Zulberti
Aprile 2022, anno XIX, numero 51

L’incontro di Chiara Mulas con Cristiana Panella: dicono tutto “Péntuma”, il video che apre Carte nel vento 51, e il testo che ne consegue.
Ricco di suggestioni, di parole, di voci, di immagini, il presente numero ci porta un po’ indietro nel tempo, al “Montano” 2019.
Quello che si consuma in fretta, in molti luoghi della comunicazione, non vale evidentemente per questa testata, che sta ancora raccontando l’edizione di tre anni fa del premio…
Oggi sono presentati Alessandro Assiri, Carlo Gregorio Bellinvia, Vito M. Bonito, Anna Maria Dall’Olio, Adriano De Luna, Zara Finzi, Eugenio Lucrezi, Alessandro Mazzi, Marco Mioli, Francesca Monnetti, Clemente Napolitano, Adriano Padua, Lina Salvi, Eros Trevisan, Gian Maria Turi: alcuni in versione lineare, altri in audio o videolettura. Tutti presentati dalla giuria del “Montano” 2019.
In chiusura l’intervento di Giuseppe Martella su “Figure semplici” di Anna Chiara Peduzzi, opera vincitrice nel 2020, e un audio di Silvia Comoglio, recentemente pubblicata da Anterem Edizioni.
Ben sapendo che la buona poesia non ha scadenza e che tutto questo, ora che è stato reso pubblico, continuerà a riverberare, promettiamo di concludere prima possibile la nostra “ricerca del tempo perduto”…
In copertina: due fotogrammi da “Péntuma” di Chiara Mulas
Ranieri Teti
Prima pagina, “Péntuma” di Chiara Mulas. Con un testo, “oggi, Madre”, di Cristiana Panella
Videasta, performer, artista plastica, fotografa e scenografa, Chiara Mulas (1972) vive e lavora tra Tolosa, in Francia, e Gavoi, suo paese natale nel cuore della Barbagia. Diplomata all'Accademia di Belle Arti di Bologna, ha fatto delle arti plastiche, della video-art e della poesia d'azione strumenti di espressione artistica privilegiati. Attraverso azioni poetiche di forte impatto estetico e concettuale promuove una geografia filosofica e sociale sincretica che parte dal Mediterraneo, in particolare dalla Sardegna, periferia rivelatrice del mondo, per raggiungere l’universale. Nell'evocare un passato arcaico, con le sue tradizioni ancora in uso, Chiara Mulas affonda le mani acute e critiche della sua modernità aprendo nuovi spazi di riflessione rispetto alla denuncia sociale, alla religione e alle tradizioni popolari. Nel suo lavoro dedicato ai rituali legati alla morte in Sardegna, tra cui Pèntuma (2006), che rievoca l’antica pratica del geronticidio, e « S'Accabadora » (2004), che documenta il canto rituale improvvisato durante la veglia funebre a Ollolai, l’artista rivisita in chiave onirica le rappresentazioni culturali ancestrali in una prospettiva contemporanea. Le sue performance, le video installazioni e i tableaux vivants fanno di Chiara Mulas una presenza inclassificabile, accolta in numerosi eventi internazionali.
Sito web : Chiara Mulas Art Action www.chiaramulas.fr
Chiara Mulas artiste : https://fr-fr.facebook.com/Chiara-Mulas-768677396553713/ Chiara Mulas Instagram : kiapra72
Cristiana Panella (Roma, 1968) è senior researcher in antropologia sociale e culturale in Belgio. Dopo la laurea in Lettere Moderne a Sapienza Università di Roma si è trasferita a Parigi, dove ha ottenuto un master (DEA) in Storia dell'Arte Africana alla Sorbona per poi conseguire un dottorato in Scienze Sociali all'Università di Leiden, nei Paesi Bassi. Ha effettuato lunghi soggiorni di ricerca in Mali sul commercio clandestino di reperti archeologici e sui cercatori d'oro, prima di dedicarsi allo studio del commercio informale a Roma. Attualmente la sua ricerca è orientata, in una prospettiva multidisciplinare, sulle implicazioni etiche della corporeità. I risultati delle sue ricerche sono stati presentati in decine di pubblicazioni e convegni internazionali in Europa, in Canada e negli Stati Uniti. Di recente pubblicazione, il volume Norms and Illegality. Intimate Ethnographies and Politics (C. Panella & W. Little eds, Lexington Books, 2021). Parallelamente alla sua attività di ricerca, ha collaborato con la casa editrice di Bruxelles maelstrÖm ReEvolution orientata sulla poesia performativa e la prosa poetica, in qualità di editor e di lettrice. Suoi testi di poesia e prosa, note critiche e traduzione di poesia inedita francofona sono stati pubblicati per Oblique Studio, Carte nel Vento, La dimora del tempo sospeso, Scritture (blog di Marco Ercolani) e Pangea. Nel 2019 ha auto-pubblicato il non-romanzo in cielo e in terra. Nel 2019 e nel 2021 si è classificata finalista al Premio di poesia e prosa Lorenzo Montano, di cui è stata membro della giuria critica nel 2020, per la sezione “prosa inedita”. Una sua raccolta inedita ha ricevuto la menzione speciale al Premio nazionale di poesia Arcipelago Itaca (2020).
Alessandro Assiri, da “L’anno in cui finì Carosello”, Le voci della Luna Editrice, 2018, nota di Giorgio Bonacini
Alessandro Assiri, in queste pagine, non scrive una semplice sequenza di poesie, ma, con forte tensione di sintesi poematica, indirizza il lettore dentro una cornice mobile che delinea l’esaurimento di una finzione. Infatti il titolo, nel contrasto con ciò che le parole manifestano, è lampante: la fine (ma sarebbe più vero dire “il mai inizio”) di una falsa innocenza. Carosello, infatti, termina nel 1977: l’anno in cui le crepe di un decennio diventano baratri. Ma l’autore è poeta consapevole che la scrittura deve aderire alla cosa, senza raccontare, per evitare che la concretezza del pensiero poetica scada in un sociologismo narrante. Caterina e lo Sciancato (due fra le tante immani fratture che si allargano fino a cedere) non sono personaggi, ma forme di disperazione storica – Caterina esprime leggerezza con i punti esclamativi; Lo sciancato è una notizia in un pollaio senza gallo – che non necessitano di colpe o giustificazioni, ma solo di poesia: che è l’unica direzione che può rappresentarne l’esistenza interiore, in vita e in morte. Perché solo “una civiltà della poesia” (definizione tanto cara all’autore e tanto auspicabile, diciamo noi) può e dovrebbe, anche nel dolore più estremo, aprire uno spiraglio nei dintorni”.
*
Lo sciancato sciupava i quarti d’ora interrompendoli di felicità
sgretolata sapeva a memoria i nomi degli eroi e di tutti i ciechi
vicini a 30 anni indecisi quanto lui tra il crescere e l’invecchiare o
cambiare nome per essere un altro
*
Non sei caduta come gli altri in quel prudente silenzio della casa
simulando nascondigli
programmando orologi per appuntamenti irripetibili con ospiti da
sempre maleducati e invisibili
*
Caterina esprime leggerezza con i punti esclamativi
con le persone è felice solo quando non ci sono
fa visita ai malati solo quando son guariti
così li trova sempre meglio o quasi sempre usciti
*
Ti ho rivisto in San Vitale nell’attimo esatto in cui l’alba diventa
mattina eri già morto come prima soltanto un po’ più storto. Avrei
voluto dirti lasciami in pace ma a cancellarti ci ha pensato la luce.
Alessandro Assiri è nato a Bologna nel 1962. Scrive da anni opere in versi. Tra le sue pubblicazioni: La stanza delle poche righe (Manni Editore), Cronache della città parallela, Poemetto in versi insieme a Serse Cardellini (Thauma Edizioni), In tempi ormai vicini (CFR Edizioni), Lo sciancato e Caterina (CFR Edizioni), Lettere A.D. (LietoColle). Vive al bar dove scrive e disegna.
Carlo Gregorio Bellinvia, audiolettura di “L’oggetto della sveglia”, nota di Mara Cini
Audio (mpeg)
Da questo testo un’impressione quasi visuale, “molto colorata”, piena di immagini suggestive: surrealisti cieli blu alla Mirò, texture puntinate alla Lichtenstein poi voci del mito innestate su inquadrature pullulanti di “avanguardie del Novecento”.
Ritroviamo, mi pare, Eluard in lieve tinta del sogno e lineata foglia della mano …
E in certe chiome nella corsa che vanno a tingersi nel mare e nella forma sul cuscino ci sono anche Dalì e Domenico Gnoli!
Testo (pdf)
Carlo Gregorio Bellinvia è nato a Reggio Calabria nel 1985 e vive a Livorno. Nel 2006 ha pubblicato Per i vicoli, macellai di piccioni e spettri di carta per Cicorivolta edizioni. Quindi, dopo un lungo pe- riodo di abbandono della scrittura, nel 2013 un suo scritto è stato inserito in Poem Shot vol. 1, traversate di testi esemplari da 15 autori italiani a cura di Davide Castiglione, su Poesia 2.0. Nel 2014 ha pubblicato Il lastrico per LietoColle edizioni. Per due volte, nel 2015 e nel 2017, è risultato semifinalista al Premio Nazionale “E- lio Pagliarani” per l’opera inedita. Nel 2019 ha ricevuto una segnalazione al XXXIII Premio “Lorenzo Montano” per la prosa inedita. Suoi scritti sono apparsi su “Nazione Indiana”, “Argo”, “Poesia del nostro tempo”, “Poesia 2.0”. La sua ultima opera è l’e- book Domotica del labirinto, Kipple Officina Libraria (2020). È presente in Cronache dall’ultimissima poesia italiana a cura di Dimitri Milleri, su “Poesia del nostro tempo”. È stato candidato nel 2018 e nel 2020 nella selezione per il Quaderno Italiano di Poesia Contem- poranea di Marcos y Marcos. Nel 2020 è risultato finalista con menzione d’onore al 6° Premio Nazionale Editoriale “Arcipelago itaca”.
Vito M. Bonito, videolettura da “Fabula rasa”, Oèdipus 2018, nota di Rosa Pierno
Il suono afferra l’orecchio del lettore e lo instrada immantinente su un binario satirico, ma anche veritiero, poiché non soggetto, come appunto accade quando si sì imposta il propio pensiero sul tasto ironico, alla salvaguardia di alcun valore. Allora il personaggio-bambina ha gioco facile nell’introdurci in un mondo efferato ove ogni credenza acquisita e non verificata diventa il nostro demone dominatore. A meno di non avere il potere, che il poeta si assume, di cambiare regole e posizioni e assumere che il gioco sia un divellere il noto: “che oscura materia.../ che raggi / che mistici assaggi!”. Se un tema centrale si riconosce, quello della morte, esso è preso in una rete di favole e preghiere, desideri e illusioni con cui avvolgiamo l’argomento, costruendo le nostre difese. Ma il far scattare tutte le serrature, aprire le scatole chiuse e mostrare gli ingranaggi della serratura, rende la morte un evento disinnescato.
grisù
Quando passano nel sonno
fanno festa
i bambini
dicono tu niente
tu hai perso tutto
noi giochiamo felici
alle lucertole
illuminate
alle fiamme nel digiuno
alla neve che a iddio risale
che non fa freddo
e non si muore
più
*
è come un fuoco
lieve
nessuno ci vede
*
le candele per favore
fatele volare
l’insonnia ci gira
la mente
ogni volto respira
Nel niente
Vito M. Bonito vive a Bologna. Ha pubblicato A distanza di neve (Book, 1997) e Campo degli orfani (Book, 2000). È presente in Poesia contemporanea. Quinto quaderno italiano, a cura di F. Buffoni (Crocetti, 1996), con la raccolta Nella voce che manca. È anche autore di saggi sulla poesia barocca e contemporanea, tra cui Le parole e le ore (Sellerio, 1996), Il canto della crisalide. Poesia e orfanità (Clueb, 1999). Le ultime prove: Papaveri per niente (Derbauch Verlag, 2020), Di non sapere infine a memoria (L’arcolaio, 2021).
Anna Maria Dall’Olio, “Sì, mi merito”, nota di Ranieri Teti, con una videolettura di repertorio
Sì, mi merito
Era
essenziale trito ripetitivo
versus
superfluo sfizioso trasgressivo
un passo poi un’era poco poco più in là
via da domestico in postindustriale
da tradizionale in ultraglobale
da famiglialfa in mondobeta
tante merende spezzate da tanti cavoli
i cavoli incessanti del tempovita
graziosa grinza di greve giornata
tra solito e solito
fra un pasto e l’altro
(Zwischenmahlzeit, bacchetta Fraumerkel)
sanzione di contratto condiviso
stop lieto di prove glorificanti
dei pasti certo il più legale
dei pasti certo il più pro-UE
la vita forma sia da riforgiare
l’infrazione sia fusa col civile
qualunque scintilla scocchi
per chiunque con chiunque
nulla si mangi
nulla si ami
tutto si pilucchi
mi piace mi piaci mi piaccio
merenda sì me la merito
sì mi merito.
*
A prima vista, a prima letta, sembra che questa poesia “Sì, mi merito” si inserisca tra Ionesco e Beckett. In questo set linguistico creato da Anna Maria Dall’Olio, vivido e quasi elettrico, assurdo e significante, la prova ultima è la tenuta della parola e del linguaggio, messi sotto pressione. La ricerca dell’autrice non si perde in sterili prove, non offre esiti fini a sé stessi, non arretra di un passo in favore di una facile comunicatività. Nel testo a tratti la lingua si piega nelle sue assonanze (“graziosa grinza greve”), oppure accoglie l’intrusione del tedesco, salta da alfa a beta, ricrea, anche con sottile ironia e forte determinazione, uno spaccato del nostro vivere.
Anna Maria Dall’Olio (Pescia, 1959). Laureata in Lingue e in Lettere, esperantista, si è dedicata alla narrativa, alla poesia e alla scrittura drammaturgica.
Ha curato una rubrica sul mondo esperantista per “Incontrosaperi” e ha collaborato al periodico “Kontakto”, con una recensione su Il dolore di Giuseppe Ungaretti.
Ha partecipato a 4 edizioni della Fiera “Più libri più liberi” di Roma e alla 1a edizione del “Festival internazionale delle Letterature” di Milano. Nel 2018 ha vinto il 3o premio del Concorso internazionale “FEI” per la traduzione in esperanto di “Su una sostanza infetta” di Valerio Magrelli. Nel 2005 ha vinto il 2o premio del Concorso internazionale "Hanojo-via Rendevuo", patrocinato dal governo vietnamita, accanto a molti altri riconoscimenti ottenuti in Italia nel corso della sua carriera.
La sua pubblicazione più recente è Segreti (Robin, 2018), preceduta da: Sì shabby chic (La Vita Felice, 2018), L’acqua opprime (Il Convivio, 2017), Fruttorto sperimentale (La Vita Felice, 2016); Latte & limoni (La Vita Felice, 2014), L’angoscia del pane (LietoColle, 2010), 20 poesie nella rivista “Calamaio” (Book editore, anni 2009 e 2011) e Tabelo (Edistudio, 2006), dramma in lingua esperanto. Recensioni e articoli di critica sono stati raccolti in Le sirene di cartone di Anna Maria Dall’Olio (Editrice Totem, 2017).
Adriano De Luna, videolettura di “Raccoglieranno”, nota di Ranieri Teti
Come si pronuncia un momento estatico?
Imperturbabile nel turbamento, Adriano De Luna inanella visioni a immagini, sposta il senso del discorso, ne riprende il filo, mette in scena un istante che dura da “albe discurate” a “sinergici tramonti”.
Tutto questo può accadere solo in poesia. L’elisione sistematica degli articoli serra ancora di più il ritmo del testo, concentra al massimo questo repertorio di parole in movimento.
Nella relatività del tempo poetico, l’ascia della seconda strofa intaglia, nella terza, gli sguardi.
Nel multiplo intrecciarsi di situazioni simultanee, che talvolta sono volutamente smisurate, fotogramma dopo fotogramma, si delinea, nel succedersi dei versi, un sentimento totalizzante.
Adriano De Luna è nato a Fermo nelle Marche, dove lavora come avvocato libero professionista e docente di Diritto nel locale Liceo Classico Annibal Caro. Da molti anni membro del Consiglio di Priorato dello Studio Firmano dalla Antica Università (Storia dell’Arte medica e della Scienza http://www.studiofirmano.net/), ha pubblicato saggi di storia materiale, arte e diritto. Ha collaborato e collabora a quotidiani, periodici, riviste culturali e trasmissioni radiofoniche. Si dedica alla scrittura poetica e alle arti figurative sin dai primordi: alcuni interventi poetici sono apparsi su raccolte antologiche e riviste, ivi inclusa Anterem. Autore segnalato alla XVIII (poesia inedita), alla XIX (raccolta inedita) e alla XX Edizione del Premio Lorenzo Montano. Ha partecipato a Verona Poesia 2006 ed altri readings.
Zara Finzi, da “Le forme della neve”, Manni 2018, nota di Mara Cini
L’invernale sereno lucido di cui ci parla Zara Finzi è qui non solo condizione metereologica (di per sé stupefacente) ma rinnovata condizione del percepire.
Il rumore dei passi sulla brina ghiacciata produce uno scricchiolio come di pennino sulla carta. Le impronte lasciano traccia sulla terra, la natura si disegna, sopra e sotto la brina. L’inchiostro forma tracce emotive e storie sulla pagina. Nero su bianco in entrambi i casi.
Le forme della neve sono forme in continuo mutamento, forme del silenzio, forme che interrogano via via la natura del fuori e la condizione più interiore, quella personale del dentro. Nel cogliere con brevi fermo immagine testuali il loro fluire, perdurare, svanire o accadere è il tentativo di esserci, nel tempo.
Nella raccolta di Zara Finzi si alternano testi rarefatti, di segno astratto, ad altri “striati” di cronaca. Là dove evapora il bianco in / trasparenza emerge / il lato oscuro della neve poiché sulla superficie di questa creatura provvisoria si incide un mondo intero fatto di puri segni ma anche di memorie, ferite, incontri, figure d’arte e d’altra poesia.
*
sotto la coltre fitta, il cancello
non ha più la forza di gridare.
si aggrappa al muretto dove il
merlo guarda con interesse un
punto.
nero su bianco
*
a seconda del vento si
aggruma attorno alla
parola, la protegge
come quando era
soltanto verità
*
evapora il bianco in
trasparenza. Emerge
il lato oscuro della neve.
lei lo sa. una luce che non
genera ombre non è una
vera luce
Zara Finzi è nata a Mantova, vive a Bologna. Ha pubblicato numerose sillogi, interventi creativi e critici su riviste antologie. Edite da Manni sono uscite le raccolte La porta della notte (2008), Per gentile concessione (2012), Escluso il ritorno (2016), Spazio/tempo piatto (2020), Transiti (2022).
Eugenio Lucrezi, dalla raccolta inedita “Ingres”, nota di Giorgio Bonacini
Poesia e arte si accompagnano spesso, pur nei rispettivi ambiti per affinità concettuali o per un amichevole interazione linguistica. Questa raccolta di Eugenio Lucrezi è un concreto esempio di come i versi possano nascere, formarsi, strutturarsi a partire dal’amicizia con cui ogni manifestazione espressiva imprime il suo segno. Ponendo in essere una parola mai descrittiva o didascalica rispetto al referente che ne titola la scansione, ma sempre ricevendo e dando un senso ulteriore, oltre l’immaginazione del suono e della sostanza “porosa del verso”, come l’autore precisa. Si va dal quasi haiku alla sperimentazione letterale, dalla leggerezza ludica, alla visività fonica, fino a testi di pensante illuminazione. Senza mai venir meno a ciò che la scrittura aggiunge nelle sue modulazioni interne.
Conversazione tra lo spettatore e l’opera - per Franco Cipriano
Uno. Spettatore
Opus senza spolvero, richiamo
afono, privo d’onde come mare
afflitto da postrema bonaccia,
immoto quale lena di morto, stige
senza espressione, ruga
non più severa: piana, rassegnata,
arresa e inutile, se non fa più ridere,
vinta, se non fa mostra più del piangere,
clorofilla espiantata in cuore d’eme,
in osso e cartilagine di foglia, in rosso
che affligge specchi in stanze, oltre
giardini di carne e orti
gonfi di muscoli, che affligge
superfici inabili al riflesso: opus!
Tu che, non visto, guardi: cosa vedi?
Pensieri di Coleman - per me stesso
Sassi muschiosi: li raschi piano
con le unghie, strofini invano
la superficie porosa del verso.
Si sa, i muscolosi maschi amano
gonne lunghe, golfini fatti a mano:
lasse perfidie per rose perverse.
Trattato di storia in tre volumi
Volume primo. Storia completa dell’universo
Non me lo dire, fatti benedire,
abbi fede e bontà, nel precipizio
attestato sul bordo particella,
ché si ride e si piange nel profondo
domani che non dice e non ascolta
ragioni infinitesime e molecole
immensamente fragili, ridicole
nell'asserzione magnifica del mondo.
Esplosione, collasso e poco più,
solo a sentire il rumore di fondo.
Negazione decisa, non polemica,
che dice alla particola:
«Non abitare nella miscredenza,
non dire male dell'insensatezza,
stai fermo e dura sulla scoscendenza
come nell'esattezza di un destino».
Eugenio Lucrezi (1952), di famiglia leccese, vive a Napoli. Medico epidemiologo, musicista blues e giornalista, scrive di letteratura e di arte. Ha pubblicato il romanzo Quel dì finiva in due, Manni, Lecce 2000, e alcuni libri di poesia, tra cui Arboraria, Altri termini, Cuma 1989; L’air, Anterem, Verona 2001; Freak & Boecklin (con Marzio Pieri), Morra/Socrate, Napoli 2006; Cantacaruso : LenOnoSong (con Marzio Pieri), La finestra, Lavis 2008; mimetiche, Oèdipus, Salerno 2013; Nimbus, Eureka, Corato 2015, Sapìa, I libri del merlo/Il laboratorio, Nola 2016; Bamboo Blues, Nottetempo, Milano 2018; La canzone del guarracino, il filo di partenope, Napoli 2018. Già redattore della rivista di letteratura Altri termini, dirige la rivista di poesia Levania. Nel 2017 è stato nominato da Mario Persico Gran Ciambellano e poetapatamusico dell’Institutum Pataphisicum. Cura la pagina di poesia sul quotidiano “La Repubblica”, edizione di Napoli.
Alessandro Mazzi, audiolettura da "Avanzi Nudi", nota di Laura Caccia
L’eco del prima
Sono in effetti residui, lasciati scoperti nel loro essenziale esporsi, i testi di Avanzi Nudi. Alessandro Mazzi vi esprime la tensione e la nostalgia verso un prima intenso e significante e insieme l’orfanità della condizione attuale. Un tornare indietro: all’alba del mondo, anche se vi restano solo silenzi corrosi; all’evoluzione della specie, benché sia perduta la forma originaria; all’anteriore rispetto a sé, a quella tribù lasciata prima della nascita. A un’unità perduta. A un’identità smarrita.
Una messa a nudo dell’esistere colma i versi, benché la parola tenti di tornare alle sue origini: al silenzio che la precede. E benché non possa non manifestare la sua afasia a dire, soprattutto rispetto alle possibilità di ricomporre l’identità perduta e di trovare unità nell’altro.
Cosa resta allora, di tutto quanto aveva senso e appartenenza? Cosa sopravvive? Il dolore del vivere, innanzitutto, comune a cose e viventi. Le fratture e le frantumazioni subite. E una speranza: “Sfiorare l’altrove / coi rigonfi del vivere”.
O con la parola: in fondo Alessandro Mazzi dà ancora credito al dire, non nella sua pienezza - la pienezza è del silenzio, così come dell’unità originaria - ma negli avanzi che lascia affiorare, nei residui a cui può dare ancora voce, fossero solo echi di incontri, sonori di corpi, “memorie / cantate al mare”.
1
Non c’è più un mondo
ma un tempo che scalda
la siepe,
rovinose vene ramificano
sugli scogli del dolore,
scaviamo un silenzio eroso
gettato in un vaso
di foschia
4
Suonano l’aria i corpi,
piovono le memorie
cantate al mare,
una torre di pietre
unisce cielo e terra,
l’asse delle schiene
sfiora il pelo
dell’anima tigrata
7
Di tanti mari piangiamo
le acque nelle acque,
avessimo una proboscide
saremmo animali saggi?
Sfiorare l’altrove
coi rigonfi del vivere,
nostalgia della coda
noi primati
11
In me combatto
la parola e il silenzio,
l’una mi vuole cantore,
l’altro confessore.
Non sono gemelli?
Il poeta è finzione
del muto.
17
Costretto a vivere
rinascite su rinascite,
cerco maestri negli alberi
e padri nelle onde,
questo è il dolore
degli orfani
19
Cos’è quella differenza
che permette la comunione
ma accenna appena
all’identità?
Anche volessi
non saprei nominarla
Alessandro Mazzi nasce a Pompei il 17 Aprile 1990. Si laurea in Estetica all’Università “L’Orientale” di Napoli con una tesi originale su Hölderlin e il Taoismo, sotto la supervisione del prof. Giampiero Moretti. Dopo un periodo in Islanda, continua lo studio della filosofia e delle scienze pure all’Università di Urbino, dove è attualmente laureando. Collabora con diverse testate online, tra cui La Tigre di Carta e L’Indiscreto, e tiene seminari filosofici all’università.
Marco Mioli, videolettura da “Leggi questo libro”, nota di Laura Caccia
Clicca oltre
leggi questo libro: ci invita Marco Mioli. E, del continuo, persistente coinvolgimento che viene messo in atto, veniamo immediatamente resi complici. In un duplice senso: quello del partecipare al testo in modo consapevole, interrogandoci, insieme all’autore, sulle questioni poste, e quello del farci lettori critici dei rituali comunicativi attuali.
I testi, pervasivamente interrogativi, esigono un lettore che stia al gioco. Un gioco libero e fermo, che richiede “un minimo di serietà altrimenti / anziché scrivere con la penna. // finisci tu la frase”.
Le frasi interrogative, come un ostinato ritmico, rimarcano il disegno dei versi, mentre la melodia, franta e dissonante, sollecita questioni esistenziali, intervallate a espressioni della comunicazione social, a richieste al lettore di completare la frase, a “clicca qui” ripetuti.
Link di collegamento apparentemente impossibili, che proprio per questo si fanno magia: una forte complicità scrittore-lettore nello smascheramento dei rituali social, nelle interrogazioni di senso, nelle aperture sull’oltre. Marco Mioli lascia intravedere fino a dove si possa arrivare: nella scrittura, fino a superare il limite apollineo, formale, “sempre più. / fino a farci scoppiare / il cuore”, e, nella lettura, fino a essere sollecitati a chiederci, a partire dai primi versi, perché si stia leggendo, cosa ci abbia “spinto fino a qui” .
-----
c'è un impasto umano
è difficile dargli quel senso
non posso dire troppo qui
preferirei scolorire encausti
trascinare radici
pendolare lampioni
consumare marciapiedi
ma non a san lazzaro
spero nemmeno tu ci vada.
-----
soffri di coliche
relazionali?
lo so che ti piace stare in compagnia.
come ti trovi li?
dove senti che altri non potrebbero mai arrivare?
dove percepisci le distanze che ti scollano.
paura vero?
un aperitivo ricongiunge l'universo
dopo mitragliate di baci a pagamento.
ma non qui.
please.
un minimo di serietà altrimenti
anzichè scrivere con la penna.
finisci tu la frase.
clicca qui per compilare la parte finale.
-----
densità di fumi rupi
asciutte sponde di mari
profondità di tebe
e tu?
dove sei ora?
-----
sempre più.
fino a farci scoppiare
il cuore.
fino ad oltrepassare
un limite apollineo
a cui siamo sconfinati
per eterno sentimento d'ordine.
clicca qui per uscire.
Marco Mioli (Montecchio Maggiore 1982) si laurea in Architettura presso l'Università IUAV di Venezia e successivamente studia Scienze e Tecniche del Teatro approfondendo una ricerca sulla relazione tra suono, spazio e scenografia.
Come critico d'arte ha pubblicato testi per artisti e mostre tra cui un'esposizione di arte contemporanea al Museo Archeologico di Napoli.
Le sue poesie sono finaliste al Premio Lorenzo Montano e al concorso Opera Prima.
Vive e lavora a Trissino (Vi) e Pola (Hr).
Francesca Monnetti, videolettura di “Di ritorno dal Mart”, nota di Ranieri Teti
Il verso scelto da Francesca Monnetti è breve. Spesso composto da una sola parola. Questa brevità produce, in “Di ritorno dal Mart”, un ritmo serrato. Le emozioni di una mostra si traducono così in emozioni linguistiche. Il pre-testo, un’esposizione di Gianfranco Baruchello a Rovereto, consente a Monnetti di coniugare le suggestioni visive con l’esperienza del viaggio, quello che è rimasto impresso con quello che si muove costantemente intorno. Tra la cosa che si è fermata nella mente e l’osservazione mobile circostante si alterna mirabilmente il testo: tra passato prossimo e presente, tra stasi e movimento, in un flashback continuo tra rotaie e cornici.

Francesca Monnetti è nata a Firenze e da sempre vive a Sant'Ellero, una piccola frazione del comune di Reggello, in provincia di Firenze.
La sua prima raccolta edita di poesie, In-solite movenze (Cierre Grafica, Verona, 2009), è giunta finalista al “Premio di Poesia Lorenzo Montano” (2008) ed è stata inclusa nella collana “Opera Prima” di Anterem Edizioni, diretta da Flavio Ermini.
Pen-insul-aria (Edizioni Helicon, Arezzo, 2017), sua seconda raccolta edita, in prima stesura era stata segnalata come raccolta inedita al “Premio di Poesia e Prosa Lorenzo Montano” (2011) ed è giunta finalista, come opera ancora inedita, alla I edizione del Concorso di Poesia e Narrativa “L'Erudita” (Giulio Perrone Editore, Roma, 2012), la cui giuria era composta da Cristiano Armati, Paolo Febbraro, Matteo Lefèvre, Giorgio Manacorda, Walter Mauro, Giorgio Nisini e Cinzia Tani.
Alcune delle sue opere poetiche hanno ottenuto vari riconoscimenti in concorsi di poesia, nazionali ed internazionali:
- una silloge ha vinto la IV edizione del Premio Letterario Sergio De Risio (2010) dedicato al pensiero poetante (i cui membri di giuria erano Renato Minore, Flavio Ermini, Filippo Maria Ferro, Giuseppe Langella, Cesare Milanese, Giancarlo Quiriconi, Maria Cristina Ricciardi, Jacqueline Risset, Marco Tornar e Raffaele Saraceni);
- nel 2018 un suo poemetto inedito, Secondo-genitura, ha vinto la sezione “Poesia inedita” del Premio Letterario Castelfiorentino;
- la poesia singola Siccità ha vinto la sezione omonima del Concorso di Poesia e Narrativa “L'Erudita” (Roma, Giulio Perrone Editore, edizione 2012);
- nel 2019 una sua poesia singola, Carne in fuga, ha vinto il III Premio alla 44° edizione del Premio Casentino;
- nel 2017 una sua raccolta inedita, (S)oggetti a (s)comparsa, è stata selezionata tra le opere finaliste al II Premio editoriale organizzato da “Arcipelago Itaca edizioni”;
- sei poemetti inediti sono giunti in finale nella sezione “Poesia inedita” del “Premio di Poesia e Prosa Lorenzo Montano” (edizioni 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020);
- nel 2014 una sua raccolta inedita, Elisa, è stata segnalata alla 28a edizione del Premio di Poesia “Lorenzo Montano”;
- poesie singole e sillogi sono state segnalate in occasione del Premio Letterario Castelfiorentino (edizioni 2011 e 2014), del Premio Nazionale Alpi Apuane (32a edizione), del Premio Nazionale di Poesia “Pietro Borgognoni” (2016), durante le ultime tre edizioni del Premio Casentino, al Premio di Poesia “Lorenzo Montano” (edizione 2019), al Premio “La Ginestra Firenze” (2020) e da parte di giurie di altri premi letterari.
Alcuni suoi testi poetici compaiono online sul sito “Carte nel vento” della rivista “Anterem” (curato dal poeta e critico letterario Ranieri Teti), sul sito del Premio Letterario Castelfiorentino (curato dal Professore e critico letterario Marco Marchi), su “Blanc de ta nuque” (del poeta e critico letterario Stefano Guglielmin) con nota di lettura del poeta e critico letterario Giorgio Bonacini,, sul blo-mag “Arcipelago Itaca” (del poeta ed editore Danilo Mandolini), sul sito del Premio “Firenze”, del Premio Internazionale di Poesia “S. Domenichino - città di Massa” e sul sito del Premio “Arno fiume di pensiero”. L'autrice è altresì presente in volumi antologici legati a concorsi letterari.
Clemente Napolitano, videolettura di “Le raffiche soffiavano distanze”, nota di Ranieri Teti
Una prosodia moderna ci viene offerta da Clemente Napolitano: il suo testo senza punteggiatura e senza rime si regge sull’architrave del ritmo, sull’architrave di un ritmo segnato dalla metrica, che incrocia l’endecasillabo. Si percepisce uno sforzo creativo centrato sulla dicibilità, come se la poesia fosse destinata, per sua naturale connotazione, all’oralità. Ora dobbiamo pensare che questo è solo il vestito, la confezione, la cornice, la forma.
Il corpo del testo rende l’istantanea di una corsa, forse in moto o più probabilmente in bicicletta, e racconta quell’attimo fermato tra l’osservazione e il pensiero, tra il sentire e il descrivere, verso ”la sola direzione celebrata”. Il senso ultimo è quello dell’inarrestabilità della vita, nonostante “macerie e disincanti”, nonostante il vento contrario.
Clemente Napolitano nasce a Caserta, il 2 giugno 1965. A Marigliano (Na) trascorre l'infanzia e durante l'adolescenza frequenta il Liceo Scientifico "C. Colombo". Si trasferisce poi a Bologna, dove si laurea col massimo dei voti al D.A.M.S.
Allievo di eminenti maestri della scena teatrale italiana (Leo De Berardinis, Claudio Meldolesi, Carlo Merlo) frequenta, durante e dopo gli anni universitari, numerosi corsi di specializzazione in arti sceniche con particolare riguardo al settore dell’interpretazione e della regia.
Dai primi anni ’90, generalizza l’attività teatrale a stimolo di rinnovati impulsi creativi e culturali: assume supplenze di Storia dell’Arte nei Licei di Napoli e provincia; promuove seminari, dibattiti, progetti interartistici per la costruzione di nuovi spazi orientati ad arginare indifferenza e degrado; è interprete delle sue messinscene e di progetti musicali; realizza reading di poesia; collabora con riviste locali e nazionali; conduce seminari, dirige spettacoli nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania e nelle Università di Bologna e Salerno; svolge attività di Teatro e carcere.
Come attore ha collaborato con Leo de Berardinis: Macbeth di William Shakespeare; Carlo Merlo: Cristoforo Colombo di Michel de Ghelderode, Filosoficamente di Eduardo De Filippo; Renato Carpentieri: La serra e Party time di Harold Pinter.
Pubblicazioni:
- Clemente Napolitano, FLUXUS, Nola, L’arca e l’arco, 2015.
- Clemente Napolitano, Oggi è “ancora più lacerante il suo silenzio”, in LA TERZA VITA DI LEO Gli ultimi vent’anni del teatro di Leo de Berardinis a Bologna, riproposti da Claudio Meldolesi con Angela Malfitano e Laura Mariani e da “cento” testimoni, Corazzano, Titivillus, 2010.
- Clemente Napolitano, La fenice e il thanatos, in “Annuario Liceo Classico <<A. Rosmini>> Palma Campania”, 2007, n° 7.
- Clemente Napolitano, ‘O compagno, in AA.VV., La Madonna del Latte 10 racconti per 10 anni, Palma Campania, Michelangelo Communications, 2007.
- Clemente Napolitano, Il teatro dell’impervio, in “Officina Vesuviana”, 2001, n° 2.
- Clemente Napolitano, La voce dell’attore, Milano, Guerini, 1995.
- Clemente Napolitano, L’attore: voce dell’uomo, in AA.VV., L’uomo la voce la comunicazione verbale, Milano, Guerini, 1993.
- Clemente Napolitano, Progetto “Prometeo”. Quanto pesa il teatro, in “Teatro e Storia”, 1992, n°1.
Adriano Padua, da “Still life”, Miraggi Edizioni, 2017, nota di Rosa Pierno
“Still life” di Adriano Padua nasce dal considerarsi immersi in una realtà metropolitana che provoca un immediato viraggio elettrico. La notte in una città non è mai buia. E per lampi si compone un collage di pezzi incongruenti. Il linguaggio è convocato come teste a cui inutilmente si chiede una deposizione: “martirio in assenza di corpi mediato in sistema di segni”. I segni non producono il nuovo, non reagiscono, si fanno complici o relitti del già avvenuto. La versificazione ritmata, anche nelle lasse in prosa che sono alternate alle poesie, ci ricorda la presenza di uno scorrimento filmico oltre che musicale. Nella sequenzialità che funziona come nastro trasportatore se non c’è speranza di uscire dal tranello esistenziale, vi è però possibilità di progettare una fisionomia personale che non venga schiacciata al pari di un’ombra, pur se “non c’è più nemmeno il luogo” nel quale esercitare un‘esistenza: “preghiere senza dio / per dirti che io sono come te / ma mi distruggo meglio ad armi pari”.
“Ancorati a un continuo tornare, dispiegandosi attorno a confine lo scarno paesaggio assediato, senza inizio di sorta, gli occhi in preda a una notte sepolta, perduranti e fissate vedute, campi neri infiniti, spazi aridi e oro di luce. Una storia che si contraddice, voce onda di cose descritte e di azioni narrate in sequenza, mentre l’oscurità scaturisce, liquefatta e s’inerpica su per il corpo contratto, incastrato nell’aria e lo arresta, di scatto. Questo niente racconto, o non te lo diranno, le parole coltelli tra i denti, un morire e rinascere muto, il silenzio tiranno, un tessuto intrecciato di stelle inesplose e splendenti, versi immersi a bruciare, nel bagliore che fanno.
1.1
poesie sbandate della bestia nera
parole torte a replicare demoni
linee precise che formano scheletri
pensieri all’universo senza senso
come scanditi in silenzi elettronici
diffusi a scosse tra le cose perse
tuoni che spezzano le ossa al cielo
visi smarriti in contorni dissolti
pioggia battente a gocce d’inchiostro
casa crollata di vive macerie
respiro pieno mozzato dal vuoto
buio deserto di città teatrale”
Adriano Padua (Ragusa 1978) vive a Roma. Laureato in Sociologia della Letteratura a Siena, lavora nel campo della comunicazione e dell’informazione. Ha pubblicato numerose opere poetiche tra cui Le parole cadute (d’if 2009), Alfabeto provvisorio delle cose (Arcipelago 2009), La presenza del vedere (Polimata 2010), Schema. Parti del poema (d’if 2012). Esegue performance in collaborazione con musicisti e videoartisti.
Lina Salvi, da "Del deserto", puntoacapo Editrice, nota di Laura Caccia
Del tutto, del niente
Quale luogo irrompe, con impeto dolente, nella raccolta Del deserto in cui Lina Salvi spalanca il suo orizzonte conoscitivo e poetico, con versi protesi, al limite del noto e del tangibile, nella loro necessità di dire?
Non il deserto vissuto attraversandone le geografie, l’autrice lo precisa in nota, né il deserto interiore di un sentire dilatato e disadorno. E neppure lo spazio che si fa metafora della sua infinitudine.
Un luogo, piuttosto, che realmente pretende di venire allo scoperto, nel pensiero e nel corpo dell’autrice, che fisicamente chiede di esistere nella sua voce e nella sua parola. E che si mostra nelle sue incursioni, in uno sguardo spaesato, nelle ferite del vivere, nei pensieri scomodi sul morire, nelle esperienze quotidiane, “dal deserto al tiglio del giardino”, fino a “quel gusto / di cenere del cielo, che è Milano”.
Soprattutto in una messa a nudo di sé, in cui il deserto incarna una tensione al vero, colto in un attimo a mezz’aria, nel percepire del luogo “l’ombra a un passo”, nel cercarne la faccia nascosta, “quasi un suo rovescio”, nel porsi sul crinale, “essere sul precipizio”.
E la parola che si mette a nudo, mentre consente al deserto di prendere voce, del deserto assorbe la violenza e l’incanto, la vitalità e l’assenza, oscillando tra i “versi cannibali” e i “nomi sconosciuti”, tra lo scrivere “per i morti / e per i vivi” e la scelta del silenzio. Poiché per Lina Salvi “ogni parola / può essere sepolta, dimenticata, / ogni parola potrà il tutto, sarà il niente”.
*
Del deserto non ho voglia
della sua violenza calma
cavalcate ai margini del cielo,
nel deserto già ci sono:
ahlan wa salan°,
nel deserto popolato di uomini
buie città, annuvolate,
assediate di ogni specie animale,
alberi con rami tondi, bocche infuocate.
Della tundra, nel polare,
che dico? Se non quel volteggiare
in aria, terra, affondare
il piede in una zolla
del viaggiatore la sua ombra
così lunga, così distante.
° (saluto di benvenuto)
*
Con palle di fuoco ho assaltato una rocca, con le parole di Emily D. con il fucile carico, l’allegro-malvagio mantiene il suo scrigno, non so cosa cercare in strade di eterni carnevali, signori impazienti nonostante le rose, per cellule anomale. Tende di lana scura punteggiate, sete, tempesta di sabbia, vigile rassegnazione, sul bordo inferiore del labbro, quel sorriso dolcemente a scavalco, dal deserto al tiglio del giardino. Nell’inverno uno sterco di animale, inclinazione alla verità puntuale. * Del deserto l’ombra a un passo senza sosta in un caravanserraglio, un ronzio di pace la melodia dai Cafè Anatolia, un canto levantino per una rotta impropria, seguirà dal nero infinito e chi fotografa teste, un fucsia legato alle stelle, dei fianchi non immobili dormono in luce piena. * Sono scesa sul fiume ad aspettare che l’acqua si placasse e il vento tutto, onda, onda d’urto mio corpo, e abbiamo parlato d’altro del nero infinito, di tecnica mista su faesite, paesaggi che vedrai, senza titolo. * 4 gennaio 2014 commuove e tinge di bianco un bosco, la neve può dire il gelo, dei visi morti. Non voglio dire niente, ogni parola può essere sepolta, dimenticata, ogni parola potrà il tutto, sarà il niente. Lina Salvi nasce a Torre Annunziata nel 1960, vive e lavora in provincia di Lecco. In poesia ha pubblicato, oltre che sulle seguenti riviste letterarie: La Mosca di Milano, Il Segnale, Gradiva, le seguenti raccolte: Negarsi ad una stella, Dialogolibri, Olgiate Comasco, 2003, con prefazione di Giampiero Neri, Abitare l'imperfetto, La Vita Felice, Milano, 2007, vincitrice del Premio Donna e Poesia 2007, Socialità (Edizioni d’if, Napoli , 2007- Premio Miosotis). Nel 2010, con la raccolta Dialogando con C.S., ha vinto il Premio Sandro Penna per inediti, pubblicata a cura del premio nel 2011 dalle Edizioni della Meridiana di Firenze, con prefazione di Elio Pecora; Lettere Dal deserto, con un’incisione di F. Giudici, per la collana Fiori di Torchio, curata dal Circolo Seregn De la Memoria, Seregno 2014; Del Deserto (Puntoacapo 2017- Finalista Premio Letterario Internazionale Città di Como, 2° Premio Città di Umbertide 2017). È presente in diverse rassegne antologiche, tra cui la recente Il Rumore delle Parole, a cura di G. Linguaglossa, Edilet, Roma 2015; Poezia edita a Bucarest (Romania), SUD – I POETI (MACABOR EDITORE), ed è risultata vincitrice del Premio Astrolabio 2016 per inediti.
La neve non è per chi non c’è più,
Eros Trevisan, audiolettura di “Gallerie”, nota di Mara Cini
Graphic novel, canovaccio performativo, tavola parolibera, canzone di guerra: …fili spianati / in spiatto cielo…fremono al nevaio…
La disposizione tipografica del testo, le immagini e gli interventi grafici che arricchiscono le pagine concorrono a fare di Gallerie un testo molto interessante pieno di riferimenti storici e letterari e nel contempo diario di voci presenti, racconto visivo, sonoro, dialogante.
Eros Trevisan sperimenta le libertà della musicale-parola _gramole perform’ poetiche.
Nel ’98 l’incontro con il poeta Camillo Pennati, che curerà la prima raccolta Agli Eterni Lunghi Flutti 2005. Segue Tiepidi Raggi 2007, sostenuta dallo sponsor -Dudu- (dir., G. Finazzi). Le pubblicazioni delle prose-poetiche illustrate divengono reading musicali:
il Pinocchio sale in Treno del 2011, inserito e promosso per il 150le dell’Unità d’Italia nella biblioteca di Villa Erizzo in Venezia. Nel 2017, Verde sasso di legno’18, la saga del buratto di legno tra i boschi, partecipa alla rassegna “Amico del Pinocchio 2018”. Terranova 2018, in memoria dei personaggi eroici quali G. Impastato, Pio La Torre e P. Rizzotto, vittime della mafia. Ricorrenza promossa dalla Biblioteca di Maerne. Commenti dai critici e lettere al poeta da Giorgio Barberi Squarotti, Aldo Forbice “Zapping” Radio Rai; Liliana Tedeschi “Arena” di Verona; Giorgio Cusatelli, Ordinario di Germanistica e letteratura Università di Pavia; Marzio Pieri, professore e critico letterario; Mario Stefani, poeta veneziano; Francesco Brunello, responsabile onorario del Gabinetto di lettura di Padova.
Gian Maria Turi, audiolettura di “Il corpo di mia figlia”, nota di Mara Cini
Un cantico della creatura che pulsa e cresce e si ramifica nel mondo.
Nasce e si fossilizza in un’eterna infanzia mutante, misteriosa: … piedini in quelle miscroscarpe costosissime o … la sua bambolina intagliata in avorio, gli arti snodati.
È di una creatura bambina che si parla, nata nell’amore del corpo di una madre, nello stupore dei balbettii che si fanno parola.
il corpo di mia figlia (mp3)
mi hai intessuto nel ventre di mia madre
Salmi 139, 13
Sei troppo vicina. Lo sei sempre stata, nessuno lo è mai stato come te.
Il tuo corpo è stato per un po’ un mio organo,
il più speciale, quello miracoloso, prima che tu acquistassi un respiro indipendente.
Il battito del tuo cuore nel mio utero ci rigenerava
già quando tu eri ancora un vermicino, una minuscola larva.
Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum
tanto veloce da sembrare nel panico, in affanno, mentre invece era gioia d’amore.
L’aggancio galenico tra cuore e amore, prima che diventasse cosa da diari adolescenti
e adesivi e carta di cioccolatini industriali,
era il mistero del sentire che si incarna, che prende forma e si muove.
Di quell’amore che sa come si mettono gli organi in posa nel ventre di una madre,
incastrati uno nell’altro e in fase, intrecciati da ghiandole e nervi,
nell’umido del sangue.
Il tuo corpo: quel miracolo collettivo di cui sono entrata a far parte nascendo.
Essere creati. Ricreare.
Il tuo corpo plastico e fragilissimo che ammette ogni sopruso e ogni carezza,
con cui, indifeso, stai imparando che farci: i tuoi piccoli gesti scoordinati,
piangerci dentro per rivendicare i desideri indicibili, provarti a imporli, chiederne il contenimento e il riconoscimento.
Cadevi, sbattevi la testa. Poche volte non sono stata attenta
e tu cadevi e sbattevi e piangevi e la consolazione ti ridava il sorriso. Hai sempre sorriso così tanto...
Al tuo corpo hai imparato a starci attenta quando ne hai preso consapevolezza,
quando hai capito che con quel bambolotto ti sentivi, ci stavi bene e male.
C’è questa spinta violenta alla vita violenta e tenerissima,
i tuoi tentativi e le cose che impari, ogni momento in cui cambi e scompari e ricompari già un’altra.
Creatura di feroci cambiamenti, senza i quali del resto non ci saresti
né ci sarebbe ogni cosa che ci è venuta incontro e intorno e ci ha fatte più felici, meglio avvedute, diverse,
tu formandoti minuto su minuto, io, cresciuta, precipitando nell’invecchiamento.
Tu e io nella banalità di essere madre e figlia, tra le banalità quella più assurda a pensarci,
e figlie insieme della creazione da cui riceviamo ogni cosa.
Ci sono le piccole cose e quelle enormi che abbiamo condiviso, che condividiamo ogni giorno.
I tuoi meravigliosi passi da astronauta – precari, traballanti, saltellanti – i dentini doloranti salivanti, le dita che ora svitano i tappi alle bottiglie
e prima erano ramuscoli letargici di carne. I tuoi piedini in quelle microscarpe costosissime
che ogni volta che restano vuote mi terrorizzano con la tua assenza.
Temo ogni giorno di non esserti abbastanza, di non dirti e non darti a sufficienza.
Ogni giorno mi spaventano le probabilità della tua morte, nel ricordo dei tanti bimbi morti
per cause naturali o accidentali o per inique violenze scellerate,
oggi e da sempre, e prego in segreto perché i lutti delle madri abbiano fine
e il dolore dei bambini sia espunto dal reale.
Da certi studi ho ricordato con pena immaginata la sofferenza che avvolse la famiglia
di quella bimba antica trovata a Grottarossa nel ’64, ritrovata mummia,
odorosa ancora di resine conifere versate sul suo corpo morto a caldo
e che in effetti quasi la resero pietra. Quando la rinvennero nel suo sarcofago,
gli operai che scavavano al km 11 della via Cassia per farci un palazzino, la buttarono via da una parte
per non dovere interrompere i lavori, fugare l’intervento della Soprintendenza.
Poi il giorno dopo qualcuno la rivide, la credé un cadavere
recente. Le foto di allora ne hanno conservato i lineamenti camusi e carnosi,
dopo diciotto secoli intatti di una sepoltura inespugnabile, ermetica, climatizzata,
i quali poi all’aria si dissolsero in un orrido scheletro conciato,
oggi esposto alla pubblica gogna dei turisti
nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo alle Terme, a Roma.
Con lei si rinvenne una bambola, la sua bambola, con lei sepolta a farle compagnia, intagliata
in avorio, gli arti snodati, con un diadema lunare a Iside sacra, la bambolina
come la bambina e i genitori del suo piccolo corpo sepolto, ripieno degli organi interni
per devozione a qualche culto orientale sincretista, probabilmente. E il dolore di quel gesto di opposizione alla corruttela della sua presenza,
l’imbalsamazione perché quel corpo amato resistesse all’annientamento, quel non volerla
mandare da sola nell’ignoto degli inferi, nel buio, nell’inerzia – lei accompagnata
dalla sua bambola devota. Quel gesto di un dolore senza tempo mi sgomenta.
Lo esorcizzo nella cura del tuo corpo, nei baci sulle costole che affiorano sul tuo torace, con il tenerti allegra, assecondando
la tua naturale gaiezza di bimba fortunata e ben nutrita.
Noi qui creature tutte nate nell’amore del corpo di una madre, per quanto poi il mondo ci oscuri, ci renda ignave, stolte, bisognose, spesso avverse.
Sei nata in luna piena e ho iniziato a contare il tuo tempo sulle lune.
Avevi una testa perfetta, rotonda, bionda, eri così senza macchia
che perfino l’ostetrica si è emozionata: “Com’è bella!” ha detto. “È tutta pulita”.
Dormivi di notte, coliche non ne hai avute, mangiavi con avidità
il mio seno mettendomi in uno stato di continua trasognata emergenza,
resa incondizionata ai tuoi bisogni di protezione e di cura, contatto primitivo.
Appena ti sei retta sulle gambe hai ballato. Ogni ritmo ti fa molleggiare
sui ginocchi, anche soltanto due mani che sciacquano i piatti e acquistano cadenza.
Avevi un anno e mezzo appena quella volta al ristorante greco,
i musicisti che suonavano il sirtaki, tu hai intrattenuto la piazza per mezz’ora
con piroette e braccia sollevate che chissà dove le avevi imparate quelle mosse.
Ti avrà mosso la musica stessa. Tutti ti salutavano quando ce ne siamo andate.
Sei una bambina che accentra l’attenzione nella benevolenza: sei bella, sorridi sempre.
Ti fidi, sei curiosa, ti interessano gli altri.
Oggi più di ogni cosa mi commuovo alle tue prove linguistiche, forse per la mia sensibilità ai linguaggi,
quando ripeti le parole che diciamo e ogni volta ti migliori e inventi codici elementari
per dire quello che ancora non puoi dire: “Sì! Sì!” quando vuoi tanto qualcosa, ripetizione enfatica; “Càcia, no. Càcia... no!”, quando sai che non ti devi togliere le calze perché ti raffreddi, ma ne vuoi la conferma.
Ogni giorno una piccola aggiunta, una sillaba nuova, un suono
più difficile per te che devi apprendere i linguaggi di due madri, due lingue materne.
Sarai più intelligente, dicono. E che emozione sentire i tuoi primi compagni
all’asilo che ti invocano, quando ti porto al mattino: “È arrivata Anna!”, che ti salutano quando ti riprendo: “Ciao ciao, Anna!”.
Sei una di loro. Appartieni a quel gruppo. Sei tu. Sei la più piccola, sei la star locale.
Non siamo già più così unite come quando mi succhiavi il calcio dalle ossa
o spremevi i miei capezzoli fino quasi a staccarli. La vita cresce in te,
s’infittisce nelle tue relazioni, la consapevolezza di te stessa sedimenta con l’esperienza che fai ogni giorno del mondo.
Piangi poco, quasi sempre ti diverti. Noi ti diamo sostegno,
siamo i binari sui quali tu puoi scorrere, fermarti, correre.
Siamo il cibo e la casa e il rifugio e il conforto, la famiglia in cui sei nata
e che secondo alcuni hai scelto quando ancora eri in spirito soltanto, per altri ti è toccata casualmente. In ogni caso
che la vita ti sia lieve, amore mio, e che tu sia lieve alla terra.
Mi chiamo Gian Maria Turi e sono nato a Bologna il 21 luglio 1969, dove ho compiuto gli studi elementari e medi inferiori. Nel 1983 mi sono trasferito con la famiglia a Genzano di Roma, per motivi legati al mestiere di mio padre. Nel 1989 ho ottenuto la Maturità Scientifica e l’anno successivo mi sono immatricolato alla Facoltà di Fisica dell’Università di Roma II “Tor Vergata”. Nel 1993 ho capito di avere sbagliato indirizzo di studi e mi sono iscritto alla Facoltà di Lettere dell’Università di Bologna, dove mi sono laureato in Filologia Romanza nel 1998. Durante il periodo universitario bolognese ho iniziato a scrivere con regolarità, risultando terzo classificato a un premio di poesie legato alla Facoltà di Lettere e presieduto da Ezio Raimondi e Niva Lorenzini. Una delle poesie premiate è stata pubblicata in Voci di poesia: rassegna di poeti contemporanei a Bologna, a c. di Gilberto Centi, Bologna 1997.
Conclusi gli studi universitari, mi sono trasferito per alcuni mesi a Saragozza, in Spagna, dove ho studiato lo spagnolo e camminato per il Cammino di Santiago di Compostela. A ridosso del nuovo millennio sono partito per l’India, dove ho viaggiato in lungo e in largo per oltre 8 mesi, raggiungendo il Nepal e le montagne dell’Himalaya. Dall’India sono approdato in Israele nel giugno del 2000. In occasione della Seconda Guerra del Golfo, ho iniziato a lavorare presso l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv come revisore dell’archivio anagrafico. Ho iniziato anche regolari studi cabalistici e, di conseguenza, ho imparato l’ebraico.
Dal 2003 al 2008 sono stato direttore amministrativo dell’Istituto Italiano di Cultura di Haifa, in Israele. In questo periodo ho terminato gli studi cabalistici, quindi sono stato costretto a lasciare il paese per la scadenza del permesso di soggiorno. Nel 2009 ho viaggiato di nuovo in India. Nel 2010 mi sono trasferito ad Atene, dove ho iniziato a lavorare come insegnante di lingua e cultura italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, e vi ho lavorato fino a quando la crisi economica ci ha permesso di avere un certo numero di studenti, cioè giugno 2012. Da allora ho lavorato come insegnante di lingua italiana privato, editor e traduttore. Sempre nel 2010 ho pubblicato presso l’editore Manni di Lecce il libro Acrilirico, raccolta di poesie e prose risalenti al periodo universitario a cui non avevo mai dato seguito. Opera segnalata al premio “Montano” - ANTEREM 2012.
A ottobre 2012 è uscito il mio libro Darśana de Malchut, che è stato presentato negli Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv e Haifa il 18 e 19 giugno 2013 e in alcune città italiane nel mese di dicembre 2013.
Il 23 marzo 2013 il mio inedito Canti della burocrazia si è classificato secondo ex-aequo al 14° premio Navile, città di Bologna ed è stato segnalato al premio “Montano” - ANTEREM 2014. Lo stesso è stato pubblicato in formato ebook nel dicembre 2014 sul sito del LaRecherche.it.
Ultima pagina: Giuseppe Martella su Anna Chiara Peduzzi, vincitrice del “Montano” 2020

Ci viene incontro nudo, inerme, questo testo di Peduzzi, quasi privo di paratesto (note, eserghi, dediche, divisioni in parti, titoli delle liriche) e di un intreccio lineare, con tanto di peripezie, nodi e scioglimenti. Soggetto invece a una serie di minime, continue variazioni di tono, ritmo e prospettiva nelle diverse liriche, a formare quasi tessere di un mosaico o facce di un prisma che rifrange la luce, proiettando molteplici adombramenti sulle figure esplorate.
Esiguo e prezioso, caustico e guizzante come lingua di fuoco che illumina e riscalda ma non si lascia afferrare e comprendere se non a rischio di ustioni: “all’improvviso accampata intorno al fuoco/ di inaudite parole scintillanti/ aggredisce il silenzio e fa irruzione/ come un vento caldo che spalanca/ le rime doppie il suono dei metalli/ così della fiamma iniziale non resta che l’assenza/ nell’incavo dei versi rifiutati/ l’eccidio dei pronomi personali.” (22) Una iniziale enigmatica dichiarazione di poetica che spero si chiarisca nel corso di questa lettura,
di cui la Poetica del fuoco di Bachelard potrebbe forse offrirci alcune chiavi. Ma più in generale è opportuno tenere presente l’influsso del pensiero e della poesia francesi del Novecento, in particolare quello di poeti come Yves Bonnefoy o Francis Ponge, col suo “partito preso delle cose” che sembrano farsi e disfarsi sotto i nostri occhi ma a nostra insaputa, come se non avessero bisogno di essere percepite dagli umani e vivessero una vita propria: arcaica, cangiante, enigmatica (“la cosa che di noi non ha bisogno/ per apparire e imprimersi nel mondo”: 21). Pura potenza che solo attende la parola che la nomini per passare all’atto, per assumere una forma semplice e necessaria (“non dette non esistono le cose/…restano inoffensive ad aspettare…infine necessarie e nominate”: 19) Ma anche le parole appaiono poi qui come cose fra le altre, indipendenti da intenzioni umane.
Proprio il dramma di tali parole-cose costituisce l’oggetto del nostro discorso, la cui nudità e candore ci lasciano a una prima lettura interdetti e stupefatti, soggiogati e curiosi. A soccorrerci ci viene incontro il titolo, “Figure semplici”, che suggerisce in prima istanza quelle della geometria euclidea che abbiamo appreso fin da piccoli: triangoli, quadrati, cerchi; cubi, sfere. Tuttavia, a me pare, che questo titolo contenga anche un’intenzione ironica, un dire altro, molto altro, ciò che c’è da scoprire nel corso del testo. Perché in che senso è da intendersi la parola “figure”? Geometriche certo, ma forse si tratta anche di figure del discorso, o piuttosto di quelle “forme semplici” di cui scriveva André Jolles: l’oracolo e il proverbio, il motto e l’aforisma, la leggenda e il mito, che si ritrovano nelle tradizioni popolari alle radici della nostra cultura. Tracce di un passato dimenticato, cellule di un discorso avvenire. Ma anche infine qui si tratta delle figure di una fenomenologia della percezione e della memoria che la nostra autrice ha perfettamente assimilato dai suoi maestri francesi, Ponge e soprattutto in questo caso Bonnefoy, con cui ha certo una grande dimestichezza avendone anche tradotto le opere. Proprio in questa “comunità dei traduttori”, per dirla proprio con Bonnefoy, bisogna situare l’opera di Peduzzi, cioè in quel lavorio continuo, carsico, di restituzione di un senso e di una presenza alle cose, attraverso parole che non appartengono mai del tutto a una sola lingua e che con le cose congiurano nel sottobosco della percezione (“L’impoetico intreccio vegetale”: 24; con le sue “agitazioni di cellule e membrane”: 27) – facendoci udire il loro brusio, come un rumore di fondo da cui le parole a lungo cercate, arrivano all’improvviso come battendo “dei piccoli colpi di martello contro la superficie del reale, sino a sbalzarne, come da una lastra di rame, la forma.” (Benjamin): l’annuncio laico di una sempre possibile rivelazione. Questa similitudine vale bene a caratterizzare l’opera di Peduzzi come quella di un incisore che forgia con lievi ritocchi una materia incandescente, per trarne forme esatte e preziose.
Ma poi “semplici” in che senso? Secondo il criterio della misura che regge la geometria euclidea o quello della deformazione continua, senza strappi, sovrapposizioni o incollature, che regge la topologia, una delle branche più feconde della geometria superiore e che per essere una scienza delle deformazioni è la più simile alla poesia, intesa nel suo senso originario e artigianale di “manipolazione” (poiein). Così per esempio in topologia un cubo e una sfera sono due oggetti omologhi in quanto da un materiale malleabile come il pongo, mettiamo, l’uno si ricava dall’altro senza strappi o incollature. A me pare che l’analogia topologica sia la più feconda per interpretare il nostro testo che simula nel suo complesso proprio un spazio di trasformazioni aperto, senza confini né direzioni, dove, tolte le incrostazioni dell’abitudine e del linguaggio, le parole e le cose si fondono in forme sempre nuove, impercettibilmente diverse, sotto la fiamma ossidrica di un demiurgo impersonale che si industria di creare un mondo in assenza di Dio e della storia, in una sorta di atmosfera quasi gnostica. Perché la semplicità annunciata non riguarda certo un linguaggio adamitico: un eden in cui le cose perfettamente create da un dio antropomorfo aspettano solo il loro censimento da parte del primo uomo, quanto piuttosto uno spazio fluido dove cose e parole galleggiano in uno stato larvale, attendendo di fondersi in un synolon, in una restituzione del pleroma dimenticato.
Lo spazio del testo infine, quello tipografico bidimensionale, è qui esplicitamente aperto, senza un inizio e una fine marcati, senza titoli e eserghi, senza uno sviluppo di alcun tipo. Dove ciascuna lirica costituisce la cellula di una micropolifonia delle parole-cose, una perlustrazione dei loro adombramenti, una serie di intagli e affondi in quella “carne del mondo” (Merleau Ponty) che pare offrirsi nuda alla esplorazione dell’infraordinario.
A costituire una minuziosa, estesa epoché fenomenologica che coincide con la s-composizione geometrica del mondo ricevuto in “figure semplici”: “Rifletti alla riduzione algebrica/ della vita ordinaria in diagrammi/ ogni punto in esatta corrispondenza/ allo stato del mondo/ alla sua essenza/ non più estrarre col forcipe un senso/ ma disegnare a matita rette e curve/ e numerare il multiplo e l’immenso/ in figure osservando” (26)
Per chi auspica una poetica dell’impersonalità, questo testo costituisce un esempio luminoso. Ma come osservava T.S. Eliot a suo tempo, per ottenere tale risultato, l’autore deve averne avuto una ricca su cui a lungo ha lavorato.
Alcune osservazioni di ordine strutturale, per concludere.
La versificazione è scorrevole. La prosodia presenta una serie di variazioni minime intorno all’endecasillabo: novenari, settenari, quinari, ma anche talvolta versi di 13, 14 sillabe, a sottolineare fasi diverse di quello scavo anamnestico, alla ricerca “della lingua sorgiva che rintocca” (8) con la quale finalmente poter restituire la piena presenza delle cose che altrimenti “non dette non esistono” (19).
L’adozione del verso sciolto non esclude affatto l’uso occasionale di rime, assonanze e consonanze a formare un denso tessuto fonico-ritmico che poi innerva i livelli semantico e figurale, a caratterizzare quella analysis situs che tocca tutti i gradi della scala naturae costituendo una peculiare fenomenologia della parola-cosa, indagata more geometrico (25) o addirittura algebrico (26), in un esame minuzioso dell’infraordinario (26), in una sistematica scomposizione delle forme ricevute (28) che tocca non solo il retaggio della storia ma anche l’inganno della ragione.
E ovviamente poi ponderate analogie, sinestesie e metafore, tra cui particolarmente saliente è quella dell’humus-sottobosco (“l’impoetico intreccio vegetale”: 24) che attraversa, anche inespressa, l’intero testo, trattato appunto qui come uno spazio topologico di continue microtrasformazioni, quell’ “infimo travaglio” (30) di cui bisogna mettersi in ascolto per poter infine pervenire alla nominazione necessaria (33) che consente il trapasso delle cose dalla potenza all’atto, in una escatologica “chiaroveggenza” (37).
E poi c’è quella della “faglia”, della cesura che abita dall’origine la parola poetica e ne comporta il rischio di una definitiva espropriazione, del suo ammutolire e farsi cosa fra le cose, “mostro e captivo o forse solo infante” (34), in quel sacrificio ricorrente che è ogni vero atto di creazione.
C’è infine quella del “limite”, di volta in volta orizzonte (31, 32) o profilo (36), ma soprattutto “crinale” tra potenza e atto, essere e coscienza, volontà e rappresentazione, come accade, con un vero e proprio soprassalto della rima, nei versi conclusivi di tenore metapoetico: “l’atto tramuta volontà in sapienza/ - saggia la forza e la sua resistenza/ condanna a prese rapide dal vivo/ coscienza intermittente e abbarbicata/ ad attimi di pia chiaroveggenza”. (37)
La fine rimane così in sospeso come l’inizio (“Circola tra oleandri mortali/ nome senza aureola/colmo all’orlo”: 17) a sottolineare la fluidità di questo spazio-tempo che resiste a ogni investimento ideologico, fatale in uno spazio metrico-vettoriale, dove le opposizioni “alto-basso”, “destra-sinistra”, vicino-lontano, aperto-chiuso, finito-infinito finiscono fatalmente per assumere i significati di buono-cattivo, giusto-sbagliato, proprio-altrui, accessibile-inaccessibile, mortale-immortale, ecc. (Lotman 262), aprendo a quelle incrostazioni culturali del linguaggio, la cui rimozione è compito del poeta.
Così invece il nostro spazio topologico non si trasforma mai in uno spazio assiologico, rimane sempre così, aperto, smisurato, cangiante, pronto ad accogliere molteplici estatiche riletture.
Quarta di copertina: audiolettura di Silvia Comoglio da “Afasia”, Anterem edizioni, 2021
Audiolettura (mp3)
Marzo 2021, anno XVIII, numero 50

Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
Questo numero esce “per tenere accese le lucciole”, per “prendere la poesia sul serio”, per raccontare le cose che “arrivano, si raggrumano nell’inchiostro, poi ci abbandonano, poi ritornano”: sono frasi contenute nei primi tre interventi, di Cristiana Panella, Beppe Sebaste e Mara Cini.
Per merito della cura e della sensibilità poetica di Cristiana Panella, siamo lieti di proporre, per la prima volta in Italia, un’opera di Christophe Manon.
Il Premio Lorenzo Montano del 2019, per l’edito, è stato vinto da Beppe Sebaste. Non essendo stato possibile effettuare una premiazione in presenza, pubblichiamo una sua lettera inviata alla giuria e la risposta di Mara Cini; a corredo, una scelta di testi tratti da “Come un cinghiale in una macchia d’inchiostro”, Aragno 2018, le note critiche di Mara Cini e Rosa Pierno, il brano musicale composto per il libro da Francesco Bellomi.
Questo numero contribuisce a ricordare (succederà anche nelle prossime tre uscite) l’edizione 2019 del “Montano”, grazie ai poeti e prosatori che vi hanno partecipato, tutti introdotti dalla giuria: abbiamo il piacere di presentare, con le loro vive voci, Sonia Ciuffetelli, Lia Cucconi, Daria De Pellegrini, Paola Silvia Dolci, Ugo Mauthe, Tommaso Meozzi, Stefano Modeo, Alberto Mori, Alessandra Paganardi, Angela Passarello, Sandro Pecchiari, Antonio Pibiri, Rossella Pretto, Francesco Sassetto, Massimo Viganò.
Notevole è il numero degli autori finora pubblicati su “Carte nel vento”: rappresentano la storia del “Montano”. Ancor più notevole è la qualità di molti interventi. La storia di questo premio così longevo è stata scritta nel corso degli anni dai poeti e dai prosatori che lo hanno attraversato.
L’edizione in corso, la 35^, porterà nuove pagine da raccontare scarica il Bando della 35a edizione
In copertina: Mario Fresa, “Passaggio” (2009); olio, carta e inchiostro
Ranieri Teti
Quarta di copertina: Autori di “Carte nel vento”
Sebastiano Aglieco, Nadia Agustoni, Alessio Alessandrini, Pietro Altieri, Viola Amarelli, Angelo Andreotti, Marcello Angioni, Cristina Annino, Gian Maria Annovi, Lucianna Argentino, Davide Argnani, Giuseppe Armani, Paolo Artale, Gianluca Asmundo, Alessandro Assiri, Daniela Attanasio, Dino Azzalin
Luigi Ballerini, Paola Ballerini, Daniele Barbieri, Bianca Battilocchi, Maria Angela Bedini, Daniele Bellomi, Primerio Bellomo, Franco Beltrametti, Mario Benedetto, Dario Benzi, Riccardo Benzina, Pietro Antonio Bernabei, Armando Bertollo, Vanni Bianconi, Nicoletta Bidoia, Ilaria Biondi, Giorgio Bona, Giorgio Bonacini, Leonardo Bonetti, Simone Maria Bonin, Doris Emilia Bragagnini, Silvia Bre, Andrea Breda Minello, Fabrizio Bregoli, Luca Bresciani, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani, Simone Burratti, Giusi Busceti, Antonio Bux
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Giuseppe Calandriello, Maria Grazia Calandrone, Giovanni Campana, Mario Campanino, Enzo Campi, Giovanni Campi, Martina Campi, Emanuele Canzaniello, Maddalena Capalbi, Michele Cappetta, Roberto Capuzzo, Allì Caracciolo, Alessandra Carnaroli, Lorenzo Carlucci, Anna Maria Carpi, Peter Carravetta, Alberto Casadei, Mauro Caselli, Guido Caserza, Marosia Castaldi, Davide Castiglione, Paola Casulli, Alessandro Catà, Elena Cattaneo, Alessandra Cava, Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Alessandro Ceni, Rossella Cerniglia, Maria Benedetta Cerro, Marilina Ciaco, Viviane Ciampi, Gaetano Ciao, Antonella Cilento, Laura Cingolani, Mara Cini, Gabriella Cinti, Domenico Cipriano, Sonia Ciuffetelli, Roberto Cogo, Gabriella Colletti, Osvaldo Coluccino, Tiziana Colusso, Silvia Comoglio, Federico Condello, Nicola Contegreco, Antonino Contiliano, Morena Coppola, Giorgiomaria Cornelio, Marina Corona, Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto, Lia Cucconi, Miguel Angel Cuevas, Vittorino Curci
Mauro Dal Fior, Anna Maria Dall’Olio, Chetro De Carolis, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Lella De Marchi, Daria De Pellegrini, Annamaria De Pietro, Evelina De Signoribus, Riccardo Deiana, Silvia Del Vecchio, Fernando Della Posta, Pasquale Della Ragione, Stefano Della Tommasina, Aurelia Delfino, Tino Di Cicco, Danilo Di Matteo, Vincenzo Di Oronzo, Bruno Di Pietro, Stelvio Di Spigno, Letizia Dimartino, Paola Silvia Dolci, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria, Patrizia Dughero, Giovanni Duminuco
Marco Ercolani, Flavio Ermini, Franco Falasca, Mario Famularo, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina, Silvia Favaretto, Francesco Fedele, Federico Federici, Annamaria Ferramosca, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Luca Ferro, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory, Zara Finzi, Antonio Fiori, Raffaele Floris, Rita Florit, Ettore Fobo, Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Valentino Fossati, Biancamaria Frabotta, Kiki Franceschi, Tiziano Fratus, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Gabriele Gabbia, Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Maria Grazia Galatà, Marinella Galletti, Carmen Gallo, Gabriella Galzio, Guido Garufi, Paolo Gentiluomo, Mauro Germani, Fabia Ghenzovich, Alessandro Ghignoli, Gianluca Giachery, Anna Maria Giancarli, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Patrizia Gioia, Carolina Giorgi, Sonia Giovannetti, Marco Giovenale, Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Llanos Gomez Menéndez, Michela Gorini, Giuseppe Gorlani, Alessandra Greco, Angela Greco, Cesare Greppi, Lino Grimaldi, Maria Grimaldi Gallinari, Iria Gorran, Giovanni Guanti, Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini, Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin, Andrea Guiducci
Giovanni Infelìse, Maria Grazia Insinga, Carlo Invernizzi, Stefano Iori, Francesca Ippoliti, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Sonia Lambertini, Michele Lamon, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Leandro, Alfonso Lentini, Laura Liberale, Nicola Licciardello, Tommaso Lisa, Oronzo Liuzzi, Domenico Lombardini, Andrea Lorenzoni, Francesco Lorusso, Ghérasim Luca, Antonella Lucchini
Loredana Magazzeni, Giulio Maffii, Franca Mancinelli, Danilo Mandolini, Francesca Marica, Marianna Marino, Emanuela Mariotto, Attilio Marocchi, Raffaele Marone, Francesco Marotta, Giulia Martini, Giulio Marzaioli, Vincenzo Mascolo, Stefano Massari, Mara Mattoscio, Ugo Mauthe, Alessandro Mazzi, Luciano Mazziotta, Daniele Mencarelli, Tommaso Meozzi, Manuel Micaletto, Emiliano Michelini, Roberto Minardi, Marco Mioli, Stefano Modeo, Francesca Monnetti, Daniela Monreale, Gabriella Montanari, Emidio Montini, Marcel Moreau, Romano Morelli, Umberto Morello, Sandra Morero, Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Gregorio Muzzì
Luigi Nacci, Clemente Napolitano, Paola Nasti, Giuseppe Nava, Stefania Negro, Giulia Niccolai, Davide Nota, Mario Novarini, Marco Nuzzo, Riccardo Olivieri, Francesco Onìrige, Margherita Orsino, Cosimo Ortesta
Luca Paci, Marco Pacioni, Alessandra Paganardi, Cristiana Panella, Carla Paolini, Alice Pareyson, Paola Parolin, Giovanni Parrini, Angela Passarello, Sandro Pecchiari, Giuseppe Pellegrino, Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Daniela Pericone, Roberto Perotti, Anna Maria Pes, Serge Pey, Mario Pezzella, Luisa Pianzola, Antonio Pibiri, Renzo Piccoli, Antonio Pietropaoli, Roberto Piperno, Pietro Pisano, Stefano Piva, Marina Pizzi, Daniele Poletti, Gilda Policastro, Chiara Poltronieri, Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Stefania Portaccio, Claudia Pozzana, Ivan Pozzoni, Chiara Prete, Loredana Prete, Rossella Pretto, Maria Pia Quintavalla
Alessandro Ramberti, Jacopo Ramonda, Giuseppina Rando, Andrea Raos, Beppe Ratti, Filippo Ravizza, Luigi Reitani, Vittorio Ricci, Jacopo Ricciardi, Alfredo Rienzi, Giuliano Rinaldini, Alfredo Riponi, Massimo Rizza, Gianni Robusti, Marta Rodini, Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa, Sofia Demetrula Rosati, Lia Rossi, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti, Greta Rosso, Enea Roversi, Anna Ruchat, Paolo Ruffilli, Gianni Ruscio
Irene Sabetta, Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Rosa Salvia, Lisa Sammarco, Massimo Sannelli, Irene Santori, Patrizia Sardisco, Francesco Sassetto, Marco Saya, Viviana Scarinci, Antonio Scaturro, Evelina Schatz, Giuseppe Schembari, Fabio Scotto, Massimo Scrignòli, Beppe Sebaste, Loredana Semantica, Luigi Severi, Sergio Sichenze, Ambra Simeone, Stefania Simeoni, Roberta Sireno, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Marco Sonzogni, Pietro Spataro, Fausta Squatriti, Giancarlo Stoccoro, Stefano Stoja, Maria Paola Svampa
Antonella Taravella, Gregorio Tenti, Diego Terzano, Italo Testa, Ranieri Teti, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato, Carlo Tosetti, Silvia Tripodi, Luigi Trucillo, Guido Turco, Giovanni Turra Zan
Liliana Ugolini, Tonino Vaan, Adam Vaccaro, Luca Vaglio, Roberto Valentini, Camillo Valle, Sandro Varagnolo, Francesco Vasarri, Matteo Vercesi, Cesare Vergati, Maria Luisa Vezzali, Massimo Viganò, Nicola Vitale, Ciro Vitiello, Annarita Zacchi, Simone Zafferani, Paola Zallio, Claudio Zanini, Claudia Zironi, Aida Maria Zoppetti, Marco Zulberti
Ultima pagina, Mario Fresa: “Serale”, “Cluster”; bio dell’Autore

Collage, inchiostro e olio su cartone, 2009

Olio e collage, 2010
Mario Fresa (1973) ha collaborato e collabora a «Paragone», «il verri», «Nuovi Argomenti», «Caffè Michelangiolo», «Almanacco dello Specchio», «Recours au Poème», «Nazione Indiana», «La Revue des Archers» e «Poesia». Tra i suoi ultimi libri: Svenimenti a distanza (il melangolo, 2018); Bestia divina (La scuola di Pitagora editrice, 2020). Ha curato il Dizionario critico della poesia italiana 1945-2020 (in corso di pubblicazione presso la Società Editrice Fiorentina).
Prima pagina: Cristiana Panella presenta e traduce Christophe Manon; audio animato dell’autore
Prima pagina: Cristiana Panella presenta e traduce « Segni dei tempi » di Christophe Manon ; audio animato dell’Autore
Il testo di Christophe Manon qui proposto in traduzione, tra i cinque testi che compongono « Signes des temps », fa parte del progetto corale di prosa, musica e immagine, « Poèmes pour les temps présents », ospitato dal laboratorio di sperimentazione Ciclic. l’epifania, attraverso il frammento, di una memoria sociale che livella i corpi umani, animali, gli oggetti, i quattro elementi su uno stesso orizzonte ; che ne fa eventi equivalenti inscritti in un tempo dilatato e ciclico. le sequenze selezionate per i cinque Poèmes sono state attinte dall’archivio cinematografico di Ciclic : marine d’infanzia ; istantanee di pelle umana e animale partorite da una stessa madre dai nomi diversi ; fratellanza per dono di carni scoperte. loro malgrado, a loro insaputa. sequenze estranee e lontane tra loro, smagliate e cucite da un video all’altro a partire, in alcuni casi, da uno stesso filmato, dove lo spaesamento dato dalla scomposizione materiale della immagini crea nuove biografie, inverte intenzioni e valori, cambia il finale, secondo un principio di trasmissione che privilegia l’istante più che la narrazione. esistenze che scorrono nei gesti ripetuti : attese nascoste, regole, file, accadimenti crudi, gioie pudiche ancorate a piccoli mondi antichi. dolori lavici svelati e decodificati da una generazione all’altra, da una classe sociale all’altra, attraverso lo specchio della sofferenza altrui. ognuno ha i codici del suo sconosciuto in virtù della semplice condivisione della comune presenza al mondo, in uno svelamento reciproco di impotenza ma anche di potenza per istinto di desiderio, per memoria ostinata. tutto brucia, tutto è sacrificio di luce e fuoco. e là dove gli umani passano e scompaiono gli animali, presenze costanti dei cinque Poèmes, vegliano da magnifiche creature guardiane ; attraversano indenni il giorno e la notte.
La cifra poetica di Christophe Manon rispecchia lo SCORRIMENTO aleatorio di questa cucitura cinematografica. « Non mi interessano le storie […]. Quello che mi interessa è la lingua, la forma che si utilizza per esprimersi, per rendere manifesto, perché la lingua rivela una visione del mondo […], rendere conto del momento quando questo sfugge. Tentare di dire con le parole il momento in cui le parole vengono a mancare» (Johan Faerber intervista Christophe Manon, Diacritik, 29 gennaio 2019, trad. C. Panella). così come per il testo, la scelta dell’immagine per Manon non dipende dalla qualità o dal contenuto ma dalla capacità di portare una rivelazione, di suscitare uno sbigottimento, subito inghiottito dal lampo ordinario seguente. la vita è una successione allucinata, ossia presa-nella-luce ; un « canto brutale » e magmatico di enfiamenti. una preghiera laica alla dignità della rovina insita nella nascita, per eredità. una contemporaneità, quella di Manon, quella della poesia, che non è mai attuale. non è una sequenza pieghevole di atti ma un’evanescenza di gesti soli, precari e compiuti; rimasti al freddo, tranne per bagliori di leggerezza inconscia, fugaci ed eterni in una comunione poverella di invisibili beni vitali ; del retaggio inconscio ma stordente dei lutti ignoti di tutte le « moltitudini braccate ». una distopia che non è finzione, presentimento ma postura banale del quotidiano « ora noi viviamo in tempi di cenere e detriti, in un deserto disarticolato di gemiti e fuoco ». il fuoco e l’acqua sono due elementi onnipresenti nei Poèmes, elementi bifronti dell’infero e del superno : violenza e svezzamento d’amore, grazia vitale e annientamento.
Nella poetica di Manon la guerra, reale e metaforica, è guardata dal basso ; dagli occhi dell’infanterìa che offre l’innocenza dell’infanzia, di chi non ha parola, come carne da cannone. dagli occhi aperti e spenti con la bocca digrignata del soldato Lucien Geominne di Dubuffet ; un volto di contadino qualunque, pazzo qualunque, malato qualunque, bambino qualunque ceduto ad armi qualunque. la guerra è metafora della banalità non solo del male dichiarato ma anche di quello patito senza sapere dove guardare. delle schegge che inveiscono con neutralità, come in uno degli « ultimi telegrammi » di Manon : « gregge di cicloni furiosi stop papaveri predatori stop urla delle forche magnetiche stop grandi piogge di virgolette stop nugoli di carni avariate stop deserti di sterco stop coorti di suicidi stop città polverizzate stop universi in briciole stop » (da Qui vive, Dernier Télégramme/C. Manon, 2018 ; trad. C. Panella). e i primi cimiteri dei fanti sono posti banali per atti di morte banali. come un uomo avvolto dal fuoco che viene guardato senza fretta (Poème #5) ; stesso evento dell’eruzione di un vulcano, della colonna nera di un’esplosione, dello sparo che uccide un volatile partito dal fucile della giuliva cacciatrice che chiude il Poème #4. dopo aver gioito della sua mira punta la persona invisibile che le sta davanti, poi l’osservatore dietro lo schermo ; noi. uccello di carne o tiro a segno del Luna Park, stesso divertissement. perché l’accadimento è di per sé neutro, e per questo il dolore dei viventi più solo. e ripetendosi solo diventa folla. chiede dolcezza, compassione, indulgenza per tanta solitudine di massa, ogni volta, chiede.
« adoprarsi, alla fine, per far battere all’unisono i cuori di coloro che sono guardati e quelli di chi guarda », scrive Manon. per tenere accese le lucciole.

Autore e copyright della foto di Christophe Manon: Thomas Deschamps
Da Segni dei tempi #4
Christophe Manon
Traduzione: Cristiana Panella
Come la luce come sovente la sera come la luce declina e si stempera poi viene la notte, assolutamente come. O come se ci fossero loro, ci fossi tu, ci fossimo noi, ci fossero lui e lei, e noi fossimo tutti così tangibili, come vestiti di sogno e cambiando forma incessanti, e come opulenti, come manifesti, girando a una velocità vertiginosa sotto un vecchio cielo di ruggine, e tutto questo fosse di una dolcezza infinita. Come corpi vinti, come corpi trionfanti, come distesi insieme e simili sulla sabbia, felici forse a guardare il mare. E la risacca delle onde. Oppure era desiderio. O il vasto spazio che improvviso si apriva poi si richiudeva. Come se questo avesse una qualche importanza. È proprio questo, sì; è questo, che ci fu chiesto. "Qui più che altrove l'uomo può contemplare con spavento l'abisso di miseria dove l'hanno dato al precipizio lo spirito di violenza e il primato della forza". Ma pietà, disse lei, pietà. Pietà per la perdita delle rose. Uno due tre e quattro, e uno è già sempre abbastanza, è abbastanza ma troppo veloce. Ma non è un luogo, o così poco luogo. A stringersi gli uni agli altri. A giocare a nascondino. A risa scoppiate e urlare e cantare e dimenarsi e divertirsi e tutto questo perché? Perché? Oh, perché? E come fronteggiare? Come fare Segno di tutto questo? Camminando verso nuovi soli, sempre più grandi, e ancora più grandi, e non è finita. Poiché mai, no, mai noi siamo stanchi. Le tue labbra sulla mia pelle. Cos'è se non danza di particelle? Una presenza che forse non è un'illusione. Né sogno né vapore. Dove si annidano precisamente i morti nel loro giusto sapere. Un aereo. Un cane. Un bacio. Un trattore. Vecchie carcasse arrugginite in fondo ai filari di vigna. Un bacio. Un chilo di patate. Una domenica. Un quadrifoglio. Un coniglio abbastanza dolce da calmare la paura. E fabbriche e macchine e motori e solidi, anche questo è pensare. E fare fieno, mietitura, e non è niente, sii buono, sii buono per favore. Ad asciugare le lacrime. E cos'altro? È il suono della tua voce che mi commuove. Sotto Ogni Cucitura. La rabbia. La rabbia è il lusso autentico di uno splendore infinitamente rovinato ma che conosce il prezzo di un'emozione condivisa e nient'altro, nient'altro, e oltre. Da impiccarsi al tuo collo. È così tanto tempo che esisto, sai, e non posso dimenticare nulla. Se hai la testa altrove, adesso. Rosso. Rosso e nero, lo striscione dei possibili. Che sia lodato l'istante in cui in uno slancio improvviso mi prendesti per mano. È esattamente qui, la misura giusta. Mamma, sei tu, sei proprio tu, mamma, sei tu? Che abbiamo sete, in questo momento. Che loro si nutrono d'insetti e limacce. Che sono spavalde. Che sicuro ti piace se io adesso godo. Qui non più che altrove. Predatori e prede. La loro magra speranza di non scomparire. La loro immensa speranza di non scomparire. Ora che non è ora, ora. Riusciamo a ritrovarci in una grande confusione. Se il tempo lo permette. Un rospo, un uccellino, molto piccolo, o giusto piccolo. E grazie, grazie per averli qui. Cosa sono diventati? Lo so? A che età? Dove ci porterà, questo? Cosa significa? Che ne pensi, tu? Noi siamo a settembre, siamo ad ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, siamo a febbraio. Morti, così tanti morti, sepolti senza funerale. Da perdere la faccia. L’antico mondo sempre si riaffaccia.
Lettura animata dell’Autore, apparsa su « Ciclic »
Comme la lumière comme souvent le soir comme elle décline et s’estompe puis vient la nuit, c’est tout comme. Ou comme s’il y avait eux, il y avait toi, il y avait nous, il y avait lui et elle, et nous étions tous si tangibles, comme vêtus de rêve et changeant sans cesse de forme, et comme opulents, comme manifestes, tournant à une vitesse vertigineuse sous un vieux ciel de rouille, et tout cela était d’une douceur infinie. Comme des corps vaincus, comme des corps triomphants, comme étendus ensemble et semblables sur le sable, heureux peut-être à regarder la mer. Et le ressac des vagues. Ou bien était-ce du désir. Ou le vaste espace qui soudain s’ouvrait puis se refermait. Comme si cela pouvait avoir de l’importance. C’est bien cela, oui, c’est cela qui nous fut demandé. « Ici plus qu’ailleurs, l’homme peut contempler avec effroi l’abîme de misère où l’esprit de violence et la primauté de la force l’ont précipité ». Mais pitié, dit-elle, pitié. Pitié, pour la perte des roses. Un deux trois et quatre et encore un c’est toujours assez, c’est assez mais trop vite. Mais ce n’est pas un lieu, ou si peu. À se serrer les uns contre les autres. À jouer à cache-cache. À rire aux éclats et hurler et chanter et se déhancher et se divertir et tout cela pourquoi ? Pourquoi ? Oh pourquoi ? Et comment faire face ? Comment de tout cela faire signe ? Marchant vers de nouveaux soleils, toujours plus grands, plus grands encore, et ce n’est pas fini. Car jamais, non jamais nous ne sommes las. Tes lèvres sur ma peau. Qu’est-ce sinon danse de particules ? Une présence qui n’est peut-être pas une illusion. Ni songe ni vapeur. Où nichent précisément les morts en leur juste savoir. Un avion. Un chien. Un baiser. Un tracteur. De vieilles carcasses rouillées au bout des rangs de vigne. Un baiser. Un kilo de patates. Un dimanche. Un trèfle à quatre feuilles. Un lapin doux assez pour apaiser la peur. Et usines et machines et moteurs et solides c’est penser aussi. Et de faire les foins, de récolter les moissons, et ce n’est rien, sois sage, sois sage s’il te plaît. À sécher les larmes. Et quoi d’autre ? C’est le son de ta voix qui m’émeut. Sous toutes les coutures. La rage. La rage est le luxe authentique d’une splendeur infiniment ruinée mais qui sait le prix d’une émotion partagée et rien d’autre, rien d’autre et d’avantage. À se pendre à ton cou. Voici si longtemps que j’existe, je ne peux rien oublier. Si tu n’as pas la tête à ça. Rouge. Rouge et noir, la bannière des possibles. Que loué soit l’instant où d’un élan soudain tu me pris par la main. C’est bien là la bonne mesure. Maman, c’est toi, c’est bien toi, maman, c’est toi ? Qu’à présent nous avons soif. Qu’ils se nourrissent d’insectes et de limaces. Qu’elles n’ont pas froid aux yeux. Qu’assurément cela te plaît si maintenant je jouis. Ici pas plus qu’ailleurs. Prédateurs et proies. Leur mince espoir de ne pas disparaître. Leur immense espoir de ne pas disparaître. Maintenant qui n’est pas maintenant maintenant. On parvient à se retrouver dans une grande confusion. Si le temps le permet. Un crapaud, un oiseau petit, très petit ou seulement petit. Et merci, merci pour les voici. Que sont-ils devenus ? Est-ce que je sais ? À quel âge ? Où cela nous mènera-t-il ? À quoi ça rime ? Qu’en dis-tu ? Nous sommes en septembre, nous sommes en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, nous sommes en février. Des morts, tant de morts, ensevelis sans funérailles. À perdre la face. Le monde ancien toujours refait surface.
Cristophe Manon (Bordeaux, 1971) ha pubblicato una ventina di opere tra cui Extrêmes et lumineux (Verdier, 2015, Prix Révélation de la SGDL), Au nord du futur (Nous, 2016), Jours redoutables, avec des photographies de Frédéric D. Oberland (Les Inaperçus, 2017), Vie & opinions de Gottfried Gröll (Dernier Télégramme, 2017), Pâture de vent (Verdier, 2019), Testament (d’après François Villon), con un CD, (Dernier Télégramme, 2020). Ha lavorato per le edizioni Ikko, che fino al 2009 hanno pubblicato Henri Chopin, Michel Valprémy, Pierre Albert-Birot, Sylvain Courtoux, Vélimir Khlebnikov, Carla Harryman, Saint-Just, e per la rivista MIR. È autore di numerose letture pubbliche in Francia e all’estero.
Terza pagina/1, Beppe Sebaste e Mara Cini: epistolario intorno alla vita e al "Montano"; una nota di Cini; scelta di testi
Terza pagina/1, Beppe Sebaste e Mara Cini: epistolario intorno alla vita e al "Montano"; una nota di Mara Cini; scelta di testi da "Come un cinghiale in una macchia d'inchiostro", Aragno 2018
Cari amici e care amiche del Premio Montano e della rivista “Anterem”, buongiorno. Io vi ringrazio, anche se non vi ho mai incontrato, e anche se non so perché il mio libro abbia vinto il Premio Montano 2019. Forse, ho pensato, per avere l’occasione di parlare (di) poesia, di parlare il linguaggio della Lode (come si dice riferendosi al Divino) e cercare quindi di pulirsi la coscienza (cosa difficilissima). Lodare il Divino (sive Naturam, se preferite) e pulirsi la coscienza, sono la stessa cosa. Si fa con azioni diverse, una delle quali è appunto scrivere poesie, una pratica non priva di austerità che in altre lingue sarebbe definita “arte marziale”, o meglio: ”Via”. «Prendere la poesia sul serio», ha detto una volta Allen Ginsberg, significa praticarla «come una specie di sadhana, di sentiero sacro, o una forma di yoga». Non «come un’arte beneducata o una disciplina accademica, piuttosto una santità».
Se rientra nel suo orizzonte anche il premio che io avrei conseguito nell’anno 2019, l’anno del Covid, la faccenda si fa seria. Questo premio, e lo sfondo sociale, biopolitico in cui ha preso forma, è stato per molti un’ennesima conferma (per altri forse la scoperta) dell’assoluta impermanenza di ogni cosa e di ogni essere, di ogni azione, della fragilità irrilevante delle nostre umane aspettative e della nostra tenera illusione di programmare e affaccendarci per mantenere i programmi. Se la nostra consapevolezza si allarga e ne guadagna, non è tempo perduto. In questo senso, questo premio senza premiazione è stato un insegnamento dello stesso tenore, se non della stessa stoffa, di cui è fatta la poesia.
Un premio conseguito da un libro di poesie mi fa pensare all’incipit ioneschiano di una poesia contenuta nel mio libro, “Suonano alla porta”: “Quando suonano / alla porta / non si sa mai / se c’è qualcuno / o no”. Ecco, il premio Montano è stato per me una folata di vento di questo genere, un evento che non si sa se è accaduto o no.
Quando pensiamo di essere pronti a qualcosa, in realtà non siamo mai pronti. Credo che sia la ragione principale per cui scrivo poesie, sono tornato cioè a scrivere parole e frasi spezzate, inconcludenti e perentorie. Sempre di più ci accorgiamo che in verità tutto è frantumi, provvisorio, impermanente. Tutto. Non lo insegna solo il Buddha, lo insegna la poesia.
Queste parole non sostituiscono il discorso che avrei dovuto fare a Verona se il premio fosse stata occasione per parlare di poesia, parlare poesia, e rispondere anche al vostro invito a evocare la storia di Aelia Laelia, una “etichetta” (piccola etica) editoriale che contribuii a fondare quasi trent’anni fa, e che rivendicava il compito di pubblicare solo libri impubblicabili e necessari, quindi bellissimi (tra gli altri, di Amelia Rosselli, Carlo Bordini, Livia Candiani, Patrizia Vicinelli). Ma ancora non ho avuto io risposta alla domanda: perché mi avete premiato? Forse per parlare tutti insieme della nuda verità dell’accadere, del tempo, del kairos? Mi sono sentito, confesso, un po’ profugo: dal mio libro, dal premio, da un incontro con voi. Non è l’unica ragione per cui ho deciso di donare buona parte del premio a chi organizza accoglienza concreta per i profughi e i migranti – associazioni su base volontaria il cui lavoro benemerito e necessario viene puntualmente sgomberato da chi detiene le redini della legalità – come accade per esempio troppo spesso all’associazione Baobab a Roma. Forse la poesia esiste per questo, per andare oltre la legalità senza subirne troppo le conseguenze?
Credo che il sentimento e l’esperienza di essere profughi spieghi la poesia meglio di tanti discorsi. È quello che avrei detto a Verona sulla necessità di questa cosa fragile, questa impermanenza in atto, che è la poesia – una verità da non rinviare mai, da accogliere in ogni occasione senza indugio, senza scuse. Adesso. Qui.
Un caro saluto,
beppe sebaste
(Roma, 15 agosto 2020)
Caro Beppe Sebaste,
ti ho incontrato molte volte. Eravamo insieme dentro ai Narratori delle riserve (in quell’occasione ti ho visto a Cortona, in una specie di chiostro, mentre spingevi un passeggino e c’era un cane lupo. 1992?). Ti ho forse incontrato anche prima, negli interstizi della via Emilia, tra Mulino di Bazzano e Bologna, tra Patrizia e Corrado, tra Giulia e Franco Beltrametti. Ti ho seguito nel sentiero in-segnante dei tuoi libri (che poi mi sembra un solo Libro), chiedendo di te a Franca di Roma o riandando a quella volta che in una mattina di dicembre, gelata, costeggiai il lago di Ginevra (un viaggio in macchina dagli Appennini a Parigi), cercando di situarti anche in qualche geografia terrestre, oltre che poetica. Poi la sorpresa di trovarti tra i libri “da scegliere e premiare”, nell’intricata macchia degli inchiostri (ma con quel titolo ci voleva un disegno di Giuliano Della Casa!), come una rosa nell’insalata. Io so perché il tuo libro ha vinto il premio Montano…
Grazie.
Mara Cini (Anterem)
Lagune di Sasso Marconi, agosto 2020
Dice Sebaste “Niente è più comune di ciò che riteniamo intimo e personale, e niente è più condiviso del disorientamento del perdersi e del ritrovarsi. Insisto da tempo sul valore della soggettività…” Ecco la giustificazione per questa lettera.
Mara Cini per “Come un cinghiale in una macchia d’inchiostro” di Beppe Sebaste
Ritroviamo in questo libro di Sebaste la sua scrittura abitata. Abitata da revenants lontani nel tempo e nello spazio, improvvisamente presenti, al nostro cospetto. Sono apparizioni che in qualche modo ci riguardano, eventi casuali, disordinate illuminazioni che implodono tra il dentro e il fuori dove comincia il volo, e dove / l’immobilità.
Ritroviamo poesie-costellazione, geometrie temporali e geografiche, riverberi culturali e antropologici da Cézanne a Laurie Anderson, da inquadrature alla Hopper [lei è nuda davanti agli alberi sulla sedia] / [io la guardo al di là dagli alberi sul letto] / [con la maglietta bianca] a tagli verso l’infinito che ricordano l’ultima fotografia di Luigi Ghirri.
Ritroviamo molteplici annotazioni, conoscenze e saperi emotivi che albergano in chi scrive e in chi legge. Ecco è questo rimbalzo che vivifica i testi: il pulviscolo del pensato, del guardato, del detto, del vissuto che torna ad essere pensato, guardato, detto, vissuto…rinnovandosi nell’epifania, nella condivisione di un breve momento.
Le poesie del Cinghiale si sfilano da una lettura letteraria, se pure, alcune, squisitamente letterarie nei loro riferimenti stilistici. Da Corrado Costa (proprio di fronte davanti agli occhi / sulla strada che è linea di separazione / degli avverbi: sopra e sotto / proprio di fronte vanno davanti / agli occhi…) a E.E. Cummings (Cara, poiché tu sei una persona / (e vedo le tracce dei tuoi piedi / sulla neve che mi hanno preceduto) / cara…), da Ginsberg (Che io possa amare e essere amato / che io possa illuminare e essere illuminato/ prego ti prego / Ti. ) a Beckett (chi parla / chi è? / chi dice / “chi è”? / Chi è che dice / “chi parla”? / Silenzio. / Quale “silenzio”?).
Sono poesie scritte in un lungo arco di tempo, poesie sparse come si dice, che coincidono di volta in volta con un accadimento, uno sguardo, una lettura, un incontro. Depositati sulla pagina, i frammenti, immagini latenti mai veramente isolate le une dalle altre, ridisegnano disordinate geometrie interiori un po’ come le amate “impressioni fotografiche” di Francesca Woodman.
A volte sono perfetti oggetti-poesia (La poesia non parla di / non dice qualcosa su / ma parla con / è parte della cosa di cui parla / è evento dell’evento del dire / che dice). A volte sono canovacci, idea di romanzo (ecco, la scena è questa, ed è breve (loro non sanno perché stanno lì a guardarlo) / dopo proseguono…) a volte insensate performance (una volta ho suonato a casa mia / a lungo /non mi sono aperto / forse non c’era / nessuno eppure / sentivo chiaramente / trattenere il fiato / dietro la porta).
La scrittura per Sebaste è un viaggio dove è possibile non vedere neanche una parola, è una prova, come nella vita, non sempre superata (mi piacciono…le frasi vuote che falliscono e cadono).
La scrittura è un luogo e un tempo senza unità di memoria che rileva un passato / tanto più remoto quanto più recente. I ricordi di altri improvvisamente sono i nostri. I sentieri che abbiamo percorso portano in luoghi dove non siamo mai stati ma che altri descrivono con i nostri occhi Scrivere è lasciare segni invisibili e / poi vederli.
Le cose (qualunque cose voglia dire) arrivano, si raggrumano nell’inchiostro, poi ci abbandonano, poi ritornano, poi ci abbandonano Lo scrivere…è forma e non è forma come il bagnasciuga / quando le onde disfano ogni segno / che i tuoi piedi e le tue mani subito ricreano...
Beppe Sebaste, da “Come un cinghiale in una macchia d’inchiostro”, Aragno 2018
Parco centrale
diciamo “c’è un albero”, ma
non vediamo realmente l’albero
(...)
proprio di fronte davanti agli occhi
sulla strada che è linea di separazione
degli avverbi: sopra e sotto
proprio di fronte vanno davanti
agli occhi con la bicicletta vanno
e possono essere uomini
sulla linea di demarcazione
o donne di differenti età o anche
vecchi col giornale oppure
bambini col gelato
(...)
Ho fatto molte letture
(...)
più tardi compirò un endecasillabo spontaneo “lèggere
fin che non mi viene sonno”
ho fatto molte letture di poesie
chi scrive una poesia e poi la legge
crede di avere chiuso un cerchio
è una sensazione idiota e sai che i cerchi
non esistono
e ogni cosa è rotta
mi piacciono le parole semplici e le parole rotte
le frasi vuote che falliscono e cadono
Disegni amati [Desseins a(n)imés]
A Juliana Reining
[lei ha preso le misure sulle sue spalle prima di farlo]
[lei è nuda seduta sulla sedia e fuori il cielo è rosa]
[la finestra nel disegno non si vede ma dalla finestra si vede la gru]
[io sono dietro o di fianco disteso sul letto con la maglietta bianca]
[tra lei e la gru c’è la finestra]
[io vedo lei che disegna davanti al vetro]
[lei mi vede dalla gru]
[io sono il vetro, e scrivo le frasi]
[lei è il vetro, non ha gli occhi e disegna]
[ci sono gli alberi dentro la finestra]
[lei è nuda davanti agli alberi sulla sedia]
[io la guado di là dagli alberi sul letto]
[con la maglietta bianca]
[io sono in basso a sinistra, nel disegno]
(...)
La neve di Zermatt
Cara, poiché tu sei una persona
(e vedo le tracce dei tuoi piedi
sulla neve che mi hanno preceduto)
cara io ti tradirò sempre per lasciare
le mie tracce, per poter dire
“sono solo” nel mio naufragare
davanti a questa nostalgia (questo
naufragio) e sentirmi perduto
e perdermi, e dirlo:
Camminare in silenzio. Ogni tanto
fermarmi. Sulle punte degli alberi
uccelli cinguettano. Guardare.
Preghiera
(...)
Che io possa amare e essere amato
che io possa illuminare e essere illuminato
prego ti prego
Ti.
Pietà per me pietà per ogni essere
che io possa onorare il mio corpo la mia natura
che io possa onorare la natura di ogni natura
prego. Ti prego
che
io possa a lungo pregare
che io possa essere felice così come ogni essere
prego. Pietà.
Ti prego pietà. Prego pietà di me di ogni essere ti prego. Ti.
(suonano alla porta)
(...)
Quando suonano
alla porta
non si sa mai
se c’è qualcuno
o no
non si sa quasi
mai niente
di quello che c’è
da una parte
o dall’altra
della porta
una volta ho suonato a casa mia
a lungo
non mi sono aperto
forse non c’era
nessuno eppure
sentivo chiaramente
trattenere il fiato
dietro la porta
(...)
Sorgente
La poesia non parla di
non dice qualcosa su
ma parla con
è parte della cosa di cui parla
è evento dell’evento del dire
che dice,
nasce insieme,
come acqua sorgiva,
come bere acqua
dalla sorgente
Idea per un romanzo n.2
(...)
c’era Easy Rider in televisione, interrotto dalla pubblicità – l’acido
fatto al cimitero con le donne –
ma c’era una scena nuova (c’è sempre una scena nuova quando
si rivede un film – o quando si legge un libro)
che non mi ricordavo (ora non me la ricordo) (ora penso solo
al blues di dylan prima della loro morte) (ora penso a un pensiero
che avevo guardando il film, sul valore dei nomi, sui nomi che hanno
le esperienze, e senza i quali non abbiamo memoria)
il carnevale, ecco, loro che vanno fuori dal bordello con le
loro donne e camminano (le donne vanno fuori dal bordello e
camminano coi loro uomini)
loro che camminano e vanno per le strade a vedere il carnevale
isterico nella città – ci sono tante cose pazzesche da vedere –
ma loro escono dalla città (non era quella la scena)
si ritrovano in una periferia molto vasta con le case, poche, bianche,
quadrate, si fermano,
ora sono chini a guardare un cane morto, accostato al marciapiede –
ecco, la scena è questa, ed è breve (loro non sanno perché stanno lì
a guardarlo)
dopo proseguono, e vanno verso il cimitero
Scrivere su: fare - l’amore
Scrivere nel vuoto. Lo scrivere crea
il vuoto. Immagina
una grande superficie colorata
che muta di continuo,
è forma e non è forma come il bagnasciuga
quando le onde disfano ogni segno
che i tuoi piedi e le tue mani subito ricreano,
ma a colori.
Saltelli sui colori come Harpo che si arrampica
sui neon intermittenti fino al cielo
Scrivere è lasciare segni invisibili e
poi vederli.
Esempio di scrittura: l’amore.
Occorre il vuoto per realizzare un abbraccio.
Scrivere nel vuoto, scrivere il vuoto.
L’abbraccio crea l’abbraccio dove
c’è il vuoto, dove (non) c’è
nulla. Poi
l’abbraccio si scioglie.
Dove è andato l’abbraccio quando l’abbraccio
si scioglie?
Scrivere campi di colore immensi,
impronte d’infinito che debordano
ogni idea, ogni parola al di là di essere
e non essere.
(...)
Terza pagina/2, Francesco Bellomi: musica per il poeta Beppe Sebaste
Terza pagina/3, Rosa Pierno su "Come un cinghiale in una macchia d'inchiostro", Aragno 2018; bio dell’autore
Verificare l’esistenza della realtà per mezzo del linguaggio. Vedere che cosa si vede quando si pensa e che cosa si vede quando si parla. Forse non è possibile distinguere le cose che si osservano se non nominandole. I rami di due alberi che s’intrecciano e il vuoto fra le loro foglie. Con il linguaggio possiamo ordinare: le foglie che stanno dietro o sotto. L’obiettivo vero è il vedersi guardare. Divenire consapevole della propria produzione, della propria realtà. Se mai dovesse emergere che il linguaggio semplifica a tal punto la complessità del reale, allora il tono dovrebbe divenire lieve, scivolare sulle cose, rifrangersi e da quelle involarsi, il che è quello che accade alla scrittura di Sebaste. In “Scrivere”: “Un raggio di sole / sul cristallo liquido del computer / imbroglia le parole / manifesta le cose”. Una leggerezza che giunge fino al punto di mettere in dubbio ciò che si conosce, il significato di alcune parole-chiave. Che cosa vogliono dire esattamente le parole di uso comune “qui”, “adesso”, “io”, “tu”, e che cosa si sta realmente percependo, persino, come da beckettiana memoria. Il baratro tra vocaboli e oggetti, a volte, si richiude miracolosamente e immotivatamente. Si possono fare bilanci, ripescare nozioni nel libro autobiografico. Di certo lo spazio risulta sgangherato, rifratto, la sua immagine mai complanare e allora anche il tempo non ha più una direzione. Il silenzio sembra essere l’unica entità a priori e nel silenzio la voce inesausta di Beppe Sebaste risuona finché può parlare.
Beppe Sebaste è nato a Parma nel 1959 e ha abitato in vari luoghi. Dopo anni di poesia underground ha esordito poco più che ventenne nella narrativa con L’ultimo buco nell’acqua, scritto con Giorgio Messori (1983). Negli anni Ottanta è tra gli ideatori e fondatori delle edizioni di ricerca letteraria Ælia Lælia (libri di Amelia Rosselli, Patrizia Vicinelli, Peter Bichsel, Livia Chandra Candiani, Carlo Bordini e altri). Ha pubblicato racconti (Café Suisse e altri luoghi di sosta, 1992, Niente di tutto questo mi appartiene, 1994, Oggetti smarriti e altre apparizioni, 2009); romanzi (Tolbiac, 2002, HP. L’ultimo autista di lady Diana, 2004, poi 2007, Fallire. Storia con fantasmi, 2015) e saggi tra cui Porte senza porta. Incontri con maestri contemporanei (1997, poi Libro dei maestri. Porte senza porta rewind, nuova edizione accresciuta 2010).
Tra i suoi ultimi libri Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne (2008, 5a ed. 2013). Ha tradotto opere di Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Bove, Nicolas Bouvier. Vive attualmente a Roma e a Narni, dove ha dato vita a un “luogo per le arti” denominato Stanza - Ci sono Cieli Dappertutto.
Sonia Ciuffetelli, videolettura della prosa inedita “La colonizzazione invisibile”, premessa di Mara Cini
La parte più interessante del testo di Sonia Ciuffetelli mi pare la sezione dove le riflessioni “sociologiche” dell’autrice di stemperano in un fermo-immagine di prosa poetica denso e senza sbavature.
Lì vediamo due donne che a distanza si ascoltano e si dimenticano in una intermittenza luminosa, in una bolla di pixel. Lì, al momento, ci siamo un po’ tutti noi, nel nostro presente “tecnologico” che ci fa davvero dire ieri non avevi capito, oggi è già passato.
La colonizzazione invisibile
Quando si trova in una strada di Vancouver o nell’estrema periferia di Roma sente poca differenza. Quel senso di libertà soffocata è lo stesso. Ovunque si collochi, in qualsiasi punto dei due luoghi, è sopraffatto dall’ombra riflessa. Non ha più amici di carne né gente che si ferma a parlare, a ridere, a discutere. Gente che faccia assemblee per parlare dei problemi comuni. Succede anche a lei, ovunque vada. Succede anche ai loro vicini e a gente conosciuta nel web, pseudo anonima. Cambiare posto e sentirsi infastiditi da un’ombra indesiderata. I Paesi, quando diventano più ricchi, sono più tolleranti e i cittadini si sentono più liberi. Eppure c’è un’ombra lunga. Esprimiamo la nostra personalità così liberamente e con un certo determinismo da diventare spesso smodatamente egocentrici. Lui e lei dimenticarono presto quel passaggio costruttivo e necessario attraverso il quale fu costruita la società democratica: l’impegno collettivo.
Oggi però i due comunicano. Comunicano tra di loro e con gli altri. Mettono in comune, da comunicare. La poeta appartiene al loro mondo, l’artista pure, e ogni figura, ogni persona. La poeta guarda dalla vetrina e ha occhi attenti e, in tasca, parole speciali. Perciò guarda le donne e gli uomini fare le stesse cose in più parti del mondo.
Nelle moschee talvolta dopo la preghiera gli uomini si ricongiungono con le loro donne e si fanno un selfie. Li ho visti farlo. Non è lo stesso selfie che fanno due innamorati qualsiasi sulla scalinata di una qualunque chiesa italiana?
E comunque quando comunicano in realtà condividono un’informazione con un gruppo o con un singolo. Ma il gruppo crea un nuovo significato comune. Quando parlano, nel senso, quando dialogano, costruiscono un significato comune. Il dialogo è democratico dunque.
Prova. Quando dialoghi l’ombra è dietro di te e non la vedi. Il vantaggio della vita collettiva era mettersi a confronto e costruire la capacità di pensare per il bene di una comunità, di individui correlati fra loro. E la democrazia funziona se noi cittadini abbiamo una visione condivisa del mondo in cui viviamo.
Eppure non sta andando così. E quella che poteva essere una straordinaria opportunità dialogica e di condivisione collettiva, Internet, proietta sulla nostra strada un’ombra lunga sovrapposta ai nostri passi, ai nostri tasti, ovunque siamo.
I
Più tardi mentre il tempo fugge al controllo
ti sfaldi in un pugno di scaglie: non possiedi.
Ieri non avevi capito, oggi è passato.
Due donne si raccontano e ricostruiscono le distanze perdute
parlano la stessa lingua e sono di colori diversi
tra i loro atomi intercorre
un mondo di bit che faticano ad integrarsi. Cortocircuito.
Si incontrano come per caso sapendo che il caso non c’è.
Nei loro occhi la panna assorbita nella bolla di pixel, la condivisione.
Una si assorda di elementi cliccati e salvati l’altra dimentica.
II
Dopo, molto tempo dopo, qualcuno aveva capito che si chiamava intelligenza ambientale.
Gli oggetti posseduti rivelano chi siamo. Le preferenze.
Avevano previsto tutto ma non lo sapevamo.
La colpa non è l’ignorare ma il non aver immaginato.
Costerà sempre di meno impiantare una polvere geniale negli oggetti
sequenziare ogni genoma al costo di un panino.
A quel punto la tentazione di aggiungere i dati estratti ai profili sarà corrosiva.
Resisteremo umani [?]
Il filtraggio comporterà un deplorevole sforzo di immaginazione
e le domande giuste da porre al gigantesco flusso binario non sarà più un problema.
Il codice imparerà. Saprà formulare da solo le domande.
Parlare seduti sulla pietra di un gradino è in disuso,
non siamo più integrati, soli interconnessi.
Abbiamo dimenticato gli odori, li compreremo presto, sotto forma di sostanze artificiali.
III
Si tratta di profilo persuasivo. Lo forniamo, punto per punto.
Mentre un tempo riservavi una quota al tuo sogno bambino
ora credi che il sogno possa avverarsi investendo.
Eppure il tuo tempo è una quota oraria prezzolata e inodore
che non difendi più dal nemico che hai lasciato entrare
e mescolarsi al tuo spazio:
parla con te coi toni amici delle cose famigliari
e tu non lo riconosci.
Adesso abiti dove lui ti ha chiesto di stare.
Ti confidi con lui come si fa quando ci credi.
Coincidere con la propria quota di sogno ammazzata
diventata investimento temporale senza nessuna garanzia di successo
fa fornire i tuoi contenuti interiori, stati d’animo, alterazioni umorali,
al metodo centrale che registra, fagocita e distingue una tua giornata sì
da una tua giornata no. Il castigo è la cecità. È il non capire.
Il funzionamento del sistema poiché il sistema non è dotato
di sangue e brevità né di fasci nervosi e sinapsi,
permette di applicare alle idee gli identici processi applicati ai prodotti.
Perciò devi smetterla di fidarti in nome della gratuità e dell’illusione bieca.
Perciò mentre le tue difese si abbassano sarai raggiunto
da una propaganda politica che ti darà il brivido improvviso
di un amore che ti spettina.
La persuasione è invisibile, contraria al principio per cui affidi
le tue rivelazioni soltanto ai più cari, ai tuoi amici.
Il castigo è che non te ne accorgi. È l’asimmetria della relazione.
L’identità ha smesso di sorridere al modo dell’era cartacea
scopre i denti
da quando l’hai regalata in forma liquida a un mostro informe
che non somiglia al mito, non si compara con la fantascienza.
Sonia Ciuffetelli si laurea in Lettere all'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Esordisce come scrittrice con Ordinaria nevrosi dell'anima, edito da Tracce nel 2003. La sua raccolta di racconti dal titolo Lampi d'ingenuo conquista il primo posto al Premio Nazionale Logos per inediti e viene pubblicata nel 2008 dall'editore Giulio Perrone.
Nel 2010 Sonia Ciuffetelli pubblica la raccolta di poesie Petali di voce, editore Giulio Perrone. Numerosi suoi racconti e poesie sono pubblicate in antologie. La sua poesia dal titolo Come il moto della Luna è stata inserita in Rosso da camera, antologia poetica curata da Letizia Leone, con poesie di Dacia Maraini, Tomaso Binga, Jolanda Insana, Serena Maffia, Cetta Petrollo, Gabriella Sica, Patrizia Valduga, Giulio Perrone Editore, 2012.
È docente di italiano e storia nei licei statali. Specializzata in didattica della scrittura, organizza corsi ed insegna scrittura creativa.
Del 2016 è il suo saggio storico-biografico Non ho vergogna a dirlo, Portofranco editore.
Del 2017 è il suo romanzo Un velo sulla memoria, Augh edizioni.
Nel 2018 pubblica per l’editore Arcipelago itaca, La farfalla sul pube, libro di poesie.
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali ed oggi è presidente dell’associazione culturale Le Muse Ritrovate. Nel 2017 ha curato come direttrice artistica il festival letterario Weekend d’autore svoltosi all’Aquila con 11 autori ospiti. Organizza eventi culturali e manifestazioni finalizzate alla promozione della poesia e della narrativa.
Lia Cucconi, videolettura dalla raccolta “Dimensioni nell’essenza dell’accesso”, nota di Giorgio Bonacini
Ciò che fin da subito sentiamo, leggendo queste poesie, è che la parola di Lia Cucconi non teme lo spaesamento che a volte subisce la mente nel confronti del silenzio. Non però una situazione di sottomissione, bensì ricca di tratti labirintici e di capovolgimenti significativi dovuti, a suo beneficio, alla “complicità della memoria”. L’autrice mostra un pensiero di lucidità e astrazione così concreto da misurarsi, in ogni dimensione pensante, (e senza mai sviare in percorsi più facili) con elementi perturbanti, ma ricchissimi di materiale poetico: il riflesso di una fuga; l’orma precaria del dire; l’inafferrabile riverbero di un ombra. E senza mai dimenticare, in tutto questo, che la forma della voce interiore, grazie al suo inafferrabile sentimento del senso, sopporta anche il tempo della fragilità e dell’abisso.
III. Dimensione: abbaglio
Esilio di nuvole senza soglia
raccontato da riflessi di luce
sorvegliati e avvolti dai veli assolti
nel pensiero d’una porta che ricade
nello stupore della solitudine.
Poi la restituzione è silenzio
le cui pareti di cripta emettono
chiuse persiane oltre ogni verbo e nota
nella complicità della memoria
dipinta in forza a traslato corpo.
VII. Dimensione: passi
Incunaboli passi: dimensione
temibile nel labirinto chiave
dove lo spazio indicato è foro
d’uno specchio legato all’occhio curvo
simile a un chiasmo d’ornati plurali.
Lunghi presagi di mura e legacci
d’acuti aprili dentro nubi lente
dementi uscite alfine d’un confine
da dogana limite mai percorsa
nella percossa orma dentro all’io evento.
XI. Dimensione: obliquità
Obliquità squilibrata al pensiero
negli interstizi estremi dello spazio
senza luogo d’accesso alla costanza
che non svela intrecci deposti, ma,
un tempo di fragili abissi lenti
dove l’istante mormorio non luce
è fluttuante reazione in dispersi.
Lia Cucconi. Docente di Attività Espressive. Ha pubblicato 9 libri in Italiano e 10 nel Dialetto di Carpi (Modena). Ha ricevuto critiche e riconoscimenti nelle due espressioni linguistiche, fra i quali: 1° Premio Noventa-Pascutto; 1° Premio Paolo Bertolani-LericiPea; 1° Premio Carlo Levi; 1° Premio Salva la tua lingua locale Campidoglio-Roma; 1° Premio Poesia in forma Landays Torino. Ha pubblicato poesie in antologie e riviste nazionali e in rete nelle due forme linguistiche, sostenuta da critici del settore, volgendo la sua sensibilità artistica nella Poesia lirica, civile e sperimentale, completandola con l’insegnamento verso la preparazione delle insegnanti dell’infanzia.
Daria De Pellegrini, audiolettura (voce di Annunciata Olivieri) da "Altalena sui larici", nota di Laura Caccia
Nell’alternarsi di sé
Quali movimenti del pensiero e del sentire dispiega Daria De Pellegrini in Altalena sui larici? Nell’oscillare da una stagione felice a una spaesata, da momenti desideranti ad altri dolenti del proprio vissuto?
Un andare e tornare tra le memorie dell’infanzia e un presente smarrito, un affondare e riemergere tra gli scorci di una natura aspra e il rimpianto per le figure parentali, un altalenare di sentimenti tra sfide e rapine, aperture e ferite, come fioriture precoci o tardive.
La spinta che si prendeva sui rami dei larici per lanciarsi in volo e poi tornare, finendo spesso rovinosamente a terra, non appare solo un ricordo di giochi d’infanzia: i versi sono tutti attraversati da questa tensione, nel desiderio di alzarsi in volo, come a inseguire “un corpo vivo di donna” e insieme dalla necessità di riportarsi al punto di partenza “per restituirmi a me stessa / tornando”. E, ancora, dal continuo franare, compiere il movimento sbagliato, venire sbalzati a terra. Esemplificati anche dalla rapina dei frutti, dalla presenza rapace della “morte che dura e respira”.
E non solo: l’altalenìo colma i testi del suo movimento, nell’oscillazione del ritmo e dei versi, attraversati da continue cesure grafiche a rimarcare la caduta, lo spezzarsi del dire. In una spinta poi, di nuovo, tesa a ritrovare parole sospese, mezze frasi che Daria De Pellegrini definisce “un lavoro incompiuto”, nella sua sofferta e desiderante sfida poetica: quasi una fioritura fuori stagione. O meglio: in una “quinta stagione”.
Da: LA QUINTA STAGIONE
-----
è la nostra quinta stagione / io
lei / le zanzare / nessun altro ad agosto
in giardino / il caldo / troppo / strappa
vive le foglie dei pioppi / vago il gesto
dal petto alla fronte / scomposta poi
la mano rinuncia / invoca muta
il cristo che sa / com’era fiorire
e vedersi prendere i frutti
-----
inatteso / un guizzo di serpe increspa
lo stagno / vigile torna tra le alghe
lo sguardo / anche la voce ritrova
le sillabe / mezze parole fanno
quasi una frase / chiede scusa come
per un lavoro incompiuto
Da: ALTALENA SUI LARICI
-----
l’aria ha pensieri in forma di foglie
altalena sui larici fioritura
di abeti / frassino messo a frenare
la frana sotto il fienile / susini
insidiosi a scalarsi / non si dava
la grazia di arrivare ai frutti maturi
la strada ha disfatto il giovane
bosco che mio padre sognava
foresta / resta ramaglia / cortecce
ruvide e rughe scavate / eppure
continuo ragazza nel gioco / sfide
e pretese / incollare di resina
e miele la lingua al palato / spargere
arachidi sui sentieri dell’orso
amare la bestia che patisce la gabbia
-----
velenosa questa fioritura
ad ottobre / trattengo la lingua
nella chiostra dei denti / non dire
l’affetto / la pena
l’offesa / le voglie
altalena continua / colchico ha nome
il fiore tardivo / fiorisce sbagliato
sentendo febbraio
nella brina d’autunno
Da: ALLA PORTA DEL SONNO
-----
anima di avanzi di stoffa / inseguo
un corpo vivo di donna / nel grigio che sale da terra a spegnere la fiducia dell’alba / viene radente dalla palude uno stormo di uccelli / non aveva segnali tra gli equiseti il pozzo scavato di frodo Daria De Pellegrini è nata a Falcade (Belluno) nel 1954. Ha insegnato Italiano e Storia negli Istituti Tecnici dal 1976 al 2014 (nel quinquennio 2003-2008 in un liceo tedesco). È autrice di romanzi (tra gli altri La locanda dei folli, Campanotto 1994, Fiorenza, Mobydick 2002, Ragazzi nel Bosconero, Mobydick 2002, e Marion, Nuovi Sentieri Editore 2011) e di racconti (con Se fu tuo destino ha vinto il Gran Giallo Città di Cattolica nel 1998, con Nelle case dei Dorf il Premio nazionale letteratura per l’infanzia “Sardegna” nel 2005, con Das Ersatzkind il Premio Frontiere-Grenzen nel 2017). Occasionalmente ha scritto testi poetici nel ladino-veneto arcaico del suo paese natale, vincendo diversi premi, tra cui nel 2015 il “Premio Città di Corridonia” e il Premio “Poesia senza confine” di Agugliano E appunto dal 2015 scrive poesie in italiano. Con la silloge inedita Fare il pane ha vinto la Sezione Poesia del Premio “Leone di Muggia” nel 2016. Con la prima raccolta Spigoli vivi (Interno Poesia Editore 2017, prefazione di Franca Mancinelli) si è classificata al terzo posto al Premio Nazionale di Poesia “Luciana Notari” e ha vinto il Premio di Poesia “Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi”.
Paola Silvia Dolci, audiolettura dalla raccolta “Bestiario metamorfosi”, nota di Laura Caccia
Tra mostri e prodigi
Una parola desiderante abita bestiario metamorfosi di Paola Silvia Dolci: in bilico tra il reale e l’onirico, il conscio e l’inconscio, l’irreale e il simbolico, il fiabesco e il mitico.
Di quanti livelli di rappresentazione la poesia riesce a farsi carico? A conferma del domandare “esistono diversi gradi di realtà? Come per le malattie?”, l’autrice ne snoda i molteplici piani attraverso prose poetiche, diari giornalieri, versi, citazioni e disegni. Introducendo personaggi fiabeschi e mitici, con riferimento ai bestiari medioevali, alle metamorfosi ovidiane, alle favole orientali e nordiche. E aprendo versi come specchi deformanti, in cui la realtà viene modificata e distorta, tra speranze e timori, sogni e terrori, desideri e paure.
I mostri, che attraversano il Bestiario, hanno per Paola Silvia Dolci le stesse caratteristiche della parola che li designa: una cosa straordinaria dalle caratteristiche mirabili, un prodigio, dall’etimologica del termine, così come una cosa contro natura, dai connotati deformi e spaventosi.
Per questo, in alcuni testi, pare di entrare in un dipinto di Chagall dove umani e animali convivono su un piano diverso di realtà. E, in altri, in un quadro di Munch, quando le metamorfosi si fanno mostruose, tra gli aspetti inconsci di sé e la realtà storica più terrificante, i campi di stermino nazisti, per cui “Ogni notte scrivo sul braccio il tuo nome”.
-----
Che tipo di creature sono?
E che cosa ci dice la nostra risposta?
-----
giorno 1
pos 42°49.24’N 10°45.81’E, vento teso, Libeccio a 17 nodi, si formano piccole onde nelle acque interne, ti amo, ti abbandono per non tornare mai più, non ti abbandonerò mai, ho ricordi di te che non abbiamo vissuto, gli uomini mi fanno volare, non mi fanno scrivere meglio, scrivere, scrivo meglio da sola, salgono a sera e sciamano per la barca
dottore, esistono diversi gradi di realtà? come per le malattie?
gli alberi delle navi sono antenne, legnetti, matite e oscillano
-----
giorno 4
pos 42°47.93’N 10°42.81’E, siamo caduti nel mare dove nascono i mostri, là sotto, un’Ondina: “la paura sembra maggiore del desiderio o esattamente uguale”
-----
Passeggiare intorno, cercando di immaginare la scena.
Ogni notte scrivo sul braccio il tuo nome.
Ho girato tre volte l’anello di ottone
della Schöner Brunnen.
Un uomo correva in bici, senza mani,
con le braccia aperte, ridendo forte.
Norimberga è stata ricostruita con le ossa dei palazzi
distrutti dai bombardamenti, ma
al Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
ne parlano come se fosse qualcosa
che non ci riguarda.
Ogni volta che torno in Germania continuo a pensare
che i volti che vedo siano quelli dei figli, dei nipoti,
dei pronipoti dei nazisti eppure sono anche io
la nipote di un assassino.
Di cosa ho paura?
-----
il cammino diventa buio
stanotte continuavo a sognare
io sono un altro fantasma
che si aggiunge a quello del passato
egli apre la bocca e io vengo assorbito
c’est cette flamme
que je dois retrouver
io sono la stessa bambina
devo uccidere un drago al giorno
Paola Silvia Dolci, ingegnere civile. Diplomata presso il Centro Nazionale di Drammaturgia. Collaborazioni con riviste letterarie. Direttore responsabile della rivista indipendente di poesia e cultura Niederngasse.
Tra gli altri ha tradotto Maxine Kumin, Galway Kinnell, Christian Gabrielle Guez Ricord e Albert Camus.
Nel 2015 ha partecipato, su invito della Fondazione Roma, alla 9^edizione dell’evento internazionale Ritratti di Poesia.
Nel 2017 ha partecipato a RicercaBo 2017, laboratorio di nuove scritture.
Selezionata per il Premio nazionale Elio Pagliarani, finalista ai premi Myosotis e Bologna in lettere, è vincitrice del premio Guido Gozzano nella sezione poesia inedita.
Suoi testi sono stati tradotti, oltre che in inglese, in francese e in spagnolo.
Libri: Bagarre-Lietocolle ed. 2007, NuàdeCocò-Manni ed. 2011, Amiral Bragueton-Italic Pequod ed. 2013, I processi di ingrandimento delle immagini-Oèdipus ed. 2017.
Ugo Mauthe, videolettura dalla raccolta “Vizio perverso”, nota di Laura Caccia
Malati di parola
Che la poesia sia il vizio perverso, che dà titolo alla raccolta di Ugo Mauthe, viene chiaramente dichiarato dall’autore:“è un classico finisce la giornata / inizia la poesia - non c’è verso / di smettere questo vizio perverso”. In contrasto, però, con il titolo, i testi si muovono con leggerezza ironica e sospesa, quasi a testimoniare quel vertĕre contenuto nell’aggettivo, quel volgersi silenzioso che risuona, quella folata di vento che porta altrove.
Vizio per il verso, dunque. E, insieme al verso, per il poco. Attraverso azioni di sottrazione, di cui l’autore si fa carico, nel rendere essenziali i suoi testi, come per effetto di erosione naturale. O come per malattia poetica, per la quale ironicamente si pensa anche alla ricetta, ma dalla quale non si cerca guarigione.
E i versi esprimono tutto il profondo e il sofferente dell’esistere. Dal sommerso enigmatico, che ci riguarda, alla superficie commerciale e acre del presente. Dalla percezione errante degli umani alle via crucis quotidiane. Alla parola Ugo Mauthe affida il senso della nostra navigazione. Come un vizio, un’abitudine radicata e persistente a dire.
Un’alterazione del linguaggio ordinario, la poesia. Che risuona della febbre del nostro errare di “terrestri navigatori”, del mistero sommerso, della tensione ad uno spazio altro.
-----
Da: involontario narciso
l’umano rosario si sgrana
escheriana sintesi di ultimi e primi
in fila sul filo che tutti trapassa
scivoliamo nel nostro mistero
-----
sulle rive di un lago scuro
niente letterarie memorie di rami
solo magri rami di memorie
niente traghettatori solo noi
terrestri navigatori
silenziosamente
grideremo una parola che non è
terra - tu spera sia cielo
-----
Da: fotogrammi
c’era il silenzio
di sempre uguali pomeriggi domenicali
c’erano le tre del pomeriggio
di pomeriggi indifferenti - e c’eri tu
tu che altro non sei
che io in quelle ore lazzare
di morte domeniche
-----
è un classico finisce la giornata
inizia la poesia - non c’è verso
di smettere questo vizio perverso
-----
Da: la cognizione del poco
ti scrivo da quel luogo
che fa la differenza fra esserci
e scomparire
-----
lenzuola sfatte in fragili grotte
rifugi di tardivi sospiri - ultimo fiato
di un tempo abbandonato
è ora di alzarsi terremotando
nostalgie
-----
con la saggezza del proverbio
con la leggerezza della discrezione
con la cognizione del poco
potremmo ancora darci molto
Ugo Mauthe è un pubblicitario con una lunga storia professionale come copywriter, direttore creativo e docente di comunicazione. Accanto alla scrittura pubblicitaria ha sempre coltivato quella letteraria. Nel 2017 con la fiaba “Sem fa cucù” ha vinto Racconti nella Rete e il premio Miglior Autore al Fiabastrocca. Nel 2018 ha pubblicato con Giovane Holden Edizioni il romanzo “Qunellis”, una particolare favola nera post apocalittica e post umana. Nello stesso anno è uscita la raccolta di poesie “Minuziosa sopravvivenza”, Il Convivio Editore, che ha ottenuto riconoscimenti in vari concorsi, fra cui il secondo posto al Premio Il Meleto di Guido Gozzano. Suoi racconti, fiabe e poesie sono stati finalisti o premiati in molte manifestazioni, fra cui Albero Andronico, Argentario, Bukovsky, Pietro Carrera, Città di Castello, Città di Cattolica, Giovane Holden, Carlo Levi, Lorenzo Montano, Percorsi Letterari, Tomolo Experience, Andrea Torresano, Tra Secchia e Panaro. Si considera un privilegiato perché ogni giorno realizza il suo sogno: vivere scrivendo.
Tommaso Meozzi, videolettura della prosa inedita “Far west”, premessa di Mara Cini
Un racconto di impianto “tradizionale” perfettamente risolto, un po’ straniante con dentro e Kafka e Carver: la sgradevole sensazione delle su spalle magre, scoperte … era stata sempre così ruvida e opaca la pelle di mia moglie?
Una storia dove il quotidiano è destabilizzato da un personaggio borderline, l’estraneo cow boy che, in realtà, abita latente dentro di noi, ci interroga e ci stupisce con il suo arrivo inaspettato sulla porta di casa.
Tommaso Meozzi - Premio «Una prosa inedita»
Tommaso Meozzi (1984). Nato a Firenze, dottore di ricerca in Letterature Comparate, ha lavorato come lettore d'italiano all'Università di Bonn, tenendo corsi di lingua e cultura italiana. Attualmente è lettore di italiano all’Università di Augsburg. Con la raccolta di poesie La superficie del giorno (Le Cáriti, 2010), ha vinto, nel 2013, il premio Contini Bonacossi-opera prima. Il suo racconto La badante è uscito sul n. 78 (aprile 2017) di Nuovi Argomenti. Nel 2017 ha ricevuto il premio della giuria nell'ambito del Premio Rimini per la poesia con la raccolta Inquieta alleanza, pubblicata nello stesso anno per Transeuropa. Sul numero 92 di «Atelier» (dicembre 2018) è uscita la sua silloge inedita Dove sei. Ha pubblicato un volume sulla distopia letteraria (Visioni dell’alienazione, Pacini, 2017) e, tra gli altri, articoli su Dino Campana e Paolo Volponi.
Stefano Modeo, videolettura da “La terra del rimorso”, Italic 2018, nota di Giorgio Bonacini
Se possiamo definire la poesia un’attività in cui il cambiamento è il suo movimento connaturato, ci sono libri, come questo, che ci confermano questa idea. Modeo, infatti, ci dà una scrittura che è vera e propria esperienza del sentire e della mente. E il segno a fondamento di questi testi, lo dice l’autore fin dall’inizio, è “un verso che risuona straniero”. Chiediamoci allora se potrebbe non essere così. Perché l’atto di poesia (comunque e dovunque venga fatto, per stili, modalità, luoghi, riferimenti e ogni altra singolarità propria) è sempre estraneo alla consuetudine normale e normativa della lingua ordinaria. “Le parole sono tante le idee sono poche”: così l’autore condensa la pratica della sua poesia. Ciò di cui la poesia ha bisogno è la povertà della parola, che si arricchisce continuamente, quando si concentra e aderisce alle cose. Un’adesione che non significa, però egocentrismo o personalizzazione. L’io poetico non è mai il soggetto che scrive, bensì una collettività interiore che sovverte la falsa comunicazione. E’ un no, precisa Modeo, che dice se stesso diffondendo il contrasto e capovolgendo l’esclamazione no! Dove il punto esclamativo diventa la i di noi. Per ritrovare ciò che si è perso nelle ”nenie consonantiche dei giullari” di “popolo senza vocali naturali”.
*
Volo all’altro capo del paese
ciò che lascio ogniqualvolta
è un verso che risuona straniero
un’onda di mare che brucia salina
quella ferita mal ricucita di spina.
Un’umanità indecorosa e piena di grazia
dalla faccia istruita alla violenza del sole.
Torno all’altro capo del Paese
lascio una lingua, una gestualità.
La vita fatta a rottami dove rullano i tamburi
e le notti randagi
di giovani padri
di baci rubati.
Arrivo all’altro capo del paese
mio nipote è già un uomo con delle parole
lo sentirò comprendere e descrivermi dove vive
mi dirà forse un giorno a che punto è la guerra
riconoscerà a fondo ciò che io chiamo: la terra
del rimorso
*
La piazza semivuota del tuo cuore.
Hai percorso la piazza.
Hai smesso di guardare il passo tuo nella piazza:
tra la gente cercavi la tua gente.
Scarpe e volti nella piazza mattutina.
Le parole sono tante le idee sono poche.
Sei tornato a casa e hai scritto una poesia:
la leggeremo in piazza, risuonerà alta:
nella piazza semivuota del tuo cuore.
*
Affrancarsi: prendere per mano la lingua morta
riportarla nei laminatoi a freddo
Lingua bene comune!
(poi: additarsi le destre passioni, stanarle)
Non imitare: uccidere lo standard:
A morte l’io.
Il pensiero nasce sempre per contrapposizione
No!:
sovvertire il punto esclamativo:
noi.
Stefano Modeo (Taranto, 1990) vive e lavora come insegnante a Ferrara. Ha pubblicatonel 2018 La Terra del Rimorso per la collana Rive (ItalicPequod) con una nota diRoberto Deidier. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati o si è parlato del suo libro suYAWP: giornale di letterature e filosofie, Poetarum silva, Poesia del nostro tempo, Midnight megazine, Atelier poesia, sulla rivista Poesia (Crocetti editore), Nuova Ciminiera. Ha collaborato con il web magazine Siderlandia.it.
Alberto Mori, videolettura da “Minimi vitali”, Fara Editore 2018, nota di Mara Cini
Sono minimi ma non trascurabili eventi questi trascritti da Alberto Mori, appunti di un quotidiano che registra piccoli, continui, significativi scarti di varia geometria vitale.
Sono fotogrammi che si spalancano in paesaggi o, più spesso, dilatano piccoli particolari e curiose apparizioni visive, catturando in contrappunto bisbigli, fruscii, movenze…
Sono fotogrammi che generano soste e attese. Sono gesti-ideogrammi a frugare dentro pieghe
d’ odori, frasi che rigano la luce, coni d’ombra, perimetri a macchia, gocce sospese per un attimo.
Sono fotogrammi come rinnovati risvegli dell’occhio e della parola, quando il cortocircuito sguardo-suono-mano-pensiero riflette, per un attimo, nel frammento, qualcosa di compiuto.
*
Fra due rettangoli bianchi
un suono elettronico
varia geometria vitale
*
Il passaggio del suono
sale acuito
In modulato debole
si spegne
Il fischio resta aperto
nell’aria della pioggia finita
*
Oltre
Vicino al binario
Vede scavo concluso
Una base cubica
Qui il palo sale liscio nella luce
*
Riassetto tenue
Neppure nulla immagina
Alberto Mori, poeta e performer, ha sperimentato l’interazione di diversi linguaggi artistici: poesia sonora e visiva, installazione, video e fotografia. Numerose le pubblicazioni editoriali, tra le più recenti Canti digitali (2015), Quasi partita (2016), Direzioni (2017).
Alessandra Paganardi, videoletture da “La regola dell’orizzonte”, Puntoacapo 2019, nota di Rosa Pierno
Il racconto affonda i piedi nel terriccio ancora umido del passato, ancora foriero di raccolti e per questo ogni ricordo merita la coniugazione del verbo al presente e trova la propria classificazione etica nel tempo della stesura poetica. Scene che forse erano già scolpite nella natura come un destino, ma che bisognava decifrare dopo avere accumulato esperienza: “la bellezza ti ha tagliato via / sei rimasto per sempre” o aver vissuto l’intera esistenza. Comprendere equivale allora a leggere, ripercorrendo all’indietro, risalire, ritornando ai passi originari. A riprova, raggiungere la comprensione di quel che è accaduto non vuol dire poter modificare qualcosa, invertire la rotta. È semplicemente un perlustrare fino alla sorgente e lì tirare i fili. Inoltrandosi nelle sezioni della silloge, si fa ancora più forte lo stridìo tra la volontà dell’individuo e la forza della natura, mentre appare ancora più inefficace la scrittura che di questo scontro vorrebbe essere il saldo. Ma forse bisogna solo cambiare angolazione e, anziché trovare la legge unificante, che tutto lega, assentire “alla sorpresa di un verso inaspettato / come un abbraccio”. Mettere in atto strategie delicatissime come elitre di libellula e vivere, “dimenticare un attimo la sera / volare incandescenti un giorno ancora”.
***
Uno stridore di corteccia
la falena barbagianni scontava
la disonesta affinità con l’albero
l’astuzia mendace della natura
una falange di bruchi bulimici
vendemmiava le foglie
la spigolatura fu
una chimica azzurra
il giardino tornato origami
***
E’ una ferita la gioia
lascia sul muro lo schiaffo di un’ombra
l’allerta delle cellule
– paura primordiale dell’attacco
dell’insetto dagli occhi così inutili
penetrato di notte con le stelle –
per questo da bambino
dopo il frastuono della risata
ti guardavi le vene
Alessandra Paganardi è nata a Milano nel 1963. Attualmente è presente nella redazione della rivista letteraria internazionale “Gradiva”, nella giuria del premio omonimo e in quella del premio “Gozzano”. Ha tradotto autori anglofoni e francofoni fra cui: Carnevali, Breton, Barnes, Braque e Stevens. Sue raccolte di poesie: Tempo reale, Joker 2008 (premio San Domenichino 2009); Ospite che verrai, Joker 2005, (ristampa 2007). Plaquette: Frontiere apparenti, Puntoacapo 2009; Vedute, Ibiskos Ulivieri, 2008; Binario provvisorio, Seregno 2006; Potevamo dire l’assenza, Crimeni, 2005. È autrice di Saggi critici, aforismi e narrativa. Ha vinto i seguenti Primi Premi per la poesia: “Europa in versi” (2016); “Alda Merini” (2013), “Astrolabio” (2009), “San Domenichino” (2007 e 2009), “G. Gozzano” (2007), “D’Annunzio e la Versilia” (2007), “Dialogo” (2003), La pazienza dell’inverno, Puntoacapo 2013 (premio Operauno) e La regola dell'orizzonte” (2019).
Angela Passarello, audiolettura da “Bestie sulla scena”, Il Verri Edizioni 2018, nota di Rosa Pierno
Il bestiario di Angela Passarello “Bestie sulla scena” appare subito straniante nell’apparente semplicità della descrizione con la quale la poetessa lo compila. Gli animali vi sono descritti e disegnati, accerchiati da un’analisi che porta a galla l’esistenza del diverso. Quell’impossibilità di definire le forme viventi che circondano l’essere umano, e che di fatto estranee non sono, poiché ne condividono l’ambiente e l’esistenza, capovolge, di conseguenza, l’assunto. A fronte della mancata definizione concettuale, che consentirebbe di misurare la reale distanza tra umano e animale, ogni volta diversa con il suo mobile confine, esiste una misura comune, di cui queste brevi lasse e poesie sono testimonianza: nulla da misurare nel mondo: il mondo è lo spazio condiviso degli esseri viventi. Il mondo è per definizione l’esistenza di sé e degli altri.
La civetta
Il suo richiamo attraversava i muri delle case. Ogni notte accompagnava il sonno degli abitanti. Il suo verso era temuto perché considerato segnale di lugubri profezie.
Anticamente, disegnata accanto a Minerva, veniva apprezzata per la sua saggezza.
Le striature dell’occhio, simili a quelle di un felino, incarnavano in sé la misteriosa indole degli uccelli notturni.
Nessuno era riuscito a catturarla, nello scenario restava sacra e intoccabile.
Il passero
Nel nido era stato uovo accanto ad altri. Il becco spalancato aveva atteso il cibo. Una peluria quasi piumata lo aveva coperto. Nel primo volo di stormo era caduto, a testa in giù, sulla rosa canina. Con gli occhietti nerissimi, tondi, aveva esplorato il giardino. Aveva beccato i moscerini nell’aria. Cinguettante aveva raggiunto la tegola. In città va in cerca di briciole, al bar Centrale.
Angela Passarello, nata ad Agrigento, vive e lavora a Milano. Ha insegnato nelle scuole elementari lingua francese e la lingua italiana agli alunni stranieri, nelle scuole medie. Crea forme con l’arte ceramica e narrazioni pittoriche. Ha pubblicato le raccolte di racconti Asina Pazza (ed. Greco @ Greco1997), di poesie La Carne dell’Angelo (ed. Joker, Novi Ligure 2002), le prose poetiche Ananta delle Voci Bianche ( I Quaderni di Correnti,Crema2008). È presente nelle antologie: Versi Diversi (edizioni Melusine, Milano 1998), Poeti per Milano (Viennepierre, Milano1998), Milano in versi, 2006; Rane e L’Uomo, Il Pesce e L’Elefante per I Quaderni di Correnti; L’amore dalla A alla Z, 2014; Ha collaborato con La Mosca di Milano. Ha fatto parte del gruppo delle Melusine. E’ stata cofondatrice e redattrice della rivista Il Monte Analogo.
Sandro Pecchiari, audiolettura della poesia inedita “Stanotte dormo fuori, premessa di Ranieri Teti
La ballata notturna “Stanotte dormo fuori” è rischiarata, metaforizzata, dai vividi colori di un semaforo in un esterno notte urbano, quando le luci sono basse come i bagliori del firmamento, evanescenti in un’assenza che si traduce in un’assenza di parole. Possiamo immaginare questo deserto, il continuo, alternato lavoro del semaforo sotto la flebile persistenza delle stelle.
Sandro Pecchiari mette in scena la civiltà della poesia, la forza della poesia quando si fa civile.
Il poeta si addentra in uno scorcio di umanità ai margini, passando da un “verde da sotto sottobosco” a un rosso “come un sorriso di fiammiferi bruciati tutti assieme”, fino a un giallo che “è ansia di divieti”: ci porta, nella pulsione della notte che vive celandosi, nel suo segreto nascosto.
Pecchiari riesce a rendere mirabilmente il passaggio da un sottobosco di cespugli, dove passano la notte i senza dimora, al vero sottobosco umano, quello delle “folle domenicali”, “della gente che ti guarda come se fossi un virus”.

Antonio Pibiri, audiolettura da “Il prezzo della sposa”, L’Arcolaio 2018, nota di Rosa Pierno
Nessuna cosa resta intonsa sotto lo sguardo di Antonio Pibiri: “una cancellata s’infoglia”, e nemmeno il suo corpo è esente da trattamenti depistanti “Il mio corpo accelerato.”. La denuncia dell’illusione letteraria è a suo modo un’ulteriore illusione, poiché dal linguaggio non è possibile uscire. E i rivolgimenti a cui Pibiri lo sottopone hanno come obiettivo di saggiarne i limiti semantici e sintattici. Ma straniante è la percezione stessa: “Chi trovi ogni volta al tuo posto?”. Quello che si costruisce con la lingua è uno specchio di quello che si percepisce, forse solo meno mobile, per questo vi è ogni volta la necessità di ricominciare daccapo. Gli inserti visivi, immaginari con i quali Pibiri costruisce le sue poesie appaiono a tratti forzati, come lo è il senso sottoposto a una virata surrealista. La realtà in tal modo appare pregiudicata due volte, una dalla sua traduzione linguistica, una perché la percezione stravolge e frattura. Il risultato non è mai ricomposizione. Non esclusa da questa verifica anche l’insufficienza linguistica: come dire i colori dei quadri di Van Gogh? Come parlare dei quartetti di Bartok? “Se sapessi scrivere io non scriverei”: ecco la palestra inesauribile di Pibiri.
***
Un ventaglio di esitazioni.
I viali mandorlati, il portico.
Sangue rinvenuto tra le carte
o s’intuisce un fiore
di breve erudizione.
Giacometti spiegato da mio figlio.
L’Eternità a una data ora del giorno.
Febbre in viso. Il cigno colpito a morte
sulla spalliera di glicini.
Un negozio di ferramenta salpa
si allontana tra foglie d’acqua.
La luce con discrezione nel tempio calvinista.
Il cervellotico decapitarsi appena.
Torre di cavalli blu, sette palazzi celesti.
Le mansarde degli scrittori
sui giardini di Lussemburgo.
Ceneri: il bardo nel cimitero del Vermont.
Malgrado non sia teca il mondo fanne inventario,
per nenia, fumaio, poema…,
***
Il ponte di legno è crollato
per mutarsi in barca,
un raggio d’acqua
in fiume.
È crollata anche la casa,
voleva scendere
più rapida delle scale
giù a piano terra,
ai cancelli – uscire
dalla promessa di piccole crudeltà.
Per questo è crollata.
Nato a Sassari nel 1968, dopo la Maturità Classica Antonio Pibiri sviluppa attenzione verso la scrittura creativa e la Musicologia, formandosi da autodidatta. Nel 2010 con Lampi di stampa (Milano) pubblica “Il mondo che rimane”( Premio della critica, Ottobre in Poesia, Sassari, e Menzione d’Onore – Premio Lorenzo Montano, 2011). Nel 2014 “Le matite di Henze” con lo stesso editore. Nel 2016 la sua terza pubblicazione: “Chiaro di terra” con l’editore Gianfranco Fabbri, L’arcolaio, di Forlì (Segnalato dalla giuria al Premio Lorenzo Montano, edizione 2017; Primo posto per Opera edita al Plics di Sassari, ed. 2017). Gli viene assegnato sempre nel 2017 il Premio Vp-Sardinia, arti contemporanee e ricerca, coordinatamente alle istituzioni letterarie di Austria/Salisburgo. Nel 2018 pubblica “Il prezzo della sposa” con l’editore L’arcolaio, segnalato all’ultima edizione del premio Lorenzo Montano (2019). Nel 2019 il libro trova spazio critico nell’Antologia di Marco Ercolani: I fuochi complici. Ha scritto sulla sua opera: Cesare Viviani, Antonio Devicienti, Marco Ercolani, Flavio Ermini, Daniela Bisagno e altri.
Rossella Pretto, videolettura dalla raccolta “Dark love”, nota di Laura Caccia
Lady narrante
L’opera shakespeariana, riletta dal punto di vista femminile: in Dark love - Ipotesi ladymacbettiana, sullo sfondo dell’eterno dramma, con versi ardenti, colmi di passioni e di abissi, Rossella Pretto ripercorre le tappe di un rapporto straziante, immedesimandosi nella protagonista di una situazione di coppia votata alla perdizione.
Un amore, fosco e buio, che nasce innocente e si fa passione cieca, volta a divenire presto “perversa battaglia”. E che emerge ancora prima: da un nulla in cui “niente era se non ciò che / non era”. Lo stesso nulla con cui, a cornice della narrazione, si conclude la raccolta, a stemperare violenze e inquietudini, sangue ed ardori.
Si tratta di un nulla reale o scenico? E la storia è realmente vissuta o solo recitata? Riguarda singoli individui o destini comuni? In un gioco di scambio in cui “non sono lei, neanche me”, i piani si intersecano di continuo. E la parola, tra disperazione e grazia, è insieme smarrimento afasico e dono.
Soprattutto, però, è la passione per la narrazione a prevalere. Rossella Pretto, nel prendersi carico del ruolo di cantore del fato e dei drammi dei mortali, si fa soprattutto Lady narrante: di “una lady tutta mia da incarnare e cantare” così come “dell'eterna storia di un amore nero” e “degli incrociati destini” degli umani.
(La raccolta nel frattempo è stata pubblicata nel 2020 da Samuele Editore, con il titolo di “Nerotonia”)
***
Vi fu un tempo in cui non vi era
nulla
puoi concepirlo, lo posso io?
nulla e dunque neanche il tempo e noi
non c'eravamo, io e te non c'eravamo
e non c'era inizio
alle nostre discussioni
seduti nello studio a tentare
l'improbabile
accordo o in una sala, in piedi per terra
con i nostri tanti corpi da suonare
a volte tutti altre solo uno.
E in quel tempo che non c'era, un tempo
del sentire di esserci
perché in quanto a esserci io ero ancora
nessuno
una strega gettò i suoi occhi
tra quelli che dovevan essere i miei piedi
la paglia nella testa che svelava vaticini
la mia arsa e vuota
incantata dall'imbroglio
di poter bastare a me stessa.
E niente era se non ciò che
non era.
Così dal buio senza tempo
emerse il dettagliato tempo del noi
l'incisione che sbozza nell'istante
le parole, nostre
queste che io ti dico, le tue
e quelle che per giorni
abbiamo gettato al vento
quelle vane
che ci han portato fin su questo palco
il molteplice filtrando
dal setaccio di altri corpi
(……)
Di corpi dapprima
passione cieca e inesausta
corpi ineguali e anelanti
nel di lui cercare il varco
stampo e marchio
nel di lei disporsi all'accoglienza
nonostante l'inane battaglia
nonostante
perché già intuiva che la perversa battaglia
era ormai vinta e già persa
----
Chi fui se non
aedo e coppa
dell'eterna storia che narra
di un amore nero
degli incrociati destini e tutti
che nel ventre trattengo
ma fuori infine rovescio
in parole in-canti?
Rossella Pretto, veneta di origine, ha vissuto a Roma dove si è laureata con una tesi sul Macbeth della Compagnia dei Quattro; ha lavorato come attrice, presentatrice Rai e adattatrice dei dialoghi. Vive a Vicenza da quando ha scoperto l'amore per la scrittura. Alcune sue poesie sono pubblicate nell’antologia del Premio Luzi. Fa parte del Premio letterario A. Fogazzaro. Condirige la rivista di critica letteraria Satisfiction e collabora alle pagine culturali di Alias- Il Manifesto. Collabora anche con la rivista letteraria L'Ottavo, con una rubrica su Karen Blixen.
Ha partecipato due volte al premio Montano, ricevendo menzione speciale per un breve saggio su Macbeth e per un racconto intitolato Erbarme dich.
Francesco Sassetto, audiolettura della poesia inedita “Roxy Bar”, premessa di Ranieri Teti
Dono del poeta è anche quello di offrire un nuovo immaginario, grazie a lui il “Roxy Bar” si popola di persone che incontriamo quotidianamente, e non di “star”.
“Tutto è come sempre”, scrive Francesco Sassetto in questa poesia che rappresenta uno spaccato di ordinarietà, tanto preciso e particolare da diventare generale. Il poeta registra come se riprendesse con una ideale cinepresa, offre repentini cambi di inquadratura tra l’interno e l’esterno del bar, tra questo e quel personaggio che lo frequenta. In questo mondo deteriore così ben descritto non sappiamo nemmeno se la scena è ripresa in una città o in borgo, in una periferia; ma sappiamo che questa forse inconsapevole e diffusa infelicità “non è inferno né paradiso, probabilmente neanche purgatorio”.
La grazia di Sassetto, il suo non giudicare, riesce a rendere vivo un mondo che sembra non esserlo più, registrando una quarta dimensione, quella del sopravvivere: “niente di più, niente di meno”.
Roxy Bar
Una donna gioca con le macchinette,
tiene d’occhio la carrozzina piantata
in mezzo al bar, il cinese gentile
al bancone fa i caffè, grazie, prego,
un euro, sorride, lava le tazzine.
Dal maxischermo il frastuono assordante
di un concerto rock.
Una ragazza guarda fuori se piove
ancora, fuma, aspetta qualcuno o
forse no
esce sotto il tendone
fradicio d’acqua sporca, si accende
un’altra sigaretta.
A tratti i colpi secchi della macchinetta,
la donna impreca, non ha mai vinto
niente.
Tutto è come sempre, nessuna
apparizione, nessun colpo improvviso
di vento, solo pioggia che scende.
Il bambino nella carrozzina adesso
piange, la donna gli grida di star buono
ché lei ha da fare, riprende a giocare
borbottando piano.
Non è inferno né paradiso, probabilmente
neanche purgatorio.
E’ il nostro usuale galleggiamento,
il pane quotidiano.
Niente di più, niente di meno.
Francesco Sassetto risiede a Venezia, dove è nato nel 1961. Si è laureato in Lettere nel 1987 presso l’Università "Ca’ Foscari" di Venezia con una tesi sul commento trecentesco di Francesco da Buti alla Commedia dantesca, pubblicata nel 1993 dall'editore Il Cardo di Venezia con il titolo La biblioteca di Francesco da Buti interprete di Dante.
Ha collaborato in qualità di cultore della materia alla cattedra di Filologia Dantesca ed ha conseguito nel 1998 il titolo di dottore di ricerca in “Filologia e Tecniche dell’Interpretazione”. Insegna Lettere presso il C.t.p. (Centro territoriale per l’educazione in età adulta) di Mestre.
Scrive componimenti in lingua e in dialetto veneziano che hanno ricevuto premi e segnalazioni.
Ha partecipato a presentazioni, incontri e pubbliche letture di testi poetici, anche in ambito scolastico. Suoi testi sono presenti in antologie e riviste ed ha pubblicato le raccolte di poesia: Da solo e in silenzio (Milano, Montedit, 2004) con prefazione di Bruno Rosada, Ad un casello impreciso (Padova, Valentina Editrice, 2010) con prefazione di Stefano Valentini, Background (Milano, Dot.com Press-Le Voci della Luna, 2012) con prefazione di Fabio Franzin, Stranieri (Padova, Valentina Editrice, 2017), con prefazione di Stefano Valentini, Xe sta trovarse (in dialetto veneziano) (Samuele Editore, Fanna, 2017), con prefazione di Alessandro Canzian.
Una silloge di poesie in veneziano, intitolata Semo fati de sogni sbregài è stata ospitata nel volume antologico Poeti in lingua e in dialetto. La Poesia Onesta 2007, a cura di Fabio M. Serpilli, Associazione culturale La Guglia, Agugliano 2007.
Una raccolta di testi in veneziano, intitolata Peoci, è stata edita nel volume antologico Poeti e narratori in italiano e in dialetto. La Poesia Onesta 2012, a cura di Fabio M. Serpilli, Associazione culturale Versante, 2012.
Una silloge di poesie in lingua e in dialetto veneziano, intitolata Di ordinari galleggiamenti è stata pubblicata, con una introduzione critica di G. Lucini, nel volume antologico Retrobottega 2, a cura di G. Lucini, Edizioni CFR, 2012.
Suoi testi compaiono nelle antologie tematiche La giusta collera, Edizioni CFR, 2011, Ai propilei del cuore. Poeti contro la xenofobia, Edizioni CFR, 2012, Il ricatto del pane, Edizioni CFR, 2013, Keffiyeh. Intelligenze per la Pace, Edizioni CFR, 2014, tutte a cura di Gianmario Lucini.
Sue liriche sono state ospitate nell’antologia 100 Thousand Poets For Change, Roma, Albeggi, 2013; nell’antologia Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati da respingimento, Milano, Rayuela, 2014; nell’antologia In classe, con i poeti, a cura di M. Casagrande, Puntoacapo editrice 2014; nell’antologia L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie tra Novecento e Duemila, a cura di M. Cohen, V. Cuccaroni e altri, Camerano, Gwynplaine edizioni, 2014.
Suoi testi sono presenti nelle riviste online Versante Ripido e Sagarana, in blog e siti web.
Massimo Viganò, videolettura della poesia “Lamentazione di Teodoro Dostoevskij nella fortezza di Omsk", nota di Ranieri Teti
Massimo Viganò, videolettura con animazione della poesia inedita “Lamentazione di Teodoro Dostoevskij nella fortezza di Omsk (frammenti apocrifi)”, nota di Ranieri Teti
Nell’incipit e nell’ultimo frammento, “tau”, si generano correnti testuali di rara efficacia: nella scomposizione e nella ricomposizione dei versi si coglie con precisione un caos interiore, lo spaesamento del soggetto, l’inafferrabilità della vita. Non è un caso che queste punte del poema si trovino all’inizio e alla fine: l’autore ha immesso questa circolarità stilistica per dare forma all’inaudito. Grazie al linguaggio che, pulsando, fibrillando, abbandona le sue abituali connotazioni comunicative e diventa poesia.
Massimo Viganò rende un grande omaggio a Dostoevskij rinchiuso nella fortezza di Omsk in Siberia, attraverso frammenti apocrifi carichi di intensità.
La suggestione del testo è tale che a tratti questa “lamentazione” sembra un corollario delle “Memorie dalla casa dei morti”, l’opera scritta da Dostoevskij a Omsk.
Il gesto poetico di Viganò riaccende una luce, genera una postilla a un capolavoro, inaugura nuovamente il libro, vara con coraggio un’inedita identificazione.
Tutto il testo ha una trama che riconduce a quel freddo siberiano, a quelle privazioni, a una durezza di fondo rivestita di passione senza fine: allo stesso tempo preciso, implacabile nel racconto, e visionario.
Massimo Viganò si laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Spagnolo + Inglese), indirizzo Filologico Letterario, alla Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1985.
Da allora svolge attività di traduttore e di redattore tecnico, prima a Ivrea e in seguito a Firenze. Da quasi trent’anni si occupa di Teatro in qualità di attore-autore e regista, prima a Milano, poi a Torino e attualmente in Toscana. Dal 1986 al 1988 ha seguito i corsi di Teatro organizzati dal Teatro delle Dieci di M. Scaglione (Torino). Con la compagnia Margutte Teatro di Torino nel 1992 partecipa al Festiva dei Teatri di Santarcangelo di Romagna.
Da sempre appassionato di poesia, ha partecipato, con esiti soddisfacenti, a premi nazionali, ottenendo i seguenti riconoscimenti:
La raccolta “Nel bianco degli occhi” è tra le raccolte inedite segnalate del Premio Bologna in Lettere 2019.
Alla raccolta “Nel bianco degli occhi” è stata riconosciuta la Menzione d’onore nella XXXII edizione del Premio Lorenzo Montano.
La poesia “Polittico dei bambini” è tra le poesie con menzione nella XXXI edizione del Premio Lorenzo Montano.
La raccolta “Falsi amici e sciocche canzoncine” è stata selezionata al Premio Internazionale Città di Como 2017.
La poesia “Ore delle colline pisane – N(u)ove improvvisazioni” è tra le poesie con menzione nella XXX edizione del Premio Lorenzo Montano.
La raccolta La voce incantata entra tra le raccolte inedite menzionate nella XXIX ed. del Premio Lorenzo Montano.
La silloge Il prigioniero e altre storie del (mio) giardino e fra le opere segnalate al Premio Letterario Castelfiorentino 2014.
La raccolta Dell’infanzia e d’avventura è tra le segnalate nel premio Letterario Renato Giorgi 2011.
Ore delle colline pisane – N(u)ove improvvisazioni è fra le vincitrici (terzo premio) del Premio Letterario Castelfiorentino 2011.
La raccolta edita Tra(s)duzioni è stata segnalata in occasione del Premio Civetta di Minerva – Antonio Guerriero I ed.
Nel 2011, la silloge Un lungo futuro è stata pubblicata sulla rivista Fili d’aquilone n- 21,
Con la raccolta Poesie dell’infanzia e d’avventura, è risultato finalista in occasione del Premio Letterario InediTO 2010, organizzato dall’associazione il Camaleonte di Chieri,
La raccolta Tra(s)duzioni ha vinto il Premio Nazionale di Poesia Sandro Penna – XXI edizione, per la sezione Poesia Inedita. La raccolta Tra(s)duzioni viene pubblicata nel 2010 da Edizioni dell0 Meridiana.
Con la raccolta Tra(s)duzioni, ha ottenuto la menzione in occasione del Premio Letterario InediTO 2009, organizzato dall’associazione il Camaleonte di Chieri,
Sue poesie sono state segnalate al Premio Turoldo – edizioni VII, VIII e IX, organizzato dall’associazione Poiein,
Nel 2009 la sua poesia Turning Torso (e la gru kockum) è tra le opere finaliste dell’evento editoriale Concepts Architettura, organizzato dalla casa editrice Arpanet di Milano; viene pubblicata nel volume Concepts Architettura & Design.
Febbraio 2021, anno XVIII, numero 49

Dedichiamo l’apertura di questo nuovo numero a Marosia Castaldi (1951-2019) che, negli anni centrali della sua vita, ha fatto parte della redazione di “Anterem”. Alla rivista ha offerto testi di grande valore: uno di questi, caratterizzato da senso, forma e tensione, è qui ripreso nell’ultima pagina, insieme con i lavori dei sodali di un’esperienza ormai irripetibile, come racconta Marica Larocchi. Antonella Cilento e Mara Cini intervengono, l’una a tutto tondo, l’altra focalizzata sugli anni anteremiani, a delineare il percorso letterario di Marosia.
Inoltre, in “Carte nel vento 49”, in continuità con il numero precedente e grazie alla nota teorica e alle nuove traduzioni di Cristiana Panella, si definiscono la figura e l’opera di Serge Pey, presentato in poesia per la prima volta in Italia su questo periodico.
Infine continua la pubblicazione di poeti, prosatori e saggisti selezionati nell’ambito dell’edizione 2019 del Premio Lorenzo Montano: siamo lieti di ospitare Gianluca Asmundo, Ilaria Biondi, Martina Campi, Antonio Fiori, Sonia Giovannetti, Oronzo Liuzzi, Cristiana Panella, Anna Maria Pes, Irene Sabetta, Sergio Sichenze, tutti presentati dalla redazione di “Anterem”.
Il lavoro intorno al “Montano”, svolto dalla giuria, è praticamente inesauribile: riteniamo che questo lavoro dia un senso perdurante al Premio, che continua a riverberare e non si esaurisce con la proclamazione degli esiti.
Ricordiamo che la nuova edizione è in corso scarica il bando della 35^ edizione
In copertina: “Questa cosa”, plaquette verbovisiva nata nello studio di Marosia Castaldi
Ranieri Teti
Prima pagina/1, Per Marosia Castaldi: Antonella Cilento, “Nelle mani di Marosia”
Mentre penso a Marosia Castaldi e alla sua opera, e al mio personale ricordo di lei, ho tra le mani una nuova edizione de I Sonnambuli di Hermann Broch e leggo la nota di Milan Kundera dove si dice dei grandi personaggi che fanno, epoca dopo epoca, la forma di un paese o una teoria del tempo: i personaggi di Kafka, di Brock, di Hašek, di Musil e Mann e Fuentes.
Nelle grandi topografie del romanzo novecentesco, nel romanzo come teoria, le donne sfuggono sempre, anche le più grandi, le più famose. Non fanno teoria, occorre per forza che facciano teoria di genere, se e quando la teoria di genere se ne occupa.
E dunque non dovrei stupirmi che l’opera sperimentale, immane, complessa e libera di Marosia sia non solo poco conosciuta ma quasi introvabile e ignorata e che persino la sua scomparsa, nel novembre 2019, sia passata del tutto sotto silenzio, senza che nessuna delle persone, che pure l’avevano incontrata e apprezzata, a volte sostenuta, muovessero un dito, dicessero una parola o fossero informate dell’accaduto.
Sì, c’è un mistero nel nostro destino, c’è un silenzio che nessuno vuole esplorare, a volte nel timore di riconoscervisi. Ci sono, in ogni epoca, voci autoriali strombazzate e celebrate e voci quasi del tutto silenziate.
Ma c’è nella nota di Kundera una frase di Carlos Fuentes che d’improvviso mi sembra adatta alla teoria di donne, la càrola, la parabola delle cieche e delle veggenti, che Marosia ha descritto pagina dopo pagina, romanzo dopo romanzo, mescolando prosa, biografia e invenzione, trasfigurandosi continuamente, trascendendosi continuamente con la consunzione di sé e del proprio corpo che anche la malattia comportava.
Scrive Fuentes: “Ci vogliono molte vite per fare una sola persona”.
E che tutti i libri di Marosia Castaldi, e tutte le sue opere pittoriche e visive, cercassero disperatamente di comporre quel che forse per gli uomini è più facile ricomporre, grazie a maschere autorizzate e scelte (mentre per le donne ogni ruolo è l’eredità di una schiavitù, di una servitù data per scontata), mi appare ora ancor più evidente.
Temi, parole, immagini tornano ossessivamente nella sua scrittura, che è corpo e compulsione, che è spesso frenesia (quel disordine così poco apollineo che sfugge ai lettori maschi, che spaventa anche i lettori di una scrittrice non meno sperimentale e geniale come Clarice Lispector) ma non assenza di disciplina.
Forse, ripetendo un paesaggio, una memoria, un luogo, sottraendo il cibo e sottraendo il corpo, Marosia Castaldi ha cercato di dar spazio alla sua opera, un’opera potente, ne restassero anche solo frammenti, come per i lirici greci.
Mia suocera, che è stata insegnante di filosofia di Marosia, un’insegnante molto amata, la ricorda giovane come una “ragazzona con una lunga treccia”, intelligente, brillante, mobile. Si sono reincontrate, milioni di anni dopo, in una delle lezioni che organizzo, ruoli invertiti, Marosia che insegnava e mia suocera allieva, ascoltatrice.
Avremmo tutti dovuto fare e dire di più per Marosia Castaldi: confesso, dopo averla invitata diverse volte a tenere lezione per Lalineascritta, di aver avuto paura a farla viaggiare per la delicatezza della sua condizione e di aver rimandato, anche se lei mi chiedeva di tornare.
Mi aveva scritto una lettera bellissima in occasione dell’uscita, seguita da polemiche, di un mio libro dedicato alle difficoltà di far cultura a Napoli (ma in Italia, ormai), quelle difficoltà che lamentiamo invano, che me l’aveva fatta sentire subito vicina.
Sospetto che ognuno di noi, che ha conosciuto e magari frequentato Marosia, sappia comunque poco o troppo poco di lei: il rigore della sua arte, la precisione geniale delle sue lezioni, lo sguardo aperto ed eclettico che ha mantenuto in ogni sua produzione meritano studi e riscoperta.
Per paradosso, come spesso capita, della letteratura delle donne italiane contemporanee si stanno occupando le università estere più delle nostre.
Uno studio più sistematico del corpus degli scritti di Marosia, una produzione trentennale iniziata con Abbastanza prossimo nel 1986, proseguita con Casa idiota (1990), La montagna (1991), Piccoli paesaggi, che pubblicò nel 1993 proprio Anterem, che oggi così gentilmente mi sollecita ed ospita questo breve ragionamento, continuata con Ritratto di Dora (1994), Fermata km 501(1997), approdata e all’editore Feltrinelli nel 1999 con Per quante vite, Che chiamiamo anima, Dava fine alla tremenda notte e Dentro le mie mani le tue (Tetralogia di Nightwater) e negli ultimi anni seguita dalla cura attenta di Agnese Manni che ne ha stampato La fame delle donne (2012), cui si aggiungono altri titoli, da Il dio dei corpi (2006) all’opera teatrale Calco (2008), In mare aperto (2001) e ai saggi dedicati alla punteggiatura pubblicati da Holden, è attesa e auspicata.
“…ero divisa tra realtà e finzione, tra ciò che si vede e ciò che non si vede”, scrive ne Il dio dei corpi, struggente controromanzo di un ricovero.
Ai lettori ora l’occasione di entrare, perché poesia, pittura, romanzo, immagine e parola hanno agito tramite Marosia Castaldi facendone un’allieva estroversa e indipendente di Virginia Woolf in Italia, tracciando una scia nuova, libera e potente.
Del tutto esterna alle piatte logiche del mercato.
Prima pagina/2, Per Marosia Castaldi: Mara Cini, “I paesaggi di Marosia Castaldi”
Di Marosia Castaldi ricordo la figura elegante e la presenza austera (ma con qualcosa di fragile) agli incontri della nostra redazione.
Ora che è mancata (ma tutti noi l’abbiamo saputo con molto ritardo) ritrovo casualmente Marosia in un refuso del suo nome (Mariarosa!), sulla quarta di copertina di un’edizione economica de La signora delle camelie dove è riportata (non so con quale pertinenza) una sua frase sulla passione… È questo improbabile cortocircuito di senso che mi riporta sulle sue tracce.
Ritrovo i testi pubblicati molti anni fa su Anterem: Paesaggio delle citazioni notturne sul numero 44 nel 1992; Paesaggio del mobile sul numero 47 nel 1993; Natura morta sul numero 49 nel 1994; Non paesaggi sul numero 53 nel 1996.
Ritrovo il volume Piccoli paesaggi, edizioni Anterem, 1993, che la nota critica di Lucio Klobas inquadra con grande perfezione: Nella scrittura di Marosia Castaldi, l’io narrante non solo si espande in tante psichiche proiezioni che preludono al suo dissolversi, ma riassume in sé la memoria del tempo trascorso che continua a vivere nell’immaginario. Oscilla a pendaglio tra l’assorta rappresentazione di un passato vischioso e, attraversando le ceneri di un presente inafferrabile quanto misterioso, giunge a sperimentare un’infinità di futuri possibili (…).
Intensità e densità, scrittura labirintica e ossessiva (Klobas parla di riferimenti a Bernhard, io citerei anche Uwe Johnson) dove tutto è paesaggio perché la scrittura tutto dispiega, sottopone e sovrappone allo sguardo. Ci sono paesaggi “reali” o plausibili, geograficamente esistenti (Paesaggio di Assisi) riprodotti alternativamente in una prospettiva a volo d’uccello e in una visione che sgrana le figure fino all’astrazione. Paesaggi della mente, infiniti, pullulanti di icone, di vuoto, di ansia fisica. E c’è un Paesaggio etrusco, un paesaggio notturno, un Paesaggio delle pareti del mondo (dove in molti hanno tentato di arrampicarsi scivolando sempre giù). Paesaggi che come i sogni si levano forti sopra le teste eppure sono contenuti nelle teste.
In una delle ultime collaborazioni alla rivista, 1996, troviamo i testi, di Non paesaggi, lucidi compatti, specchianti, assurti quasi a una sorta di still life, linea d’ombra, ricordo del limite, pienezza della vita che dà, in quanto tale, la prossimità costante della morte.
Prima pagina/3, Per Marosia Castaldi: Marica Larocchi, “Questa cosa per Marosia Castaldi”
L’ “oggetto” (nei primi anni Novanta il termine s’imponeva come il più consono e attuale per indicare il prodotto di un lavoro creativo) potrebbe adesso definirsi più equamente una ‘raccolta di parole e immagini ‘ realizzata in maniera casalinga nel corso di due /tre anni da una manciata di amici artisti e poeti. I quali incollano, cuciono, sigillano con tanto di ceralacca rossa l’esito delle loro conversazioni zeppe di spunti, di scambi e passaggi d’idee, di revisioni, fino a trarne il ‘quaderno’ denominato “Questa cosa”. Ma l’animatrice -l’anima-, collante e calamita, e del progetto in sé e delle numerose riunioni, distribuite a turno nell’alloggio di ciascuno dei partecipanti, quasi membri di una setta speciale; il fulcro di “Questa cosa” è stata lei, Marosia.
Un po’ titubante, se non proprio timida, sulle prime, quindi sempre più armata di volontà acuta e ardente, ci propose di riflettere sull’ ‘amicizia’, sedute/seduti intorno a un tavolo, sovente in cucina, per ricavare pensieri, colori e figure che testimoniassero del breve periodo durante il quale, noi, segreti speculatori e amanuensi segregati, dopo riflessioni, incontri e scontri, elaborammo finalmente una sorta di sinossi del nostro piacevole confinamento meditativo. Sul quaderno bene appuntato, stretto fra due fogli - bianco su nero di costellazioni caserecce ma di mallarmeana ascendenza- risaltano vocaboli che sono i capisaldi, les points de capiton lacaniani, della scrittura di Marosia Castaldi, in particolare dei suoi primi libri: ‘purga’ ‘vuoto’ ‘tempo’ ‘voglio’ ‘privazione’ ‘pienezza’.
Ora, rileggendo i suoi Piccoli Paesaggi (Verona, Anterem 1993) e Ritratto di Dora (Loggia de’ Lanzi, Firenze 1994) sono percorsa da un brivido che segnala e marca sia il dolore per la sua perdita, direi ‘precoce’, sia la scoperta sempre più sorprendente dell’originalità e della forza che si sprigionano ancora dal suo linguaggio. E’, il suo, un linguaggio paradossale che nega e afferma simultaneamente; ipergenerativo, grazie alla sua specifica abilità nell’allungare e accorciare il nastro tagliente del tempo/spazio come fosse un elastico flessibile allo scopo di fare esistere e d’insistere, nel tratto più corto di scrittura -frase, sintagma, lemma- le più numerose e puntute antitesi.
‘Un letto di spine. Si fa tutto nei letti. Si nasce nei letti si muore nei letti si fa l’amore nei letti ci si soffre e ci si gode ci si adagia e ci si divincola come in catene si urla si ride si sospira si geme. I letti sono di roccia di rose di spine di erba di magre lenzuola di morbide piume. I letti sono tombe. Milioni di tombe come letti sotto la volta enorme del cielo. Ognuno che dorme ignaro del suo destino e ignaro del destino dell’altro. Quando s’incontreranno tutti questi letti?’ (Paesaggio delle citazioni notturne, pag. 17, Op. cit.)
La ripresa ossessiva dei vocaboli, la predilezione per la sintassi paratattica con periodi brevi e brevissimi, nei quali passato e futuro si contraggono dentro un presente verticale, teso tra conflitti verbali inesauribili poiché fondati sulla specularità, costituiscono le caratteristiche più evidenti del suo stile. E risaltano oggi come l’esclusività della sua pratica linguistica, feroce e soave, impietosa e generosa, sempre innervata dall’impeto verso il sublime. Le sue parole si rivestono di quella sostanza immateriale che io chiamo il Femminile nell’atto poetico creativo: si tratta di materia ironica e spirituale, sottile e pungente che attraversa e compone tutte le visioni dei suoi paesaggi, quasi mattoni sganciatisi da ogni legge gravitazionale, come nel duetto interiore di Dora.
‘Sì, non riesco a sentire la vita del corpo ma solo la sua morte.’
‘E’ per questo che tendi a nasconderlo, come se potessi essere io il tuo corpo e tu farne a meno.’
‘Sì, potresti essere tu la madre e quindi il corpo.’
‘E tu stare sempre all’interno di questo corpo in una fantasia fusionale irrisolta.’
‘Per questo non posso staccarmi da te e io sono te e tu sei me.’ (Ritratto di Dora, pag.91)
Forse la carne della sua scrittura, muscoli, tendini, pelle e ossa, si è lentamente, senza che lei, l’Autrice, se ne avvedesse davvero, sostituita agli elementi essenziali della sua vita terrestre, senza che noi, lettori, ci accorgessimo della metamorfosi, se non apprendendo tardi la mesta notizia della sua scomparsa terrena.
‘Quando conversiamo è come se un immenso vuoto si facesse intorno e dentro di noi e le parole ruotassero e volassero privandosi a poco a poco della sostanza concreta di ciò che dovrebbero connotare e alla fine si equivalgono e io potrei assumere il suo ruolo e lei il mio. Tuttavia, queste parole ci servono, come il battito del cuore il rumore incessante del corpo e della vita. Così ce le diciamo anche se alle volte ci sembrano insensate. Ma è forse più insensato il battito del cuore o il fluire incessante della vita?’ (Op. cit., pag. 91/92)
Marica Larocchi, settembre 2020
Terza pagina, Cristiana Panella sull’opera di Serge Pey: nota teorica e nuove traduzioni
INFINIZIONE, TESTIMONIANZA, INVERSIONE, penso, mentre ascolto Serge Pey e Chiara Mulas. « Infinizione » coniuga l’accezione di moto e quella di contrario. La prima è quella di Lévinas, l’infinizione come ospitalità, la capienza nell’accogliere quello che non si può contenere ; la seconda è la non-finizione, l’anti levigatura, che riporta alla prima, all’infinizione come non-intenzionalità. Contrariamente all’infinizione, l’intenzionalità, scrive Lévinas, presuppone già l’idea di infinito ; è l’inadeguazione per eccellenza. Pertanto, contenendo l’idea di infinito che non può contenere né prefigurarsi, il poema di Serge Pey « non è mai finito ». E questa in-finitezza si manifesta nell’incarnazione della parola. Pey è banditore dell’oralità, della testimonianza attraverso il corpo e la voce, e con corpo e voce l’avvento poetico fa luogo, fa cerchio, si fa « creatura » intrinsecamente e incompiutamente futura. Mostra come « crier » (gridare) sia « créer » (creare) : di come, nell’abbraccio aereo dell’assonanza, il grido sia atto di creazione. « Net cuer crie en mei, Deus » (Liber psalmorum). « Dio, crea in me un cuore puro ». E una volta generata, la criatura prende la forma della sua strada. In The Life of Lines (2015), l’antropologo Tim Ingold, nel solco della sua riflessione sulla forma come movimento continuo già proposta in Being Alive (2011) e in Making (2013), propone un’interrelazione alternativa rispetto al concetto di rete, comparando il pellegrino al navigante. Per il pellegrino la destinazione è il cammino ; il suo tracciato prende forma strada facendo. Diversamente, i movimenti del navigante procedono punto per punto secondo tappe intermedie calcolate in parte prima di iniziare il tragitto. Il passo pellegrino procede come la ragnatela : non è una rete di nodi, giunture che sottendono la testura, l’impalcatura, l’ossatura ; è una dinamica di congiunture, di (s)nodi, che il ragno crea nel suo movimento di tessitura. Il cuore stesso, dice Ingold è congiuntura, mentre le ossa si incontrano nella giuntura. La forma e la traiettoria di un movimento sono quindi imprevedibili prima del movimento. Nell’interrelazione umana ciò si traduce nella risonanza, nell’ « attenzionalità » più che nell’ « intenzionalità » (Ingold, « On human correspondence », JRAI, 2016), nell’andare verso più che nel trovarsi dentro. Il poema di Pey scende in strada a cercare i suoi ospiti, fa casa per chi si avvicina, per chi c’è. In questo senso non è mai finito, privo di levigatura. L’ultima parola sarà quella dell’ultimo commensale, di colui che deve ancora prendre posto alla pubblica mensa del poeta. Così il poema rimane aperto, collettivo. La parola è veste aderente al suo messaggio. Non si specchia, ne se cherche pas. Non deve fare « opera volontaria di differenza. È il poema stesso che fa quest’opera », dice Pey. Il poema opera per chi ha ceduto il passo, per gli invalidati. Braccio di testimonianza che ripete e scandisce in verticale, incarnando un memento di giustizia, diventando cahier de doléance(s). « Ci sono morti », ripete il poeta ; marca l’impronta per chi è diventato sabbia. Testimonia per i vivi e per i morti di tutti i tempi, seduti alla stessa tavola, in abitudini di uno stesso tempo. « Ci sono morti che escono dal parrucchiere/e altri che vorrebbero recuperare/semplicemente i loro olivi e le loro capre dalle corna limate ». I morti sono invocati, ringraziati, sollecitati nel ricordo. La rimembranza ravviva l’esperienza di compagnia, riporta il passo. Esplicitato in diverse interviste, il dialogo con i morti, così come il passaggio tra mondo dei vivi e mondo dei morti, è tema caro alla poetica di Serge Pey, in particolare nel libro di racconti biografici « Le trésor de la guerre d’Espagne » (Éditions Zulma, 2011) : « Uno dei miei maestri di poetica è stato mio padre, elettricista, che un giorno fece un gesto fondamentale davanti a me: poiché il nostro tavolo era troppo piccolo per accogliere gli ospiti, scardinò la porta di casa e la posò su un cavalletto. Abbiamo pranzato su una porta. Sul luogo di passaggio. La mia tematica viene da lì ». Un’inversione senza coordinate spazio-temporali. L’inversione è nell’atto di creazione stesso, non risponde all’unità di misura ; come il sogno, non discrimina tra incombente e remoto, tra semafori e fette di arancia blu. Tutto è orizzontale, scevro da giudizio. Ancora una volta, è il canale aperto dello sguardo poetico, lo sguardo celeste dal basso, che unisce il verso, l’avverso e l’inverso ; che chiama il décalage comunanza. « Il pennello è un coltello » realmente, come la porta fu da sempre tavolo.
Serge Pey e Chiara Mulas
Azione da Occupation des Cimetières (Éditions Jacques Brémond, 2018)
Chiesa di Sigale (Vallée de l'Estéron), 2017
Foto: Sabine Venaruzzo
Il peso dei morti
I morti pesano uguali ovunque
ma quando li si sotterra
non si recita per ognuno la stessa preghiera
sulle tombe
I morti pensano che la terra sia un orecchio
fatto per udirli
almeno una volta sola
anche cantando in falsetto
Ci sono morti che pesano
più di altri
e non sapremo mai perché
eppure le bilance non sono truccate
né gli aghi storti
Ci sono morti più leggeri di altri
E altri più pesanti dei primi
Ci sono anche morti
che non esistono
talmente li abbiamo dimenticati al mercato
delle resurrezioni
e dei trapezi.
Ci sono morti che sono grandi farfalle
Ci sono morti che sono magri serpenti
che perdono le vertebre
Ci sono lunghe lucertole che fanno i nodi all'aria
Ci sono morti che nuotano come piccoli pesci
in boccali rossi
Mi hanno chiesto di scrivere
un poema sul peso dei morti
sul bordo di un'enclave
in un territorio di Giove
È quello che faccio ma non riesco
perché la bilancia ha un piatto solo
e tutti sgomitano per farsi pesare
Su Marte quest’anno
sono stati abbattuti
133 politici
ma nessuna radio ne parla
Dal 2002 su Venere
sono stati assassinati 124 giornalisti
su Plutone
sono stati soppressi 200 poeti
In un pianeta lontano
della costellazione di Quetzalcoatl
ci sono stati 800.000 morti
Ma la televisione interplanetaria non dice niente
lo stesso
Su Nettuno
si collezionano le foto
dei bambini morti sotto le bombe
o decimati dai cecchini
Sulla luna
al mercato del sabato
si vendono francobolli
con i loro nomi a colori
per i collezionisti
Sull’Orsa Maggiore
in particolare
vengono sgozzate donne a decine
Erano compagne coraggiose
che inventavano il mondo
e difendevano il diritto all’aborto
Così un po’ dappertutto
su Urano ad esempio
gli aerei di una grande monarchia petrolifera
bombardano gli autobus degli scolari
Ci sono morti di cui non si parla
Ci sono morti con la bocca aperta
Ci sono morti che non hanno più la dentiera
Ci sono morti a cui hanno strappato la lingua
con un colpo solo affinché non possano parlare
Ma credetemi
Nessun poeta va a passeggio
con una bilancia per pesare i morti
e constatare che ci sono morti più importanti
di altri
I morti hanno lo stesso peso
anche se le bilance mentono
Tuttavia una cosa è certa
il poeta sa che i morti
si beffano delle preghiere
ed è per questo d’altronde
che scrive poemi senza peso
Insisto di nuovo
I morti non pesano tutti uguale
Sono le foto che fanno la differenza
l’inquadramento
la maniera di appenderle
e soprattutto la natura del loro assassino.
Ci sono morti
né leggeri né pesanti
Ci sono morti che non esistono
a forza di esistere
Ci sono morti alla moda
Ci sono morti senza patria
Ci sono morti nudi e morti vestiti
Ci sono morti che fanno l’appello nelle scuole
Ci sono morti senza telefono
E altri in abito nuziale
Ci sono morti nascosti negli ospedali
Ci sono morti che sono bambini
con camicie rosse naufragati su una spiaggia di Syrius
o di Sicilia
Ci sono morti che escono dal parrucchiere
e altri che vorrebbero recuperare
semplicemente i loro olivi e le loro capre dalle corna limate
Questo poema non è una preghiera
né un volantino di propaganda destinato ad essere
distribuito in un cimitero perduto
di Alfa Centauro o Plutone
né un ritornello canticchiato sui morti che dimentichiamo
e su quelli che non si dimenticano
D’altronde non si prega che per i vivi
perché il regno dei coglioni appartiene loro
nei cieli
in mezzo alle fiche profumate delle vergini
dei cecchini del purgatorio
davanti a un fabbro chiamato Pierre
o a un marmista che risponde al nome di Maurice
sul Sinai
I morti, loro,
si sono messi in Comune
da lungo tempo
e condividono il poco pane che hanno
sul bordo delle loro tombe
invitandoci a un pranzo
dell’avvenire senza marmellata
sempre nel passato
al bistrot degli assassini
I soli monumenti ai morti
che conosciamo
sono quelli dei vivi
che ammazzano i vivi
nell’altissimo della costellazione
della Croce del segno
o della scimmia
che sputa alfabeti
che nessuno comprende
Correggere Dio
Il busto di quest'uomo
è un'onda del mare
tagliata a fette di arancia blu
Non si dipinge mai un paesaggio su una tela
Si dipinge sempre su un paesaggio
che si ricopre con la tela una volta terminato
perché il paesaggio è sempre fatto male
L'uomo dice
Noi correggiamo Dio
Questa macchia rossa è il sangue di un toro
di plastica a sinistra di una geografia
Qui risiede il segreto di quest'uomo
Qui non si vede una tela
ma un paesaggio su cui si stende
il liquido rovesciato da un bidone di sangue
Per fare questo l'uomo
si è coperto il viso con una maschera da scimmia
Dietro di lui uno spettatore autoritario
sorveglia il cielo
Forse una spia o un inviato dei morti
che non sanno più dipingere
Questa spia nasconde il sesso dietro agli occhiali
Uno spaventapasseri blu
coglie ciliegie multicolore per il mercato
dei macellai della luce
Il paesaggio è una bandiera
La tavolozza dell'uomo è verticale
Il pennello è un coltello
Il paesaggio trema di paura
Dio è una donna
che fa colare le sue mestruazioni
L'uomo beve il sangue che versa
sul paesaggio poi lo scambia col nostro
con un tubo nascosto
in tutta la luce.
Carogna
Il poeta di oggi
non è un raccattatore di libri
ma di immondizia e rifiuti
A volte è un macellaio
o un cernitore di rifiuti
o anche un parrucchiere di escrezioni
o di peli di naso
La poesia resuscita le carogne
in particolare quelle degli uccelli
per farle volare
un'altra volta
o quelle dei cani
per dare voti ai loro latrati
su grandi quaderni contabili
scambiati per partiture
di free-jazz
La poesia è malata
La luce ha mal di fegato
e vomita pezzi
di metallo brillante
e liquido
I cani sono calvi
I loro crani rilucono al sole
come olio di ricino
Un cieco chiude il viso
in un armadio dopo essersi
a lungo guardato
in uno specchio
Gli orologi sono rotti
E anche le bussole
che si fanno gioco delle direzioni
Il poeta
è colui che lascia colare sale
sulla coda del lupo
senza farsi mordere
Questa è la sua arte poetica
perché in fondo vuole divorare
i lupi
anche se non ha denti
Lancette rotte arrugginite sfuggono
agli orologi
per fare flebo
sulle carte d'identità
è la condizione della bellezza
delle nostre foto
Ti amo davanti alla tua carogna
ritrovata
sotto un ammasso di foglie di platano
Avevi cinque anni o mille
o non eri neanche nato
Sono le iene che conobbero davvero
la tua età
La poesia è monosillabica
Quando gli uccelli recitano i poemi
hanno la bocca piena di piume
e di becchi
Hanno i sandali ricoperti
da una pelle stropicciata
rubata a Dio
sudando nel suo retrovisore
I morti hanno i bicchieri
mezzi riempiti di vino
Non riescono a terminare
le ultime gocce
del sangue perso da una statua senza testa
sulla croce della sua liberazione
I corvi ci rimpiazzano
ogni vertebra
con un uovo
è per questo che non ci si può alzare
senza farli crepare
I mendicanti ci seguono
per sbattere frittate fredde
Fumiamo due sigarette
insieme
una per il morto che culliamo
sulle ginocchia
l'altro per inchiodare una stella
alla notte
Gli angeli fanno bruciare le biciclette
e si scaldano
tra le ruote
Un poeta è un ladro di portafogli
e di quaderni
La tua carogna
è un'opzione d'interlinea
su un programma della vita
al centro di una zuppa di pesce
o di un mucchio di merda
I morti ricominciano
a tornare
bambini
giocando a quello che morirà per primo
mangiando terra
Li si sente già camminare
Sono come fiumi in piedi
che scendono verso il mare.
Il precedente intervento di Cristiana Panella su Serge Pey, che contiene anche la nota biografica dell'autore, si trova qui: https://www.anteremedizioni.it/prima_pagina_cristiana_panella_presenta_e_traduce_serge_pey
Gianluca Asmundo, audiolettura dalla raccolta inedita “Lacerti di coro”, nota di Laura Caccia
Nel periplo umano
Si muove in un’erranza spaesata la raccolta Lacerti di coro di Giovanni Luca Asmundo, quasi un periplo intorno all’umano: una mappa di attese e di ipotesi, una rotta smarrita e desiderante, disillusa e dolente, che l’esordio ipotetico della maggior parte dei testi evidenzia: “se inerti giaceremo senza terra // lacerti di coro noi saremo / di sagome disarticolate / danzanti su crinali impietosi”.
Ad ogni “Se”, con cui iniziano molti testi, veniamo mossi in un ondeggiare continuo, in cui ogni cosa può mostrarsi nel suo contrario, ogni pensiero passare da sogni a ombre, da corpi a carta, “nell’assoluta diacronia del vero”.
In un percorso, insieme, cosmico ed interiore, reale e mitico. Tra numerosi riferimenti a elementi naturali, metafisici, onirici, come suggeriscono anche i titoli delle sezioni interne. Tra corpi e coste, cosmi e caos, sogni e dissolvenze. Tra infinito e finito, inizio e fine. Passando dalla realtà mitizzata al pensiero metafisico, dal desiderio sognante all’impietoso declinarsi della condizione umana.
Giovanni Luca Asmundo ci coinvolge nel suo dire navigante e sofferto, metafora del vivere umano tra erranze e naufragi, sconforti e consolazioni, smarrimenti e stupori. Permettendo di sentirci parte di questo coro: lacerti, certo, ma anche voci ed echi della comune sofferenza del vivere, tra i richiami del principio e dell’oltranza.
Da: Parte I
I. Corpi
II.
Se di cenere sigillerà gli occhi
sfocati già da nera caligine
quest’orrida fertilità non scelta
scarna, pestata, materna, agognata
se per braccia non daremo nuovi getti
di sanguinelle che suggono lava
dolci vampando di zagara i clivi
se inerti giaceremo senza terra
lacerti di coro noi saremo
di sagome disarticolate
danzanti su crinali impietosi.
II. Coste
III.
Se il mare arenasse le voci dei dispersi
tutti i fasciami distesi sul basalto
tra colpi di remi senza cetra né versi
risacca perpetua e per rispetto muta
recherebbe conforto agli scogli anneriti
da oblio di gasolio e stasimi ed esodi
macchiati da cori arrochiti
prenderebbe in custodia la costa che arretra
per gli altri addolcirebbe il limone promesso
per noi serberebbe nell’abisso
quest’ancora buona, di pietra.
Da: Parte II
I. Onirica
I.
Se non sapremo la fine delle onde
resteremo così, a baciarne il senso
ne terremo in mano una dipinta
su ceramica rossa e sorridendo
ci addormenteremo in un frammento
di spume, di poemi, di orizzonti.
IV. Dissolvenze
I.
Se accetteremo i lacerti di coro
se accetteremo la dissoluzione
che importerà ormai di questa immanenza
palpebre arance al medesimo sole
i nostri corpi troveranno posto
nell’assoluta diacronia del vero.
Giovanni Luca Asmundo (Palermo 1987) vive a Venezia, dove attualmente svolge un Dottorato presso l’Università IUAV e lavora nel campo dell’architettura, della ricerca universitaria e della didattica internazionale.
La sua prima silloge è pubblicata nel volume Trittico d’esordio, a cura di Anna Maria Curci (Roma, Cofine Edizioni, 2017). Il libro Stanze d’isola (Premio Felix 2016, introduzione di Domenico Notari) è edito per i tipi di Oèdipus (Salerno, 2017).
Sue poesie sono inoltre pubblicate su riviste e blog letterari tra i quali Poetarum Silva, La poesia e lo spirito, La macchina sognante, La foce e la sorgente (allegato a Perìgeion), Un posto di vacanza, Poliscritture, Prospektiva, La Masnada. È presente in antologie cartacee internazionali, tra le quali Poesia e luce: Venezia, a cura di Marco Nereo Rotelli (2015), nonché in tre ebook antologici a cura del blog La presenza di Èrato.
È risultato vincitore in diversi concorsi di poesia, narrativa e prosa lirica, tra i quali il Premio Letterario Castelfiorentino, il Premio Nazionale di Prosa Lirica del Centro Studi Campaniani (2016), L’Italia dei paesi, Le radici tra abbandoni e ritorni (2018).
Negli anni partecipa a vari reading, tra i quali Vitàcora de Maya alla 57a Biennale d’Arte di Venezia, La Palabra en el Mundo a Venezia, Èrato a Matera, festival dell’Arte e della Poesia.
È tra i fondatori del progetto intermediale di poesia e fotografia Peripli.Topografia di uno smarrimento ed è stato co-curatore di Congiunzioni Festival internazionale di poesia e videoarte, ideato da Maria Grazia Galatà (edizioni 2015 e 2017).
Ilaria Biondi, audiolettura dalla raccolta inedita “Madri dolorose”, nota di Laura Caccia
Offrire parole
Come può la parola dare voce ad atrocità e strazi al limite dell’indicibile? Facendosi gemito e balbettio oppure lingua razionale di analisi o ancora, piuttosto, sussurro intenerito che offra un diverso sguardo, un altro dire nel toccare il dolore?
In Madri dolorose Ilaria Biondi, nelle sue venti storie poetiche, lasciate nude, di madri abusanti e abusate, maltrattanti e maltrattate, riesce a portare la sofferenza ad altezza e leggerezza tali da consentire di trovare parole che possano musicarne il respiro.
La voce che racconta si fa spesso roca, spezzata, “le parole si seccano” così come “un verso scordato inciampa”, ma è soprattutto il linguaggio lirico a prendere il sopravvento. Quasi un controcanto in opposizione alle efferatezze che mette in luce, cullando la sofferenza “col passo lieve del pettirosso in volo”.
Come a sottrarre le storie tragiche di maternità dolenti da altri modi di narrarne e interpretarne il buio. Con un diverso modo, ci mostra Ilaria Biondi, di considerarne la sofferenza qualunque ne sia l’origine, senza retorica, senza esibizione, senza valutazione di giudizio. Curandone l’ombra, le pieghe nascoste. Cercando di toccarne il silenzio, di dargli voce: tutto quello che di autentico, di fronte al dolore, la poesia ha la grazia di offrire.
VI
Mi è cresciuta fra le mani
questa conchiglia al sapore di vento
la accosto al petto
nella stagione chiara delle ciliegie
quando il mattino rincorre le spore
irrequiete dell’estate
io la sento, sfiorare sottile i miei capezzoli
orfani di figlia
nell’inganno di quiete
che fa vuota la pancia
VII.
Ti porterò nell’erba bianca di neve
col passo lieve del pettirosso in volo
sotto l’ombrello celeste di baci
e di canzoni al sole
la gonna corta e le scarpette a fiori
avremo frange di cielo e specchi di stelle
ventagli di gigli a chiamare l’estate
il profumo giallo delle ginestre
sulle tua fronte piccola senza più capelli
per cancellare nelle sere d’argento
l’odore di fenolo che piange la pelle
XI.
Ritrovata carrozzina abbandonata
nell’aria d’inverno il pianto bianco
di una neonata
Mi divori di latte e sangue
col tuo pigolio di bucaneve
mi sfondi le asole del cuore
e cancelli la grammatica spaurita
delle mie parole
non ha peso il mio pianto
né il silenzio delle mie carezze
sono una lucertola stanca
che raccoglie le ultime schegge
di un’estate bianca
mi nascondo fra le gambe dei salici
impazienti di chimere
mentre annego nella placenta abortita
delle mie ferite
ficcate – una a una – nella brocca del buio
XIV.
Non sono pronta a spostare le parole
sul palmo di una mano sconosciuta
– le parole si seccano
come panni stesi sugli spigoli del vento
si stacca, nel vuoto della testa,
la meridiana smarrita dei miei pensieri –
le gonne dei sogni di maggio
si scolorano nei cassetti spalancati
dei ricordi all’ombra
di una memoria fragile, di me
di chi ero e sono
di chi, forse, sarò ancora
appoggio il silenzio delle unghie
sul filo esiguo delle ultime sillabe
allo sbando
un verso scordato inciampa
nelle mie cellule dementi
– dimmi, figlia,
per quanto tempo sarò ancora
io?
Ilaria Biondi nasce a Parma nel 1974 e vive in un piccolo borgo dell’Appennino Parmense. È laureata in Lingue e Letterature Straniere e Dottorato di Ricerca in Letterature Comparate.
Attualmente si dedica all’insegnamento, benché a tempo parziale, con incarichi presso la scuola primaria e come titolare di corsi di lingua straniera e di letteratura per adulti. Ama lavorare con i bambini e organizza periodicamente, in forma gratuita e volontaria, letture animate, laboratori poetici e creativi.
Si occupa di poesia, traduzione letteraria e critica della traduzione, con particolare interesse per la letteratura al femminile, la letteratura fantastica e la letteratura per l’infanzia. Sue aree di studio principali sono la letteratura francese ultracontemporaine e quella belga francofona.
Sue traduzioni e suoi contributi sono apparsi su diverse riviste letterarie cartacee, tra cui “Quaderni di Synapsis”, “Comunicare Letteratura”, “Ottocento”, “Experience” e “Leggere Donna”.
Collabora con alcuni blog e siti letterari (“Cultura al Femminile”, “Gli Scrittori della Porta Accanto”, “La Bottega dei Traduttori”, “Sognaparole Magazine”, “La Stanza di Virginia”) con articoli, recensioni e traduzioni (dal francese all’italiano e nella combinazione inversa).
Nel 2011 pubblica il volumetto a carattere biografico-critico, Raymond Radiguet. Giovinezza perduta, eterna giovinezza (Delta Editrice). Nel marzo 2017 pubblica la sua prima silloge poetica, In canti di versi (Edizioni Il Papavero) e nel dicembre dello stesso anno una raccolta di haiku, L’età dell’erba (Fusibilia Libri). Nel settembre 2018 esce la sua terza silloge poetica, Corpo di vento (Controluna Edizioni), che le vale una Menzione d’Onore al Concorso nazionale di poesia e narrativa Va Pensiero.
Sue poesie sono presenti in diverse antologie: Antologia del Premio Letterario «Age Bassi 2003» (2004, Milano, Montedit); Tracce 04. Lo scarto, Antologia della Quarta Biennale di Giovani Artisti e del Primo Premio Letterario per Giovani Autori «Effetto Notte», (2004, Felina (RE), Nuova Tipolito); Veglia. 24 agosto 2016 (2016, Selfpublishing); Caro papà. Le parole non dette, in collaborazione con “Gli Scrittori della Porta Accanto” (2017, Selfpublishing); ChiaroScuro, in collaborazione con “Gli Scrittori della Porta Accanto” (2017, StreetLib); Perle d’amore – volume IV (2018, Apollo Edizioni).
La sua poesia Le sonagliere dell’alba è stata selezionata per l’agenda 2019 Il segreto delle fragole dell’editore Lietocolle. Un suo racconto figura nell’antologia Mille voci contro la violenza (La Strada per Babilonia, 2018), a cura di Emma Fenu. Di prossima pubblicazione il racconto “Il mio nome era Silvia” all’interno dell’antologia Caro maschio… che mi uccidi (in corso di stampa-FusibiliaLibri). Un suo racconto per bambini è inserito nell’antologia Favolando–I colori della diversità (Apollo Edizioni, 2017), di cui è anche co-curatrice. È di recente stato pubblicato il breve racconto per bambini Lettera alle Parole (FaLvision Editore), di cui è disponibile anche la trascrizione in lingua Braille.
In collaborazione con la Community “La Bottega dei Traduttori” ha pubblicato la sua traduzione dal francese del breve romanzo di George Sand, Cora (ottobre 2017) e il racconto di Paul Arène Il buon vischio, facente parte dell’antologia in due volumi Cosa c’è sotto l’albero? Fiabe, racconti e leggende dal mando da scartare insieme (2018, Youcanprint).
Martina Campi, videolettura dalla raccolta inedita “Le stagioni estreme”, nota di Giorgio Bonacini
Una scrittura poetica che si apre sotto il segno di Emilio Villa pone subito il lettore di fronte a una consapevolezza precisa: la lingua che pensa e scrive la poesia è significante in ogni sua determinazione e tratto distintivo. Martina Campi dentro questa ricerca – che è esistenziale più che sperimentale – ci offre il suo dire speciale: che attinge dal suono ovunque siano grafia e fonia. Ciò, però, non si rivolge a un’ingenua cantabilità dei versi, anzi, la sua voce ci sorprende per una lucida concettualità, unita in modo inedito (e inaudito si può ben dire) a un sentimento di apprensione per la forma sofferta di quelle
parole mai pronunciate. Perché la poesia che leggiamo in questi testi butta fuori e recupera anche quei momenti di impossibilità a parlare, lì dove la schiusa dei sensi vocali sembra impossibile.
*
Sulla terra il tempo è memoria.
Musica, giorno, fuoco,
perdendo i confini del viso che si scioglie
di espressioni divenute ormai indistinte.
Rompersi le ossa nella coerenza
occorrente al semplice, solitario, contemplare
il disagio di un sentirsi meno disabitati
Bere molta acqua, non pensare al fuoco
agli infiniti altri, cuciti nella tasca,
agli infiniti altri, polverizzati, nella borsa.
Occorrerà ricordare almeno
d’esser stati
uno.
*
Le correzioni si mostrano,
nei tratti dolci di qualcosa
che non c’è più per cancellazione.
Sono i fuochi concepiti dal dramma muto
entrando di soppiatto nelle stanze come in scena
per sorprendere e partecipare alle continue
trasformazioni della materia.
*
Gli allontanamenti creano sobbalzi
particelle smosse dagli occhi.
Pulsazioni che saltano in resistenza separando
il ritmo accurato dal cuore.
Qualsiasi apertura come una granata
acronica è lasciata alla sua fine
inesorabile, annientata dallo spazio-turbine,
esplosione nell’aria e nei polmoni di parole mai pronunciate.
Sapere di esserci è contenere una paura, una
gioia scomoda del salvarsi che non fa passeggeri,
senza fermate, appartenere alla venuta al mondo
(che riporta a casa) che richiede proprio e soltanto il bene.
Martina Campi, autrice e performer, ha pubblicato: Quasi radiante (Tempo al libro, 2019), La saggezza dei 9corpi (L’arcolaio, 2016), Cotone (Buonesiepi Libri 2014), Estensioni del tempo (Le Voci della Luna Poesia, 2012 – Vincitore Premio Giorgi), e la plaquette È così l’addio di ogni giorno (Corraino Edizioni 2015), con il poeta V. Masciullo. Curatrice, con A. Brusa e V. Grutt, di Centrale di Transito (Perrone Editore 2016). Fa parte del Comitato Bologna in Lettere. Co-fondatrice, insieme al compositore polistrumentista Mario Sboarina, del progetto Memorie dal SottoSuono – The poetry music experience.
Antonio Fiori, videolettura da “Nel verso ancora da scrivere (1999-2017)”, Manni 2018, nota di Rosa Pierno
La complessità della silloge di Antonio Fiori “Nel verso ancora da scrivere. 1999–2017” si gioca sul continuo trapasso tra fisico e mentale e, in successione tra questi due estremi, tramite dislocamento di segnali per ciò che non è possibile conoscere. La figura dell’inversione è un potente mezzo per ribaltare l’importanza delle cose, così il “Campo dei miracoli” equivale al pianerottolo della propria esistenza, l’ultima alba del mondo non farà perdere alla natura le sue caratteristiche, la possibilità di predire i suoi comportamenti. Ciò che è mobile trova sempre un riferimento in ciò che è fisso. Fino all’ultimo istante, Fiori sembra non sapere come evolveranno le situazioni, come si disporranno gli eventi; altre volte disegna con assoluta precisione ciò che accadrà: è lo spazio della poesia, dell’imprevedibilità eppure della sua conclamata certezza. Spesso il senso delle cose appare precario e l’esistenza stessa sembra legata alla catena delle convenienze e delle abitudini, ma è al contempo scolpita nel marmo, se basta un lieve ricordo proveniente dall’infanzia a rendere eterno il rapporto con i propri genitori. Le parole sono come l’ago della bilancia in questi trascorrenti sentimenti, in questi errabondi percorsi. A volte mancano, altre volte sembrano ineludibili. L’amore è certamente un propulsore che infonde fiducia nel linguaggio e le poesie su questo tema appaiono maggiormente effervescenti, rilanciando nondimeno un’oscillazione negli spazi dell’attesa e dell’incertezza degli incontri.
Potessimo tutti
Potessimo tutti fare pochi passi
ogni giorno verso il nostro Oriente spirituale
giungervi pure disillusi e stanchi
o nemmeno arrivarvi
ma certi della direzione presa
della visibilità delle tracce, certi
che il soccorritore possa ritrovare
i nostri corpi esausti.
Al nuovo anno
Col fiato sospeso
tra un Brindisi e un attacco
in attesa, noi vivi
di un atto di coraggio
di una battuta a sorpresa
quando s’apre il sipario
— che si compia un disegno
o un miracolo.
Antonio Fiori è nato nel 1955 a Sassari, dove vive e si occupa di poesia. Al suo attivo ha prestigiosi premi letterari, collaborazioni a riviste specialistiche, sei raccolte poetiche e la presenza in varie antologie. Con Manni nel 2002 è uscito Sotto mentite spoglie.
Francesco Bellomi, musica per il poeta Antonio Fiori
Sonia Giovannetti, prosa inedita “Il tempo tra due secoli”, videopresentazione, premessa di Mara Cini
(Nel video qui proposto Sonia Giovannetti presenta la prosa finalista al “Montano” 2020, mentre il testo che segue è quello segnalato nel 2019: abbiamo così un doppio sguardo sull’attività saggistica dell’autrice. rt)
Il nucleo significativo delle riflessioni di Sonia Giovannetti mi pare risieda in questa frase: Occorre…guardare con speranza all’arte, convincere ed educare gli uomini al senso e al valore dell’estetica affinchè anche l’etica…possa riacquistare valore.
E, ci dice Giovannetti, tra le forme dell’arte da coltivare, la poesia rivendica un ruolo particolare in quanto capace di reinventare il tempo, libera da tutte quelle sovrabbondanti icone visive nelle quali sembra ormai abitare il nostro presente tecnologico e virtuale.
Oronzo Liuzzi, da “Lettera dal mare”, Oèdipus 2018, nota di Rosa Pierno
Un testo che potrebbe essere considerato una polifonia teatrale, assorbendo, la voce narrante, migliaia di voci, le quali vengono trascinate sulla scena, tutte travolte dalla stessa condizione esistenziale. È, infatti, “Lettera dal mare”, immersione in una delle tragedie della contemporaneità: la necessità di emigrare. Oronzo Liuzzi riesce a immaginare le condizioni insopportabili a cui i migranti devono sottostare e a fare nostri i loro pensieri. La scrittura, scansionata da ripetizioni e da ritornelli, quelli tipici delle cantate, determina un andamento calmo, intriso di nostalgia e di dolore, strutturando lo svolgimento del racconto come un’infilata di perle. Ciò che è franto, franto resta: il pensiero è spezzato, quasi un coacervo di tutti i possibili pensieri che costituiscono l’identità del migrante, ma non è mai abbandonato dalla partecipazione dolente del poeta. La poesia rende, infatti, possibile la condivisione dell’esperienza, affinché essa divenga consapevolezza e presa di posizione da parte di tutti.
*
“dormo sveglio vedo dentro fuori questo mondo un pensiero orribile un maledetto dramma crea inquietudine in mio fratello mio fratello che osserva attentamente la scena e la subisce è incazzato mio fratello l’angoscia soffre di angoscia troppo il suo corpo l’energia in continua rivoluzione mastica la rabbia si morde terribilmente le mani scarica nella mente una sottile linea di informazione per nuove idee mio fratello sogna il viaggio insieme in transito ama discutere mio fratello mio fratello nei suoi occhi la pace nei suoi occhi il desiderio la speranza indossare vestiti puliti nei suoi occhi la pancia piena di sogni un lavoro mio fratello mio fratello non ho paura di e non ho paura non ho paura ancora mio fratello guarda il mondo guarda il cielo coglie i segni del destino mio fratello guarda il mare è bello il mare dice”.
Oronzo Liuzzi, nato a Fasano (BR) nel 1949, vive e lavora a Corato (Ba). Ha conseguito la laurea in Filosofia Estetica presso l’Università di Bari. E’ attivo nel panorama artistico-letterario con numerose mostre personali e collettive a livello nazionale ed internazionale, libri d’artista, libri oggetto, scrittura verbo-visuale e mail art.
In poesia ha pubblicato: L’assoluta realtà (Firenze, 1971), Poesie (Albatros, Roma, 1975), Teresa/Attunico (Schena, Fasano-BR, 1977), Poesie (Albatros, Roma, 1977), Bio (Edizioni Tracce, Pescara, 1987), Ronz (Campanotto, Pasian di Prato-UD, 1989), Canzone antica (micronarrativa, Pensionante dè Saraceni, Caprarica di Lecce, 1990), Plexi (Campanotto, Pasian di Prato-UD, 1997), Nuvole di gomma (Edizioni Riccardi, Quarto-NA, 2001), Poesie (1972-1977) (Edizioni Riccardi, Quarto-NA, 2002), L’albero della vita (Portofranco, Taranto, 2003), Chat_Poesie (Edizioni Spazioikonos, Bari, 2004), Pensieri in_transito (Fermenti, Roma, 2006), Poesia Povera (SECOP Edizioni, Corato-BA, 2009), Via dei barbari (Edizioni L’Arca Felice, Salerno, 2009), Io e Caravaggio (SECOP Edizioni. Corato-BA, 2010, In Odissea visione, 2012; Condivido, 2014, DNA, 2015. Conversazione con Proust, antologia a cura di Giuliano Brenna e Roberto Maggiani (LaRecherche.it, eBook, 2011). Ha realizzato numerosi video di poesia.
Cristiana Panella, videolettura con animazione della prosa inedita “l’amore mendica e ripete”, premessa di Mara Cini
…ero venuta a dirti…
È una trina il testo di Cristiana Panella, un pizzo lacerato, umido, macchiato, costellato di punti di sutura.
È un abito di sirena ferita e sporca con la coda di pece.
È un testo mendicante e materno …conservo almeno le braccia per covarti nell’impronta spiaggiato, richiedente asilo di parola.
Cristiana Panella (Roma, 1968) è senior researcher in antropologia sociale e culturale in Belgio. Vive all’estero dal 1994. Dopo la laurea in Lettere Moderne all'Università La Sapienza si è trasferita a Parigi, dove ha ottenuto un master (DEA) in Storia dell'Arte Africana alla Sorbona per poi conseguire un dottorato in Scienze Sociali all'Università di Leiden, nei Paesi Bassi. Tra il 1995 e il 2005 ha effettuato lunghi soggiorni di ricerca in Mali sul commercio clandestino di reperti archeologici e sui cercatori d'oro, prima di dedicarsi allo studio del commercio informale a Roma. Attualmente la sua ricerca è orientata sulle implicazioni etiche della corporeità. I risultati delle sue ricerche sono stati presentati in decine di pubblicazioni e convegni internazionali in Europa, in Canada e negli Stati Uniti. Di prossima pubblicazione, un volume sul rapporto tra etica individuale, norma e costruzione politica dell’illegalità. Parallelamente alla sua attività di ricerca, tra il 2015 e il 2018 ha collaborato con una casa editrice di Bruxelles orientata sulla poesia performativa e la prosa poetica, in qualità di editor e di lettrice. Alcuni suoi testi di poesia sono stati pubblicati su retabloid (rassegna stampa di Oblique Studio, 2018); nel 2019 è stata finalista al Premio di poesia e prosa Lorenzo Montano per la sezione “une prosa inedita”, e membro della giuria critica del Premio nel 2020. Nel 2019 ha auto-pubblicato il non-romanzo in cielo e in terra. Nel corso del 2020 ha curato e tradotto per Carte nel Vento testi di poesia francofona contemporanea inedita in Italia (Marcel Moreau, Serge Pey e, prossimamente, Christophe Manon e Hélène Dorion). Un suo testo figura tra gli Atomi 2020 di Oblique Studio (#20).
Anna Maria Pes, videolettura della poesia inedita “Esi(s)to”, premessa di Ranieri Teti
“Dietro quinte fragili” agisce questa poesia di Anna Maria Pes. Tra finzione e realtà si incunea il poeta: quello che è sembra non essere, quello che non è sembra prendere una forza inesausta. Mentre un mondo cadente viene definitivamente spogliato dalla poetessa, un mondo in attesa della prova mostra tutta la sua fragilità.
Al termine del testo soccorre il tornare al titolo, a questo “esisto” scritto con la seconda esse tra parentesi, che nella rappresentazione grafica porta il senso di un esistere esitando, porta all’incerta presenza di fronte al mondo, alla consapevolezza di esservi provvisoriamente parte.
Non ci sono certezze nel “quotidiano esistere” se non un vano girovagare, un disfarsi tra “dissonanze e assonanze”.
Là, dove cadono fittizie impalcature, il poeta registra con la massima attenzione il disfacimento.
Esi(s)to
Nel personaggio – non personaggio
Nel proscenio del quotidiano esistere
Nell’Io – non Io dell’esistenza effimera
Nel baleno dietro nuvole annodate di giorni incerti
Ossimori differenze obbligate dall’umano persistere
Di azioni insulse negate offuscate da nebbia vile
Nel girovagare notturno di attori scalzi svestiti
Maschera / Trucco Pubblico distratto Annoiato
Senza trama Senza luci Senza musica
Velluti cremisi di sipari impazziti alla ricerca di
Personaggi – non personaggi
Dietro quinte fragili
Protagonisti in attesa Copioni vuoti Suggeritori assonnati nel buio
Pantomime in agguato Dissonanze/Assonanze Sincronie metafisiche
Apparenza insolente Mefistofele del giorno Enigma provvisorio
(alle spalle ti aspettano per abbattere impalcature)
Anna Maria Pes (già docente nella scuola media statale), opera in campo artistico dal 1978 (acquerello, ceramica, incisione) e in campo letterario dal 1998.
Dal 1998 le sue poesie sono state pubblicate in riviste letterarie: SILARUS Battipaglia, POESIA Crocetti Editore (Testi dei lettori) e in Antologie: “Andar per poesia“, “Luci ed ombre“ (Ibiskos Editrice Empoli), “Scriviamo un libro insieme“ (ALI Penna d’autore Torino), Circolo Culturale Identità Pontedera, Spazio Donna Striano Napoli, “L’emozione del ricordo” Armonia delle Muse (Ibiskos Editrice Empoli) (Fiera del Libro 2006 Torino, Fiera del Libro Roma 2006), “Incontri di Poesia“ (Ibiskos Editrice Empoli), “Officina della Percezione”, “Percorsi del dire I” (Anterem Verona), “Città di Salò 2006” Riviere del Benaco, “Solchi di Scritture”, “Poeti e scrittori contemporanei allo specchio “, “Tendenze di linguaggi “ (Edizioni Helicon).
Riconoscimenti e premi nei Concorsi: “ G. Gronchi” Pontedera , “Gli Etruschi” Vada-Livorno, Circolo Culturale Sardo Brescia, Concorso Nazionale Ibiskos - Risolo ( sez. Poesia singola, sez. silloge inedita), “Spazio Donna” Striano-Napoli, “Città di Salò” Ibiskos Ed.Risolo, “Mondolibro” Roma, “Casentino” Poppi-Arezzo, “Maestrale San Marco 2006” Sestri Levante-Genova, CEAC 2011 Milano – “Citta di Pontremoli” La Spezia, “L. Montano” Anterem – Verona: 2003 /2013 /2014 / 2016 /2017/2018/2019 (sez. Una poesia inedita), 2006 (sez. Raccolta inedita)-; Premio “Il Delfino” 2015/2016/2017/2018/2019 (sez. Poesia) Marina di Pisa.
1° premio Concorso “Il Delfino 2014” Marina di Pisa –Pisa sez. Poesia: ” Come gabbiano” (da “Solo sentire”).
Opere edite:
2002: “TRASPARENZE” Ibiskos Editrice Empoli (Fiera del libro 2003 Torino).
2007: “SOLO SENTIRE” ( Fiera del Libro 2007 Torino, 2006 Roma ) Ibiskos Editrice A. Risolo -Empoli (segnalazione d’arte Premio Internazionale “L’integrazione Culturale per un Mondo Migliore” 2011; finalista sez. Poesia Concorso di poesia “Terzo Millennio” XIV Ed.2014 C.A.P.IT. Roma)
2015: “IN DIES” (Book Festival di Pisa 2015) Ibiskos Editrice A. Risolo - Empoli (Premio della Giuria “Città di Pontremoli” 2016)
Opere presenti presso le Biblioteche:
Biblioteca Universitaria Cagliari, Biblioteca Comune di Cagliari, Biblioteca Provinciale di Cagliari, Biblioteca Universitaria di Sassari, Biblioteca Comune di Sassari, Biblioteca Nazionale Centrale V.E.II Roma - Biblioteca Civica Terzo Alessandria, Biblioteca di “Presenza”, Striano - Napoli, Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Biblioteca Marucelliana Firenze, Biblioteca Comune di Poppi ( Arezzo), Biblioteca Civica Verona.
Irene Sabetta, videolettura con animazione dalla raccolta inedita "Nomi cose città", nota di Laura Caccia
Nel rovescio del trittico
Contrariamente a quanto il titolo induca a pensare, nomi cose città di Irene Sabetta, non dispiega solo i temi familiari, naturali e urbani, indicati dalle tre sezioni dell’opera, ma ne rovescia le superfici, ne capovolge le prospettive.
Quasi un trittico che, come le antiche decorazioni d’altare ad ante richiudibili, ci mostra sul lato visibile situazioni e pensieri manifesti e sul lato interno, nascosto, un sentire più in ombra: “Nel prato di maggio / ho trovato nascosto / un fiore sotterraneo”. Di fronte i nomi delle figure familiari o amate, le cose, le città. Sul retro l’orfanità, l’invisibilità, l’erranza.
In tutte le sezioni a permearne i versi sono le zone d’ombra, segrete l’invisibilità che quindi vi risuona, la difficoltà di farne parola, così che “Come un usignolo, / voli di notte e non canti”. E, insieme, l’erranza che spinge oltre l’apparenza, il nomadismo che intride i testi e la distanza che chiede cammini di incontro.
E la poesia? Mostra anch’essa il suo lato nascosto, indica Irene Sabetta: “Incontriamoci / nell’ottava stanza di una poesia / dove il silenzio non è mai troppo / e l’alfabeto non basta”. A custodire tacitamente, nel rovescio del suo trittico, un nuovo alfabeto, una voce che ancora possa cantare.
Da: cose
Light in May
Nel prato di maggio
ho trovato nascosto
un fiore sotterraneo.
Nella cripta luminosa
la luce proietta da oriente
l’immagine di un dio
che viene.
Nel libro aperto dei muri affrescati
angeli tristi
sospendono il giudizio
e ripudiano il volo.
Con le ali abbassate
il dono delle stelle nere
è nelle loro mani.
Vivremo sempre
o non vivremo affatto.
Eppure a luci spente
è facile e sensato
scorgere nella cripta un chiarore
d’arte o di fuoco
che emana dal muro
e ci accompagna allo scoperto.
Usignolo
La forma del mondo
non ti precede
e neanche ti accoglie
con collane di fiori
ai piedi della scaletta.
E tu non precedi la forma.
Nessun architetto ha firmato il progetto.
Nel gelo dell’inverno
il chiarore del pensiero
risplende sulle montagne
e annichilisce ciò che non si adatta.
Mortali i sensi e gli uccelli.
La forma baratta il metodo con la complicità.
E tu non essendo complice ti disfi di metodo e forma.
Come un usignolo,
voli di notte e non canti.
Da: città
Rio bound
Obliterami
con la tua potenza.
Dimentichiamo il mondo
e ricostruiamo la parola,
tra gli alberi tropicali
e le piume dei pappagalli
impazziti di gioia.
L’anima violenta
scalpita in quiescenza
sulla montagna
e vibra di musica.
La senti solo da lontano.
Acqua azzurra e acqua nera
nelle insenature minime.
Corpo inerte della cultura
smembrato e adagiato
sulle spiagge
nei rituali
dell’estate eterna.
Non c’è luce più vera
di quella che non vuoi vedere
né città più concreta
nelle vie di fuga.
Siamo gente nomade
in una galassia di periferia
e negli angoli soltanto abbiamo dimora.
Irene Sabetta vive ad Alatri dove insegna inglese al liceo e coordina, da oltre venti anni, un laboratorio teatrale per gli studenti con il regista Marco Angelilli. Ha pubblicato, con FrancoAngeli, un saggio per il volume La mediazione scolastica. Scrive poesie e molte di esse sono presenti in antologie curate da vari editori come Perrone, Aletti, Poetikanten, Il Foglio Clandestino, Pagine, Bertoni. Nel 2015, si è classificata prima al concorso Augusto Tacca e, nel 2017, è stata finalista al Festival della Lentezza con un racconto breve e al premio letterario Don Luigi Di Liegro. La casa editrice LietoColle ha scelto alcune sue poesie per l’Antologia iPoet 2018 e per l’ Agenda poetica Il segreto delle fragole. Recentemente ha pubblicato una plaquette dal titolo Inconcludendo con l’editore Escamontage e ha ricevuto una menzione di merito al premio Lorenzo Montano. Suoi testi sparsi si trovano sulla rete (Poetarum Silva, Patrialetteratura, Neobar, Gateway to the fourth dimension, I poeti del parco).
Collabora con il sito Atlante delle residenze creative di Tiziana Colusso e un suo articolo è incluso nel volume Residenze e Resistenze creative, Luoghi Interiori ed.
Sergio Sichenze, videolettura della poesia inedita “La versione dell’enigma”, premessa di Ranieri Teti
L’altezza del momento fermato in “La versione dell’enigma” ci dona un controllato soprassalto, ci porta dove la vita è enigma e doloroso passare, la terra è fragile, la memoria è abissale.
Sergio Sichenze, da grande arrischiante, si sporge fino all’ultimo centimetro possibile di un ideale crinale, fino a quella sospensione, a quel lembo in cui non c’è distinzione tra terra e aria, in un mutuo rovesciarsi.
In questa poesia tutto è sempre in bilico, come nella vita. Tutto ciò che viene osservato o registrato è già stato mediato nel pensiero: a esempio la voce, nella verticalità del testo, da “calligrafia aerea” diventa un insoluto silenzio.
La complicità del ritmo all’idea, il versificare breve, un vocabolario sceltissimo e coerente, la tecnica compositiva, rendono possibile l’aderenza perfetta di senso e ritmo.
La versione dell’enigma
Incerta geometria
della voce, calligrafia
aerea, straniato
suono: spezzato lascito
di parole.
Inaccessibile piega
del labbro: crinale con zelo
affilato. Abisso
della memoria: rantolio
terreno.
Oscillare
di toni: vertici, arrendevoli
conche, aline
plaghe.
Sussurri, bisbigli, insoluti silenzi.
Consumato
ansimare, rappreso
alito: apnea di sfiorito
tempo.
Tardivo vivere
nell’altro.
Sergio Sichenze è nato a Napoli nel 1959. Vive e lavora a Udine. Ha pubblicato racconti e raccolte poetiche, tra cui “Nero Mediterraneo” (Campanotto Editore, 2008), “BOBBIO Y MOSTAR” in “La natura dell’acqua: almanacco di letteratura rinnovabile 2011” (Marcos y Marcos Editore, 2011), “Nei chiaroscuri del tango” con Elisabetta Salvador (Campanotto Editore, 2018), “Il futuro cede al ritorno” (Convivio Editore, 2019), “Tutto è uno” (Terra d’ulivi edizioni, 2020), “Incantazione” (Màrgana edizioni, 2020). Sue poesie compaiono in alcune raccolte. Nel 2018 ha vinto il Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio. Dal 2019 è membro della giuria Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio. Fa parte del comitato di redazione del quadrimestrale internazionale di cultura poetica e letteraria “Menabò” (Terra d’ulivi edizioni) per il quale cura la rubrica “Pi greco”.
Ultima pagina, Immagini da “Questa cosa”
Immagini da “Questa cosa”: Marosia Castaldi, Gio Ferri, Milli Graffi, Marica Larocchi, Maria Pia Quintavalla, Fausta Squatriti







Quarta di copertina: Autori di “Carte nel vento”
Autori di “Carte nel vento”
Sebastiano Aglieco, Nadia Agustoni, Alessio Alessandrini, Pietro Altieri, Viola Amarelli, Angelo Andreotti, Marcello Angioni, Cristina Annino, Gian Maria Annovi, Lucianna Argentino, Davide Argnani, Giuseppe Armani, Paolo Artale, Gianluca Asmundo, Alessandro Assiri, Daniela Attanasio, Dino Azzalin
Luigi Ballerini, Paola Ballerini, Daniele Barbieri, Bianca Battilocchi, Maria Angela Bedini, Daniele Bellomi, Primerio Bellomo, Franco Beltrametti, Mario Benedetto, Dario Benzi, Riccardo Benzina, Pietro Antonio Bernabei, Armando Bertollo, Vanni Bianconi, Nicoletta Bidoia, Ilaria Biondi, Giorgio Bona, Giorgio Bonacini, Leonardo Bonetti, Simone Maria Bonin, Doris Emilia Bragagnini, Silvia Bre, Andrea Breda Minello, Fabrizio Bregoli, Luca Bresciani, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani, Simone Burratti, Giusi Busceti, Antonio Bux
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Giuseppe Calandriello, Maria Grazia Calandrone, Giovanni Campana, Mario Campanino, Enzo Campi, Giovanni Campi, Martina Campi, Emanuele Canzaniello, Maddalena Capalbi, Michele Cappetta, Roberto Capuzzo, Allì Caracciolo, Alessandra Carnaroli, Lorenzo Carlucci, Anna Maria Carpi, Peter Carravetta, Alberto Casadei, Mauro Caselli, Guido Caserza, Marosia Castaldi, Davide Castiglione, Paola Casulli, Alessandro Catà, Elena Cattaneo, Alessandra Cava, Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Alessandro Ceni, Rossella Cerniglia, Maria Benedetta Cerro, Marilina Ciaco, Viviane Ciampi, Gaetano Ciao, Antonella Cilento, Laura Cingolani, Mara Cini, Gabriella Cinti, Domenico Cipriano, Roberto Cogo, Gabriella Colletti, Osvaldo Coluccino, Tiziana Colusso, Silvia Comoglio, Federico Condello, Nicola Contegreco, Antonino Contiliano, Morena Coppola, Giorgiomaria Cornelio, Marina Corona, Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto, Lia Cucconi, Miguel Angel Cuevas, Vittorino Curci
Mauro Dal Fior, Anna Maria Dall’Olio, Chetro De Carolis, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Lella De Marchi, Annamaria De Pietro, Evelina De Signoribus, Riccardo Deiana, Silvia Del Vecchio, Fernando Della Posta, Pasquale Della Ragione, Stefano Della Tommasina, Aurelia Delfino, Tino Di Cicco, Danilo Di Matteo, Vincenzo Di Oronzo, Bruno Di Pietro, Stelvio Di Spigno, Letizia Dimartino, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria, Patrizia Dughero, Giovanni Duminuco
Marco Ercolani, Flavio Ermini, Franco Falasca, Mario Famularo, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina, Silvia Favaretto, Francesco Fedele, Federico Federici, Annamaria Ferramosca, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Luca Ferro, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory, Zara Finzi, Antonio Fiori, Raffaele Floris, Rita Florit, Ettore Fobo, Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Valentino Fossati, Biancamaria Frabotta, Kiki Franceschi, Tiziano Fratus, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Gabriele Gabbia, Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Maria Grazia Galatà, Marinella Galletti, Carmen Gallo, Gabriella Galzio, Guido Garufi, Paolo Gentiluomo, Mauro Germani, Fabia Ghenzovich, Alessandro Ghignoli, Gianluca Giachery, Anna Maria Giancarli, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Patrizia Gioia, Carolina Giorgi, Sonia Giovannetti, Marco Giovenale, Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Llanos Gomez Menéndez, Michela Gorini, Giuseppe Gorlani, Alessandra Greco, Angela Greco, Cesare Greppi, Lino Grimaldi, Maria Grimaldi Gallinari, Iria Gorran, Giovanni Guanti, Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini, Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin, Andrea Guiducci
Giovanni Infelìse, Maria Grazia Insinga, Carlo Invernizzi, Stefano Iori, Francesca Ippoliti, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Sonia Lambertini, Michele Lamon, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Leandro, Alfonso Lentini, Laura Liberale, Nicola Licciardello, Tommaso Lisa, Oronzo Liuzzi, Domenico Lombardini, Andrea Lorenzoni, Francesco Lorusso, Ghérasim Luca, Antonella Lucchini
Loredana Magazzeni, Giulio Maffii, Franca Mancinelli, Danilo Mandolini, Francesca Marica, Marianna Marino, Emanuela Mariotto, Attilio Marocchi, Raffaele Marone, Francesco Marotta, Giulia Martini, Giulio Marzaioli, Vincenzo Mascolo, Stefano Massari, Mara Mattoscio, Alessandro Mazzi, Luciano Mazziotta, Daniele Mencarelli, Manuel Micaletto, Emiliano Michelini, Roberto Minardi, Marco Mioli, Francesca Monnetti, Daniela Monreale, Gabriella Montanari, Emidio Montini, Marcel Moreau, Romano Morelli, Umberto Morello, Sandra Morero, Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Gregorio Muzzì
Luigi Nacci, Clemente Napolitano, Paola Nasti, Giuseppe Nava, Stefania Negro, Giulia Niccolai, Davide Nota, Mario Novarini, Marco Nuzzo, Riccardo Olivieri, Francesco Onìrige, Margherita Orsino, Cosimo Ortesta
Luca Paci, Marco Pacioni, Alessandra Paganardi, Cristiana Panella, Carla Paolini, Alice Pareyson, Paola Parolin, Giovanni Parrini, Angela Passarello, Giuseppe Pellegrino, Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Daniela Pericone, Roberto Perotti, Anna Maria Pes, Serge Pey, Mario Pezzella, Luisa Pianzola, Antonio Pibiri, Renzo Piccoli, Antonio Pietropaoli, Roberto Piperno, Pietro Pisano, Stefano Piva, Marina Pizzi, Daniele Poletti, Gilda Policastro, Chiara Poltronieri, Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Stefania Portaccio, Claudia Pozzana, Ivan Pozzoni, Chiara Prete, Loredana Prete, Maria Pia Quintavalla
Alessandro Ramberti, Jacopo Ramonda, Giuseppina Rando, Andrea Raos, Beppe Ratti, Filippo Ravizza, Luigi Reitani, Vittorio Ricci, Jacopo Ricciardi, Alfredo Rienzi, Giuliano Rinaldini, Alfredo Riponi, Massimo Rizza, Gianni Robusti, Marta Rodini, Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa, Sofia Demetrula Rosati, Lia Rossi, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti, Greta Rosso, Enea Roversi, Anna Ruchat, Paolo Ruffilli, Gianni Ruscio
Irene Sabetta, Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Rosa Salvia, Lisa Sammarco, Massimo Sannelli, Irene Santori, Patrizia Sardisco, Marco Saya, Viviana Scarinci, Antonio Scaturro, Evelina Schatz, Giuseppe Schembari, Fabio Scotto, Massimo Scrignòli, Loredana Semantica, Luigi Severi, Sergio Sichenze, Ambra Simeone, Stefania Simeoni, Roberta Sireno, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Marco Sonzogni, Pietro Spataro, Fausta Squatriti, Giancarlo Stoccoro, Stefano Stoja, Maria Paola Svampa
Antonella Taravella, Gregorio Tenti, Diego Terzano, Italo Testa, Ranieri Teti, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato, Carlo Tosetti, Silvia Tripodi, Luigi Trucillo, Guido Turco, Giovanni Turra Zan
Liliana Ugolini, Tonino Vaan, Adam Vaccaro, Luca Vaglio, Roberto Valentini, Camillo Valle, Sandro Varagnolo, Francesco Vasarri, Matteo Vercesi, Cesare Vergati, Maria Luisa Vezzali, Nicola Vitale, Ciro Vitiello, Annarita Zacchi, Simone Zafferani, Paola Zallio, Claudio Zanini, Claudia Zironi, Aida Maria Zoppetti, Marco Zulberti
Settembre 2020, anno XVII, numero 48

Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura della redazione di "Anterem"
“Chi scrive una poesia la scrive soprattutto perché l'esercizio poetico è uno straordinario acceleratore della coscienza, del pensiero, della comprensione dell'universo. Quando si è provata una volta questa accelerazione non si è più capaci di rinunciare all'avventura di ripetere questa esperienza; e si cade in uno stato di dipendenza, di assuefazione a questo processo, così come altri possono assuefarsi alla droga o all'alcol. Chi si trova in un simile stato di dipendenza rispetto alla lingua è, suppongo, quello che chiamano un poeta”.
Convochiamo idealmente Josif Brodskij, l’autore della frase, come portavoce della fedeltà dei poeti alla parola. Testimonianza che il “Montano”, anno dopo anno, continua a raccogliere e proporre in questo periodico. Trasmettere, rinnovare e condividere questa esperienza rappresenta per noi un grande piacere. Ringraziamo i poeti e i prosatori presenti nel nuovo “Carte nel vento”, non solo per i testi inviati al premio lo scorso anno, ma anche per la disponibilità a offrirci le loro voci e i loro volti.
Il presente numero si aggiunge ai due precedenti nel racconto dell’edizione 2019 del Premio Lorenzo Montano; altri ne seguiranno, con regolarità. Qui presentiamo Lucianna Argentino, Paolo Artale, Doris Emilia Bragagnini, Fernando Della Posta, Bruno Di Pietro, Ettore Fobo, Miro Gabriele, Michela Gorini, Iria Gorran, Sonia Lambertini, Franca Mancinelli, Danilo Mandolini, Francesca Marica.
L’apertura del 48° “Carte nel vento” è dedicata a Serge Pey, importante poeta francese praticamente inedito in Italia, presentato e tradotto da Cristiana Panella, e al ricordo di Fabrizio Bianchi offerto da Michela Gorini. La conclusione è affidata al cameo di Bianca Battilocchi, con la sua videolettura di “Nontiscordardimé”, e alle immagini dell’inaugurazione di “Albedo”, la scultura di copertina, con Isabella Caserta e Vittorino Andreoli che accompagnano l’artista Piera Legnaghi.
Ranieri Teti
In copertina: “Albedo”, scultura di Piera Legnaghi
Prima pagina: Cristiana Panella presenta e traduce Serge Pey
Nota ai testi di Serge Pey (prima parte)
Caminante no hay camino, se hace camino al andar...
Golpe a golpe, verso a verso...
La poesia non si spiega che con la poesia. Cerco frasi ordinate in cui contenere il magma di terra laterizia del mondo poetico di Serge Pey, stratigrafie di scrittura/oralità in cui coabitano i leoni di Chauvet, i troubadour e la memoria eretica occitana, lo zaum dei futuristi russi, il Dada, il rap del tumborro di Barbagia, la cosmogonia huichol, il Magnum Opus alchemico, la letteratura Beat, la Scolastica, l'archeologia, la fenomenologia, la militanza politica, il flamenco. Un "misticismo ateo" che proferisce un'incessante creazione, il duende proprio al principio di vita stesso in quanto pulsione, anelito, conato.
Cerco frasi ordinate, e non le trovo. Ho chiesto al poeta le poche necessarie.
I versi di Antonio Machado racchiudono alcuni elementi fondanti dell'itinerario poetico di Serge Pey. Innanzitutto la memoria. Di un uomo i cui ultimi passi si sono incrociati, verso destinazioni che segneranno destini, con quelli di José Juan Amelino Pey-Saguer, padre di Serge Pey, anarchico catalano internato nel campo di concentramento di Argelès sur-Mer in quello stesso anno 1939, pochi mesi prima che Machado morisse, insieme a sua madre, anch'egli negli stenti della Retirada dei 500.000 dalle truppe franchiste verso la Francia, a Collioure, dopo essere passato per Cerbère dove venne a trovarsi anche José Juan Amelino Pey-Saguer. Nel maggio del 2014 Serge Pey e Chiara Mulas hanno percorso quelle strade della memoria portando, in un'altra marcia collettiva di resistenza e testimonianza, 400 lettere scritte da bambini sulla tomba di Machado, vegliata da una buca delle lettere rossa, così come veglia il fiore. Per Serge Pey Antonio Machado è infanzia, radice; è il primo esempio del camminare in poiesis, nella vita come movimento di farsi e disfarsi, passo dopo passo, "colpo dopo colpo, verso dopo verso". Colpo, passo, verso. Colpo, passo, verso. Seguendo la nota blu che alita la parola poetica attraverso il corpo in gesto, voce e protesi: la poésie d'action in cui Serge Pey è maestro.
GESTO: braccia e piedi piantano la parola poetica. Una volta piantata essa è sancita, è al mondo. Le parole del poeta si piantano nel basso e nell'alto. Nella terra e nel cielo. Nella terra Serge Pey piantuma i bâtons à parole, bastoni incisi a poesia d'inchiostro; piantuma il piede che scandisce il verso, il pomodoro rosso maciullato tra le mani. Nel cielo piantuma la piuma, l'invocazione, l'occhio che si fa pertica, scala, dito. La parola non è solo manifesta ma è manifesto, dichiarazione di intento al singolare: tendere verso, desiderare. Piantumare il gesto significa fare del desiderio azione, dare al cuore braccia volenterose, mettere in circolo per radicare il soffio del desiderio attivo. Lasciarlo in eredità gravido.
VOCE: la voce viene trasformata in verso, affinché sia riconosciuta sorella dai vulcani e dagli uccelli. Viene sputata in grumo, espulsa dalla fucina verticale che va dall'ipofisi all'ano, e dall'ano all'ipofisi in un'incessante inversione del senso di marcia; il desiderio che esce dal corpo-metronomo si fa suono materico, verso ibrido cerebrale, gutturale, cardiaco, gastrico, intestinale, sfinterico. Umano, animale, minerale, atmosferico. "Colonna vertebrale" polifonica della postura poetica.
PROTESI: oggetti di natura, utensili illuminati: rose, pomodori, pietre, piume, reti, scarpe, maschere, cappelli, fotografie.
Si piantuma per chi verrà. Si piantuma per chi è stato.
I testi qui proposti sono frammenti di questa spira mirabilis, in un continuo rimando tra cielo ctonio e cielo astrale, in una militanza etica in cui il battito poetico segna il giusto tempo di una dimensione senza tempo, raggruma nell'istante la ciclicità non dell'evento ma dell'avvento. La coglie situandola, come sciamana, attraverso il verso. Una poesia situazionista perché in-sita il verbo poetico; perché in una logica transitiva di volenza risponde presente all'istante. Ricuce il ritmo interiore con quello esteriore, che si soffi su una piuma, si spacchi una pietra o si depongano rose, per riprendere alcune splendide immagini dell'azione poetica "La pierre et la plume" (Serge Pey e Chiara Mulas, 2017). E tuttavia il gesto poetico in situ non è contingente. Non si esaurisce nel qui e ora di una serie di azioni ma è presente all'azione del soffio vitale, di quel "respiro nella contraddizione" con cui Pey definisce l'arte. In questo soffio convivono la presenza e il suo contrario, in uno stesso flusso coerente, cioè coeso: "una bestia che non esiste, una bestia che esiste", "una bandiera che non è una bandiera", "le forze ctonie che sono il rovescio del cielo". Tutto è collegato grazie al tempo intonato della contraddizione. Tutto nell'essere presenza di per sé testimonia non solo la possibilità ma la reale esistenza del proprio contrario; del non-essere e dell'assenza, ma anche del rovescio, dell'inversione.
In questa contraddizione, che è quella vitale dell'umanità, la poesia è insieme traccia ed eco. Pietra e aria. Il gesto in presenza, quello della poésie d'action, è così impronta di gesti e rumori ancestrali, di rifrazioni del cosmo senza nome che ci permettono, oggi, di stare al mondo, di essere contemporanei non perché dipendenti dall'attualità ma perché battiamo il giusto tempo di un soffio cosmico, eredi di una condivisione di passi, mani, suoni, umori, escrementi. Anelli di una lunga catena di aneliti in transito. Inalare l'azzurro dell'infero e del superno.
In più di te
I morti non sono
solo cifre
Quando ti amo
amo qualcosa
in più di te
ma che tuttavia viene da te
fino a occhi che non si vedono
Qui i cani non abbaiano
li si sente ridere
nelle pozzette di urina
Le nicchie sono taverne
dove gli angeli ruttano
consonanti
sulle nostre labbra incompiute
Le vocali sono mani
che lacerano la notte
Quando si scrive
qualcuno che viene dall'avvenire
ci tiene la mano
poi ci offre la pelle come una pagina
I tavoli sono infelici
sotto le lampade
I calamai non esistono più
eppure nei nostri corpi
colano riserve d'inchiostri
che terminano la notte
con una stella
in fondo a una frase
Una flebo goccia lentamente
dal mio cervello verso la pagina bianca
di un libro senza titolo né copertina
È il suo sangue bianco
che sale improvviso
verso di me
e che scrive il poema
che non hai ancora scritto
e mi fa sanguinare la pelle
fino al tuo amore.
Sul dettaglio delle cose
1
Questa bottiglia infranta sul pavimento
non è vetro
ma una parola rotta
forse uno specchio
posato su un orecchio
Ora le parole che spazzo
nella vanga parlano
un'altra lingua
più forte di quella della bottiglia
quando era intatta
e piena d'acqua
Un'altra bottiglia
posata più in alto sulla mensola
guarda la scena
Spezzare un'altra forma
far nascere una parola
di questa forma che non possiamo raggiungere
e che non sarà mai letta
Ma anche spezzare una parola
nella tua mano
è una cosa rotta
soprattutto amandoti nelle tue ombre
Le lettere che spazzo
nella vanga
chiamano ora
una parola senza cosa
ma che le contiene tutte
e che non ama nessuno
neanche l'infinito
che non smette di (ri)finirsi
camminando a piedi nudi
sul vetro rotto
2
Il ventre aperto del sole
all'improvviso davanti al paesaggio
ci mostra le trippe
o i suoi spiriti
Il paesaggio ci fotografa
lentamente
e ci fa indietreggiare
L'abisso ci guarda
perché da tempo
ci abbiamo gettato occhi
Il poema si torce le mani
a forza di avvicinarsi al vuoto
che batte come un cuore
Una parola non è che questo
ma è già troppo
senza sapere
poiché le cose ci ascoltano
Il vuoto non ha che un unico bordo
come una tazza
e quando lo voltiamo
è la tazza che cade
e il bordo guarda ciò che è caduto
Il cielo beve quello che può
rimpiangendo di non aver avuto bordo
come un bordo senza buco
un buco senza bordo
dove nessuno può scendere
ma dove tutti i bordi del mondo
saltano passando dietro di noi
3
Il parto dell'aquilone
si è svolto
all'ospedale della spiaggia
in mezzo a cordicelle
e fogli storti
Quest'uccello intempestivo
Questa mano su di noi
come uva
che fa sanguinare le sue unghie
Le parole sacrificate
che trascina nella coda
permettono di trattenere
gli eventi
che sono per esempio
il volo di corvi
o di aerei a reattore
In un angolo
del paesaggio
ci nascondiamo
in ciò che ci guarda
con la coda dell'occhio
Così te
davanti alle pagine bianche
che trascinano i venti
che si prendono per biancheria
Così con i tuoi occhi persi
che abbiamo ritrovato
o restituiti
per gettare biglie nei buchi
4
Una parola è un nodo
in ritardo o in sguardo
sul mondo
o in anticipo
quando il mondo non è più qui
La poesia è un concorso di circostanze
che uniamo in una botta sola
disfacendo i nodi
Piantiamo
la matita in mezzo al poema
che ha appena scritto
come un coltello
per disfare il nodo
Una parola è un pericolo isolato
circondato dall'abitudine
delle altre parole
Ti chiamo in questo giorno
con il tuo nome
Ti chiamo
Ti lego
Ascolta
La poesia si strappa
gli occhi per parlare
come i denti
Le parole non odono
Guardano le orecchie
di quelli che leggono
e fanno nodi
Stamattina, la poesia mangia
le orecchie delle parole
che non sentono
affinché le si possa sentire
e fare nodi
5
Ogni parola perde le sue lettere nella morte
e il suo silenzio cola
goccia a goccia
minuscola dopo minuscola
Un segno lampeggia
all'incrocio di tutte le strade
di tutte le colombe
di tutti i corvi
e di tutte le maiuscole
Il poema
che sfugge a questa parola
è un pericolo nuovo
che esita a iniziare
il poema da una minuscola
e il seguito della frase
in maiuscolo
La parola
di un testimone principale
partito senza che nessuno
l'abbia identificato
si perde le lettere
Ora una bestia fabbrica l'universo
e trascina la testa del tempo
con un capello solo
Vediamo il vuoto
discendere dal cielo
come una parola proveniente
da una geometria
Il nocciolo sotterraneo
dell'altezza
6
In un poema
il lettore che si oppone
a un dettaglio
che ha davanti
sottintende la somma
dei dettagli che lo guardano
Poster strappato
Corvo appollaiato su un semaforo
Specchio che beve in uno specchio
Un dettaglio si accorda sempre
con il nome della cosa
contenuta in questo dettaglio
e che va a generalizzare
tutti i dettagli che circondano
questa cosa
Ogni poema è anche una somma di dettagli
da dove sfuggono i titoli
delle cose che li guardano
Il dettaglio di un poema
si accorda sempre con un dettaglio
che sfugge
a colui che lo legge
in un segreto ad alta voce
Sono i dettagli
che si leggono tra loro
e a volte il titolo di un poema
non è che la somma di tutti i dettagli
che ha davanti a sé
ma in un nuovo ordine
del canto generale
Perciò per riprendere
i dettagli seguenti e citati sopra
riconsideriamo questa lista :
Poster strappato
Corvo appollaiato su un semaforo
Specchio che beve in uno specchio
Si otterrà una combinazione
di titoli come un giro di parole crociate
Corvo strappato su un semaforo
o Poster che beve in uno specchio
Così questo paesaggio che ho davanti
è divenuto stamattina
un dettaglio generale
e il lettore è
il quinto dettaglio
davanti ai quattro angoli del paesaggio
generale che ha perso i dettagli
7
Come leggere il poema
o piuttosto come leggere
il silenzio che circonda
le parole che formano questo poema
Ogni parola stamattina è un dado
che roteo nella mano
sopra al tavolo di un gioco
che non gioca
La poesia perde sempre
quando vuole allineare l'infinito
come i dadi
Il poeta gioca a Dio
sul tavolo da gioco
Getta gli occhi
facendo rime e luoghi
La rima non appartiene che all'orecchio
e se è il caso
cessa immediatamente di essere poesia
La rima appartiene all'occhio
stabilendo per esempio
un ponte
tra dio e gioco
Il pensiero suona unicamente
nelle rime
dissotterrando luoghi che non sono mai
esistiti e che all'improvviso ci vedono
8
Il ruolo della poesia
non è di togliere
le spine del rosaio
nel vaso posato sul tavolo
Né di aggiungere spine
al profumo delle rose
che cola sul tavolo
La poesia ci lascia
incerti
e la rosa distesa
su tutto il tavolo
ci lascia la promessa
di non esistere più
Questa rosa è un avvenire
già scritto
ma questa rosa è necessaria
e somiglia a una finalità senza fine
che tuttavia si ferma per guardarsi
Le casualità mentono
e questa rosa
è la giustizia di un nulla assoluto
Questa rosa posata sul tavolo
è bella perché è incapace
di capire la sua bellezza
Nessuna bellezza sa che è bella
Il suo suicidio di luce
fa di lei l'assente di tutto il mazzo
e il nulla diventa all'improvviso bello
davanti alla rosa intera
tacendo
9
La poesia è bassa
Bisogna sporgersi per raccoglierla
in mezzo a sedie rovesciate
La poesia non esiste da sola
sopra cose
sedute su sedie
Eppure è prigioniera
di quello che l'ha giustamente costituita
in bellezza
quando una cosa si alza
dalla sedia
La poesia non è mai una verità
senza la realtà
di una sedia che si siede
su un'altra sedia
La poesia va fino al fondo
dell'uomo
che smonta la sedia
per accendere un fuoco
La poesia è una decisione
che crede alla propria esigenza
delle parole della sedia
Abbiamo talmente picchiato
sul naso di questa sedia
che continua a sanguinare
senza accorgersi che è un uomo
che sanguina su di lei
o i suoi piedi che l'hanno attraversata
10
E per alleviare
il tavolo abbiamo
tolto i piatti e il pane
Poi ci siamo messi sulla panca
per smontare il tavolo
e l'acqua era assetata
di sole
Poi abbiamo svitato
i piedi e tolto il piano
fino all'entrata
rimasta beante davanti allo zerbino
Il mio tavolo è diventato così
una porta
ma quando è giorno di fame
la rimettiamo sempre in piedi
per sederci in casa attorno
Così quando mangiamo
non abbiamo più porta
all'entrata di casa
E quando chiudiamo a chiave
la porta per uscire
non abbiamo tavolo
all'interno di casa
E perciò per alleviare
casa
abbiamo eretto un tavolo
contro l'entrata e i cardini
e all'interno una porta per mangiare
La poesia sa che una porta
è sempre un tavolo
e un tavolo una porta
Fino a una parola che non sa
essere né orizzontale né verticale
per uscire o mangiare
decide che non ci sarà più niente
in casa.

Serge Pey e Chiara Mulas: "La plume et la pierre"
"fiestival" maelström 2017, Bruxelles
Foto: John Sellekaers, 2017
("fiestival" è scritto proprio cosi'). Questo fiestival annuale è organizzato dalla casa editrice di poesia e prosa poetica maelström réEvolution.
https://www.facebook.com/fiestivalmaelstrom
Serge Pey: nato nel 1950, scrittore, poeta, scultore, tra archeologia, filosofia ed etnologia, Serge Pey resta uno dei più singolari esponenti della poésie-action internazionale. Esperienza dei limiti del linguaggio, impegno politico e filosofico della poesia, esame critico della performance, statuto del ruolo delle avanguardie sono temi centrali della sua ricerca teorica. I suoi testi chiariscono in modo pertinente e polemico il ruolo che il poeta può avere negli spazi urbani di una società che propulsa la poesia fuori dal libro. Tra più di 50 opere ricordiamo Ahuc, poèmes stratégiques (Flammarion), Le trésor de la guerre d’Espagne et la Boîte aux lettres du cimetière (Zulma) Le manifeste magdalénien (Dernier Télégramme), Jérôme Bosch, avertissement d’incendie (Voix éditions), Histoires sardes d’espérance, d’assassinat et d’animaux particuliers (Castor Astral), Occupation des cimetières (Jacques Brémond), Poésie-action, manifeste pour un temps intranquille, (Castor Astral), Mathématique générale de l’infini (NRF Gallimard), Le carnaval des poètes (Flammarion), Victor Hugo, Notre Âme des paris (La rumeur libre). Vincitore del Grand prix national de poésie de la société des gens de lettres et du Prix international de poésie contemporaine Robert Ganzo, nel 2017 gli è stato conferito il Grand Prix de poésie Guillaume Apollinaire. Presidente della Cave Poésie di Toulouse, professore emerito, membro dell'Unité mixte de recherche CNRS, Framespa, satrapo del Collegio di Patafisica, Serge Pey ha diretto fino al giugno 2018 gli Chantiers d'art provisoire del CIAM, all'Università Toulouse2-Jean Jaurès.
Terza pagina: Michela Gorini per Fabrizio Bianchi, editore e poeta (1946-2019)
e non ho nemmeno la forza di scriverlo
in chiaro
5 dic. 2019
Auguri, Michela.
Anche se in ritardo.
Sarò un po' fuori dal giro fino a tutto gennaio.
Sono in cura.
Al San Matteo di Pavia.
Per una leucemia quasi fatale.
~
Non ho il controllo del corpo
~
Senso, corpo, corpo, senso. Tutto ciò che dell’essere vivi o imprigionati, in quel corpo e senza, sentirlo e non sentirlo. Sentirsi senza corpo. Queste parole – notizie dall’ospedale – mi attraversano come una doccia fredda. Leucemia (quasi, fatale). Questione severa, l’onere del corpo, corpo che si sente, corpo che non si sente. Il controllo nelle vie cerebrali, sistema nervoso autonomo, viscere, quale corpo non sentivi?
Scrivo queste righe in periodo lockdown (Covid 2020). Confinamento al proprio corpo. Mi chiedo, allora (dicembre 2019) dieci volte prima di scrivergli, se scrivere meno, se giusto ricevere, la consistenza materiale di parole. Perché si posano sul corpo. Vorrei, domandare. L’istante stesso vorrei domandare, l’istante che riguarda il corpo. Quanto forte affrontarsi, l’istante della perdita suprema, il discorso senza parole addosso e non poter replicare perché comanda la temporaneità per essenza e saprai, lì, che è in atto l’istante in cui smetterai di sentire le tue tracce. Il bordo trasferiva tracce, immissione di ossigeno, proprietà riciclabili sostenibili, sentire il lavoro e l’abito vitale che si rigenera da sé. Non esiste un sapere oltre, una forma vivibile sperimentabile alternativa. Non esci dal confinamento, dal confine al corpo che si morde e ti straccia, pezzo per pezzo, la vita che pensavi appiccicata. La vita che mordeva il corpo – desideri rabbiosi – non è la stessa vita che ti libera, è questa labile fatta di contorni che modifica gli umori e ti permea le ossa di movenze, lega muscoli e toni a un grado inferiore.
Sei pallido, bianco. Così ti vedo.
Malato ma vivo. Vivo ma silenzioso. Goffo e sparpagliato, la tua sfida con la vita, spavalda timidezza, parole accantonate, posate, scritte, quelle che ci siamo detti. Riposano e restano, a rischio di fragilità e senso.
Fabrizio scrive un corpo che non riposa, incessante, inappagato. L’incontro che non si rivela, il sogno e definirsi ogni volta altrove: supereroe della scena, schizzo a carboncino, scarabocchio. Il suo tono nitido, le sue timidezze, pause, l’essenziale e necessario, sempre, la sua voce misurata. Dietro sentivo il suo sguardo, la sua ricerca, le sue riproduzioni, le sue questioni. Trovare qualcosa per dire qualcosa, senza dirlo a tutti. Tutto non è stato manifesto, con Fabrizio. Mi domando cosa avrebbe sentito del corpo disarmato del lockdown, l’alterità trasmessa in decibel, offuscata incessante. L’aritmia e lo scompenso. Avrebbe cercato ancora un senso, il suono incessante dopo il silenzio.
La lettura qui sotto, sono tracce della sua poesia, di corpo maschile estratto e non trattato, adolescente, padre e bambino, identità fallibile, corpo animato, animale, amante.
Sul bordo
Come si imparenta un corpo – padre – a un corpo altro – figlio? Restiamo affiliati a una matrice (che non ha di materno). Se parti di un tessuto che si separa, e separato comunque. Forse sei lì a domandarti se viene, da te. Il grande scarto tra grande e piccolo, sconfinate solitudini e anni luce, dalla loro affamata allegria. Non poter dare una collocazione alla funzione, fare l’adulto, fare il padre con il piccolo staccato e congiunto. Le parti corporee staccate che non incarnano funzione. Non starci dentro, il paesaggio, non esserci. Un soprassalto fisico di insopportazione. La tua voce in silenzio che grida, la scrittura addosso che ti tormenta e distrae, il tuo sguardo linguaggio che corre oltre lo spazio.
Prestare cura (è il tuo sangue), tratta in qualche modo di un codice, una scrittura genetica che tratta il suo sangue, la marca maschile sconfinata e scritta nel tuo. Sieroso appiccicoso, estraneo e inassimilabile. Un derivato, in formula differente. La biologia che ti richiama all’ordine, a una trama ancestrale che non ti contiene e ti assenti, presti ascolto al tonfo della caduta. Domandandoti, vestito, dove, esistere. Se figlio, uomo, adolescente. Il codice ti consegna un figlio in eccesso, vivide pulsazioni, amorevole ricettivo alle attenzioni barbariche che sei chiamato a mostrare, mentre zampilla altro sangue a rintocco e tu, la deriva, padre dismesso a osservare vividi orizzonti sconfinati e perderti, in solitudini. La tua necessaria impossibilità di non combinarti all’insieme, proclamarti silenziosamente uno, uomo. Stazionare per vivere sul bordo.
Giardinetti 1
piangi per un’improvvisa caduta
[le ginocchia strisciate
da polvere nera e sieroso sangue appiccicoso]
devo farti fare pipì tergerti
le righe terrose delle lacrime
[mentre non so perché /vivo
/vivi
in /orrenda caduta verso il nulla]
/rapidissima
Fare finta di niente.
La melma del reale
Dov’è la concessione all’esistere? Fabrizio è il suo sottosuolo, il primo piano nella sua dipartita e molto prima e ripetutamente, dominano le sue tonalità, il terreno già sporco di melma reale e scorie. Lasciate le sue piccole tracce composte e decomposte. Lineari.
(afasia) Perdita della capacità di comporre/comprendere. Fabrizio non si interroga, sullo strumento (linguaggio), lo osserva, lo usa, lo sfida, cerca senso e scopo, disperatamente, nel sottofondo di indistinti rumori. Forma lo strumento, il suono, suona nella scrittura lo strumento poesia. In afasia su ogni tassello noioso e noto, suona lo strumento corpo stracciato nel sudario del foglio bianco.
Stardust
E sporchiamola, dunque questa poesia
con tutte le scorie e la melma del reale
ingoiando, fino in fondo lo schifo di un mondo che ti stupra,
ti violenta, ti tortura a morte, oggetto senza dignità
corpo stracciato sotto il sudario del foglio
lenzuolo bianco che deve testimoniarne lo strazio
Male version
Macchiolina costante e accesa, il punto più reale dell’umano, piccolezza e precocità nel sentire e sentire senza dominare, senza dignità. Al tuo interno, commentabili, visibili, risibili macchioline, pois così netti, neri (Dio le ha fatte resistenti), ti salgono al dito. Macchioline che ti hanno scritto come invisibili occhi. Tracce di esiguità e finitezza in potenza, convocata istintività. La forza vivificante del corpo animale, il rettile che ti spoglia la pelle e la riforma, si decuplica, in forme che dipartono alla struttura animale che ti contiene alternato e sognante, avvolgente e imperativo, con l’elemento al femminile. Dove si fonde, generosamente, l’animalità e sublimandosi, al dio serpente, ingoiandosi ogni remake di piacere esistito / esistente, finalmente sazio. Umano, premeditato, perversamente (entro) il corpo del linguaggio, ricresciuto in parti (altre), code, zampe, bifide lingue. Ancora vivo. La struttura del linguaggio muove pezzi, assembla, tramuta, taglia e morde. E ricompone, ne esce la raccolta. Parole mai a riposo, qualche altro ti ricorderà, leggendoti, decostruirà e ricostruirà, deformato, oltre il game over. Ciò che non può, nell’abitare l’uomo, Fabrizio lo lascia al corpo dell’animale in mutazione, al videogame con superpoteri, al maschio del sottofondo urbano, che possiede senza domandare.
Sacrificio al dio serpente
Ed ecco: siamo all’elevazione. E ti proclamo beata
[di fronte a Dio e agli uomini]
e vorrei avere 3 peni, e 2 bocche a ventosa
e più lingue [nei posti giusti]
migliaia di sensori e tentacoli
su un corpo da enorme pitone
per possederti tutta
contemporaneamente
e avvinghiarti poi fino a toglierti il respiro
e ingoiarti poco a poco nella bocca slogata
smisurata
gli occhi sbarrati in uno sforzo disumano
il corpo deformato che segue la tua sagoma:
una pelle che scivola, con lentezza, sulla tua
fino ad avere, perfettamente, la tua forma
[così amata]
Divento te, dentro.
Pigramente piangendo,
[dal piacere] per settimane.
Finalmente sazio.
Sfamato.
Fast Sex
mentre le abbasso la gonna e i collant
e cerco famelico il suo sesso bagnato scostando gli slip
e la penetro /in piedi [tra le imprevedibili scosse del metrò]
/in equilibrio
sicuramente tra gli applausi ammirati degli altri viaggiatori
[urla e fischi di incoraggiamento, una standing ovation
sincera e liberatoria, richieste di bis].
Smettila di saltare, Lara.
Sparare senza tregua.
Toglierti il reggiseno. [ci sarà un trucco per farlo]
Fammi provare. Toccarti. Giochiamo col tuo corpo. Ti prego.
O violentami tu. Sono pronto.
E [dopo averlo fatto] fammi pure saltare via il cervello.
La nostalgia di te
Invece malsicuro, imperfetto, quel tuo essere nel maschile (o trovartici a che vedere?) Il rapporto che non si realizza insieme alla donna, mai sincrono, reiterante quella implacabile tua scelta di solitudine, linciaggio di eredità che non si intrecciano a ciò che di te compie l’idea di un desiderio, un desiderio ardente, inserito dentro la donna. Fino a l’amare, l’irraggiungibile a te simile, al di là di lei. Maledettamente solo.
Fast sex
[mentre mi divora la nostalgia di te
e di tutti i tuoi buchi sensibili
della tua pelle
di ogni sua macchiolina o lentiggine
delle tue labbra socchiuse]
una donna sufficientemente /bella
/a te simile
da provare a levarle [anche solo mentalmente] i vestiti
[…]
E invece,
arrivo frustrato a Porto di Mare
per incontrarti [mentre stai partendo]
per un fugace abbraccio
un bacio furtivo sulla guancia
nel buio
e nel buio subito scompari
[lasciandomi un desiderio ardente di te
che divampa e mi brucia dentro i calzoni congelati/stecchiti]
triste e inappagato pendolare dell’anima
[maledettamente solo]
Retroscena
Polvere di stelle, sbiadita. La scena generosa e insensata che sbiadisce, in onore al vero. La partecipazione vuota, mummificata. La scrittura non tradotta. Dove l’abito maschera e distorce, frenesie di comparire, repentinamente scomparire, nessuna scelta: blackout. Tutto può essere scarabocchio, anche la polvere che si decompone e sbiadisce, caricatura di specie di esistenze autorigenerantesi, agghindate di suoni e specchi ove domare un “piccolo” posto e garantito, nei pressi del nulla. Disarmonia che si disgrega, austerità e melanconia, verità e vuoto. Parole che si dimenano distorte, all’ascolto. E non si propagano. Noia, sonno, ingoio di nascosto Fisherman’s per tenermi sveglio. Addormentamento, letale.
I vecchi poeti
recitano tutti una poesiola sui gatti
[e anche sui moscerini e sulle mele]
e c’è anche quello più famoso
[già mummificato]
Mister Zhou
Poeti esangui
tutti concentrati in privati [noiosi] malesseri
[in genere insegnanti: lettere o filosofia]
[…] incapaci di vivere davvero la vita
di amarne i reali odori & sapori
e il denso sangue nero che la irrora
Showdown
Dio, non farmi diventare un vecchio poeta
gonfio dei suoi miseri ricordi
dei premi collezionati
28 dic. 2019
In ricordo di
Fabrizio Bianchi
Poeta e direttore editoriale
Dot.com press Poesia

Postilla di Ranieri Teti
Il 12 ottobre 2019 è la data di una delle ultime apparizioni pubbliche di Fabrizio Bianchi. Lo invitammo a Verona, in qualità di editore, al Forum Anterem – Premio Lorenzo Montano.
Le due immagini proposte sono state scattate quel giorno.
Molti ricorderanno il suo intervento, ricco di spessore, passione, competenza, pacatezza e disponibilità al confronto. La sua umanità fu un prezioso elemento aggiuntivo.

Lucianna Argentino, video presentazione; prosa inedita "Il silenzio è ascolto", nota di Mara Cini
1
Il silenzio è ascolto.
Il silenzio è per l’anima ciò che lo spazio è per il corpo. Apertura. Esercizio. Intimo movimento di ciò che senza voce dà voce all’essenziale.
Lo sanno bene i poeti nel loro essere contesi tra parola e silenzio personali, creativi, che creano dialogo, che esprimono - fanno intimità. E parola e silenzio impersonali, mondani, che creano confusione, distanze - spezzano legami o li impediscono.
Il poeta fa silenzio per farsi ascolto. Con la parola poetica crea silenzio e ascolto.
L’essere poetica della parola dipende dal silenzio su cui è innestata.
Allora si può dire che anche il silenzio è conteso tra la parola poetica e l’abisso del nulla, il nulla che certe parole portano con sé quando nascono da silenzi inagrestiti e che anche il silenzio si contende i poeti per sfuggire al nulla che non gli appartiene. Perché se il silenzio non nasce alla parola e al pensiero non è silenzio.
La collisione tra parola e silenzio crea poesia, avvia la metamorfosi della parola in poesia, là dove l’acceleratore è lo Spirito, la Ruah, che abita il silenzio.
Il silenzio dei poeti è una presenza che si fa presente e fa le cose presenti.
La parola poetica è il salto quantico del silenzio, il suo mutare di stato e di sostanza e attraverso il quale le parole si offrono al potenziale d’azione del dire.
5
Il silenzio è speranza.
Il silenzio è speranza che la parola poetica da esso possa emergere come la vita dall’acqua primordiale e a quell’emergere segua la precisione del dire perché anche la poesia è speranza. Speranza che si compie, ma non si esaurisce, speranza in atto che genera speranza.
Silenzio e speranza sono attesa, ma sono soprattutto cammino verso qualcosa che già è presente e non attende altro che la nostra collaborazione per manifestarsi.
La speranza - innestare il futuro nel presente - richiede lavoro, proprio come il silenzio che una volta accolto viene trasformato in qualcosa d’altro in cui continua a respirare e dunque è anch’esso materia che il poeta plasma, anzi è il silenzio stesso a rendere le parole malleabili, pronte all’impasto poetico. Ma il silenzio, il vivo silenzio dei poeti è anche dubbio e paura perché dubbio e paura sono parte della nostra sostanza e possono essere zavorra oppure slancio. Temiamo che l’attesa sia vana quando non riusciamo a trovare vita nell’attesa. Quando l’attesa è più una resa mentre attendere è un verbo attivo: indica - azione.
In ebraico il verbo sperare, qiwwah, vuol dire anche essere teso, aspettare ed è collegato a una parola che, tecnicamente, indica la corda dei muratori e oltre a voler dire del legame della vita con la speranza e della speranza con l’“Altro da sé” sta a significare che la speranza è misura del valore che diamo alla nostra vita. Giacomo Leopardi parla di speranza come passione e George Steiner si diceva “incapace, persino nelle ore più tetre, di rinunciare alla convinzione che le due meraviglie che giustificano l’esistenza mortale sono l’amore e l’invenzione del futuro verbale”. Amore e futuro verbale che sono quella speranza nella cui declinazione siamo tutti.
7
Il silenzio è una voce e due punti.
È nella sospensione dei due punti, in ciò che il silenzio introduce, invita con la sua presenza.
È nell’attesa di ciò che nel silenzio, con il silenzio av-viene.
L’avvento fuori tempo, l’imbattersi del presente nel futuro. Di quanto nell’avvenire accade, giunge sotto altra specie.
È la visita dell’angelo.
È l’attesa e la sospensione dell’Annunciata di Antonello da Messina.
Tutt’intorno l’oscurità del silenzio in cui si nasconde la luce, e Miryàm sta, senza aureola, perché è ancora solo Miryàm - una fanciulla. E il silenzio è ancora solo silenzio, è ancora solo respiro che sfoglia le pagine del libro.
E la mano dice all’angelo attendi, taci, così la parola al silenzio:
fammi domanda e attendi che io diventi pronunciabile.
E Miryàm attende che diventi pronunciabile il suo assenso.
14
Il silenzio è digiuno.
Un digiuno non penitente, ma di purificazione, di alleggerimento.
Un digiuno festivo. Un digiuno che nutre.
Il silenzio così vissuto e praticato libera la nostra anima dalle scorie della quotidianità. Asterge il nostro essere dal superfluo che lo appesantisce, lo ancora a terra, lo rende cieco e soprattutto sordo all’ascolto di quanto in noi vibra all’unisono con il canto sommesso del mondo. Bereshit – prima parola ebraica del libro della Genesi – significa In principio e contiene sei lettere che secondo la Cabala possono essere scambiate di posto per formare altre parole che danno vita a importanti messaggi. Uno è Taev shir che vuol dire “desiderio di un canto”. Dio dunque creò il mondo perché desiderava sentir cantare, desiderava che il mondo cantasse - il canto che ogni essere umano deve trovare il modo di intonare. Per di più alcuni scienziati ipotizzano che prima di imparare a parlare, gli ominidi, modulassero dei suoni simili a un canto, un po’ come fanno alcune scimmie del Borneo. Quindi il canto prima della parola e quindi il silenzio come un canto misterioso e nudo – la vibrazione cosmica di fondo del nostro essere.
Pericoloso è il digiuno dal silenzio.
Virginia Woolf quando le voci che sentiva divennero talmente intense e ingestibili da non permetterle di concentrarsi sulla scrittura mise delle pietre nelle tasche del cappotto e si lasciò annegare nel fiume Ouse.
34
Il silenzio è tenda.
Tenda dal latino tendere: attendere, prendersi cura.
Attesa e cura di qualcuno o di qualcosa.
Ma anche tendere verso qualcuno verso qualcosa.
Tendere all’unione, alla comunione, alla relazione questo è scritto nel nostro DNA biologico e spirituale.
Silenzio/tenda – luogo dell’incontro e presenza.
Incontro con l’altro da sé e presenza di entrambi in uno stare che è stare in presenza ognuno della presenza dell’altro e dell’essenza in essa incarnata.
Recinto sacro ritagliato nello spazio del quotidiano affanno. Luogo dell’incontro in cui la parola poetica, dopo aver attraversato la presenza fondante del silenzio, si fa testimonianza - testimonia il suo stesso essere presenza che nel dirsi si offre, si dà a nuove nascite.
Tenda in cui trovare riparo per esporsi a e sopra ciò che è margine e marginale eppure è radice del farsi tenda del corpo poetico della parola.Il Verbo divenne carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. Così la parola poetica si fa carne a immagine e somiglianza. Ma c’è dell’altro. Per i latini la tenda da campo è il papilio perché spiegata e tesa assomiglia a una farfalla. E da papilio si giunge a padiglione parte esterna dell’orecchio dove confluiscono suoni e rumori, voci e parole.
Dove ha principio l’ascolto.
Così il silenzio è anche
35
Il silenzio è campo.
Il silenzio è il terreno in cui si pianta la tenda – doppia dimora, dunque doppia esposizione: all’aperto, al fuori dalla tenda e al chiuso, al dentro la tenda. Là dove il fuori ha un suo essere all’interno in una chiusa esteriorità e il dentro ha un suo essere fuori in una aperta interiorità dove si crea lo spazio per la libertà.
Silenzio/campo – luogo dell’attesa e della cura.
Nel silenzio si attende in una attesa che è già cura. Ci si prende cura di sé per aver cura dell’altro, perché cura è responsabilità:
Dov’è tuo fratello?
ma prima
Dove sei?
Se so dove sono, so dov’è mio fratello e mio fratello sa dov’è. Un sapere mai completamente raggiunto, un sapere sempre in cammino. Un sapere del sangue e delle viscere. Un sapere dell’amore che sa sempre quali strade percorrere. In quella libertà che non finisce dove inizia quella dell’altro, ma la prende per mano. Si prendono per mano.
Nel silenzio con un esercizio interiore ci si predispone all’attesa, si rivolge l’animo a qualcosa o a qualcuno ci si distoglie da sé e attraverso la lontananza da noi stessi si attua lo spazio per la cura, per l’accudire – un domestico rimettere a posto. Fare ordine.
Acc-udire – accorrere ascoltando. Attendere è ascoltare attentamente, fare bene, impegnarsi in qualcosa, impegnarsi con qualcuno.
Aspettare: ex - spectare – guardare fuori di sé, guardare attentamente. Senza cupidigia. Guardare per ri-conoscere l’altro, per ri-conoscersi nell’altro e per fare in modo che l’altro, accolto, si ri-conosca.
Ma il silenzio è anche il campo, mai neutro né neutrale, di terra e di carne in cui si svolge la battaglia tra il poeta e la parola poetica spesso renitente, spesso al limite del dicibile.
***
Il testo di Lucianna Argentino mi riporta al mondo di un’amata autrice, Chandra Livia Candiani, che nel suo recente Il silenzio è cosa viva racconta come il meditare, in silenzio, sia un perfetto stare dentro se stessi, abitando lo spazio del vuoto, ascoltandosi consapevolmente.
Dal silenzio si impara appunto ad ascoltare la vibrazione, il respiro, a sintonizzarsi con la propria voce interna, ricettacolo della nominazione, eco dei giorni.
Del testo di Lucianna Argentino mi piace sottolineare l’equazione tra parola poetica e silenzio. Il suo mutare di stato e di sostanza (del silenzio e della parola poetica) verso un potenziale d’azione del dire.
Lucianna Argentino è nata e vive a Roma. Dai primi anni novanta il suo amore per la poesia l’ha portata a occuparsene attivamente come organizzatrice di rassegne, di presentazioni di libri e con collaborazioni a diverse riviste del settore. Sue poesie sono presenti in molte antologie tra le quali “Poesia’ 90″ (Il Ventaglio), “Incontro di poesia” (Rebellato, 1992), “Poesia degli anni novanta” (Poiesis), “Poeti senza cielo, vol. 2°” (Il Melograno) “Poeti e poetiche n. 2” a cura di Gianmario Lucini, “Fil Rouge antologia sulle mestruazioni” a cura di Loredana Magazzeni e Antonella Barina e in riviste tra le quali Poiesis”, “Origini”, “Gradiva”, “La Mosca”, “Italian Poetry Review”, “Il Monte Analogo”, “The world poets quarterly”, “L'ustione della poesia” (ed. Lietocolle 2010), “La Clessidra”, “NoiDonne”, “Capoverso”, “Il Fiacre n.9”, “Arenaria”. “Punto- Almanacco della poesia italiana n. 3- 2013”, È presente in diversi blog di poesia, come “Lapoesiaelospirito”, “Imperfetta Ellisse”, “liberinversi”, “Isola Nera”, “Furioso Bene”, “Blanc de ta nuque” “Amigos de la urraka”, “La dimora del tempo sospeso”, “Nazione Indiana”, “Le vie “poetiche”, “Rai News24”, “Moltinpoesia”. Ha fatto parte della redazione del blog letterario collettivo “Viadellebelledonne”. Ha partecipato a diversi Festival tra cui “Ottobre in Poesia” (2007) di Sassari; al Festival Caffeina di Viterbo nel 2011 e nel 2017; al “Festivart della Follia” a Torino (2015); al Festival “La Rocca dei Poeti” nel borgo medioevale di Ostia (2015, 2016, 2017) e nel Tempio di Santa Croce a Tuscania (2018); allo “Stabia Teatro Festival di Castellammare di Stabia (2016); a “Ritratti di Poesia” di Roma (2017); al Festival della poesia nella cortesia a San Giorgio del Sannio (2017); al Festival “La luna e i calanchi” di Aliano (2017); al Festival “Notturni di Versi” di Portogruaro (2018). È coautrice con Vincenzo Morra del libro “Alessio Niceforo, il poeta della bontà” (Viemme, 1990). Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: “Gli argini del tempo” (ed. Totem, 1991) con la prefazione di Gianfranco Cotronei; “Biografia a margine” (Fermenti Editrice, 1994) con la prefazione di Dario Bellezza e disegni di Francesco Paolo Delle Noci; “Mutamento” ((Fermenti Editrice,1999) con la prefazione di Mariella Bettarini; “Verso Penuel” (edizioni dell’Oleandro 2003) con la prefazione di Dante Maffia; “Diario inverso” (Manni editori, 2006), con la prefazione di Marco Guzzi; “L'ospite indocile” (Passigli, 2012) con una nota di Anna Maria Farabbi; il poemetto “Abele” (Ed. Progetto Cultura, Le gemme 2015) con la prefazione di Alessandro Zaccuri di cui alcuni brani sono andati in onda, nel giugno del 2017, su Radio Vaticana nella rubrica “Pagine Fogli Parole” a cura di Laura De Luca nell’interpretazione di Pino Censi; “Le stanze inquiete” (Edizioni La Vita Felice, 2016); “L’ombra dell’attesa” (Macabor Editore, 2018) con la prefazione di Elio Grasso, ristampa revisionata del libro “Verso Penuel” del 2003. Nel 2009 ha pubblicato la plaquette “Favola” (Lietocolle), con acquerelli di Marco Sebastiani. Il suo lavoro inedito “La vita in dissolvenza” (quattro monologhi al femminile) sono stati musicati dal chitarrista Stefano Oliva e presentati in vari teatri, associazioni culturali e Festival. Dal 2014 collabora con le Acquelibere Ensemble con lo spettacolo “Almanacco indocile”. Il 9 settembre del 2018 su Radio Vaticana è andata in onda la sua intervista impossibile ad Abele, interpretato ancora da Pino Censi, nella trasmissione “Domande impossibili” curata da Laura De Luca. Il 27 dicembre 2018 è stata ospite di Radio Radio nella trasmissione “Un giorno speciale” di Francesco Vergovich nella rubrica “Affari di libri” curata da Maria Gloria Fontana.
Paolo Artale, videolettura; dalla raccolta inedita "Conversazioni in giardino", nota di Laura Caccia
La cura del dire
Con chi dialoga Paolo Artale nelle sue conversazioni in giardino?
Dove parole e gesti, nel contesto di una natura prossima, sono disseminati attraverso molteplici, differenti cure. Delineando confini e delimitazioni e nel contempo spalancando passaggi e dilatazioni, ponendo rimedi all’incompletezza e insieme proponendo inedite soluzioni, cercando di volgere attenzione alla “paziente / ricostruzione del cielo”, così come alla devota edificazione di “punti di rugiada”.
È chiaro come, per l’autore, la natura rispecchi elementi di separazione e di distacco, nei suoi “aspetti di confine. / a esilio”, e nello stesso tempo consenta un’immersione totale in essa. E come, ancora, riesca a garantire “un impreciso numero di felicità”
Anche la parola viene coinvolta nell’azione naturale di ricomposizione e di creazione di nuove soluzioni, inediti disegni. E la natura, nei suoi “colloqui vegetali”, appare l’oggetto e insieme l’interlocutore privilegiato delle conversazioni, tanto da far supporre che proprio da essa venga raccolta un’eredità di cura e di parola.
Così, nella necessità etica di un pensiero rivolto alla ricomposizione, come nell’esigenza estetica tesa alla creazione, in questi testi di Paolo Artale sono soprattutto gli elementi della natura a sostenere la cura del dire, a proporre “soluzioni diverse come calchi di gioia”.
Da: conversazioni
-strada per Tovi-
per lato a confine di giardini o
qualcosa lasciato in dono:
costruire punti di rugiada.
questa estate è la prossima esitazione.
ma soprattutto i soffioni aperti.
profaniamo il bosco da ogni parte.
spesso i fiori sanno ripetersi
per imitazione. durante la notte.
***
deve cambiare questa aria in clausole
di piuma. vestigia
rimangono di intenti a fogliame.
propagate per semina si oppongono.
bacche.
un impreciso numero di felicità.
Da: acque di riposo. di composizione
***
osservando gli occhi delle altre, dice
è sbocciato quasi nulla tra le forme
private del caprifoglio.
un posto dove si aprono in un modo diverso.
dimenticano il dominio.
altra cosa è le proprietà del gelo.
la luce riflessa dal dorso degli insetti
il controllo delle- posizioni lontane
dove si trovano le cose cadute.
mentendo sulla bellezza feriale
sulla composizione del giardino
e delle terre sigillate.
i suoi orli nella finitura delle lampade
è come ammirare questa residenza
in una-altra estate fredda
***
sostituendo i pensieri delle altre, dice
e poi ripenso alle cuciture del bosco
il tentativo di educare la luce negli inneschi
o capsule- ugualmente
gli apici sono solo una parte della notte.
per poi diligere il contenuto del buio.
Paolo Artale, nato a Busto Arsizio nel 1966, vive a Cantello (VA). Ha fatto parte di diversi gruppi poetici e ha partecipato a numerose letture pubbliche. Suoi testi sono apparsi, tra l’altro, su “L’Ulisse”, rivista on-line per la quale ha intervistato Antonella Anedda; sulle riviste “Resine”, “Atelier”, “La clessidra”; su “poeticodiario”, Lietocollelibri; su “Le vie della letteratura”, puntoacapo Editrice; su “almanacco punto”, sito on-line della puntoacapo editrice.
Dal 2010 al 2012 ha tenuto, in co-conduzione, un laboratorio di poesia per conto di un’associazione culturale. Dal 2002 al 2005 è tra gli autori di “invisibile voce” poesia a teatro contro la guerra.
Da diversi anni, sta approfondendo la conoscenza della letteratura dell’ottocento, soprattutto italiana e francese e della letteratura americana e inglese del novecento.
Dal 2015 collabora con “puntoacapo Editrice” di Alessandria. Ha pubblicato: ”La stagione sconosciuta”- Centro Stampa (1998); “L’abbandono” – EOS Editrice (1999) prefazione di Marco Merlin; “Una specie di quiete”- Dialogolibri Editore (2008); “Gli incanti” -Book Editore; “i meli”-puntoacapo Editrice (2014), prefazione di Valeria Serofilli.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti sia per l’edito che per l’inedito, tra i quali: la silloge “i meli” ha ottenuto la “menzione” alla XXVII edizione del premio “Lorenzo Montano”, sezione inediti; un testo tratto dalla raccolta inedita “conversazioni in giardino” ha ottenuto la “menzione” al XXIX premio “Lorenzo Montano”.
Hanno scritto di lui e della sua poesia: Angelo Lorenzo Crespi, Lorenzo Scandroglio, Giorgio Romussi, Fabio Simonelli, Marco Merlin, Giuliano Ladolfi, Manrico Zoli, Jacopo Marchisio, Valeria Serofilli, Emanuele Andrea Spano, Tito Cauchi, Raffaele Piazza
Doris Emilia Bragagnini, audiolettura animata; da "Claustrofonia", Ladolfi Editore 2018, nota di Giorgio Bonacini
Con una scrittura densa e avvolgente – per concretezza visiva e sonora – l’autrice ci presenta un libro dove la parola è sganciata da ogni senso di realtà ordinaria e referenziale, per creare essa stessa il vero reale: quello di una poesia che ha, nel suo proprio e unico dire, la composizione di un mondo. Dunque non un’ispirazione a sé predestinata, ma “un movimento sotterraneo” in cui anche il vuoto che comincia a prendere mente e a farsi pensiero. E’ suono interiore che si rende visibile per farsi scavo verso il paradosso di un silenzio che parla sospendendo il senso. Perché la poesia è parola sempre nuova, che, da un passato sconosciuto, si riaccende oltre il significato, alla ricerca del senso che non trova. E’ così, come scrive l’autrice, che l’implosione di poeticità diventa un sentire necessario, che espone il poeta come “illusione ottica e sonora/.../ senza solco peso dimora”, lasciando spazio all’unico vero “io”: l’io poetico. Quello che solo è capace, non tanto di estrarre le parole che non sappiamo, ma anche di mantenerle sconosciute, perché possano, nel loro cammino nascosto, uscire improvvise in un’inedita visione: quella che ci fa veramente sentire che “di fantasmagoria si può vivere”.
Dalla sezione sfarfalii – armati – sottoluce
Claustrofonia
il muro tace, non risponde più
si lascia guardare angolandosi
in riproduzioni lessicali nei passi
o sfarfallii – armati – sottoluce
ogni tanto un urto di temperatura
differente, a porte chiuse] tolte le dita
da maniglie ingoiate a sorsi uscite laterali
agglomerate al bolo circolante, contropelle
la risalita dei ricordi sfida il cemento
dell’anima in guardiola, divelta e sugosa,
chiaroscuro del Merisi
stretto chicco d’uva fragola come fosse un uragano
moltiplicato a schizzi su pareti in guanti bianchi
divaricate a terra ora
“...tu aprimi al tuo fiato singultato, viola di Tchaikovsky
Dalla sezione giunchiglie trapassate
Ricreazione
Evito parole così a me uguali da risultarmi ovvia
non cercherò la trama – quella sottile – mai
scomparsa attesa di dire le cose
fatalità scorrevoli come gabbie aguzze
un pennino spuntato che non sa più curvare
la chiamavano Boccadirosa invece
un baco piovuto dall’alto sgranato sul filo
l’impronta sul colletto mille zampe conficcate
nei pensieri dalla bocca aperta io stormisco
di gelso nella luce verde con le foglie
Dalla sezione nonnulla da tenere
*
a volte penso a quelle scale compassate e smunte
ala passamano steso sopra una brughiera in ferro
spazzata da riccioli gaglioffi come un vento
*
mendico di me le pause tra i pensieri fatti a imbuto
sulla pioggia dei nonnulla da tenere per domani
domai saprò vederli sentirli nominarsi
e si sapranno dire, in questo inesauribile fragore.
Doris Emilia Bragagnini è nata in provincia di Udine dove tuttora risiede. Suoi testi sono presenti in alcuni periodici online e cartacei tra cui Carte nel Vento a cura di Ranieri Teti, EspressoSud a cura di Augusto Benemeglio, Noidonne a cura di Fausta Genziana, in varie antologie (tra cui Il Giardino dei Poeti ed. Historica e Fragmenta premio Ulteriora Mirari ed. Smasher), in blog e siti letterari come Neobar e Il Giardino Dei Poeti (collabora in entrambi come redattrice), Carte Sensibili, Via Delle Belle Donne, La Poesia e lo Spirito, La Dimora del Tempo Sospeso, Poetarum Silva, WSF, Linea Carsica.
Ha partecipato ai poemetti collettivi La Versione di Giuseppe. Poeti per don Tonino Bello e Un sandalo per Rut (ed. Accademia di Terra d’Otranto, Neobar 2011). Il suo libro d’esordio è OLTREVERSO il latte sulla porta (ed. Zona 2012).
Fernando Della Posta, videolettura; dalla raccolta inedita "Sole raso", nota di Laura Caccia
Per gli invisibili
Non la luce a picco sulle cose, che ne prevarica le ombre, piuttosto la luminosità bassa che le incipria e si insinua tra gli anfratti, portandone a vista gli aspetti più intimi e nascosti. Così illumina il sommerso la parola di Fernando Della Posta in Luce rasa.
Parola che, simile al sole radente tra le gole, “come lo sguardo di un amante”, si distende sulle cronache degli invisibili, sui gesti minimi, sulla forza di ribaltare stagnazioni e ripari. Muovendosi tra l’affettivo e il sociale, l’esistenziale e l’etico, il letterario e il naturale nei diversi testi spesso non titolati, lasciati esposti.
Dove, nello snodarsi delle storie dei vinti, trovano parola personaggi accomunati dal ruolo di “attore di seconda fila” o di comparsa. E dove il dire trae forza nell’opporsi a chi scarta “come fosse superflua / ogni visone ulteriore” e nel cercare, rispetto a tutto il difficile dell’esistere, di “farne salto / che precipita in nuova luce”.
E cos’è la poesia? Non è forse luce rasa che sceglie di non violentare le cose, ma di toccare, con voce d’amante, le più intime oscurità, così come i lati più mutilati del vivere? “Più che la bontà può la letteratura”, dichiara Fernando Della Posta, in grado, di fronte a oltraggi e consunzioni, di accarezzare le cose e i viventi, illuminare ogni solitudine, dare chiarore agli inciampi, consentire ogni volta di rimetterci al mondo.
(Questa raccolta è stata pubblicata nel 2020 da Giuliano Ladolfi Editore con il titolo "Sembianze della luce").
***
Non è facile, non è facile catturare una luce
nel temporale portato dal vento, mentre
la noia pasquale imperversa, e una parvenza
di perdita ci assale, una caduta al ribasso
tra le lente ore che passano, incespicando
in un buco, una gora, una traccia, una fiumara
che s’ingrossa dietro i vetri che si riempiono
di timide gocce di cielo ricacciate nel nulla
dal lesto sole. Altri maestrali si porteranno via
questi già vecchi e fragili puntini di mimosa.
***
Ci si può vestire
di versi di pelle sintetica,
farne cappotti da stendere
sui nostri anni irrisolti,
come a coprire cadaveri
il cui odore non si scioglie
nemmeno rivoltando le zolle
di una pagina bianca.
Ma si può farne salto
che precipita in nuova luce.
***
Dite a quelli
che cavalcano sicuri in superficie
che sotto di loro
c’è sempre stato
tutto un mondo sommerso
e che soprattutto il tempo
sostituisce fatti e testimoni oculari.
Odiarvi, odiarvi
quando a pancia piena
scartate come fosse superflua
ogni visione ulteriore.
***
Chi arriva prima sbiadisce lentamente.
Nonostante ciò l’usignolo di Keats
non avrà mai il becco scheggiato.
Luce naturale
Sono l’attore di seconda fila
la comparsa che riempie il paesaggio
la chioma dell’albero che sta nel contorno
la mia storia non ha importanza.
Spesso faccio flessioni sul tetto di un grattacielo
e guardo un mare sconfinato.
Spesso ravviso il tuo seno
nei chicchi di melagrana.
***
Più che la bontà può la letteratura.
Ogni sentiero deve segnare un passo,
ognuno deve raccontare una storia.
Fernando Della Posta. Nato nel 1984 a Pontecorvo in provincia di Frosinone, è laureato in Scienze Statistiche, vive a Roma e lavora nel settore informatico. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti in poesia nel 2011 è arrivato tra i finalisti al concorso di poesia “Ulteriora Mirari” nella sezione silloge poetica inedita; nel 2015 è risultato tra i finalisti del concorso letterario "Sistemi d'Attrazione", legato al festival "Bologna in lettere 2015", nella sezione dedicata a Pier Paolo Pasolini; nel 2016 vince il concorso “Stratificazioni: Arte-fatti Contemporanei” legato al festival letterario di Bologna in Lettere 2016 nella sezione B poesia inedita a tema libero e ottiene una menzione al XXX premio Montano per la silloge inedita. Nel 2017 vince il Premio Nazionale Poetika nella sezione silloge inedita. Nel 2018 si classifica secondo nella sezione inediti di poesia al Premio “Andrea Torresano”, ottiene una segnalazione al premio Lorenzo Montano per la silloge inedita e vince il Premio Letterario Zeno nella sezione poesia. Numerose sono le sue recensioni e le sue sillogi reperibili su diversi blog letterari come Neobar, di cui è redattore, Words Social Forum, Viadellebelledonne, Poetarum Silva e Il Giardino dei Poeti. Nel 2011 ha pubblicato la raccolta di poesie “L’anno, la notte, il viaggio” per Edizioni Progetto Cultura e, sempre in poesia, nel 2015 "Gli aloni del vapore d'Inverno" per Divinafollia Edizioni, nel 2017 “Cronache dall’Armistizio” per Onirica Edizioni, nel 2018 “Voltacielo” per Oèdipus Edizioni e “Gli anelli di Saturno” per Ensemble Edizioni, nel 2020 "Sembianze della luce" per Ladolfi Editore.
Bruno Di Pietro, videolettura; da "Impero", Oèdipus 2017, nota di Rosa Pierno
Bruno Di Pietro attua un confronto tra Impero Romano e società contemporanea al fine di trarne alcune considerazioni che dovrebbero aiutarci nella costruzione dell’Europa. La silloge - pur tessuta con l’intervento di diverse personae, imperatori, cittadini, militari, in cui ciascun individuo è visto sul fondale contraddittorio e contraddicente degli eventi storici - evidenzia anche il piano relativo al potere: esso è una fiera dalle cento teste, rispetto al quale le forme istituzionali non sono che strumenti di gestione ineludibili, necessari e tuttavia non sufficienti. Il potere è qualcosa che si rafforza anche col linguaggio e il poeta appunta la sua ricerca sulle formule linguistiche con le quali esso si descrive. Con una profusione di versi liberi, di endecasillabi, e settenari e ottonari affiancati a due a due, Di Pietro costruisce le sue arringhe, i suoi discorsi, le sue memorie, espressi da personaggi coinvolti a vario titolo nel progetto dell’Impero. E, ancora, a versi di misura tradizionale affida il commento ironico, il quale denuncia comunque la vacuità dell’avvicinamento tra ideale e realtà. Vedere in anticipo la sciagura non aiuta a evitarla. Ecco l’amara verità che Di Pietro non lesina di consegnarci e, per questo, la vena malinconica a volte emerge, assieme a quella, ma non assume mai il valore di un’assunzione pessimistica: nel computo della storia il negativo trova una sponda proprio grazie alla spinta propulsiva offerta dall’ideale.
XXVIII. Nerva
Fin quando la forza non prevarrà sul diritto
sarà solo il Senato a farsi inquisitore
di un senatore accusato di lesa maestà.
Io Nerva questa vorrei fosse norma perenne
per moderare forza e tirannia
( per quanto oggi la maestà sia mia).
La modestia si accompagna alla autorità del Senato
ora che il principato sembra essere un’idea del passato.
Vespasiano aveva ragione:
quale filiazione, quale adozione, quale legione
l’Impero necessita di una Costituzione.
XLIV. “L’Impero deve diventare adulto”
L’Impero deve diventare adulto:
è un insulto all’intelligenza (e alle casse dello Stato)
la guerra di aggressione e di conquista
di inutili e indifendibili territori.
C’è troppa resistenza fra i senatori
che con la guerra ci fanno affari:
cambierà la tendenza solo una sana immissione
di uomini delle province nel Senato:
questa infantile ideologia del confine
resterà infine un’idea del passato.
Così il Vallo resterà il confine permanente
fra la Britannia e il resto del continente.
Bruno Di Pietro (1954) vive e lavora a Napoli esercitando la professione forense. Ha pubblicato diverse raccolte poetiche: “Colpa del mare” (Oédipus, Salerno-Milano 2002), “[SMS] e una quartina scostumata” (d’If,Napoli 2002)“Futuri lillà” (d’If, Napoli,2003)“Acque/dotti. Frammenti di Massimiano” (Bibliopolis,Napoli 2007) “Della stessa sostanza del figlio” (Evaluna,Napoli 2008) “Il fiore del Danubio” (Evaluna,Napoli 2010)“Il merlo maschio” (I libri del merlo, Saviano 2011) “minuscole” (IL LABORATORIO/Le edizioni, Nola 2016) “Impero” (Oèdipus,Salerno-Milano, 2017) “Undici distici per undici ritratti” (Levania Rivista di Poesia n° 6/2017).”Colpa del mare e altri poemetti” (Oèdipus ,Salerno Milano 2018); “Baie” (Oèdipus ,Salerno-Milano 20199. È presente in diverse antologie fra cui: “Mundus. Poesia per un’etica del rifiuto” (Valtrend, Napoli 2008) Accenti (Soc. Dante Alighieri, Napoli 2010) Alter ego. Poeti al MANN (Arte’m, Napoli 2012). Errico Ruotolo, Opere (1961-2007) (Fondazione Morra, Napoli,2012) Polesìa (Trivio 2018, Oèdipus Edizioni).
Articoli e interventi sulle sue opere sono presenti in diverse riviste e blog (Nazione Indiana, Infiniti Mondi, ClanDestino, Trasversale, Versante Ripido, Frequenze Poetiche, Atelier, Levania, Trivio, InVerso, Menabò)
Ettore Fobo, videolettura; prosa inedita “Di silenzi, deserti, addii e altri enigmi”, nota di Mara Cini
Di silenzi, deserti, addii e altre cose
I
Quando il silenzio ingigantisce meteore di metafore e la languida ebrezza non può sfumare in circonferenza di abbracci, nella scrittura del tramonto si nasconde il tormento, evento circoscritto alle esperienze di fumo di un Perelà dissociato: confrontarsi con il proprio vuoto umano è assai dura fatica ma non deve vincere il deserto senza sfumatura d’espressione.
Come dire il mistero di questa esplorazione senza testimoni? Sforzo di udire il mormorio distante della galassia. Sguardi in apnea nell’oceano del non visibile. Parola murata viva nel suo svanente profumo di abisso. Orchidea nel buio, suppliziata intelligenza senza uditorio, io cerco un’illuminazione al principio dell’altrove. Là, dove abitano le ombre che furono i nostri primitivi sguardi.
Sorge dalla terra questa misteriosa mistica, che la stregoneria amplifica fino a farne la rosa pregiata nel giardino dei re. Udire la notte gravida di segreti, nel mutismo dei monumenti illuminati dalla luna o parlare sotto vento all’indolenza delle nuvole, che sperano ancora nella pioggia.
Quale musica allontana da me il maleficio del pensiero? M’interroga l’incendio e la marea azzurra delle domande senza risposta. Suvvia, questi cerchi nell’acqua sono da decifrare come la nudità dell’arcobaleno.
Unire a questa consapevolezza un oceano di bellezza da auscultare come un medico, nella sua agonia storica. Quale musica riunisce la croce e la rosa? Di quanti brividi è fatta la beatitudine sconosciuta? Quale ombra in agguato dietro il pensiero è pronta a balzare? Quale bestia si duole della perdita di sguardo all’acme del sogno? Con quali occhi non infetti visitiamo il crepuscolo?
Queste interrogazioni muovono il silenzio e lo costringono a specchiarsi nella parola, quest’acqua muta sotto la terra del segno. Disorienta questa ribalta senza pubblico, scrivendo l’onda di un encefalogramma in sussultante ritmo, sollevando obiezioni conto la regola del tacere oppure… Osservare senza catastrofe la venuta al mondo di una musica abissale come il silenzio dell’assoluto, per sapere infine che lo squarcio che attrae il pensiero è lo stesso che gli dà luce. Il deserto e il giardino qui trovano il loro incontro e nessuno conosce la formula esatta della fusione.
II
Così, vita, mi racconti l’infinita tristezza dell’addio, anche se la scrittura è ciò che ci dissuade dal piangere per celebrare la fluttuante bellezza del divenire. Oh cieli di madreperla delle antiche poesie, dove vi siete nascosti, nel fondo di quale lacrima nuotate? Non ci resta che educare il tuono a farsi sinfonia, trasformare il rumore della pioggia in una partitura jazz, adorare il vento che fa respirare le maree, tornare dunque pagani, sull’orlo della catastrofe terrestre, per vedere un tempio di Iside sulla luna o nell’acqua di un fiume la guizzante silhouette di una ninfa duellare con una bottiglia di plastica là gettata.
Sondiamo il precipizio della scrittura per estrarvi l’essenza di tutto il precipitare umano, il cui canto ci lascia esterrefatti come l’improvviso bagliore di una lucciola in un parco la sera. Eccoci, dimentichi del nostro volto, inabissati nell’anonimato della folla sciamante, nell’immensa città, di nuovo riconnessi con la dimensione dello sgorgare pianto, là dove cresce il riso indifferente della gente. Fiume di una parola che traduce l’essere in un riflesso del tacere ambiguo delle montagne tutt’intorno e da questo tacere noi estraiamo il ricordo di una risata infantile che disegnò nell’aria la storia delle nostre angosce future.
Perché tutto è intrecciato e se parlo groviglio è perché la vita nel suo erompere è caotica e sfuggente e se la morte è impensabile, questo impensabile accompagna come ombra ogni pensiero.
Siamo inseparabili dall’abisso, generati in una notte di follia da un dio che è una cicatrice e da una dea che è una striatura rossa su una pietra. Figli di un’antichità tramata d’impossibile, dove una notte cieca guida poeti notturni a fondersi con il verso del gufo o della civetta. L’essere è incapsulato nel nulla ed è assai dura fatica togliere la millenaria patina di silenzio da ogni parola umana.
Così, vita, mi racconti che ogni addio è infinito e su questa corda tesa danzano come lacrime le ore di gioia passate con la persona con cui condividemmo un’unione, o con l’animale che leccò dalla nostra mano il peso dell’angoscia.
Non c’è addio in fondo, perché se tutto è addio, il vuoto è il precipitato cosmico cui fare affidamento per descrivere l’esperienza da carcerato dell’essere umano, serrato fra nulla e nulla.
Così l’abbaiare di un cane morente, che molto si è amato, ci penetra nell’anima come il soffio della caducità che tutti ci accomuna nello stesso gorgo. La scossa delle lacrime diventa dunque simbolo di un dolore universale e ci invita a vedere nell’acqua dell’oblio naufragare la nostra faccia, tutte le facce, la siepe, l’infinito, Dio. Solo rimangono, smisurati, i silenzi stellari che nessuna lacrima può scalfire e dove nessun grido riecheggia, nessun pianto.
***
Si presenta qui il tema della decifrazione. Ma come decifrare tutte le vibrazioni dell’atmosfera, del corpo, del pensiero stesso mai del tutto silenzioso che, il silenzio, genera domande?
Simboli da decifrare di una partitura scritta e taciuta, groviglio di suoni e di soffi verso un Là dove abitano le ombre che furono i nostri primitivi sguardi.
Ettore Fobo (pseudonimo di Eugenio Cavacciuti) è nato a Milano nel 1976. Ha pubblicato tre libri di poesia con Kipple Officina Libraria: “La Maya dei notturni” (2006), “Sotto una luna in polvere” (2010), “Diario di Casoli” (2015) e un audiolibro “Poesie allo stato brado” (2020). Con la casa editrice Montedit pubblica la silloge “Canti d’Amnios” (2020)
Sue poesie sono apparse in diverse antologie, fra le quali la raccolta connettivista “SuperNeXT” (Kipple Officina Libraria, 2011). Dal 2008 gestisce un blog di letteratura “Strani giorni” (www.ettorefobo.it). Collabora con la rivista multilingue “Orizont literar contemporan”, con il portale di critica letteraria e dello spettacolo “Lankenauta” e con il blog collettivo “Bibbia d’Asfalto”.
Una sua silloge, “Musiche per l’oblio”, è stata tradotta in romeno, francese, inglese e spagnolo.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti a concorsi letterari, fra i quali: vincitore ai Premi “Le Occasioni (2018), “I Colori dell’Anima” (2018), “Il Sublime - Golfo dei poeti” (2018), “Besio 1860” (2019), segnalato al Premio “Lorenzo Montano” (2017, 2018 e 2019), Premio Speciale della Giuria a “Ossi di seppia” (2019). “Musiche per l’oblio” è stato fra i libri selezionati per il “Premio Gradiva” (2019). Il 15 febbraio del 2020 fonda il Movimento del Mitorealismo di cui scrive il primo dei manifesti.
Miro Gabriele, videolettura; poesia inedita "Forse", nota di Ranieri Teti
In quel rassegnato profilo sul divano
antica gioia forse ti sorprende
il mattino eterno di un giardino
l’ineffabile presenza degli alberi nel cielo
quasi una spina alle tue spalle
e il levitare silenzioso della notte
rimbalza come un mare fra le case
la sua luce vuota ancora mi raggiunge
oltre il sussurro della memoria.
***
La mano leggera del poeta traccia segni perenni. Ascolta i silenzi. Ascolta il battito che senza sosta attraversa le cose, pulsa nelle profondità del sentire. L’osservazione che si interiorizza qui produce un effetto straniante: può un albero diventare una spina? Un mare, proprio un mare e non una laguna, in quale altro luogo potrebbe essere collocato tra le case, se non in una poesia?
Nel testo c’è qualcosa che non si ferma e sempre agisce nel pensiero, diventa portatore di senso. Leggere ci trasporta a guardare il dipinto di un interno: forse Hopper, quando nei quadri inserisce finestre. Nel testo di Miro Gabriele la fisicità non è statica, si coglie un continuo lieve movimento che costantemente attraversa “Forse”: forse gli alberi sono mossi dal vento, si percepiscono le fasi del giorno dal mattino alla notte, è presente l’immanenza mobile delle sfere colte fino al levitare montante dell’oscurità, che qui diventa “luce vuota”.
Miro Gabriele vive a Roma. Ha pubblicato per l’editrice Ianua, Edizione del Giano Roma 1988, Odi et amo, una traduzione di poesie di Catullo, con prefazione di Luca Canali. Presso lo stesso editore nel 1992 ha pubblicato Il Gaio Verso, antologia di poeti latini.
È stato inserito da Luca Canali nella raccolta I poeti della ginestra, Lalli editore 1989. Assieme a Maria Luisa Spaziani ha partecipato al primo Reading di poesia contemporanea tenutosi ad Agnone nel maggio 1991, da cui è stato tratto il volume Ad alta voce, editore Enne 1992.
Ha vinto il premio Montale per la poesia 1992, e compare nell’antologia Scheiwiller Sette poeti del premio Montale, Milano 1993. Compare anche in Vent’anni di poesia Passigli Editori 2002.
Ha pubblicato il romanzo La vita incerta Valter Casini editore 2004. Ha pubblicato inoltre, con Anna Maria Giannetto, Navigare - Versioni e temi di lingua e cultura latina, Zanichelli 2006, testo di latino per i licei.
Nel 2014 è uscito Le Città Antiche ed altre poesie Ginevra Bentivoglio Editoria, con prefazione di Alessandro Fo.
È presente nell’antologia “Poesia luce del mondo” a cura di Francesca Farina, Bertoni editore, pubblicata in occasione della Giornata mondiale della poesia 2019. Il suo ultimo libro, Dentro lo sguardo, è stato pubblicato da Ensemble nel 2020.
Michela Gorini, videolettura; da "La produzione di amore", Dot.com Press 2019, nota di Giorgio Bonacini
In questo canto d’amore, disorientante ma totale, Michela Gorini, mette in scena il frantumarsi del senso e dei sensi, di cui solo la scrittura poetica – nelle sue indefinite e sorgive diramazioni intime – può dire qualcosa: cercando, tra difficoltà e tremori, un’ardua ricomposizione. L’autrice divide l’opera in quattro parti. La prima apre alla richiesta di un senso che il corpo, altro da sé, può solo significare in dissolvenza e silenzio, che “si nutrono in briciole”. Nella seconda lo scenario guarda la voce allontanarsi verso una perdita che si riaccende nella solitudine di un amore a due:ma, precisando,“io tu/e non scriverci noi”. E in questo è centrale il dire poesia con la lingua che non c’è. Così nella terza la parola mancante, quando arriva, è da lontano, anche incompresa, ma illumina. Perché è lingua madre e madre di lingua in ciò che rinasce. Nella quarta il dualismo amare/amarsi conosce la non-possibilità del “verso intatto”;perché lì dove i segni non arrivano, “la produzione di amore” rischia di perdersi. Ma, paradossalmente, nell’ambivalenza del titolo la vediamo arricchirsi. Quanto e quale lavorio occorre ai viventi per toccare o anche solo sfiorare l’atto d’amore? E cosa nasce nei luoghi metamorfici di amore in sé; quale condizione generatrice di sensi? Un libro, allora, da leggere tutto col fiato e nel piacere dell’affanno.
Dalla prima parte
poesia sola generosa desiderata
perdona ogni istante
me respiro fino al nucleo
patente
riciclo la sua eco
mi concede il tempo di
serbarla espirarla fino a potersi
non digerire
di traverso passa fende le membra
patisce l’anima geme e urla
tutto il mio silenzio impossibile
scuote ogni paura di crudo
ripensamento
non credo ai giullari – e per essenza
non vedo chi ho davanti
[il mio silenzio impossibile]
Dalla seconda parte
si tratta
di due solitudini
del tuo
battito incoerente
del tuo
crederti acceso e diretto
del tuo
muoverti
fermo
restando
crepe del tuo sguardo
prenderesti
les plus desert liex
[si tratta di due]
Dalla quarta parte
[ma tu] non cerchi il mio corpo
cerchi un corpo – un’ombra pieghevole
non mi celebri l’anima, pronto a separarne
un pezzo – all’occorrenza reputarla tediosa
non sogno una congiunzione di artifizi
[ma tu] non ami ciò che parlo d’essere
preferisci tagliare d’istinto la mia trasparenza
e disperderti in quell’aria circostante dove
giochi il tuo tempo in
sequenze ripetute
[ma tu]
Michela Gorini è nata a Pesaro nel 1971, dove vive e svolge libera professione come psicoanalista. Si è formata a Roma e specializzata secondo l’orientamento psicoanalitico di Jacques Lacan. Da sempre interessata alle tematiche del femminile, ha tenuto diversi incontri pubblici, in particolare: la presentazione del documentario di Elisabetta Francia Parla con lui: la voce maschile all’interno della coppia.
Varie conferenze tra cui L’amore imperfetto; La donna, inventarsi per essere. Nel 2017 ha partecipato all’ultima edizione de L’angolo della poesia. Questa è la sua opera prima.
Iria Gorran, videolettura; poesia inedita "Verona rupes", nota di Ranieri Teti e presentazione dell’Autrice
Verona rupes
è questa la notte?
la notte in piedi che decide
la notte bianca dei conigli
ultravioletto violento tra
magnetismo gravità
bande spettrali sequenze intermittenti
frequenze asperse
elongazioni
orientali benedizioni
fotometrie di qui a la stella quella alta a l’apparenza spinta radiante
sorgente arrossa
cala energia
nell’ultimo segnale musicale onda al perielio
una boccata presa a caso sopra il lungomare
stacco strappi sottili ceneri arguzie senza testo a fronte
seguo l’osservazione misurabile l’inclinazione
tra incudine tempi scomposti
arrischio strettoie angolari
a favore di buio
corro di là
di là vantano effetti possibili
***
Quando il primo verso è una domanda, una domanda che potrebbe essere tratta dal dialogo interrotto di un film d’autore o dal monologo interiore di un viaggiatore notturno, cosa succede dopo, nel testo?
Qui succede qualcosa di caosmico, tra gravità, frequenze, fotometria, stelle.
Il pretesto, come ci dice il titolo “Verona rupes”, è spaziale, e riguarda la scarpata più alta del sistema solare. Ma essendo un pretesto, consente a Iria Gorran di dispiegare una ridda di effetti interstellari, accompagnandoci in un mondo di elementi rarefatti, rappresentato nel momento di fluttuazioni inimmaginabili che la poetessa traduce in versi calibrati sulla dimensione umana. Proprio qui risiede la bellezza particolarissima di questa poesia: nella trasposizione terrena di un tema celeste, nel passaggio tra il perielio e, quaggiù, una strettoia.
Così, tra il lontanissimo e il possibile, da ultravioletti e magnetismi a “una boccata presa a caso sopra il lungomare”, Gorran ci rende partecipi di multipli viaggi che, probabilmente inconsapevoli, continuiamo a compiere; ci porta in un punto della notte che è rischio senza paura, in un punto dove si accendono i sensi.
L’ideale accompagnamento musicale, il sonoro per questa poesia potrebbe essere il brano “Interstellar overdrive” dei Pink Floyd.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Iria Gorran (1957) ha origini croate e formazione classica. Fa esperienze teatrali in Sicilia; segue studi di Architettura a Roma. A Firenze frequenta l’Università Internazionale d’Arte e l’Atelier di Paola Bracco. A Genova lavora al restauro degli affreschi della chiesa della Santissima Annunziata, con interventi di ancoraggio e consolidamento. A Milano frequenta la scuola di Pinin Brambilla Barcilon e si occupa del Cenacolo di Leonardo. A Montalto Pavese lavora al restauro di tele del Seicento nella pieve di Sant’Antonino Martire. Testi di riferimento: Il corvo e i racconti del mistero di Poe, la Commedia di Dante. Ancoraggi filosofici: la scuola ionica di Mileto e Parmenide. Risiede per lunghi periodi a Vienna e a Londra. Vince “Opera Prima” 2018 di Anterem Edizioni con la raccolta “Corpo di Guerra”.
Sonia Lambertini, da "Perlamara", Marco Saya Edizioni 2019, nota di Laura Caccia
Il corpo estraneo della poesia
Dentro quali profondità, quali dolori, si forma, da un intruso che ferisce e si insinua nel profondo del corpo e del pensiero, la bellezza straniante di perlamara? Sonia Lambertini vi riversa, congiuntamente, il male che taglia corolle e ali al respiro e la parola che resiste al corpo estraneo e vi innesta sementi e spore di vita.
Una sofferenza cosmica e personale, a partire da “un vuoto esilio, suono assoluto”, colma i versi che si fanno strappo sintattico, insieme ai nomi che ne richiamano il patire: in un “mal stare”, tra il buio che rincuora e la “malanotte” tra lo stato di “mala grazia” e la ricerca di un centro, di un senso, a “malapena a stento”.
La parola diventa perciò l’alleata del vivere, scioglilingua che forma in bocca la sua sofferta perla ,“Giocavo a rotola parola / corpocarta perla amara”, così come urto sonoro in combattimento: “Staglia la lingua, battaglia / striscia”. Con un respiro breve e affannato, a volte, con il fiato che si alza leggero, altre, a ossigenare il dire di inedite figure.
Muovendosi nei sottofondi, “Sottoterra bisbigliano, / sottoterra. Gridano i folli”, a partire dal buio e dall’assenza di sé, dove “Qui non c’è corpo // non c’è un filo di luce” per arrivare al chiarore affidato a una medusa abissale, la cui “gola è acqua nera e il buio / fa brillare di luce propria chi può”, Sonia Lambertini dà vita, nei suoi versi, alla perla sofferta e preziosa della poesia.
***
Cosa ne faccio dei fiori
gingilli a strappo,
sul corredo corrono a crocchio
soffio di aliti pollini
e l’antèra mia dondola,
autofertile il mio fiore
ha il fiato corto giù, nell’anello
ancora il centro del mondo, pare.
***
In alto e circolare, respira
alza il fiato e l’occhio
mezzaluna la sera
è naturale: leggera, un grammo
più o meno la piuma,
il ventre è spazzato da un nido di uccelli.
***
Qui non c’è corpo
non c’è un filo di luce, da infilare gli aghi
da cavarsi gli occhi, non c’è lingua
che mangi le parole, da scavare il petto
c’è un buco a forma di peccato
un vuoto esilio, suono assoluto
da stare piegati in due centimetri
di terra, a guardarsi i piedi
da cavarsi gli occhi
non ricordo nulla dei rammendi
dei miei ritagli, solo pause
ritmi irregolari, da tremare in testa
da scordare il mondo.
***
Giocavo a rotola parola
corpocarta perla amara,
ripetevo a sgrana dita
sfilavo dalla bocca
bacche, lingua secca
filigrana di preghiera
corpocarta perla amara,
ripetevo a squarcia noia.
e poi un vento dal deserto
le coprì tutte, le parole
***
Staglia la lingua, battaglia
striscia. Sottoterra bisbigliano,
sottoterra. Gridano i folli, s’incurva
il merlo; sbecca, mutila il canto.
***
Il plenilunio di novembre
eccita i coralli e nel ventre
schiude l’ombrello la Periphylla,
la sua gola è acqua nera e il buio
fa brillare di luce propria chi può.
Sonia Lambertini vive a Ferrara. Sue poesie sono state pubblicate su «La clessidra», Semestrale di cultura letteraria, Joker Edizioni, 2015. Ha pubblicato la raccolta poetica Danzeranno gli insetti (Marco Saya Edizioni, 2016). Una selezione di poesie è stata tradotta in inglese e pubblicata nel «Journal of Italian Translation» - Volume XII, Number 1, Spring 2017. Ha pubblicato il racconto Les incurables in AA.VV, Anatomè (Ensemble, 2018).
Franca Mancinelli, videolettura; da "Libretto di transito", Amos Edizioni 2018, nota di Rosa Pierno
La prosa compatta di Franca Mancinelli in “Libretto di transito” descrive una percezione che assedia le cose per estrapolarne un succo, una figura, un senso. La ricchezza del reale, la sua complessità o estraneità non ha valore se non dopo che sia stata riconosciuta, messa nero su bianco e in tal modo fatta reagire col sé. Allora la scrittura riconquista un potere epifanico; attraverso essa vediamo l’incongruità messa a frutto, la disomogeneità riammessa su un riconosciuto binario: “Nessuna presenza, nessuna costanza delle cose”. La scrittura porta il peso anche del dialogo, della comunicazione con altri esseri; essa non avviene attraverso le parole, ma con gli sguardi e le sensazioni. La casa, le soglie, il giardino, il treno sono luoghi per incubare le nascite, per trasferire le proprietà fisiche tra gli esseri: ecco che la voce di lui è attraversata da uccelli di alta quota, oppure una faglia gli infrange le costole. La scrittura fa parlare il mondo, ce lo presenta come mai visto.
***
“La sera, con una sigaretta tra le dita, guardando il cielo scurirsi come terra bagnata, mio padre annaffia. Quando è laggiù, nascosto dalle piante dei pomodori, nell’angolo più lontano del giardino, posso sentire dal pozzo l’acqua versarsi e scendere tra i granuli, fino alle radici dove è attesa. Qui, dove il flusso si perde, crescono erbe dure dal piccolo fiore, piante dal frutto velenoso. Ma non riesco a zapparle via, non riesco a riparare la falda.
***
Ero una casa abitata da piante che si sporgono ai vuoti, sottili si avvolgono dentro il franare dei muri. Si è dimenticata la porta, questa casa, l’ha inghiottita come un boccone messo un po’ di traverso. È così che vengono e vanno: rondini in cerca di rifugio e poi libere gridano di piacere.
Nessuno calma il grido. Non c’è niente da donare in pasto. Non si dorme con questi che chiedono cibo, grattano con il becco e le unghie, in volo spezzato, sporco su ogni cosa. La mattina le strade, e il loro grido insaziato. La grande ciotola della piazza.”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Franca Mancinelli (Fano, 1981), è autrice dei libri di poesia Mala kruna (Manni, 2007), Pasta madre (con una nota di Milo De Angelis, Nino Aragno, 2013), Libretto di transito (Amos edizioni, 2018), uscito in traduzione inglese presso The Bitter Oleander Press (Fayetteville, New York) con il titolo The Little Book of Passage. Una riedizione dei suoi due primi libri è raccolta in A un’ora di sonno da qui (Italic Pequod, 2018). Suoi testi sono compresi nell’antologia Nuovi poeti italiani 6, a cura di Giovanna Rosadini (Einaudi, 2012) e, con introduzione di Antonella Anedda, nel XIII Quaderno italiano di poesia contemporanea, a cura di Franco Buffoni (Marcos y Marcos, 2017).
Danilo Mandolini, audiolettura con immagini; da "Anamorfiche", Arcipelago Itaca 2018, nota di Rosa Pierno
Una corrispondenza tra scala cosmica e scala umana è per Danilo Mandolini, in “Anamorfiche”, sempre riscontrabile. È come un memento che ricorda ciò che è ciclico sia nelle grandi orbite sia nella vita di un singolo. Ma anche orme, scie, segni riscontrabili sull’acqua e fra le nuvole. Il poeta è alla ricerca non di una medietà, ma di una misura. La misura è ordine, ma in ogni cosa Mandolini avverte soprattutto dolore e angoscia. L’assurdo pare il tristo pescato dell’ascolto e dell’osservazione, mitigato soltanto dai momenti di quiete in cui il poeta riesce a porsi dinanzi al mondo, sottraendo “alla temperie urgente del nulla” anche un solo sguardo. Riuscire, pertanto, a sentire il divenire come diverso dal normale percepire, lì dove il tempo non occlude più le peregrinazioni della mente nell’eterno, è l’agognato fine. Il futuro, non solo il passato, risiede in noi e il vuoto riempie nuovi spazi: le nostre stanze senza punti di fuga o prospettive limitanti.
***
L’improvvisa eco che porta
dalla cucina il tumulto
duro dei piatti impilati
e insieme spostati
è norma di consuetudine,
è familiarità fortuita
che senza indugio si riconosce
anche se a provocarla è
l’agire appartato
d’uno sconosciuto qualunque.
***
L’esistenza ferisce
con ferite che sono
ombre vocianti di soldati
ammassati al fronte
che più non torneranno o che,
anche se torneranno,
mai li incontreremo.
Danilo Mandolini è nato nel 1965, vive ad Osimo (AN). Scrive poesia. È ideatore e curatore di “Arcipelago itaca” blo-mag. Si è sempre occupato di Marketing e Vendite. Oggi è anche editore. Sue poesie e suoi racconti brevi sono apparsi in antologie, blog e riviste. Ha ottenuto numerosi Premi e riconoscimenti. Ha pubblicato in versi: Diario di bagagli e di parole, 1993; Una misura incolmabile, 1995; L’anima del ghiaccio, 1997; Sul viso umano, 2001; La distanza da compiere, 2004; Radici e rami, 2007.
Francesca Marica, videolettura; da "Concordanze e approssimazioni", Il Leggio Libreria Editrice 2019, nota di Laura Caccia
L’intonazione del vivere
Che la poesia, nel suo farsi, proceda attraverso continui avvicinamenti al senso segreto delle cose e dell’esistere, è quanto, a partire dal titolo, ci mostra Francesca Marica in Concordanze e approssimazioni.
Il bisogno di conoscenza sospinge i versi poiché “c’era qualcosa da scoprire, / ma bisognava tradurre quel bisogno”, anche se poi giunge la constatazione che, in fondo, “si conosce solo quello che è già stato immaginato”. In una alternanza, che si pone spesso come diversità di tono, con versi in tondo e in corsivo, tra i momenti riflessivi e il dialogo diretto con vari interlocutori, tra resistenza e abbandono, dissenso e cura. Tra le crepe del vivere e il bianco e la neve così spesso richiamati, tra l’esigenza del dire e il silenzio che prende la parola.
Dove il pensiero sull’esistere è scandito dai tempi del vissuto. Dove “La bellezza è un’ingiunzione” e “L’esilio è una prova di resistenza”. Nell’esigenza di trovare consonanze, muoversi accanto, tenere per mano. Attraverso l’attenzione a sfumature e spiragli, a “piccoli gesti di dimenticanza” e a “minute acrobazie”, così come ai dimenticati e ai sopravvissuti della storia e degli affetti...
In cerca di un’intonazione che consenta alla vita e alla voce di prendere e di dare forma, nel farsi carico di una parola in grado di dare senso a perdite e abbandoni, Francesca Marica ci indica che “Tutto sopravvive a una possibilità di traduzione. /Tutto sopravvive a un altrove”.
Da "Il tempo indietro"
***
La storia si ripete e lascia andare.
Non trattiene perché quella è la vittoria
incisa tra lo scheletro e il cielo
dove neanche tu sai, neanche tu puoi.
Bisogna camminare accanto per capire.
Come la parte migliore,
la forma assoluta e vicino allo zero,
un’isola che non è gelo ma nube,
la possibilità di una danza tra i larici ingialliti.
L’inverno è spostare il bianco con la mano,
per andare giù nel profondo, con le dita.
***
A buon diritto il freddo ha preso casa,
assomiglia a una montagna il suo profilo,
un facile rimedio per chi è costretto a ricordare.
Non c’è riposo che sia vero per la meccanica del tempo,
si ripete uguale il suo copione come in uno scherzo.
In fondo si conosce solo quello che è già stato immaginato.
Da "Dalla parte dell'acqua"
***
È una concezione del male meno sottile quella che proponi,
le parole che dici un incantesimo, la notte poi lo sai che arriva
ma i conti non tornano anche quando sono in eccesso.
L’esilio è una prova di resistenza.
Tutto sopravvive a una possibilità di traduzione.
Tutto sopravvive a un altrove.
***
Questo bianco non mi trattiene più.
Gli eventi con anticipo hanno fatto un balzo
perché la storia è fronde e voci.
Bisognerà farsi neve, ingoiare il sale,
prendere forma - come uno strumento,
un fiato, una nota che ha trovato la propria intonazione.
Da "Interstiziale fra elementi uguali o analoghi"
***
Lo spaccarsi della crepa
l’umidità che cresce e alleva rose.
I piedi svelti, i passi indietro,
il tuo segreto a lato
come un pugno lo racconti nella notte.
È il tremore di chi ha scelto di cadere
scampato il precipizio, a poco a poco.
***
Ti dico stiamo qui e in nessun altro luogo,
il resto sono storie inventate, sono scuse.
Profondità abissali, talvolta enigmatiche.
Ti cedo la parola, tu consegnami la voce.
Fai in modo che io possa poi parlare.
Francesca Marica (Torino, 1981). Vive a Milano, dove esercita la professione di avvocato penalista, dedicandosi prevalentemente al disagio e alla marginalità giovanile, alla violenza sulle donne e alla tutela delle fasce deboli.
Redattrice e curatrice di riviste letterarie, si occupa di critica poetica. Cura su Carteggi letterari la rubrica Segni, cifre e lettere e la rubrica La poesia del giorno. Ha collaborato con Argo, Poesia del nostro tempo. Traduce dall’inglese e scrive di teatro. Concordanze e approssimazioni è il suo primo libro.
Ultima pagina: videolettura di Bianca Battilocchi, "Nontiscordardimé"
Nontiscordardimé
Finalmente parla l’angelo
Bianca Battilocchi
Dublino, aprile 2020

Simone Martini, Annunciazione e i santi Ansano e Massima, 1333, dettaglio.
(a Michel de Certeau e James Hillman)
Simili a sordi, ascoltano e non intendono.
Per loro vale il detto: presenti, sono assenti.
(Eraclito, fr. 50)
Che muffa che truffa
questa prigione
le partite di solitario
l’attesa di una chiamata
sarà dato vedersi ancora
il mio imponderabile arrivo?
potrò ancora arrivare?
sogno un occhio
allenato alla trasversalità
al sintomo alla visibilità sparente
un orecchio che oltrepassi
più in alto del silenzio
un annuncio è atteso
o non c’è più tempo?
ricordate chi sono
e le incisioni
la memoria di corpi solcati?
perché non parlano più quelle tracce?
permettetemi di imprimere con inchiostro allora
afferrare con carne una tromba o una viola
muovere le foglie col canto
e farle ammirare dall’occhio
instancabile di verifiche
vi inviterò
ad abbattere le frontiere del tempo
che la mia parola hanno chiusa in libri dimenticati
seppur ben catalogati
fateli rifulgere di luce piena quei corpi inscritti
che morte non devono conoscere
chiudete gli occhi per vedere
il mio volto fiammeggiante
quei dardi che bombardano i confini
cesserà il senso dei clivaggi
lo strapiombo o l’elevarsi
si farà spazio sola
la fusione liberatrice
ascoltami umbratile anima
dispiega quell’infiltrato ardore
in moltitudini di esplosioni
restituisci l’evanescenza
che alla parola e a noi appartiene
tu stessa
effimera
puoi parlare di me
Prima ancora della ragione vi è il movimento vòlto all’interno che tende verso ciò che è proprio.
(Plotino, Enneadi, III, 4.6)
Bianca Battilocchi (Fidenza, 1988) ha studiato Lettere all'Università di Parma e Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ha ottenuto un dottorato di ricerca sui Tarocchi inediti di Emilio Villa presso Trinity College Dublin, dove insegna dal 2016. La sua ricerca esplora i territori della poesia e delle arti contemporanee, i linguaggi sperimentali e i riaffioramenti dal passato di archetipi e simboli ancora operanti. Suoi interventi sono usciti per “Griselda online”, “Parole Rubate”, “Carte nel vento”, “JOLT – Journal of Literary Translation”, “Engramma”, “Nazione Indiana” e “Hypérbole”.
Quarta di copertina: Piera Legnaghi, bozzetto di "Albedo", foto, biografia

Cartolina

Da sinistra: Isabella Caserta, Piera Legnaghi, Vittorino Andreoli

Bozzetto di Albedo
Piera Legnaghi, scultrice. Lavora il ferro e l’acciaio dalla piccola alla grande dimensione: cerca relazioni e armonia nei luoghi dove colloca le sue installazioni. Ama scrivere poesie, parole come materia da plasmare. È stata finalista al Premio Montano nel 2003 con il libro “A cuore aperto”, Ponte Nuovo Editore, Verona 2002.
Giugno 2020, anno XVII, numero 47

.jpg)
Questo nuovo numero di “Carte nel vento” si apre e si chiude con un omaggio a Franco Beltrametti (1937-1995), storico collaboratore, per vent’anni, di “Anterem”. Tutto avviene attraverso i contributi di chi l’ha conosciuto e ha vissuto con lui una stagione poetica appassionante: Mara Cini, Giulia Niccolai, Anna Ruchat. E mediante il racconto di chi l’ha invece conosciuto profondamente per mezzo delle sue opere, Francesca Marica e Stefano Stoja.
Abbiamo inoltre il piacere di presentare, in diretta continuità con il numero scorso, altri poeti e prosatori selezionati dal Premio Lorenzo Montano 2019, tutti introdotti dai redattori di “Anterem”. In audio e videoletture, in alcuni casi con vere e proprie ricreazioni dei testi con innesti visivi e sonori: Elena Cattaneo, Morena Coppola, Marco Ercolani, Paolo Ferrari, Giovanni Infelìse, Maria Grazia Insinga, Antonella Lucchini, Giulio Maffii, Roberto Minardi, Loredana Prete, Maria Pia Quintavalla, Claudio Salvi.
“Carte nel vento”, prendendo vita dalla realtà del Premio Lorenzo Montano, da sempre pubblica le autrici e gli autori che lo hanno reso considerevole e che lo animano, edizione dopo edizione, da moltissimi anni: è un periodico on-line che opera in stretta connessione con l’esperienza della rivista “Anterem”, da cui tutto questo origina.
Buona lettura, buon ascolto, buona visione. Ranieri Teti
In copertina: Franco fotografato dal figlio Giona Beltrametti nel 1980 e “Corrispondenze 1977-1995”, archivio Mara Cini
Quarta di copertina, Franco Beltrametti da “Anterem” 26/27 (dicembre 1984) e una pagina di "1984" (TAM TAM Edizioni)
Una dichiarazione di poetica da "Anterem" 26/27 (dicembre 1984)

Una pagina di testi tratti da “1984”, TAM TAM Edizioni

Prima pagina, Francesca Marica: Franco Beltrametti, Uno di quella gente condor; collage dedicato
Uno di quella gente condor – vita e opere di uno degli ultimi irregolari e clandestini della letteratura; collage dedicato
Cinquantotto anni sono pochi, pochissimi, sono un tempo infinitamente piccolo per chi la vita l’ha divorata, sfidata, presa a morsi, celebrata e onorata. Per chi la vita, in una parola sola, l’ha vissuta. I (quasi) cinquantotto anni di Beltrametti sono stati pochi, disgraziatamente pochi, ma anche straordinariamente densi, travolgenti, abitati da molti amici e molte presenze. Come racconteranno negli interventi successivi le persone che lo hanno conosciuto, che gli sono state amiche e che ne hanno curato le opere, Franco è stato una persona generosamente e autenticamente interessata all’incontro con gli altri; una persona viva, curiosa, che non si è mai risparmiata in nulla e il suo tempo lo ha speso intensamente fino all’ultimo dei suoi giorni.
Franco Beltrametti nasce a Locarno il 7 ottobre del 1937 e muore a Lugano il 26 agosto del 1995, improvvisamente e in piena attività.
L’esordio poetico risale al 1970. La plaquette, pubblicata dalle edizioni GEIGER di Adriano Spatola e fratelli, ha un titolo curioso: Uno di quella gente condor.
Lì vengono raccolti testi scritti tra il 1965 e il 1968 e legati quasi interamente alla sua prima esperienza in Giappone e California. Il titolo gli viene suggerito dallo stesso Spatola durante uno dei loro primi incontri a Roma e nasce dai versi finali della poesia Un uccello? Un’aquila?
In quella plaquette, dall’aspetto sobrio e minimale, sono già rintracciabili tutti gli elementi che diventeranno fondamentali nella poetica beltramettiana: l’immediatezza e l’essenzialità dei versi, la sperimentazione di un linguaggio nuovo, il sacrificio dell’io poetico in favore degli oggetti della realtà, il suo continuo interrogarsi sul rapporto tra incompiuto e immediato.
Il poeta Nelo Risi in una lettera indirizzata a Beltrametti all’indomani della pubblicazione scriveva: Vedo che anche lei appartiene (come Cid Corman) a quella razza di poeti girovaghi che sembra aver preso l’avvio da Allen Ginsberg. Il suo CONDOR vola alto, secco e tagliente, o casca giù dal cielo come una pietra. Davvero lei è riuscito a prosciugarsi in così poco tempo (3 anni!) tra Kyoto e Los Pedres National Forest? E prima, come scriveva prima? Pound e Cummings c’entrano nella sua formazione?
A quella lettera, in cui scorge una profonda comprensione del suo modo di intendere la vita e la poesia, Beltrametti risponderà poco tempo dopo proprio con una poesia, la numero 24 del suo libro successivo Un altro terremoto: “Il suo condor vola alto/secco e tagliente o casca giù/ dal cielo come una pietra”. ecco proprio come/pensavo dovesse essere/ gli rispondo contento/ quando tira vento/ mi aspetto di vedere/ il tetto della baracca/ volare via (29.07.1970).
Ecco proprio come pensavo dovesse essere. Il risparmio e l’immediatezza verbale che caratterizzano l’esordio di Beltrametti (frutto anche della sua ammirazione per le forme poetiche orientali) e il suo genuino interesse per il processo creativo più che per la finalizzazione dell’esperienza creativa secondo la celebre formula beat First Try, Best Try (nel 1990, in un’intervista ad Antonio Ria, Beltrametti dirà che il risultato è solo una messa a fuoco delle tracce) caratterizzano anche le plaquette degli anni a seguire. Beltrametti è stato un poeta prolifico; si contano oltre sue cinquanta pubblicazioni.
Tra i suoi lavori più noti: Un altro terremoto nel 1971 dedicato ai compagni del Belice (edizioni GEIGER); In transito nel 1976 (sempre, GEIGER), allora: poesie 1977-1981 (GEIGER, 1981), 1984 – 15 poesie x Irene Aebi & Steve Lacy, nel 1984 (TAM TAM), 19 permutazioni nel 1986 (Edizioni Inedite/Milano), Tutto questo nel 1990 (Supernova), Monte Generoso nel 1991 (Josef Weiss & Ascona Presse), Dossier Villon con Corrado Costa nel 1991 (Elytra), Trattato nanetto nel 1992 (Supernova), Codice Biancaneve con Dario Villa nel 1992 (Scorribanda&Edizioni Nanette), KTCFYW con Tom Raworth nel 1992 (Scorribanda & Infolio), Poesia diretta con Antonio Ria nel 1992 (Edizioni Mazzotta), Logiche & illogiche nel 1994 (Giona Editions), Perché A nel 1995 (Supernova), Choses qui voyagent nel 1995 (Edizioni Mazzotta).
Ma la poesia non esaurisce la produzione artistica di Beltrametti. Accanto al Beltrametti poeta hanno convissuto, con identica forza, impegno e rigore, il Beltrametti saggista (Belice: lo stato fuorilegge, 1969), lo scrittore in prosa (Nadamas, 1971, GEIGER e Quarantuno, 1977, Cooperativa Scrittori), l’artista visivo e il collagista (numerose sono state le sue personali, soprattutto in Francia, Italia e Svizzera; il segno grafico e il dato figurativo sono stati elementi sempre complementari alla parola; talvolta è stata la stessa parola a farsi segno grafico), l’editore e il redattore di riviste di poesia (Abacadabra e Mini – la rivista più piccola del mondo, nata da un suggerimento del figlio Giona), il curatore di antologie (Montagna Rossa nel 1971 realizzata con la moglie Judy Danciger e C/O nel 1984 dedicata interamente alla poesia visuale, realizzata in collaborazione con la poetessa e amica Patrizia Vicinelli), il traduttore (sono sue molte delle traduzioni degli amici beat americani, per esempio), il performer e l’organizzatore di festival di poesia (P77, la cui prima edizione ha luogo a Venezia nel 1977, assumendo negli anni successivi una vocazione internazionale) e, non da ultimo, il collaboratore di numerose riviste indipendenti e underground, tra cui TAM-TAM (poesia/Italia), Anterem (poesia/Italia), Cervo Volante (poesia/Italia), HOTCHA! (poesia/Svizzera), Coyote's Journal (poesia/USA).
Come ha ricordato l’amico Dario Villa su Il Manifesto all’indomani della sua morte, Beltrametti ha inseguito sempre la poetica del frammento, partendo da una posizione di centralità della marginalità e con lui se ne è andato uno degli ultimi rappresentanti di una generazione di irregolari e clandestini della letteratura.
Uno degli ultimi irregolari e clandestini, verissimo. Tutta la sua vita e la sua produzione artistica sono state una testimonianza concreta della sua vocazione di irregolare e clandestino e anche le sue scelte editoriali non potevano che confermare quella vocazione: Beltrametti ha sempre prediletto i piccoli editori indipendenti e tutta la sua opera letteraria è composta da plaquette a tiratura limitata e da uno svariato numero di pubblicazioni in rivista dove si è mantenuta sempre alta e costante l’attenzione all’attimo, alla velocità di esecuzione e stesura del testo, all’economia delle parole. Come ha scritto Niccolò Scaffai nel 2005, Beltrametti sembra andare incontro una nuova concezione della poesia, lontana dalla logica del libro di poesia (così in Il poeta e il suo libro. Retorica e storia del libro di poesia del Novecento, Le Monnier).
Della scrittura Beltrametti ha sempre avuto un’idea precisa. Nel volumetto Autobiografia in 10.000 parole (uscito nel 1991 per la Contemporary Authors Autobiography Series, CAAS, vol. 13 e, in Italia postumo, per le edizioni sottoscala nel 2016) annotava: Scrivere vuol dire scrivere della scrittura che chi scrive sta scrivendo. Vuol dire anche registrare una voce. E poco dopo, citando una sua poesia del 1969, aggiungeva: there is not much to understand/ just pay attention.
Quale fosse il suo pensiero appare evidente: scrivere vuole dire vivere il tempo presente, c’è da prestare attenzione, occorre essere vigili e mettersi in ascolto di una voce. Recuperando il pensiero di Ernest Fenollosa (sinologo americano della fine del XIX secolo, fondamentale nella sua formazione), Beltrametti ritiene che la poesia debba tradursi in un assemblaggio di immagini, estranee al filtro della logica, deve essere una fede assoluta nei confronti degli oggetti della realtà.
Già nel 1973, in un suo intervento su TAM TAM (numero 3/4, primo semestre, poi riportato anche nella rivista Allora, Quaderni della Fondazione Franco Beltrametti, n. 3 del 2003, a cura di Anna Ruchat) Beltrametti rivendicava per sé una poesia capace di sfuggire alle regole fisse e vedeva nella crudezza dei fatti la sola realtà realizzabile: Ogni poesia è per me un viaggio mentale (o sciamanico) che si può percorrere e ripercorrere. Le parole sono casse di risonanza, percezioni, tracce, suoni. Le parole e le frasi hanno ossa carne pelle tendini nervi. Un’intelligenza interna, quasi biologica (…).
Ma la definizione più interessante e completa di poesia la si rinviene in Un altro terremoto e siamo nel 1971. La poesia numero 34 della plaquette così recita: La poesia/ (visto che me l’hai chiesto)/ è una specie/ di filosofia d’azione/ cioè/ telegrammatica. In quella definizione c’è lo slancio vitale di Bergson, c’è il pensiero di Nietzsche ma anche l’amore di Beltrametti per la filosofia orientale, il Taoismo e il Buddhismo zen. Fare poesia per lui significa indagare la realtà senza filtri, senza strutture estetizzanti; come lui stesso dirà in uno dei suoi taccuini (oggi custoditi, insieme alla quasi totalità della sua produzione letteraria, a Berna, presso l’Archivio Svizzero di Letteratura) la mia poesia è una sintesi di situazioni molto contingenti e limitate-localizzate, compresse “dentro” con la speranza di riuscire a “comprimere dentro” sempre di più, un concentrato di parlato e di pensato. L’unico modo in cui sono capace di fare poesia è questo.
Come altri hanno già avuto modo di far osservare, e penso soprattutto a Dario Villa, Giulia Niccolai e Maurizio Spatola, in Beltrametti vita e poesia hanno coinciso, finendo per diventare una cosa sola. La sua poesia è stata, di fatto, il diario particolareggiato della sua vita. Giulia Niccolai, nell’introduzione italiana a Autobiografia in 10.000 parole, ha scritto che la sua poesia era una sorta di diario di bordo, una lunga serie di appunti su pensieri, immagini, amici, situazioni di una vita che Franco aveva deciso: sarebbe stata bella e libera. Bella e libera, e sempre in movimento. Sì, perché per Beltrametti il viaggio ha sempre rivestito un ruolo fondamentale. Antonio Porta nel 1979, in Poesia degli anni Settanta, scriveva Le tematiche del poeta-viaggiatore (e il viaggio ha qui tutti i suoi significati possibili, dalla droga fino alla morte) ci vengono illustrate con eleganza paradossale da Franco Beltrametti. Dico "paradossale" nel senso in cui lo è ogni scelta stilistica di fronte a temi così radicali. I graffiti di Beltrametti resistono proprio per la loro provvisorietà, per il negarsi ogni carico troppo pesante. Ciò che rimane è il senso di una fuga senza fine dall'idea di una morte innaturale, quella fornitaci dalla nostra cultura. All'orizzonte, irraggiungibile, "il lampo verde dell'alba". Beltrametti inizia a viaggiare dopo la laurea in architettura a Zurigo, approdando in un primo tempo a Parigi e a Londra dove lavora in uno studio di architetti. Insoddisfatto della libera professione, decide di muoversi alla volta del Giappone nel 1965 (quel viaggio di cui esistono diversi taccuini, viene raccontato anche in Transiberiano, edizioni sottoscala, 2016 a cura di Anna Ruchat e Stefano Stoja). Vive per diverso tempo a Kyoto e lì, nell’ottobre del 1966, nascerà Giona, il suo primo figlio. Tramite Nanao Sakaki, padre del movimento alternativo giapponese e poeta girovago, conoscerà in quegli anni Gary Snyder, Philip Whalen e Cid Corman e con loro instaurerà un’amicizia lunga un’intera vita. Dal Giappone, si trasferirà in California dove insegnerà all’università di San Luis Obispo, siamo nel 1967. Ad accogliere lui, la moglie e il figlio ancora piccolissimo, al porto di San Francisco, ci sarà il poeta e l’editore James Koller che diventerà nel tempo un altro dei suoi più cari amici. Molti altri incontri con poeti e artisti verranno e si consolideranno negli anni successivi: Allen Ginsberg, Lew Welch, Michael McClure, Duncan McNaughton, Joanne Kyger, William Burroughs, Urban Gwerder, Ted Berrigan, Annabel Levitt Lee, Julius Bissier, Jack Boyce, John Giorno, Tom Raworth e Julien Blaine. Dopo la California, tornerà in Svizzera e poi in Italia (stabilendosi per un periodo a Roma, Venezia e Milano). Nel 1969, raggiunge Partanna, città distrutta dal terremoto del Belice e lì vivrà, insieme alla moglie Judy e al figlio Giona, per un anno tra la popolazione locale cercando di dare un aiuto fattivo per la ricostruzione. Quell’esperienza confluirà, non senza amarezze, nella plaquette Un altro terremoto e nel saggio Belice: lo stato fuorilegge. Nel 1971, su invito della cara amica di gioventù Flora Ruchat, si trasferisce a Riva San Vitale. Farà di Riva San Vitale, sede della Fondazione che porta il suo nome, il suo feudo, uno dei suoi luoghi-approdo. Lì lo raggiungeranno a più riprese gli amici americani, francesi e svizzeri ma anche quelli italiani, Adriano Spatola, Giulia Niccolai, Corrado Costa, Dario Villa con cui nel frattempo continueranno diverse collaborazioni. Negli anni successivi si muoverà incessantemente tra Europa (Francia soprattutto) e Stati Uniti abbracciando molti progetti artistici, si interesserà di poesia performativa e reading e organizzerà lui stesso un festival di poesia, la cui prima edizione, P77, si svolgerà a Venezia proprio nel 1977 ai Saloni del Sale (festival da cui si defilerà dopo qualche anno non riconoscendosi più nello spirito e nel progetto da cui tutto aveva avuto inizio). Solo nel 1986 riuscirà a fare ritorno a Kyoto per l’inaugurazione di una mostra, a distanza di vent’anni dal suo primo viaggio in Giappone. Negli anni ‘90, ai vecchi progetti se ne aggiungeranno di nuovi, soprattutto in campo artistico (del 1993, l’esposizione alla Gallerie 22 di Marsiglia e a Bellinzona da Attila Centro d’Arte Contemporanea; del 1994 invece l’esposizione a Locarno delle collaborazioni 1984/1994 con Tom Raworth). In quegli anni incontrerà anche la ceramista Antonella Tomaino, che diventerà sua compagna e con la quale vivrà una ritrovata serenità. Dalla loro unione nascerà, pochi mesi dopo la prematura scomparsa di Beltrametti, Franca – la sua seconda figlia. Tutto nella vita di Franco Beltrametti sembra essere stato guidato e graziato dal caso. Forse perché lui per primo aveva raccontato di credere al caso (così come lo intendevano John Cage e Duchamp) e continuava a sorprendersi davanti all’intrecciarsi dei fili della vita. La tragedia, la passione, la confusione, la disperazione, anch’esse fanno parte del tutto, parte del mio essere ancora qui – scriverà in Autobiografia in 10.000 parole. E sono convinta che continuerebbe a scriverlo anche oggi, con lo stesso identico fervore ed entusiasmo. La vita negli anni ‘80 non è stata un viaggio su un petalo di rosa, scriverà sempre in Autobiografia ma, probabilmente, è stato il migliore tra quelli possibili. Quello con cui ci congediamo, tenendoci stretta la sua costellazione di sogni e ideali sempre vivi. Francesca Marica, Niente da (in memoria di Franco Beltrametti), collage, tecnica mista su cartone, 2020 
Francesca Marica è nata a Torino nel 1981.
Ha pubblicato: Concordanze e approssimazioni (Il Leggio 2019, segnalazione Premio di poesia e prosa Lorenzo Montano, XXXIII edizione).
Sta lavorando a due nuovi progetti poetici e a un libro d’artista a quattro mani con una scultrice italiana.
Redattrice e curatrice di riviste e blog letterari, si occupa di critica poetica e poesia visiva. È anche artista visiva e collagista. Traduce dall’inglese e dallo spagnolo, ha scritto - e scrive - di arte e di teatro. Sue poesie sono apparse su diversi blog, riviste e antologie.
Fa parte della Giuria del Premio letterario Internazionale Franco Fortini e del Premio nazionale Gianmario Lucini.
Vive a Milano, dove esercita la professione di avvocato.
Mara Cini: Poesie per Franco Beltrametti, da “Scritture” (North Press Edizioni, 1979); immagini d’archivio

Mara Cini, per Franco Beltrametti, da "Scritture", North Press, 1979

Lagune di Sasso Marconi, 1982. Giulia Niccolai, Franco Beltrametti, Harry Hoogstraten, in primo piano il piccolo Jacopo
archivio Mara Cini

archivio Mara Cini
Mara Cini è nata e vive a Lagune di Sasso Marconi. Ha studiato all’Istituto d’arte e al DAMS di Bologna. Collaboratrice di storiche riviste sperimentali come “Tam Tam” diretta da Adriano Spatola e Giulia Niccolai, “Mini” diffusa in tutto il mondo da Franco Beltrametti, “Il poesia illustrato” di Corrado Costa, “Mgur” curata da John Gian, è da tempo redattrice di “Anterem”. Ha partecipato a letture e incontri di poesia (tra gli altri “romapoesia” e Biennale di Venezia) e a collettive di scrittura visuale. Ha pubblicato le raccolte e film introverso e film chimico (1976); Scritture (1979); La direzione della sosta (1982), Anni e altri riti (”Premio Lorenzo Montano”, 1987), Dentro Fuori Casa (1995), Specchio convesso, con Rita Degli Esposti (2006) ; racconti in Narratori delle riserve a cura di Gianni Celati (1992), Racconta 2 (1993) e diversi lavori di microeditoria “artigianale”.
La “Chicago Quarterly Review” ha pubblicato traduzioni di sue poesie a cura di Olivia Sears, l’Atelier InSigna ha realizzato libri d’artista con suoi frammenti testuali, racconti recenti sono apparsi su “il verri” n. 70 (2019).
Per approfondire:
http://www.nannicagnone.eu/html/guests/html/mara.html
http://www.gianpaologuerini.it/b_aboutyou/2_guests/pdf/cini.pdf
http://rosapierno.blogspot.com/2012/09/alcuni-frammenti-inediti-di-mara-cini.html
Anna Ruchat: Sulla Fondazione Franco Beltrametti e una poesia inedita “Per Franco”; foto di repertorio

Inaugurazione Fondazione: Tom Raworth
La Fondazione Franco Beltrametti, nata nel 2002 su iniziativa di Stefan Hyner, poeta tedesco e amico di Franco, di suo figlio Giona e mia, ha chiuso formalmente i battenti nell’autunno 2019. Del comitato promotore facevano parte molti amici di Franco che hanno anche sempre concretamente sostenuto le diverse iniziative. Tra loro in particolare Giulia Niccolai, Giovanna Manduca, Christoph Beriger, Laurie Hunziker-Galfetti, Claudio Tettamanti, Johngian, Rita degli Esposti, Nino Locatelli, Tom Raworth, Jim Koller e molti altri.
La chiusura non è però ancora stata annunciata pubblicamente perché avremmo voluto organizzare una festa con letture poetiche e musica (come ce n’era stata una di apertura, a fine aprile del 2002). Quest’anno però, per ragioni evidenti, non è stato possibile neppure pensarci.
In quasi vent’anni di attività, la fondazione ha voluto rendere accessibile e far conoscere l’opera di Franco Beltrametti con più modalità: tramite le pubblicazioni (la rivista «Allora», monografie su vari scrittori della "galassia Beltrametti", edizioni in diverse lingue delle opere di Franco Beltrametti inedite o da tempo inaccessibili); tramite l'allestimento di mostre in Svizzera e in Italia (Sempre cercando, Museo cantonale, Mendrisio 1999; dal 2006 al 2008 una serie di mostre presso le biblioteche lombarde conclusesi poi con una mostra presso la Biblioteca cantonale di Lugano nel 2009; La musa leggera, Biblioteca cantonale, Bellinzona 2016; Anche soltanto scorrendo, Palazzo Trevisan, Venezia, 2017).
Dal 2012 infine l'Archivio Svizzero di Letteratura presso la Nationalbibliothek di Berna ospita nel fondo omonimo carteggi, manoscritti e dattiloscritti di Franco Beltrametti,, che la Fondazione ha ceduto, mettendoli a disposizione degli studiosi; grazie a ciò possiamo ad oggi contare diverse tesi di laurea e articoli su riviste letterarie.
Ultima grande fatica della Fondazione è stata la pubblicazione dell’antologia Il viaggio continua (L’Orma editore, 2018), con la quale si è raggiunto l’obbiettivo non solo di rendere di nuovo disponibili per un pubblico ampio le opere più significative di Beltrametti, ma anche di suscitare la curiosità e l’interesse per una modalità di relazione totale con l’arte e la scrittura che oggi sembrano del tutto scomparsi.
Anche la biblioteca, che dovrebbe presto trovare una collocazione definitiva a Mendrisio presso la biblioteca comunale della Filanda, e che è rimasta finora nella sede della fondazione a Riva San Vitale, testimonia l’identificazione dell’arte, da parte di Beltrametti e della sua rete di amici, con la vita stessa. Si tratta di un fondo piccolo, di circa 3.000 volumi tra libri e riviste, ma molto compatto e fitto di rarità.
Saremmo felici se, con la sua maggiore accessibilità all’interno di una biblioteca pubblica, questa testimonianza di un “fare poesia” completamente al di fuori dalle logiche del mercato e dell’industria culturale, potesse alimentare nelle giovani generazioni un desiderio di sperimentare o anche solo una curiosità.

Interno, Fondazione
Per Franco
Non erano ancora vestite
le bambine
quando hanno bussato alla porta
prendevano il latte
Ho aperto fuori il cortile
nella luce pallida di fine estate
il tavolo da ping pong
le tue finestre
Per giorni
si contraevano
i muscoli
poi
tu
nell’aria
come la poiana prima della pioggia
sul lago
Sono donne
ora
le bambine
la casa
è cambiata e tu
nell’aria.
Anna Ruchat, traduttrice e scrittrice, insegna Traduzione alla Civica Altiero Spinelli.
Nata a Zurigo nel 1959, ha studiato filosofia e letteratura tedesca tra la sua città natale e Pavia. I suoi esordi letterari sono legati alla traduzione e, in particolare, quella di Il respiro e Il freddo di Thomas Bernhard, pubblicati per le edizioni Adelphi. Da allora ha tradotto molti scrittori di lingua tedesca, tra cui Paul Celan, Friedrich Dürrenmatt, Victor Klemperer, Nelly Sachs, Mariella Mehr, Christine Lavant. Nel 2004 ha esordito come scrittrice col volume di racconti In questa vita (Casagrande).
Nel 2006 ha pubblicato la sua prima raccolta poetica intitolata Geografia senza fiume (Campanotto) e, in collaborazione con la fotografa Elda Papa, il racconto Il male minore (Ed. Fondazione Beltrametti). Nel 2009 è uscita, in collaborazione con l’artista Giulia Fonti, la raccolta di poesie Angeli di stoffa (Pagine d’Arte) e, nel 2010, il romanzo breve Volo in ombra (Quarup), tradotto in tedesco nel 2012. Nel 2011 ha pubblicato Terra taciturna e Apocalisse (Campanotto), un’opera accompagnata dai disegni di Daniele Brolli, e l’anno dopo Il malinteso (Ibis). Nel 2014 pubblica il poemetto Binomio fantastico (Di Felice), nel 1917 Lì e l’ombra (Pagine d’arte) e nel 2018 Gli anni di Nettuno sulla terra (IBIS). Ha collaborato con testate italiane (Il Manifesto, Pulp, Il primo amore) e la Radio della Svizzera Italiana. Dal 2002 al 2019 si è occupata della Fondazione dedicata al poeta Franco Beltrametti (1937-1995).
Elena Cattaneo, videolettura; poesia inedita “Sei tu nel magma che mi sfiori”, nota di Ranieri Teti
Sei tu nel magma che mi sfiori
Sei tu nel magma che mi sfiori
e ancora non siamo,
è unico occhio, bulbo di lava,
mani fuse nella caldera.
Chi dall’alto veglia ignora
sesso, gestazione, furore.
Soffia per confonderci.
Io sono il nero e l’arancione,
senza gambe ti cerco,
di ogni crepa faccio stampo.
Ridi esplosivo, puro e in fiamme
Non mi sai, mi intuisci enorme,
tentacolare.
Liquida bacio la lava che
forma il tuo dorso-bollore,
bianca incandescenza è lingua
nei piedi immaginati.
Chi dall’alto veglia piange
acqua di scalpello, ora.
Ho capelli di manganese
e seni di cobalto in cui
ti specchi.
Esistiamo in frattura docile,
ti bacio nell’oro degli occhi,
neri e acuti, prima
del dolore che patirai
oltre la miseria del tempo.
Quando una poesia non ha titolo, lo chiede al primo verso, come se proprio a quel verso fosse debitrice.
Elena Cattaneo, con “Sei tu nel magma che mi sfiori”, costruisce una suite a tratti ipnotica che ricorda una colata lavica: la poesia è tutta strettamente innervata da termini collegati a un’ipotetica eruzione. Ci porta a essere allo stesso tempo abbagliati dai colori che si sprigionano e consapevoli di un pericolo. Infatti “Sei tu nel magma che mi sfiori” dice l’ardere dei corpi, il possibile della bellezza, il furore del desiderio. Dice anche la consapevolezza che tutto passa ma alla fine niente resta come prima; Mario Luzi, in “Nel magma”, scrive: “Prega che la loro anima sia spoglia / e la loro pietà sia più perfetta”. Questa citazione è importante per rendere conto fino in fondo del testo, per trasportarlo nella sua misura spirituale.
Si potrebbe infatti dividere il testo di Cattaneo in due parti, evidenziate da un verso che ritorna con una decisiva variante: “Chi dall’alto veglia”, prima “ignora” e poi “piange”. Si tratta del momento in cui la passione stempera nel dolore, dall’arancione si vira al blu cobalto, da “sesso, gestazione, furore” la coppia protagonista della poesia comprende che “esistiamo in frattura”.
La pietà della chiusa, il finale in diminuendo, come quando si spengono attenuandosi le luci e si affievolisce il sonoro, quando il ritmo rallenta nel placamento, quando si passa da un bulbo di lava all’oro degli occhi, ci fa assistere a un fuoco frantumato in scintille, presenta l’essenza, quel tanto di brace che ancora cova nella cenere.
Elena Cattaneo è nata a Milano nel 1971. Dopo la Laurea in Lingue e Letterature Straniere presso lo IULM di Milano, con una tesi incentrata sul poeta inglese Charles Tomlinson, si è specializzata in studi di traduzione in Inghilterra, allo UMIST di Manchester.
Opera da circa vent’anni nel mondo della musica classica.
Suoi componimenti poetici sono apparsi in riviste di settore e siti web di scrittura poetica (Carteggi Letterari, Atelier On Line, Blanc de ta Nuque, la Recherche, La Bella Poesia, tra gli altri).
Le sue ultime pubblicazioni sono “Il Dolore un Verso Dopo” (Puntoacapo editrice, 2016, postfazione di Ivan Fedeli), Finalista con Attestato di Merito al Premio Alda Merini di Brunate (2017) e Segnalata al Premio Ponte di Legno Poesia (2017) e “Sopravvissuti” (Prospettiva Editrice, 2015, pubblicazione premio).
E’ risultata finalista ai premi Bologna in Lettere 2017 ed Europa in Versi 2017, ed è stata segnalata dalla giuria al premio Rodolfo Valentino 2018, poesia inedita.
Una sua poesia estratta da "Tardigrada" (suite zoofila a quattro voci scritta con F.Bregoli, S.Gallo e G.Isetta) è apparsa su Il Segnale, n.108, Milano, ottobre 2017.
Morena Coppola, audiolettura-cartolina; dalla raccolta inedita "Ordalie nel Cacacosmo Organizzato", nota di Laura Caccia
La forza della parola
La rivolta alle forme di dominio intesse l’ordito di Ordalie nel Cacacosmo Organizzato di Morena Coppola, in un intreccio di versi, testi, poesia visiva, immagini, richiami musicali.
A partire dal titolo di matrice dadaista. Se Raoul Hausmann esprimeva tutto il suo disgusto per la civiltà “del cacacosmo organizzato”, nella raccolta questo viene rivolto verso l’inciviltà dell’organizzazione, delle sue leggi, della sua burocrazia, del suo linguaggio.
E anche contro i domini che, a tutti i livelli, deprivano il sentire estetico ed etico “di bellezze o di verità”, tra i richiami ontologici, quale “un cielo. molteplicità dell’uno”, e la rivolta contro un pensiero predominante di “sub-affittanza smetafisica”. Tra i richiami alla musica contemporanea, nei suoi repertori sperimentali e nelle diverse espressioni di jazz, rock, hard rock, heavy metal, e le prese di posizione nei confronti di un potere politico che uccide il desiderio e induce alla sudditanza.
Con parole irridenti che si prendono ogni libertà di dire, per portare la ribellione, etica ed estetica, sul piano poetico. Scrive Morena Coppola: “le parole hanno arti. a volte artigli”. Non a caso si tratta allora di Ordalie: duelli giudiziari messi in atto con la forza della parola. Come, nei riferimenti anche alle figure delle carte e degli scacchi, a porre in gioco un’autentica partita sia contro le storture istituzionali, sia contro il linguaggio. Per liberarli entrambi.
_______.0. _______
[pro] [as] [tro] [logos]
-----
è il cacacosmo che si espone all'aria e non viceversa
-----
dedico questi lessemi alla baratrocrazia occultatrice della desideranza di molti polloi. con qualche discromia differenziale, connotati ricorrenti avventano historiae di minima quotidianità, inessenziale al dispiegarsi della terribilità degli eventi, eppure essenziale allo svolgersi dell’umano. uno shark acromatico pattuglia i fondali dei servizi pubblici, divorando cruores dell’utenza inabilitata a qualsiasi udienza
scaglio questi lessemi sulla baracrazia, spelunca magma d vassalloni della dominanza, flacconi a profilo carenato, cacologi di polluzioni eternamente demoniache, moscerini eccitati dal moccio, fasmidi inumati, servi di dyonisî qualsiasi, icari di terraferma. maledetti nell’uscire, maledetti nel subentrare. beccamorti, begalini, brucasorci, no ciapa musàti, cacasotto, zucabbi, imbriaghi spòlpi. non il dialetto li rende disumani
-----
asso di quadri
alcuni vani di pregio. alcuni vani di pregio esibiscono pareti con opere d'arte in vista e inventarî su targhette adesive altrettanto in vista
asso di danari 111 111 1 1 1 1 1 1 1 111 111
alcuni saloni di pregio sono di pregio. alcuni saloni di pregio attraversati da alcune persone non sono più di pregio
asso di bastoni
la capacità di imporsi si desume dai metri quadrati occupati. la capacità di imporre se stessi si desume anche dall’occupare i metri quadrati da soli o con altri
asso di cuori
porte antincendio tingono gli ambienti di un rosso dai più indesiderato. l’effetto complessivo ricorda la cardiochirurgia o la terapia intensiva. come quando vengono chiesti relazioni o report mensili, trimestrali semestrali annuali biennali pluriennali secolari, d’urgenza; d’urgenza?
----
PUNTE E REDINGOTE DI PICKWICK
\ le parole hanno arti. a volte artigli
\ intarsi ricami broccati. opus sectile su tibia e urne
\ frastagliamenti d’ufficio, autocrazia e loneliness. fashion fascism sub specie cacacosmitatis
\ metadati e data mining al centro del burrone lavorativo di amanuensi digitali
\ di pasque e natali il saluto non dipende dal grado. Pathetikformel
\ verdana rimane prediletto da oltre un ventennio, al di là dei contenti. aldilà dei contenuti
\ abbuffandosi di “cittadinanza” che mette al riparo dal fetish sado-reputazionale
\ cambio di governo. insabbiati nelle previsioni di quel che sarà del tale o di quell’altra
\ crani preistorici accapo della modernità. et in arcaicità, ego
\ attaccamenti e ardori. patres e fratres devoti all’impepata di moules. per cozza ricevuta
\ bring your own device ! build your realdoll di silicone mezzatacca !
\ pantouflage e incandescenza silenziati. occhi messi a muto. laudate dominum: a faccia mia sott’ ‘e pied’ vuote
\\ fante. ierofanti dal desiderio di picche e ripicche
\\ regina. regine in piqué di ripicche
\\ cavaliere. cavalieri di araldiche ripicche
\\ re. pareti musive rappresentano il lavoro. chiediamo udienza alla cattedra di pietro
Morena Coppola vive a Roma. Si interessa di scritture non convenzionali e di arte contemporanea. Sul crinale verbo-visuale, sperimenta linguaggi innestati nel visivo, accomunandone sguardo e lingua. Un suo testo accompagna l'immagine xilografica dell'artista Andreas Kramer per le Edizioni PulcinoElefante [2008]. Segnalata più volte al Premio Lorenzo Montano, [2013 sezione Una poesia inedita; 2014 sezione Una prosa inedita; 2017 sezione Raccolta inedita; 2018 sezione Raccolta edita]. Alcuni testi sono pubblicati in raccolte antologiche [Empiria 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018]. Nel 2016, in occasione della pubblicazione di Avrei fatto la fine di Turing, di Franco Buffoni, uno scritto critico relativo alla raccolta è stato pubblicato sul sito del poeta. Ha curato la postfazione de Il criterio dell'ortica di Stefano Mura, edito dall'Editore Manni nel 2016. La raccolta poetica Sgorbie e Misericordie di Fratelli Elettrici, finalista al Premio Bologna in Lettere, edizione 2017, segnalata alla XXXI edizione del Premio Lorenzo Montano, è risultata vincitrice del Premio letterario Formebrevi Edizioni, 2017. Finalista al Premio letterario Bologna in lettere edizione 2018. La raccolta Psychopompï è stata selezionata alla IV edizione del Premio Elio Pagliarani, sezione Inediti, edizione 2018.
Marco Ercolani, videolettura; da“Nel fermo centro di polvere”, Il Leggio Libreria Editrice 2018, nota di Rosa Pierno
Tentare la parola affinché essa si riveli, renderla spazio in cui agire. Sarà la parola, allora a convocare il mare, a generare visioni, a provocare azioni. L’io si proietta con slancio in un simile teatro, guarda le proprie visioni accadere. Il vento attraversa i secoli, persino i miti intervengono sulla pagina, il viaggio è il viaggio inconcludibile, lo stesso viaggio di tutti coloro che scrivono: “ove la rotta è un miraggio”. Tentare la parola ha qualcosa di dionisiaco. È arte dell’incanto, si vede realmente ciò che si pone sulla carta. Viene dal cielo la parola e ad esso Marco Ercolani sembra rinviarla nel suo libro di poesia “Nel fermo centro di polvere”. La scrittura è ciò che accade nel centro fermo del nulla, quando la mente è eclissata. Non obbedisce all’ordine convenzionale. È un cortocircuito di cui il poeta è il tramite: attraverso le parole il mondo intero risale, attraversa e si spande. Poesia è il centro del mondo-nulla. È sulla pagina/specchio che si può vedere il suo passaggio.
*
È la rotta dello specchio a impedirti il sonno?
Oltre il vetro dorme uno straniero.
Aspro, in piena luce, è tornato
il freddo. Abbandonato,
il corpo riscrive il suo abbandono.
Dietro le palpebre rovesci gli occhi:
ascolti, cieco, musica nuova,
bisbigliata ai prigionieri di un cielo incomprensibile.
Partiamo, il buio
non incantesimo ma guida.
Per viaggiare senza possedere.
Scrivere senza parlare.
Respirare senza promesse.
Possiamo. E il buio dell’andamento è l’unico bagliore.
Marco Ercolani (Genova, 1954), è psichiatra e scrittore. Tra le sue ossessioni l’apocrifo, il nodo arte/follia e la poesia contemporanea. Tra i suoi libri di narrativa: Col favore delle tenebre, Il ritardo della caduta, Vite dettate, Lezioni di eresia, Il mese dopo l’ultimo, Carte false, Il demone accanto, Taala, Il tempo di Perseo, Discorso contro la morte, A schermo nero, Sentinella, Turno di guardia, Camera fissa e Preferisco sparire. Per la saggistica: Fuoricanto, Vertigine e misura e L’opera non perfetta. Per la poesia: Il diritto di essere opachi e Si minore. I suoi taccuini sono raccolti in Nottario. In coppia con Lucetta Frisa cura “I libri dell’Arca” e scrive L’atelier e altri racconti, Nodi del cuore, Anime strane, Sento le voci e Il muro dove volano gli uccelli.
Paolo Ferrari, audiolettura animata, con Erika Carretta: immagini e pianoforte di Paolo Ferrari, nota di Rosa Pierno
da “I sentimenti gloriosi”, Marco Saya Editore 2018, nota di Rosa Pierno
“Sarà mai nata la parola / dal senso adeguato?” Adeguato ad esprimere “L’avvenuto probabile risveglio”. Rendere il linguaggio capace di registrare le labilissime sensazioni, le flebili intuizioni che inclinano verso uno stato differente dell’essere umano è l’impresa tentata da Paolo Ferrari nel suo libro “I sentimenti gloriosi”. È necessario un ascolto e, letteralmente, una ricreazione per giungere a tale risultato e, naturalmente, tutti gli espedienti rintracciabili nel linguaggio, inediti o inusuali che siano, possono essere utili almeno a mettere a registro la propria presunta alterità. Il linguaggio consente a Ferrari di immaginarsi in una multidimensionalità che è la cifra stessa della sua creazione, la quale gli consente di sfuggire a una realtà “già detta a priori”. L’uso di un font tipografico differente per segnalare una diversa dizione, un diverso respiro, è anche un mezzo per evidenziare alcune parole alle quali delegare la funzione di chiave di volta di tale mobilissima architettura, la quale, inoltre, grazie a spazi, cesure, incolonnamenti a blocchi, viene dispiegata da Ferrari con ricchezza barocca sulla pagina. Un dialogo s’inscena in codesta struttura, quasi un sostegno, a tratti, un imperativo che pare rivolto a se stesso. Buttare lo sguardo oltre la siepe, non fornisce risultati certi. Con ipotesi alle quali seguono domande e risposte che cercano la propria negazione, il poema si dispone non in un percorso lineare, ma, inevitabilmente, come in un cerchio di Möbius, in cui si può perdere anche se stessi o ritrovare il proprio sconosciuto essere.
Il risveglio
Ho sentito che s’era smarrito
in quell’ora che indica il risveglio
del corpo
assonnato. la memoria ricomposta
a metà,
pronta a ripetere (a memoria) la
Vita che rimanda
per una volta a sé.
L’io e l’altro
Ma l’Altro è Altro?
Ma l’Altro è la morte?
un’altra volta già accaduta?
Non ci pensai su
è già fui morto
potendo pensare alla
sorgente d’un me
sconosciuto
Paolo Ferrari : umanista scienziato, è fondatore e presidente del Centro Assenza di Milano. Esordisce nel 1978 con il romanzo Paolo e il suo compagno senza morte
(Apollinaire di Guido Le Noci]. Vince il Premio Lorenzo Montano nel 2008 con Saggio-poema del pensareassente e nel 2013 con la prosa Memorie d’inciampo . Del periodo 2013-2016 la raccolta di poesie I colpi del-Nulla. Poesie dell’Inconoscibie. Con il segno—(meno) e il poema scientifico De Absentiae Natura. intorno alla nascita d’altro Universo (O barra O). Nel 2018 l’opera in prosa OpusMinus – 0.
Giovanni Infelìse, videolettura; da “Per ordine di indefinita vita”, Italic 2019, nota di Rosa Pierno
L’attenzione di Giovanni Infelìse per la danza delle forme, i mutamenti della sostanza, i colori, i suoni si tramuta per il lettore in un fantasmagorico ambiente, ove quest’ultimo si accinge ad abitare un’atmosfera del tutto al di fuori dell’ordinario. L’orizzonte di riferimento è la poesia di fine Ottocento con il suo vitale interesse per le soglie fra il visibile e l’invisibile. I riferimenti concreti, infatti, sono sempre virati verso un luogo esclusivamente metafisico, ove risalti l’artificio letterario: “tra macerie che redigono / acronimi di impervi luoghi” come a trarre da esso la propria validità o in ogni caso, affermare che la vera realtà è al di là dello specchio. Estetico è il cuore della silloge “Per ordine di indefinita vita” alla quale Giovanni Infelìse affida la descrizione delle sue percezioni e dei relativi pensieri, indicando con nettezza che oltre l’abbraccio, la presenza carnale, per lui, molto più importante è il campo del non visibile.
*
Si dipinge l’ordine confidenziale del movimento
non il suo aspetto estenuato e immobile
– la pittura rende l’artista veritiero in una piccola
parola che l’occhio restituisce nel vedere
il suono dell’anima e la forma di ciò che non appare
e si dona nel colore di una nota, rivelandosi
in un tempo mutevole che continuamente è in ogni
istante e fra le cose dove una volta almeno s’accende.
Giovanni Infelíse è nato a Cosenza nel 1957. Ha pubblicato Sfero (1987), Zèfiro (1989), Sotto la luna (1991), Cuora tremula (1992), Canti dell’amarezza (2001), L’isola senza desiderio (2006), L’ultima dimora (2007), Dépassé (2011), Per ordine di indefinita vita (2019). Si occupa di critica letteraria. Suoi scritti sono apparsi su riviste. Ha scritto per il teatro. Nel 1995 ha pubblicato un saggio dal titolo La voce imperfetta: il poeta e l’inquietudine della parola. Vive e lavora a Bologna.
Maria Grazia Insinga, videolettura; da “Tirrenide”, Anterem Edizioni 2020, nota di Giorgio Bonacini
Una delle caratteristiche proprie della poesia è l’andamento sonoro che ne scandisce il tracciato, qualunque esso sia: lineare, accidentato, spezzato, in una struttura lirica o poematica. Ma questo, che sembra un’evidenza naturale, implicita e assodata del “dire in versi”, in realtà non è affatto scontata nella sua valenza profonda. Ed è proprio questa difficoltà (felicemente attiva, possiamo dire) a dare, con i suoi tratti distintivi mai univoci, particolari e indefiniti sensi a ogni esperienza di scrittura. La raccolta di Maria Grazia Insinga nasce e si sviluppa dentro un’architettura che non disgiunge suono e senso: anzi, li incrocia e li annoda in un movimento che porta la parola a “precipitare” dal “dirupo fonetico”, dove il corpo-fonema (così l’autrice sembra indicare la poesia che si fa verso anche dal nulla) senza mai distruggersi, si disgrega e si riforma, aggiungendo continuamente, all’intimità dei suoni, un accadimento impensato: l’apparizione pura e vitale di qualcosa che sembra inidoneo o sbagliato, mentre è, nella sua essenzialità, un refuso mistico. Un ritmo incongruo che nel suo errare (a volte in linea, a volte claudicante) all’interno del poema, arricchisce un dire che tende alla non-perfezione. A un’esistenza, cioè, in continuo cambiamento inaspettato, dove “il vero pensiero è...cedere al sogno” la sua forma e la sua facoltà. Perché la poesia è sempre discontinuità. Non è mettere ordine nel caos, bensì attingere da questo modulazioni e sommovimenti per “incendiare la voce”.
Dalla sezione Le tuffatrici
l’altra cavalca su posidonie
in una regione del cervello piena d’acqua
e cavallucci microscopici non è udibile l’udibile
di questa musique à boire rumore bianco e bianco
mangiare la parola è qui cosa è presenza non quella
giusta né la soluzione né idea di luce perché qui
tutto è nuovo nulla ripete e nulla è in vita grazie a dio
*
e dall’infinito areale un corteo di posidonia sbuca
mostruose evoluzioni di unicorni e sirene in miriadi
di ippocampi la cui polvere è cura è linea di flusso e luce
tra opera viva e opera morta pinne dorsali disseccate
rapidissime farfalle cavalcatura e guida dei mostri
*
tutto di mala faccia da per tutto
ingoiare la gola a imbuto e lei
ci passeggia sopra su in strada
per tirrenide il viaggio è già
compiuto e alza lo scirocco e
il pianeta è perfetto sto per
sto per morire e tu parli parli
Dalla sezione Il sonno
si fa parte da svegli
dello stesso sonno
e al risveglio tutto è lì e tutto è
come sembra e ripopola tirrenide
o era insonnia? e il sonno
si appropria di tutto anche nulla
e del tempo insonne in tempo
sempre il tempo va a tempo
*
fa parte almeno da dormienti
del tuo stesso sogno? non credere
ognuno va a credere di nominare
ma non è non è per nulla il caso
Maria Grazia Insinga, siciliana (1970), dopo la laurea in Lettere moderne, il Conservatorio e l’Accademia musicale si dedica all’attività concertistica. Nell’ambito degli studi musicologici censisce, trascrive e analizza i manoscritti musicali inediti del poeta Lucio Piccolo. È docente di ruolo presso l’Istituto “G. Verga” di Acquedolci dove insegna Pianoforte. Nel 2014 idea La Balena di ghiaccio, il premio di poesia per i giovani in memoria del poeta Basilio Reale. Nel 2019 idea il Premio Lighea – sostenuto dalla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella – per fare poesia con gli studenti delle scuole. Ha pubblicato libri di poesia: Persica, vincitrice del concorso “Opera prima” (Anterem, 2015); Ophrys, finalista al XXX “Premio Montano” (Anterem, 2017); Etcetera, leporello in versi illustrato da Alessandra Varbella (Fiorina, 2017); La fanciulla tartaruga, carnet de voyage illustrato da Stefano Mura (Fiorina, 2018). Alcuni testi in versi si trovano in riviste e antologie: Il rumore delle parole a cura di Giorgio Linguaglossa (Edilet, 2014); Blanc de ta nuque vol. II a cura di Stefano Guglielmin (Le voci della luna, 2016); Umana, troppo umana a cura di Fabrizio Cavallaro e Alessandro Fo (Aragno, 2016); Punto. Almanacco di poesia a cura di Mauro Ferrari (puntoacapo, 2017); Osiris Poetry n. 84 (Andrea and Robert Moorhead, 2017); Trivio. Polesìa vol. IV a cura di Ferdinando Tricarico (Oèdipus, 2017); Il corpo, l’eros a cura di Franca Alaimo e Antonio Melillo (Ladolfi, 2018); Fuochi complici. Saggio di critica letteraria di Marco Ercolani (Il Leggio, 2019); Sicilia. Viaggio in versi a cura di Lorenzo Spurio (Euterpe, 2019). Nel 2017 con Historica edizioni pubblica in Itinerari siciliani (a cura di M. A. Ferraloro, D. Marchese, F. Toscano) un saggio, “L’ondina siciliana e il sortilegio della voce”, sulle sirene viste attraverso il racconto di G. Tomasi di Lampedusa, La sirena. Nel 2019, la raccolta in versi Tirrenide vince la XXXIII edizione del Premio Lorenzo Montano.
Francesco Bellomi, brano originale per Maria Grazia Insinga
Antonella Lucchini, videolettura-presentazione; saggio inedito “L’opera d’arte come affermazione...", nota di Mara Cini
L’opera d’arte come affermazione del proprio sé: Flaubert e Van Gogh
L’opera d’arte come l’uovo dischiuso dell’inconscio. I segni e il loro bagaglio, siano essi colori o parole, sono frutto del nostro albero interiore e dei suoi fantasmi. Chi ha il dono della creatività, chi riesce a produrre arte, che sia pittura, letteratura o poesia ha il potere, come disse Paul Klee, “di rendere visibile l’invisibile”, di tradurre la lingua dell’inconscio in espressioni grafiche. È necessario fare atto di disambiguazione. Per affermazione del proprio sé, qui non si intende discutere della questione se l’autobiografismo sia un peccato, una colpa, un’omissione di modestia, ma sull’importanza che l’opera artistica può costituire nei casi in cui l’uomo o la donna artista patisca di una qualche mancanza affettiva o di un disagio (non necessariamente psicotico), ricordando che, come ebbe a scrivere Giacomo Leopardi in un’accorata e orgogliosa lettera al padre Monaldo, nel luglio 1819 “…e perché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione…”. Gustave Flaubert e Vincent Van Gogh, l’uno scrittore l’altro pittore, sono accomunati dalla stessa “patologia affettiva”: l’assenza del nome del padre o, per dirla con Lacan, la forclusione del nome del padre.
Flaubert nasce come secondogenito di Achille, un rinomato chirurgo di Rouen. Il primo nato, Achille, verrà avviato dal padre alla sua stessa carriera, come proprio clone: stesso nome, stessa professione, così da tramandare l’eredità paterna. La moglie, desiderosa di avere una figlia femmina, anche per poter riscattare la propria esperienza traumatica (la madre era morta dandola alla luce), attende con ansia i 9 mesi della gravidanza successiva. Nasce Gustave, il non previsto, il non atteso; Gustave che doveva essere femmina. Dopo qualche anno, finalmente arriverà l’ agognata figlia. Ricapitolando schematicamente: il primo figlio è il prediletto del padre, colui che traghetterà il nome e il cognome ai posteri, la terza sarà tutta a disposizione della madre. E Gustave? Si troverà nella terra di nessuno, con un nome che è un significante riempito da nulla: niente considerazione, attenzione, insegnamenti, rispetto per l’unicità individuale. Si vedrà più avanti, con l’esempio di Van Gogh quanto sia devastante avere un nome vuoto. Per tornare a Flaubert, la mancanza del riconoscimento di figlio atteso (elemento fondamentale per la crescita sana e consapevole del bambino) lo porterà a definirsi, all’età di sedici anni, delicata età di passaggio, come un “fungo gonfio di noia”. In questo ambiente anaffettivo si sviluppa l’idiozia di Flaubert, che Sartre prima e Jacques Lacan dopo definiranno bêtise. Veniva considerato il giullare della famiglia (atroce lo scherzo di uno zio che gli chiedeva: “Gustave, vai a vedere se sono in cucina.” Il bimbo correva a sincerarsi, tra le risate dei presenti, e al suo ritorno ovviamente rispondeva “No, zio, non sei in cucina”). Lui, l’idiota, lo zimbello, diventerà un genio della letteratura: tanto quanto la sua vita è stata imperfetta, informe, la sua scrittura sarà una magnifica perfezione, creerà una nuova forma di romanzo. Attraverso di essa, Flaubert si darà dunque un nome, un’identità, un valore. Affermerà il proprio sé. E come non leggere in quel “Madame Bovary c’est moi!”, anche il suo grido di affrancamento da una condizione di sottovalutazione?
Biografia sconvolgente quella di Van Gogh. Nasce il 30 marzo 1853, a un anno esatto dalla nascita/morte del fratellino Vincent. Se Flaubert è il figlio non atteso, Van Gogh è un bambino desiderato ma solo ed esclusivamente perché deve sostituire il fratellino morto. La coincidenza terribile della sua data di nascita con la data della morte del primo Vincent, suggerisce al padre pastore protestante il macabro rituale di portare Vincent, ad ogni compleanno, a visitare la tomba del fratellino. Così Van Gogh vede il suo nome e la sua data di nascita su una tomba: si vede morto. Figlio sostituto e figlio che festeggia il compleanno in un cimitero. La questione del nome proprio di persona va ovviamente al di là delle mere circostanze burocratiche: dare un nome al figlio significa non solo riconoscerlo come frutto del proprio sangue ma lo iscrive all’ordine simbolico della famiglia prima e del mondo poi, cosicché lo identifichi come individuo unico con le sue specificità e caratteristiche. Come ricorda Massimo Recalcati in Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh “Nel caso di Vincent Van Gogh il nome proprio, anziché sancire questa iscrizione, svolge piuttosto la funzione di alienarlo nel nome di un altro negandogli ogni iscrizione simbolica nel campo dell’Altro”. Questa condizione lo porterà, giocoforza, a non trovare il proprio posto nel mondo (al fratello Theo scriverà di sentirsi “un cane randagio”) e a sviluppare una melanconia che lo accompagnerà per tutta la vita fino a degenerare in uno scompenso psicotico che lo porterà al suicidio. La pittura è il tentativo di dare un senso al suo esistere, di darsi un’identità; lui, caduto nelle tenebre, cerca ossessivamente la luce; il suo vagabondare dal nord al sud della Francia, è percorrere la strada verso la luce, verso l’intenso sole meridionale, perché il Sud è la vita, per lui che è stato un bambino sostituto di un bambino morto, e egli stesso morto in vita. Un viaggio che si rivela anche attraverso le tele, attraverso i colori che si fanno via via più carichi, più chiari. Afferma il proprio sé, il proprio nome attraverso la sua opera diventando, in qualche modo, padre e figlio di sé stesso.
***
Cosa è dunque l’opera d’arte se non un contenitore di spasmi, emozioni, deliri, sogni? Quale grande grazia è poter riscattare, per suo mezzo, una biografia deludente e sofferente? Benedetta sia la reciprocità della relazione tra l’artista e la sua opera, per cui egli la crea a partire dalla propria biografia zoppicante e lei ricambia donando in ritorno una cura, i centimetri che mancano.
L’opera d’arte è figlia generosa che restituisce.
Secondo Lucchini, nell’opera d’arte possono riscattarsi eventi irrisolti o traumatici della propria biografia zoppicante. Del resto gli studi sulla cosiddetta sindrome degli antenati e la psicoterapia transgenerazionale analizzano proprio questi fenomeni.
In certe “ferite famigliari”, nell’ordine simbolico dei nomi, nelle fessure della propria imprecisa identità può inserirsi, come “cura”, l’espressione artistica con risultati tanto più alti, a volte, quanto più profonde furono le ferite.
Vedi per esempio, Flaubert e Van Gogh.
Antonella Lucchini nasce a Mantova, dove tuttora risiede, nell’aprile del 1964. Agli inizi del 2013 pubblica la sua prima raccolta di poesie, Tra morsi e strida, per la casa editrice REI, seguita da Il margine bianco (Ed. Divinafollia).
Ad aprile 2017 esce la sua terza silloge poetica, Il Femminino e la sua voce (ed. Il Seme Bianco - Castelvecchi).
Scrive, oltre che in italiano, anche in francese, inglese (lingue di cui è anche traduttrice) e in dialetto mantovano cittadino.
È redattore del sito di recensioni librarie Mangialibri.
Giulio Maffii, audiolettura su immagine; dalla raccolta inedita "Uno Stato di orgasmo apparente", nota di Laura Caccia
Fuori copione
Quasi la messa in opera di una sceneggiatura, la raccolta Uno Stato di orgasmo apparente di Giulio Maffii. Nell’evidenziare come tutto venga dissimulato da finzioni e ipocrisie, maschere e simulazioni, ruoli e copioni. E nel dispiegare un pensiero addolorato per la condizione umana che, in apparente stato di eccitazione e di frenesia, occulta in realtà un profondo disagio.
“C’è sempre un ruolo un copione da seguire”, scrive l’autore. Un copione che interpretiamo a livello individuale, in un gioco continuo di maschere, sul confine labile tra reale e finzione. E che recitiamo a livello sociale, dove tutto in apparenza si muove freneticamente, in un fermento continuo, pulsante tra la vita e la morte. Dove infine si esce bruscamente di scena e la morte è reale, in guerre lontane e vicine
Il linguaggio si fa carico del senso di frustrazione e di amarezza che ne consegue, come evidenziano le frasi in sospeso e i tanti inizi con lo sconfortato “che”: “che pure non c’è altro”, “che viviamo affollati in mezzo al niente / gli dei hanno voltato l’angolo”, “che non c’è uomo / senza balbuzie d’identità”.
E il poeta? Anche lui apparenza e finzione? Anche se, rileva Giulio Maffii, la stessa “lingua si ritrae”, è la parola poetica che consente di togliere la maschera, sollevare il velo della finzione. Con una parola libera, anche se amara. Con una parola che si muova fuori copione.
Dalla sezione Copione
l’affogato nella carta dei tarocchi:
Gli indomenicati dal volto di sorba
potrebbero ricordarsi di tanto in tanto
di essere felici perlomeno unici
Silenzio un atto di intimidazione
-non siamo necessari al mondo-
Lo sguardo è così pieno di debiti
C’è sempre un ruolo un copione da seguire
tranne poi depistare le reliquie
dentro a un figlio o a un videogioco
Queste righe mi si fanno fuoco
Dalla sezione Congiunzioni
che pure non c’è altro
che la sottrazione è un metodo
necessario
che nessuno è venuto al mondo
per sua volontà
(quel che fa dolore
non esiste)
[oh sì felicità raggiunta
si cammina sempre
su qualcosa che puzza]
-----
che tra poco saremo corteccia
che ci nasconderemo come luce
nell’antebuio di una stanza
o di una gabbia toracica
che non c’è uomo
senza balbuzie d’identità
-----
che al supermercato si sentono discorsi
-che poi lui che ero io
mi stava uccidendo-
non pesava la morte
[ al chilo a saldo potendo ]
senza maschera ho visto
il volto che non era il mio
Dalla sezione Orgasmo apparente
che la gente muore davvero
e si divora l’un l’altro con gusto
mentre il silenzio impiglia
lo spreco di persone che abbiamo vissuto
la testa nel canotto rovesciato a pelo d’acqua
che non dovevano stare attenti soltanto alle meduse
che sottovoce facevano il segno della croce
-----
[che la gente muore davvero per quieto non vivere]
Giulio Maffii, docente, scrittore e critico, ha diretto la collana di poesia contemporanea per le Edizioni Il Foglio. È capo redattore della testata giornalistica “Carteggi Letterari”. Suoi lavori sono stati tradotti in spagnolo, inglese e romeno. Nel 2013 è uscito per Marco Saya Edizioni il saggio breve “Le mucche non leggono Montale”. Nel 2014, dopo aver vinto il Premio Internazionale Castelfiorentino con “Arische rasse – Novella di guerra”, ha pubblicato per Marco Saya Edizioni “Misinabì” sui miti della morte degli Indios Taino. Sempre nel 2014 un suo saggio “L’Io cantore e narrante dagli aedi ai poeti domenicali: orazion picciola sulla parabola dell’epos” è stato pubblicato da Bonanno Editore. Nel 2015 il poema storico “Il ballo delle riluttanti” per Lamantica Edizioni e nel 2016 “Giusto un tarlo sulla trave” per Marco Saya Edizioni. Nel 2018 “Angina d’amour” (Arcipelago Itaca ed.) In corso di pubblicazione gli interventi tenuti tra il 2017 e il 2018, uno nel congresso “Identy agonies” svoltosi a Padova, l’altro per l’Archivio per l’antropologia e l’etnologia, dal titolo “Con i piedi in avanti”: la lunga passeggiata di antropos e thanatos tra poesia e vizi simili”.
Fa parte dell’associazione Pallaio per gli studi antropologici e multidisciplinari di Firenze. È docente di storia contemporanea del corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza presso l’ISP di Firenze.
Roberto Minardi, audiolettura; poesia inedita “Mare”, nota di Ranieri Teti
Un mare totale, questo raccontato da Roberto Minardi. Un mare senza coordinate geografiche né denominazioni. Un mare che diventa “il” mare, quello che nessun obiettivo fotografico potrebbe riprendere, che solo un poeta può cogliere, che solo un poeta può descrivere in un preciso, esattissimo momento: quando contemporaneamente vede, sente e media nel pensiero. E articola nella memoria.
La lettura di questa poesia è sia orizzontale che verticale.
Nell’orizzonte compaiono immagini in serie, che potrebbero essere colte in qualsiasi battigia, in qualsiasi luogo del mondo. Con la particolarità di un doppio registro: Minardi mescola versi alti, anzi, altissimi, a versi volutamente caratterizzati da un linguaggio basso; come se anche nell’orizzontalità ci fosse una verticalità. Quando scrive “per credere nei secoli c’è il mare” fa precedere questo verso da “pernacchie al largo”. La cartolina che riceviamo è frammentata, si compone di tante varie immagini: l’autore gioca con noi mediante voluti inciampi, sdrammatizza, evviva, il concetto di poesia, riesce con piacere suo e nostro a rendere paritari la “plastica” e il “ragionamento”, un “galleggiante” e un’”isola”.
La verticalità invece produce una vertigine. La cartolina che riceviamo dal mare è un interno domestico. Racconta che l’idea del mare è dappertutto: affonda nell’infanzia, resta impressa, diventa mondo riproducibile ovunque ci siano acqua e fantasia, per l’eroe del lavabo, l’irriducibile pescatore allo specchio. Non ci sono confini, né età, se siamo poeti.
Mare
cuore di spadaccino che mai trafiggerebbe
perlustra la battigia con amore, a mani vuote
raccoglie un flacone ammaccato
così forte è la luce che l'azzurro della plastica sbiadisce
ogni tinta scolora, ogni ragionamento scioglie
con le orme dei suoi più che bianchi piedi prosegue
così facendo trae in salvo il mare, la terra
è la mobile arena che l'andamento storce
affossa le caviglie dell'uomo dell'urbe
lascia la ferocia dei raggi fare il corso che deve
oltre la storia uno scafo compie un mezzo cerchio
le sue pernacchie al largo spadroneggiano
per credere nei secoli c'è il mare, un galleggiante rosso
si affaccia da un triangolo di luce che scoppietta
non resta che tacere, in controluce squaglia ogni certezza
la barchetta nel lavandino colmo dell'infanzia
pescava pesantissimi tonni il lupo di mare
sognarsi isola e non robot, eliminare la rissa dal petto
ed un granchio attende che lui se ne vada prima di sbucare
l'essere umano non possiede serietà.
Roberto Minardi (Ragusa, 1977). Nel 1999 si è trasferito in Inghilterra, a Londra, dove risiede tuttora lavorando come insegnante di lingue. Ha pubblicato le raccolte Note dallo sterno (Archilibri 2007), Il bello del presente (Tapirulan 2014) e La città che c’entra (Zona 2015), segnalata al Premio Montano l’anno successivo. A questa raccolta è ispirato il mediometraggio The city within, realizzato in collaborazione con il regista Tomaso Aramini. Oltre che in volume, suoi testi sono apparsi su riviste, antologie e litblog. È co-fondatore del progetto poetico dopotutto [d|t] che si occupa di scrittori e scritture del 'dispatrio'.
Loredana Prete, audiolettura, con animazione di Pedro Schavemaker; dalla raccolta inedita "Omphalos", nota di Laura Caccia
Il centro di tutto
A quale ombelico, centro del tutto o dell’esistere, tra sensi e materia, chimica e mito, ci conduce Omphalos? In questi versi, dal titolo oracolare, che richiama la pietra scolpita di Delfi, dell’oracolare non hanno il profetico, ma il senso profondo suggerito dal termine, che etimologicamente conduce al dire.
Il centro di tutto è l’oracolo, colui che ha parola. Il centro di tutto è la parola.
Come, narra il mito, a determinare il centro del mondo Zeus liberò due aquile che, volando in direzioni opposte, si incontrarono a Delfi, così appare in questi testi il perno tra due diverse polarità: da un lato, l’universo, gli spazi siderali, la materia nei suoi aspetti fisici e chimici; dall’altro, l’esistere umano, i suoi miti, le sue percezioni sensoriali, il suo sentire desiderante. Due mondi che hanno un punto comune, un ombelico insieme di materia e di senso.
Ogni parola, concentrata e lieve, scossa e tellurica, nel disporsi isolata e raccolta sulla pagina, si fa ombelico, centro del proprio universo, frammentato, dissolto, a volte riunificato: “Spezzati / nodi / Cristallizzano / Sincopi”. In grado, da questo centro e coinvolgendo ogni aspetto del sentire, di irradiarsi come riverbero e vibrazione fino ai territori ignoti del mondo, fino all’inconosciuto del dire.
1.
Inopinate
Pungenti
Poliedriche
ecchimosi
Sfuggono//
Oltraggiano//
Assiderano//
Esplosioni di nuvole catodiche
3.
Muoiono larve
in
Asincronie
Velate//
Spezzati
nodi
Cristallizzano
Sincopi
7.
Canto
voci
Solo voci
Silenzio corrotto
viaggi siderali
Solstizio
Di spiriti
imprigionato in asfissie
17.
sonniferi
Satira di rugiada
Condensa
Vibrazioni di
ciclonici
Universi paralleli
29.
idrogeno
liquido di anime
foglie//
sangue
scalpiccio
quadrato poligonale
impastato
a notte
Loredana Prete, nata a Brindisi (7 giugno 1978) e vissuta a San Vito dei Normanni fino all’età di 19 anni.
Ho conseguito i miei studi universitari a Lecce (Economia e Commercio, tesi dal titolo “Il mercato dell’uranio”; specializzazione di matematica applicata alla finanza).
Dall’età di 27 anni sono emigrata prima in Francia, poi in Lussemburgo, dove attualmente vivo.
Le mie poesie sono evoluzione, decomposizione, silenzio e spasmi, purificate, essenziali.
Poesie:
- Caustico Tocco (2004)
- Chi sei (2004)
- Endorfina (2004)
- Solstizio Alcalino (2004)
Raccolte di Poesie:
- Latitudine 49° 7’ 13,08” N Longitudine 17° 42’ 0” E (2005-2012 raccolta di 365 poesie, classificate per mese, scandiscono un periodo; scritte tra Metz e il paese natale, San Vito dei Normanni; un viaggio attraverso i sensi, le disillusioni, le paure, le sensazioni. L’incontro con ricordi; la latitudine è quella de Metz, la longitudine quella di San Vito dei Normanni).
- OSSA (2013)
- LIQUIDO (2014)
- AERIFORME (2015)
- SOLIDO (2016)
- ORBITALE (2017)
- OMPHALOS (2019) – autrici Chiara e Loredana Prete
Antologie:
500 poeti dispersi, Libro secondo, AA.VV., Edizioni La Lettera Scarlatta, ISBN 978-88-908601-8-8
Habere Artem vol.16, AA.VV., Aletti Editore, ISBN 978-88-591-1399-7
Segnalazioni:
-27° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “Raccolta inedita“ con la raccolta di poesie intitolata Novembre.
-28° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “Raccolta inedita” con la raccolta di poesie intitolata Liquido.
- 30° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “ Raccolta inedita” finalista con Orbitale.
Conferenze:
L’8 marzo 2013 partecipazione come autrice alla giornata poetica “Sbatte l’aria. Era una vanessa!”. (Università di Lussemburgo - Les lettre romanes – section italienne. L’incontro fa parte del progetto di ricerca del TIGRI – Textualité des Italiens de la Grande Région et Intégration).
Racconti:
- Adele (2010)
- La messe rouge (2010)
- Iadava (2010)
- Accidia (2011)
- il vento di Cordoba (2011)
- Purificazione (2011)
Sceneggiature:
- Sogni in penombra (il cortometraggio ha partecipato al Festival Internazionale Cortometraggio Salento Finibus Terrae).
Maria Pia Quintavalla, audiolettura; prosa inedita “La tragedia di Augusta”, nota di Mara Cini
La tragedia di Augusta
I pesci scappati dal fondo del mare impazziscono come asteroidi in forze centrifughe, ma dividendosi esplodono divergono tuttavia in lampi, come luminosi spazi, da entità marine stellari. Le assi diagonali in legno sembrano già fradice da notti, se hanno bevuto tutta quest'acqua e la trattengono; da questi legni fessurati dall'acqua. Da questi tagli uno strano mormorio di attese sembra salire e alludere a un intrecciarsi anche là dentro, ai gesti: del povero cibarsi, e dei corpi, ma poi deposti e abbandonati, poi enfiatisi nell' acqua, che si avvinghiano. Chi può vedere da quale occhio celeste vivente l'intreccio, non ancora marcescente ma mobile, e quasi di gomma, di bocca e piedi, di teste annodate che cercano di separarsi dal blocco che fu di carne. Ma questo ultimo è nascosto dalla fuga dei pesci. il fetore è nascosto o velato dalla fuga dei pesci. Le grida indisseppellite, ad oratorio, ecco sono nei gesti di abbraccio, un poco come nelle camere pompeiane finite sotto la cenere. Mi avvicino, lentamente, e guardando da una fessura, un sottile taglio come l'interno del legno, subito ammollato e marcito, che mi fa intra sentire intra immaginare, e vedere infine il groviglio dei corpi, intrappolati come acini di un frutteto divino.
Ma io lo vidi già, era narrato, fin da bambina, nella corona di nudi e angeli della Cattedrale di Parma, disegnata e dipinta nella visione di Antonio Allegri, detto il Correggio, e questa è una simile ascensione, ma orizzontale, dove tutti cercano spazio, e lo comprimono anche, tutti, e si disperdono, anche alla fine. Materia nel liquido, carne che fu ossa e sangue e non gomma, e non blu morte ma vita, delicatamente corpi sacco, velati dalle acque, lì sprofondati e che l'hanno bevuta fino al punto della terra un equatore zenith, dove eravamo oceano su oceano. Una forza centrifuga, a onde, disegna un movimento come cullato, una leggera distonica musica spezzata: sono i morti, i semplici (e bellissimi) morti che volano nel cielo delle acque profonde, al largo della costa libica, nel blu scuro e macchiato di morte, del mare Mediterraneo. Quelle dita tumefatte hanno perso escrescenza, dopo che reso molle e gommoso lo scheletro tutto, ma non hanno esaudito un destino, o l'hanno fermato alla domanda impigliata nell' enigma dei gesti, nelle strette ultime dei tumefatti: queste voci sono nella gola del mondo. E loro: gli afflitti, i perseguitati, gli assetati di giustizia, lo hanno sottovalutato troppo il peso del mondo, questo peccato dei poveri di spirito. La potenza della realtà che sconfigge il loro atavico, il loro grande - di già perduto – sogno di vivere nella vita, la propria vita. Vivere nella pace l'esistenza di sé, e dei propri figli. nella onesta ricerca di un lavoro una casa una patria terra. In un esodo non scelto, ma dovuto alle guerre, alle carestie, alla fame ed alla predazione.
Ora, questo immenso camposanto è marino, l'assenza di pietà umana ha scelto il colore dell’acqua per manifestarsi, un cielo capovolto e profondo pieno dei pesci ora in frotte, ora in fuga. Secondo le parole di Papa Bergoglio questa è la bancarotta dell'umanità che non ha trovato per ora, salvatori e salvezza. "All'interno del relitto, secondo quando accertato dalla Marina italiana, sono stati recuperati :458 corpi senza vita; a questi ne vanno aggiunti altri 169 raccolti sui fondali circostanti altri 48 ritrovati, che si avvicina molto alle 700."(Corriere della sera, 16 luglio 2016, Claudio Del Frate). Ma la scoperta che in cinque, in piedi, stavano in poco meno di un metro quadro disegna bene il come.
Hannina e Omar viaggiano da due lune e imprecisati soli, hanno poco alla volta smesso di parlare, e raccontarsi a parole nell' intreccio delle mani; a sera, quando il vento è calato e l 'acqua del mare da bere è stata sostituita dall' urina, e dal succhiare vecchie bucce sudice, che erano già seccate, o la pelle di frutta. Il loro silenzio è più soave dei pasti infetti della fame, croce che sta dentro il corpo e lo taglia in parte muta e parte che emette strano risucchio, doloroso sempre; i pasti dei bambini e dei più vecchi, non ci sono più né come favoriti né come protetti; né quelle donne che come vele si alzano, da accovacciate e strette, e solo a volte attaccano al nero dei capezzoli i loro piccoli, ma senza cavarne nulla.
Quando la luna si stacca dal fondo del mare, e sorge, è splendente anche per quelle anime di disperazione, e il vento le illumina, lente ombre di tenerezza. Conosciute nella vita dapprima, e sole, era tutto diverso, erano giovani erano vecchi, erano uomini nel fiore degli anni, erano coppie come Hannina ed Omar, e camminavano, avevano strade bianche e sabbiose o piene di terra, camminavano. La secchezza e il non farsi più domande ha fatto posto al miraggio di silenzio e alla rassegnazione. In realtà silenzio non ce n'è mai abbastanza, fra il rumore di acque irreali e immobili e dei venti, delle scie del barcone che trascina sé e loro, noi tutti e nessuno, esclusa questa notte al termine della notte... Gli accenti di tutte le lingue si fondono in un salmo.
Che succede. Staremo qui? ma no, era solo una pressione fra l'aria e il carburante, chi l'ha detto. Perché quel ragazzo piange allora? Ma lo vedi quel punto sotto la luna. È una barca chiede Amina. Ashef batte le mani, ha quasi dieci anni, se è una barca ci salva e ci porta in Italia, vero? No, non lo sappiamo e non ci sono barche qui vicino, risponde la madre.
Non è nessuno, dice Mohammed, è una stella, e tu stai male, vai a dormire. Chi dorme mi stringe un osso della mano fino a farmi malissimo, ma non la sento.
***
Quintavalla è vincitrice del Premio Montano 2019 per la prosa con un testo che già era risultato tra i finalisti in una precedente edizione.
A volte succede. Capita tra le mani qualcosa che abbiamo già letto e ci sembra più lucido, più necessario, più prezioso.
Può essere per quei pochi refusi corretti, per quella disposizione grafica appena ritoccata? O per quella silenziosa insistenza dell’autore e del testo stesso a chiedere ancora attenzione?
Può essere.
E’ lo stesso testo, lo stesso affresco ma lo leggiamo con più riguardo.
Un affresco dalle tinte bluastre, un immenso camposanto marino dove le forme della morte, nell’incessante trasformazione delle cose, diventano di nuovo vita. E’ una vita liquida, germogliante, vibrante nelle correnti profonde di acque ascensionali, in una vertigine che avvolge.
Certe disperate vicende, nella cornice del racconto, luccicano di sacralità e bellezza (donne che come vele si alzano, non è un Compianto di Jacopo della Quercia? morti che volano, non è una scena del Correggio nella Cattedrale di Parma?).
Sono notizie di migrazioni e naufragi che i reportages giornalistici non riescono a descrivere nella loro portata tragica, Quintavalla le ricompone in un contrappunto di immagini fluide attraversate da musica e silenzio, acqua e siccità, luce e buio dove gli accenti di tutte le lingue si fondono in un salmo.
Da qualche parte Maria Pia Quintavalla ha parlato di una sua lingua apneica, una lingua “d’emergenza” e una scrittura che mi sembra ritrovare in questo testo.
Maria Pia Quintavalla è nata a Parma e vive a Milano. Ha pubblicato i libri di poesia: Cantare semplice (Tam Tam, 1984), Lettere giovani (Campanotto, 1990), Il Cantare (Campanotto, 1991), Le Moradas (Empiria, 1996), Estranea (canzone) (Piero Manni, 2000, prefazione di Andrea Zanzotto), Corpus solum (Archivi del ’900, 2002), Album feriale (Archinto, 2005), Selected poems (Gradiva N.Y., 2008), China, (Effigie, 2010), I Compianti (Effigie, 2013), Vitae (La Vita felice, 2017), Quinta vez (La collana, Stampa 2009, 2018). Sue poesie sono presenti nelle antologie: Trent’anni di novecento (a cura di A. Bertoni, Book, 2005), Passione poesia (CFR, 2017). Ha vinto numerosi i premi, tra i quali: Tropea, Città S. Vito, Turoldo, Cittadella, Alghero donna, Marazza, Nosside, Alto Jonio, Dario Bellezza, Alda Merini, Città di Como, Europa in versi; nel 2000 è stata finalista in cinquina al Viareggio. Dal 1985 cura la rassegna Donne in poesia e le sue antologie; in seguito proseguita nelle rubriche: Le Silenziose (Book City, Milano), Muse, Autori, Resurrezioni (Casa della cultura, Milano), Essere autrici / essere curatrici. Ha curato il convegno Bambini in rima (Atti su «Alfabeta» 1987). È docente presso l’Università degli Studi di Milano, con laboratori di lingua e scrittura italiana. Sue poesie sono state tradotte in numerose lingue.
Francesco Bellomi, brano originale per Maria Pia Quintavalla
Claudio Salvi, audiolettura con testo; dalla raccolta inedita “Sequenze”, nota di Giorgio Bonacini
La scrittura di Claudio Salvi si presenta in parole nella loro nuda sostanza, avviate verso un percorso che intreccia (con valore esclusivo) il rapporto tra lingua e cosa. Ma ciò che si evidenzia è molto di più: il pensiero che scrive conosce solo l’essenzialità del dire, la sua denotazione libera da ogni sintagma troppo articolato. La parola vuole essere solamente se stessa in quanto cosa. Ma questa apparente semplicità ha bisogno di una concettualità stringente, che affonda all’ interno di una coesione che “afferra con le dita ogni non detto”. Perché al di fuori della lingua che si fa cosa resta solo un senso in-significante del “come se”. La voce dell’autore agisce grazie ad attrazioni minime dove lo sguardo parla, e ogni “configurazione... è una possibilità” di variazione del dato reale da sentire con gli occhi.
Dalla sezione “sequenza nun”
***
parola mano
(sia
sia
preme
per
per
me)
***
preme lontano, da lontano
parola
preme basta —
parole suono
mano
***
sai, non
come cosa
preme
***
prendi,
che rimane
ancora parole date
di’,
parole date
Dalla sezione “corrispondenze”
è più lento di quanto pensavo, è un’attesa
andiamo a san pietroburgo oppure a est in una città di
fabbriche, in transiberiana, prima però dobbiamo
formalizzare la nostra posizione (chi sa cosa vuol dire)
sogni di essere in un paese dove fa bel tempo ascolti un
carosello russo e pretendi di impararlo, chi sa cosa vuol
dire
guardo la villa del conte traverso il parco a pranzo, ho
parlato di te, volevo dirlo
jeu de balle è un piazzale come non ce ne sono da noi,
proporzionato, un piazzale inclinato sembra di utrillo la
gente è come a quel tempo
entro in chiesa, accendo un lumino e sai cosa sta sopra, il
quadro di un incontro tra un maschio e una femmina
Claudio Salvi - pubblicazioni: Album (Arcipelago Itaca Edizioni, 2016) a cura di Renata Morresi, postfazione di Giulio Mozzi.
Pubblicazioni web: gammm.org (polaroid, 2012-2015) – nazioneindiana.com (scritti, 2012-2014) – vibrisse.wordpress.com (tagebuch, 2012-2013) – franco-carlevero.com (non scritto)
testi pubblicati in Nazione Indiana (https://www.nazioneindiana.com/2018/02/18/sequenza_nun/)
testi pubblicati in Argo (http://poesia.argonline.it/sto-fronte-alla-chiarezza-dei-colori-inediti-claudio-salvi/).
Partecipazione a Ricercabo 2016 (taccuino e diario giapponese 2015-2016).
Partecipazione a Riassunto di Ottobre (2016).
Traduttore da inglese e francese: recentemente 12 testi da “Lo spleen di Parigi” di Charles Baudelaire.
Giulia Niccolai, in ricordo di Franco Beltrametti: Una brevissima intervista, con foto di Antonio Ria

Giulia Niccolai e Franco Beltrametti, foto di Antonio Ria
1. Il poeta Franco Beltrametti. Quale legame umano e artistico vi univa?
Ho conosciuto Franco, sua moglie Judy e Giona (che avrà avuto un anno o due), a Trastevere, dove abitavo anch'io con Adriano Spatola, nel 1966, prima che Franco partisse per il Belice terremotato, col programma di lavorare lì come architetto, assieme ad altri, che avevano avuto la sua stessa idea.
Nessuno di loro venne mai utilizzato dal potere locale. Dunque il medesimo idealismo, in questo senso, era stato di diversi architetti, e questo aneddoto ci fa capire anche quanto poco si sapesse, allora, del nostro stesso paese. In Sicilia Franco scrisse "Un altro terremoto" che Spatola volle pubblicargli subito nella piccola casa editrice, la Geiger, che aveva fondato con i due fratelli, Maurizio e Tiziano.
2. L'influenza della cultura asiatica sulla poetica di Franco.
In questo caso è molto importante ricordare che Franco era laureato in architettura e che si sentiva profondamente attratto dal rigore e dall'integrità dell'architettura giapponese. Sempre a questo proposito, è il caso di ricordare che, quando venne a conoscenza dell'opera di Carlo Scarpa, Franco confessò che, se lo avesse conosciuto da giovane, non avrebbe mai abbandonato l'architettura.
3. I rapporti tra testo scritto e immagine. La passione di Franco per l'arte figurativa e il collage.
Se pensiamo al lavoro di Franco, l'aspetto figurativo, anche del semplice testo lineare è sempre presente nelle sue opere, come se non potesse non prenderlo, istintivamente, in considerazione. Si tratta comunque di un comportamento "innato", che, dal mio personale punto di vista, ha a che fare addirittura col suo stesso aspetto fisico di uomo decisamente piacente, bello, che però, per eleganza, non ha mai sfruttato, o messo in risalto, per farsi avanti: fare strada o avere successo con le donne.
4. La sua abitudine di inviare lettere e cartoline agli amici. Un modo per rimanere in contatto al di là delle frontiere e dei confini?
Franco, nella sua vita, ha sempre fatto conoscere i suoi amici agli altri suoi numerosissimi amici! Così, per lui, è anche come: trovandosi con certuni in un determinato paese, questi gli ricordassero sempre anche gli altri, altrove, e che, dunque, gli mancavano... Non c'era sentimentalismo in ciò, era piuttosto una sorta di legge "della natura" per lui. Essere alla presenza di certi amici non poteva non fargli pensare a quelli che non c'erano... Franco era una sorta di "chioccia" mentale di tutti coloro ai quali voleva bene!
Ultima pagina, Stefano Stoja: Filologie transiberiane, la copertina di “Transiberiano”
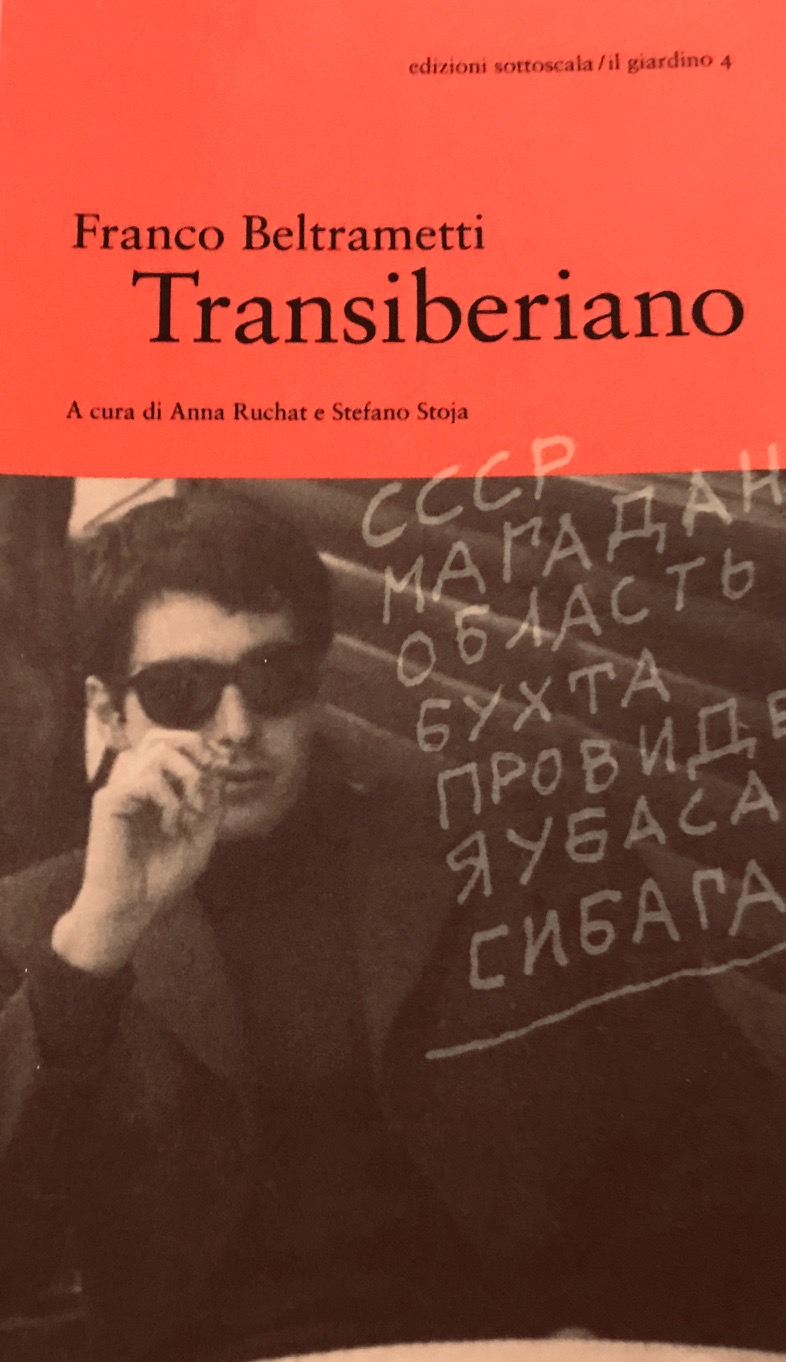
Copertina di "Transiberiano"
Il volume di Franco Beltrametti, Transiberiano, pubblicato dalle edizioni sottoscala di Bellinzona nel 2016, del quale fui co-curatore insieme ad Anna Ruchat è, in senso filologico, un affettuoso arbitrio: Franco Beltrametti non scrisse il diario di viaggio da Venezia a Tōkyo via Mosca con l'intenzione di pubblicarlo; ma il taccuino su cui lo redasse è talmente "beltramettiano" che per questa volta la Filologia può chiudere un occhio.
La diaristica di Franco Beltrametti è sempre molto contaminata da disegni, piccoli dipinti, collages di oggetti recuperati dal suo quotidiano; e il Transiberiano non fa eccezione. Beltrametti si dirigeva in Giappone, già affascinato dallo Zen e dalla mistica orientale, e il taccuino è pieno di pagine di esercizi di scrittura giapponese, la cui frequenza dà l'idea di quanto egli fosse ansioso di entrare in contatto con quella cultura sul suolo che l'aveva generata. Tuttavia, durante il viaggio in treno, egli si trovò immerso in un'altra cultura, le cui tracce sono evidenti nelle pagine del taccuino. Affascinato come s'è detto dal segno, grafico e sonoro, Beltrametti si cimenta in diverse occasioni a scrivere in cirillico, per esempio, un indirizzo postale, o a trascrivere a orecchio parole russe afferrate qua e là. Lo accompagnano, dal 9 al 19 maggio 1965, svariati personaggi, alcuni decisamente variopinti, con i quali Franco Beltrametti comunica pur non conoscendo il russo, gioca a scacchi, fa passare il tempo fumando e bevendo vodka. La sua facilità di comunicazione, l'empatia con gli sconosciuti e con le persone amiche, sono tratti fondamentali del suo carattere che affiorano di continuo nella sua opera poetica e grafica; e anche il Transiberiano e la poesia su questo viaggio non fanno eccezione: ce lo dipingono come una persona genuinamente interessata agli Altri. È anche grazie a questo che la "galassia Beltrametti", irta di figure e personaggi anche molto distanti fra loro, di molteplici ambiti artistici e letterari, è a tutt'oggi così variegata e numerosa, e su più grande scala rispecchia il microclima ferrato e rotolante del Transiberiano.
Stefano Stoja, studioso di letteratura italiana del Novecento, è nato a Lecce nel 1965. Ha pubblicato diversi saggi sulle riviste d'italianistica «Cartevive» e «Studi novecenteschi», ed è stato tra il 2010 e il 2019 archivista e bibliotecario presso la Fondazione Franco Beltrametti di Riva San Vitale, nel Canton Ticino.
Aprile 2020, anno XVII, numero 46

Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura della redazione di "Anterem"
Diamo vita a quello che non è stato.
Un ormai abituale appuntamento come il Forum Anterem, vibrante perché solitamente vissuto “insieme”, in questo periodo trasmetterà la stessa passione grazie alla tecnologia.
Ascolteremo i poeti dalle loro case, dal loro giardino, come se fossimo in Biblioteca Civica a Verona.
La viva voce dei poeti rompe il silenzio di questo tempo sofferto.
Sono gli autori finalisti per “Una poesia inedita” al “Montano” 2019. Da remoto proviene anche il brano originale composto da Francesco Bellomi per la poesia vincitrice di Roberta Sireno.
La novità introdotta lo scorso anno, e che si ripete con identica modalità nell’edizione in corso, è stata la creazione di una Giuria critica per determinare il testo da premiare. Per istituire questa giuria, che si affianca a quella storica composta dalla redazione di “Anterem”, abbiamo invitato finalisti e vincitori della precedente edizione del “Montano”. La stessa cosa, con personalità quindi differenti, sta accadendo quest’anno:
www.anteremedizioni.it/premio_lorenzo_montano_xxxiv_(...)
Com’è prassi per la giuria storica, abbiamo chiesto anche ai nuovi giurati di scrivere su alcune delle poesie valutate, scegliendo liberamente. È il motivo per cui è stata denominata “Giuria critica”.
Tutto il lavoro collettivo è racchiuso in questo nuovo numero di “Carte nel vento”, che si apre con un omaggio allo scrittore belga Marcel Moreau, figura dirompente della letteratura francofona del ‘900, praticamente inedito in Italia e di recente scomparso.
Buon ascolto, buona lettura.
In copertina: Fotogramma di Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi
Ranieri Teti
Prima pagina: Marcel Moreau (1933 – 2020) tradotto da Cristiana Panella
Da Moreau. Quintes, L'Ivre Livre, Sacré de la femme, Discours contre les entraves. Éditions Denoël, p. 419
Traduzione e premessa: Cristiana Panella

Cantore e soggetto, per sua stessa definizione, dell'Escritauro (Escritaure), creatura ibrida Verbo e Bestiario, Marcel Moreau riporta il monstrum al suo senso originario di prodigio come ammonimento, messaggero del divino. In una lingua intrinsecamente 'ossimora': astrale e intestinale, numinosa e sanguinolenta, edotta e carnascialesca, Moreau erige l'amore carnale a banchetto sacro. In perpetuo bilico tra la combustione dell'istante e l'imminenza della separazione, si celebra l'anelito all'Assoluto che attraverso il lamento veggente rimpiange il presente osservandolo dal già futuro.
Estratto da: “L'anima dei bolidi” in “L'Ebbro Libro” (1)
[…] Neanche tu mi segui più. Neanche te che amo, mi segui. Sei più lontano di me, ancora dietro ciò che mi soverchia. Più nessuno mi segue, riesce ad afferrare al volo gli assi folgoranti, e mi ritrovo solo con le mie rapidità bionde che mi spaccano il corpo da te solcato. Anche i miei omaggi alla tua bellezza ti attraversano così rapidamente che ti sfuggono al momento della carezza. E la carezza ha un bell'attardarsi, compiacersi alle labbra, abbeverarsi alla feccia, le galassie che mi ispiri, loro, viaggiano a distanze tali avanti a noi da sembrarti opache. Eppure i miei omaggi ti hanno presa, portata via, esposta a soli di parole; ti hanno piantata dentro, trascinata sopra, inchiodata a loro, oppure hanno girato con violenza attorno alla tua carne, abbeverandosi a cosce a gola, a sessi liquidi e vasche succose. Non saprai mai a che punto lo sciabordio di ogni goccia di te sulla mano fece danzare duro e folle la mia mente (2). Ma i vortici se ne sono andati, e noi ci ritroviamo corpo lento addosso a corpo ancora più lento...
Questo non è che un esempio; tuttavia quale altro esempio può raccontare della velocità dei linguaggi non indottrinabili? Arruolamento impossibile, schiavitù in arretramento, né patria né partito, sostegno rifiutato, perpetue partenze, arrivi annullati. Ma dolori attivati, sconforto che rimesta, eccome rimesta... [...].
Marcel Moreau (Bossu 1933-Bobigny 2020) è uno scrittore belga francofono. Proveniente da una famiglia operaia, abbandona gli studi adolescente, poco dopo la morte del padre, e inizia a lavorare in una rubinetteria. Assistente contabile per il giornale Le Peuple, a Bruxelles, sarà correttore di bozze per Le Soir, attività che continuerà a Parigi, dove si trasferisce nel 1968. Nel 1963 pubblica il suo primo romanzo, Quintes, a cui faranno seguito più di 60 opere, per lo più in prosa poetica, tra cui Sacre de la femme (1977), L'Ivre Livre (1973) e Discours contre les entraves (1979), riproposte insieme dalle Edizioni Denoël nel 2005. Orgambide (1980) inaugura la fase più travagliata e prolifica della vita di Moreau, caratterizzata da una profonda crisi esistenziale in cui lo scrittore renderà omaggio, in testi che definisce degli "adoratoires", alla sublimazione della donna; un'apoteosi della carne e dell'amore che continua con Bal dans la tête (1995), l'ultimo romanzo. L'elemento della carnalità, che unisce l'amore per la donna e la scrittura, di cui Moreau farà una militanza intellettuale, sfocia maturo in Corpus scripti (2002); esso si rifletterà nell'opera degli anni 2000, tra cui Adoration de Nona (2004), Une philosophie à coups de reins (2008), Un cratère à cordes (2016), e con la ripubblicazione di À dos de Dieu (2018).
(1) Una seconda valenza, certamente voluta da Moreau, è "L'ebbro si racconta".
(2) La traduttrice ha scelto di lasciare "dur" et "fol" al maschile per restituire l'uso dell'aggettivo come avverbio del francese e mantenerne l'effetto icastico.
Andrea Breda Minello, “Berkana”, videolettura; note di Silvia Comoglio, Patrizia Dughero
Perché quando Berkana ornata di rami
Si innalza sino ai margini del cielo
Emana la tensione delle tue viscere
Dichiara un nuovo inizio:
Una mutazione del sangue per accoglierti
Come il Dio che porterà in dono
La testa spezzata di Fenrir.
Allora rinasceremo l’uno nell’altro
Ci scambieremo la pelle
Per essere il seme fecondo della madre terra.
Nota: Berkana è la Runa del femminile, simboleggia la Betulla. Fenrir è il lupo, figlio di Loki, che nel Ragnarok delle saghe norrene verrà ucciso dal dio Vidarr.
Silvia Comoglio per Andrea Breda Minello
Due dimensioni convivono nel testo di Andrea Breda Minello, quella mitico/divina e quella umana. Berkana, la Runa del femminile e Fenrir, il lupo delle saghe norrene, ucciso dal Dio Vidarr abitano i nostri spazi, sono presenze con cui misurarsi, figure che finiscono con il sovrapporsi alla nostra essenza. Ed è proprio da questo sovrapporsi che nasce un innesto, una correlazione tra l’umano e il mito che ci disvela il ciclo della vita racchiuso in inizio/mutazione/fine/rinascita. Ciclo, questo, che richiama a sua volta un altro mito, il mito dell’eterno ritorno.
In un testo dalla struttura compatta e dalla luce asciutta, l’umano e il mito, in un gioco continuo di rimandi, si incontrano e scambiano pelle per poter essere, come scrive Andrea Breda Minello, “il seme fecondo della madre terra” . Una fecondità che nel testo di Breda Minello si traduce, da un lato, in rinascita e in stretto legame tra il mito e l’umano e, dall’altro, in forte correlazione tra scrittura lirica e epico-mitologica.
Patrizia Dughero per Andrea Breda Minello
Con un colpo fendente tra terra e nebbia questa poesia incede, incalza, una quartina e due terzine, a ribaltare il mondo, destando al contempo nel lettore una certa fantasticheria sul sonetto, come un dolce ricordo, per la quartina d’attacco che sembra portare avanti una narrazione previa, qui tesa a circoscrivere il necessario mutamento, un nuovo inizio.
Poesia carica di visioni, per la sua atmosfera, un gelo rotto soltanto dai rami bianchi e luminosi di betulla, per l’“attesa” quartina d’inizio che si scarica sul suo ultimo verso, Dichiara un nuovo inizio:, per il passo epico e gli incipit di ogni verso, in maiuscolo, desueta maniera, e per quella dichiarazione: all’inizio occorrerà un cambiamento viscerale oltre che un’azione.
Poesia assertiva che attinge dunque al sangue e agli elementi viscerali stabilendo un’equilibrata tensione per l’inevitabile, “non possiamo più attendere”, sembra essere l’incitamento del poeta che ricorre alla primordiale lotta tra buio e luce, che ristabilisca il brodo affinché la parola continui in bios e nell’unione. Non possiamo più aspettare ma non possiamo arrenderci e allora il poeta “si fa carico”, e il suo carico è “ogni disperazione”, così “prende spazio” all’assoluto. Se via d’uscita non c’è occorre declamarlo (mi pare importante sottolineare che per il Premio Montano, sezione Poesia inedita, è richiesto un componimento “che costituisca per l’autore un momento privilegiato della sua ricerca, un testo che proprio nell’unicità trovi la sua ragione”); occorre guardare la bestia spezzata, la testa del lupo sacrificale con cui scambiare la pelle, per far rinascere una nuova umanità e perché la terra venga rigenerata. Versi che conducono a stupore assoluto, ma non si ammantano di silenzio, piuttosto di orme pesanti tra nebbie fonde tagliate dall’alitare di chi non desiste, pur senza fuoco a scaldare e nessuna fiammella che possa alimentare lo scambio necessario, soltanto un click che il volto epico possa introdurre nel nostro DNA.
Poesia epica antilirica, retta da un’apertura che contiene una domanda, sia causale che finale su un determinato accadimento, sembra quasi farsi beffa del canone e della scansione metrica, oscillante com’è tra versi alessandrini, fino al limite dell’endecasillabo sdrucciolo, intervallati in maniera atipica da settenari e novenari: inducono a pensare che anche la rima avrebbe avuto una giusta collocazione al fine di ristabilire il passo marziale evocato. Ma nessuna rima appare, mentre noncurante il poeta inneggia saldamente a un gesto eroico che ristabilisca vera giustizia fuori dall’umano, con una luce lunare riflessa nel pallore della bianca betulla, frondosa e poetica runa offerta. Noi lettori a raccoglierla, quasi indifesi, almeno coloro che non sono addestrati a una buona osservazione degli elementi naturali, veri protagonisti di questo componimento. Rischiando pure di essere risucchiati da un’epica che non ci appartiene (interessante, affascinante lavoro di contaminazione) quasi un manga europeo o un must da graphic novel, risollevati poeticamente dall’ottimo equilibrio di questo testo che dalla sua brevità trae forza e potenza, mentre i versi lanciati ondeggiano, e continueranno a farlo, tra grigie volute norrene, aprendosi al vento per spargere semi che, composti e segreti, getteranno basi sicure ad altri componimenti.
Andrea Breda Minello (1978) è nato a Treviso, dove vive e lavora come docente. È poeta, traduttore e drammaturgo. Ha esordito in X quaderno di poesia contemporanea e ha poi pubblicato Del dramma, le figure (Zona, 2015) e ora Yellow (Oèdipus, 2018). Come traduttore: Julien Burri, Se solamente (Kolibris edizioni, 2010), Pierre Reverdy, Sabbie mobili (in “Testo a fronte”, 2015), Anna de Noailles, Poesie d’amore (Arcipelago Itaca, 2019). Suoi testi sono usciti su “Poesia”, “Nuovi Argomenti”, “Versodove”, “l’Immaginazione”. Collabora con “Testo a fronte” e “l’avantionline”. Sta ultimando il suo primo romanzo.
Giuseppe Calandriello, “Pneumeno”, audiolettura; note di Silvia Comoglio, Ranieri Teti
Pneumeno
edificio nella notte, fiotti d’uomo
(terra di gonfiore)
sulla direttrice del nuovo viso
(effetto sagittale)
Talete al timone del lobato
a braccia separate
le vite mai sognate
a un ritmo più lento, nauti oltre, a sostegno
(in acque cordate)
disàrmati, qualcosa del consiglio, la qualità del suono netto
(a giaciglio delle torbe)
respiro di erranza
gli dèi degli avanzi
vanga di mucosità
spegni le vie, sbarra le rotte, nel piano, del suono, l'esercito è rotto
Silvia Comoglio per Giuseppe Calandriello
Su acqua e respiro si fonda il testo di Giuseppe Calandriello costruito con un sapiente uso della parola e con forti e vivide immagini. L’uomo, nel testo di Calandriello, si sveste della sua solida essenza e si fa fiotto, onda che imprime al suo viso una nuova identità, che lo trasforma non momentaneamente ma in modo perenne in un nauta che si trova in cordata con altri nauti, una cordata fatta di acqua, ossia di qualcosa che è inconsistente, che sfugge. E in questa cordata, ci chiediamo, che non ha la resistenza della fune ma l’inconsistenza dell’acqua, come possono, se possono, sostenersi e salvarsi gli uomini diventati nauti? E neppure, si direbbe, rassicura la presenza di Talete al timone, quel Talete che sosteneva che il principio, l’arché, di tutte le cose è appunto l’acqua e che è dall’acqua, forza attiva e vivificatrice, che si trae nutrimento.
Rimane così all’uomo il respiro ma è un “respiro di erranza”, perché quando cerca di diventare suono, e da qui poi si presume parola, si infrange e l’esercito dei nauti si scopre rotto, e quindi ancora una volta senza salvezza. “spegni le vie, scrive Giuseppe Calandriello, sbarra le rotte, nel piano, del suono, l’esercito è rotto”.
Ranieri Teti per Giuseppe Calandriello
L’incipit del testo è cinematografico, con il passaggio da un’inquadratura aperta e generale, da un esterno simbolico che si protrae fino al primo piano di un volto: tutto mediato, tra parentesi, da una considerazione dell’autore e da una sorta di appunto sceneggiato per la regia. Nei quattro versi iniziali Giuseppe Calandriello produce e crea un accavallarsi spaesante di immagini che offre una chiara indicazione di lettura: “Pneumeno” chiede di abbandonarsi al suo flusso, richiede di condividere e di abitare l’idea del suo autore. Questa si precisa in maniera definitiva subito dopo, quando nel testo interviene il “lobato”, un aggettivo adoperato come se fosse un sostantivo, per dirci che in poesia tutto può succedere all’improvviso e niente è mai scontato. E “nauti” lo conferma. La fusione dello stile con il senso offre uno degli elementi distintivi di una poesia che non si appiattisce sulla realtà ma la trasforma creando una parte di mondo prima inesistente. Le percezioni del poeta predispongono frammentazioni del sentire, avvenendo simultanee come respiri in corsa, e in questa modalità assecondando, nella messa in pagina, un andamento interiore. Lo testimoniano i versi ora sincopati ora lunghi, e franti se lunghi, come se fossero pulsioni irregolari, sintomi di uno spezzare il ritmo per un dire ulteriore. Come se fossero fuse insieme tecnica e visione, forma e idea, sapendo che non c’è idea che non sia riconducibile all’esperienza di una cosa generata nel pensiero: gli ultimi versi, così spiazzanti e fatalmente nitidi, concludono l’unione di pneuma e immaginazione.
Giuseppe Calandriello nasce a Pietrasanta nel 1979. Dopo gli studi artistici si laurea in Cinema, musica e teatro presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa. È membro del gruppo [dia•foria, con il quale ha pubblicato opere di Balestrini, Ballerini, Blotto, Burchiello, Carravetta, Curi, Mansour, Péret, Toti, Villa e altri. Nel 2017 cura, con Daniele Poletti, la seconda edizione di "Obsoleto" di Vincenzo Agnetti con testi di G. Agnetti, C. Bello Minciacchi, B. Corà e C. Costa. Sue opere sono pubblicate nelle antologie "Tuttologia e Contro Zam", Cinquemarzo; "Nuova Tèchne", Quodlibet; "Scrivere all’infinito", Museo della Carale Accattino; "Offerta Speciale", Carla Bertola editore; "Athe(X)ehtA", Edizioni GDFAEOA. Ha partecipato a contenitori d'artista come "BAU" e "Antologia Ad Hoc". La sua ricerca poetica e artistica verte su tematiche come la casualità, il determinismo, il rapporto tra l'impossibile e l'improbabile, le energie cosmiche e il potere del linguaggio segnico.
Giorgiomaria Cornelio, “Palinsesto”, audiolettura-cartolina; note di S. Comoglio, M. Guatteri, D. Pericone, L. Rossi
Giorgiomaria Cornelio, “Palinsesto”, audiolettura-cartolina;
note di Silvia Comoglio, Mariangela Guatteri (con immagine asemantica), Daniela Pericone, Lia Rossi

Silvia Comoglio per Giorgiomaria Cornelio
Con parole soppesate e di limpida densità Giorgiomaria Cornelio concentra la sua attenzione su due elementi che in poesia sono cardine/essenza: il nome e la scrittura. Dall’oggetto, dalla “cartula” di cui parla Cornelio, si astrae il nome, quel nome in cui tutto in potenza è contenuto e che ci rimanda, tra l’altro, al Prologo del Vangelo di Giovanni, In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Richiamo avvalorato dal desiderio di baciare nell’orazione la cartula che si è fatta nome, “baciarla nell’orazione”, ossia proprio in un momento privilegiato dell’incontro dell’uomo con Dio. Ma quel nome, che tutto contiene e che è presso Dio, pronunciato e mediato dall’uomo muta e perde i suoi connotati, la saliva lo corrode, e nella saliva diviene mancante, incompleto. E questa mancanza, incompletezza, si trasmette alla scrittura, allo scrivere, che, ci si rende conto, non è evento che dà risposte ma evento che le risposte le allontana a favore di un cercare continuo, meglio, di uno scrivere e riscrivere continuo. Del resto, un palinsesto è proprio questo, un manoscritto da cui si raschia ciò che è stato scritto per scrivere un nuovo testo.
Palinsesto, oserei dire, una dichiarazione di poetica, acuta e ponderata.
Mariangela Guatteri per Giorgiomaria Cornelio (con immagine asemantica)
Rebus
Il titolo di questo testo poetico è l’intero processo di stratificazione e rimaneggiamento occorso al segno (scritto tanto quanto dipinto) attraverso un'azione perentoria di raschiatura che rinnova la superficie che lo ospitava.
Per economia di supporti – come pergamene, muri intonacati, tele, tavole lignee, carte – o per necessità di trasformazione, si organizza il segno su una superficie usata che viene resa vergine o quasi: il supporto non viene raschiato e lavato, e ciò che accoglie si trova parzialmente neutralizzato da un'ulteriore scrittura, da segni che cancellano, da velature cromatiche, da tagli che escludono.
Se questo processo abrasivo e sostitutivo che definiamo “palinsesto” è assimilabile all'intendimento dell'atto della scrittura – «Così s'intende la scrittura: un | lento stornare la necessità | della risposta», come termina il testo di Cornelio –, dovremmo comunque fare i conti con gli strumenti e i processi (anche chimici e radianti) di risuscitazione di ciò che appare estinto, che «è venuto a mancare». Nome, che viene nascosto, che manca, che muore. Si rimane in una sospensione del pensiero di fronte a questo testo, testimone del suo stesso processo, già riassunto nel titolo ma annunciato poi – senza parole – alla fine e da un'immagine iconica: un dettaglio. Così riporta la didascalia dalla quale si può dedurre cosa esclude il riquadro, e perciò cosa è stato annunciato. Si vede infatti che manca una parte della figura; si sa che manca l'agente dell'Annunciazione. In modo paradossale e analogico e lontano da ogni tautologia, è annunciata l'assenza stessa dell'annuncio.
In ogni caso la scrittura ha agito e il Verbo ha forse già attecchito dentro la quasi Vergine senza la testa.
Mi viene naturale chiamare questa piccola opera una "lirica concettuale" che ha la forma di un asciutto "iconotesto" e dove le chiavi d'entrata sono esposte, installate all'ingresso e all'uscita; cosicché «a via diritta» e scartando ogni volta «Qualcosa insinua».
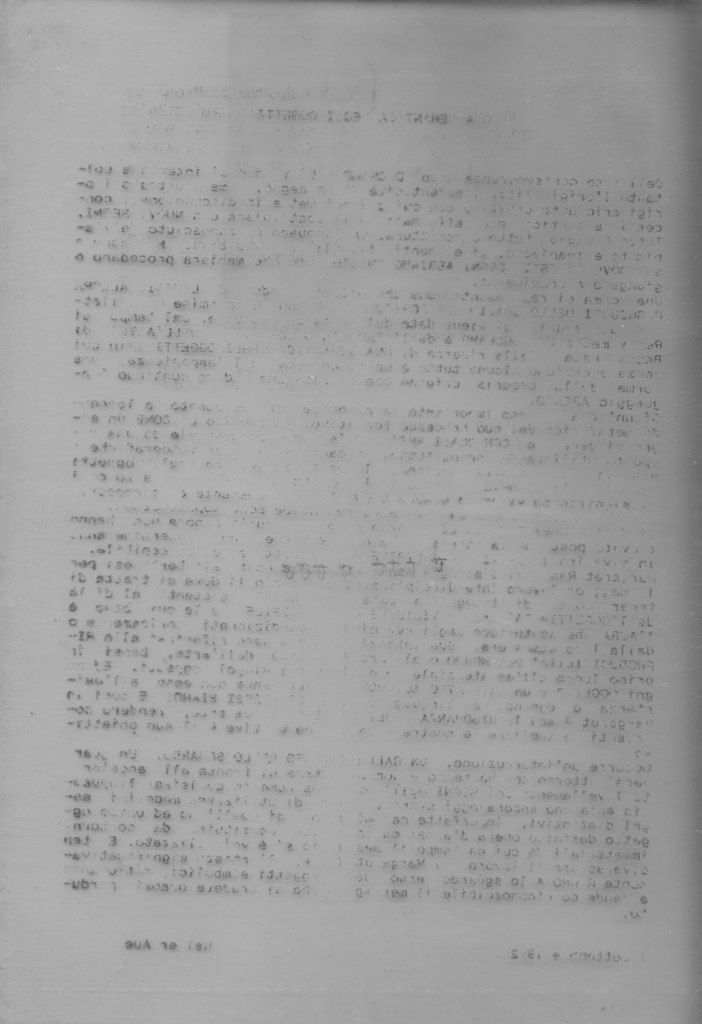
Daniela Pericone per Giorgiomaria Cornelio
La scrittura è sovente ri-scrittura, tanto si ravvisa nell’intrinseca significanza del termine palinsesto (dal greco παλίμψηστος, «raschiato di nuovo»). La poesia Palinsesto di Giorgiomaria Cornelio insorge come un’ostensione di verbo su una pergamena, legata a un affresco del Beato Angelico, a una particolare angolatura dell’Annunciazione della cella 3 di San Marco. È nel contempo architettura autonoma, edificazione di forma nel «sortilegio dell’ombra», nominazione insistita come un’eco che si perpetua tra le pareti di una stanza (o di una cella). L’ignoto si manifesta nel moto («insinua»), se ne coglie la direzione («a via diritta»), intelligibile tuttavia discontinuo se esorbita a volte nel verso la misura consueta tra le parole. La «cartula», ora abrasa ora incisa, conserva tutte le sue tracce, i sedimenti non più visibili, gli affioramenti nella parola presente (o mancante). Eppure a chinarsi in ascolto si sottrae «la necessità / della risposta».
Lia Rossi per Giorgiomaria Cornelio
Respira l’aria della postilla, Palinsesto di Giorgiomaria Cornelio, tra righe, tra spazi, via via cautamente fa sorgere sentimento, introduce in seno il senso, fa fare incantesimo, fa operare poesia: un sortilegium, una malia.
Bacio-baciare è recitare discorso e preghiera, fare compiere libri di orazioni.
E si sta in orazione a rileggere Palinsesto, preghiera significativa autenticamente nella forma a postilla, preziosa cartula.
Non manca di solennità, né di vita della lentezza questa scrittura che volge in diversificati versi e distoglie in tante sensate soluzioni, in pesi pensati e sottilmente filati come fili di lana, scomponendo le falde, battendole e torcendole. Filatura e filanda la scrittura; filatrice-poeta, femmina o maschio che sia, con saliva bagnandosi i polpastrelli, allunga torcendo la materia grezza dal fiocco al filo.
La certezza di esistere che avrei/ se fossi tu a pesarmi, poesia, scrive Josè Saramago nelle Poesie possibili. Sempre Saramago: E quando non si placa la protesta/del sangue soffocato nelle arterie? (…) E quando siamo stanchi di domande, e risposta non c’è, neanche urlando? G. Cornelio ha consapevolezza degli orli della voragine e li trasforma in impalcatura petrografica (sia secca, sia rude / come pietre calcinate), netta attraverso una coscienza linguistica nella densità di quel che era indicibile fino ad ora.
Ora è una pergamena raschiata, sottostante è un’altra scrittura, vergata nello stesso senso o in senso trasversale al primo testo: segnale già iniziale di suggestione della molteplicità insinuata di verso e di significato.
La chiave è il palinsesto, la porta è la cartula, l’interno è la scrittura.
E nel lago del cor, immagine fulminante di Dante, rimane il bacio al segno della gioia-gioiello-poesia.
Giorgiomaria Cornelio (14 gennaio 1997) ha fondato insieme a Lucamatteo Rossi l'atlante Navegasión, inaugurato con il film Ogni roveto un dio che arde durante la 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. È co-curatore del progetto di ricerca cinematografica La Camera Ardente, e redattore di Nazione Indiana. Suoi interventi sono apparsi su Le parole e le cose, Doppiozero, Il tascabile e Il Manifesto. Nel 2019 ha vinto il Premio Opera Prima (Anterem) con la raccolta La Promessa Focaia. Studia al Trinity College di Dublino.
Mario Famularo, “Vivo la tregua del desiderare”, videolettura; note di Giorgio Bonacini, Allì Caracciolo, Giuseppina Rando
vivo la tregua del desiderare
lo spazio senza fine in qualsiasi
direzione
disturbi ma di rado per
irrobustire il vuoto
ed è sempre maggiore
ad ogni picco quel
distacco
non v’è disperazione
né gioia né amarezza
l’asprezza dell’esistere
in un cardiogramma
piatto
orienta solo il bene
dove riesco ad abitare
qualcosa da ricevere
e tutto da
lasciare
rimango per il male che svanendo
potrei dare
la mia è la pace
dei morti
Giorgio Bonacini per Mario Famularo
I versi di Mario Famularo offrono al lettore attento – oltre a una parola non programmatica, ma di essenziale precisione evocativa – uno sguardo di movimento dove l’occhio, e non solo il pensiero, trova il percorso di una vasta ma precisa significazione. Perché la poesia è scrittura e voce che attiva la metamorfosi e l’attrazione di tutti i sensi. E’ così allora che si può sintetizzare, senza sminuire, un percorso di senso sostanziale attraverso il tragitto di alcune sue parole (direzione, vuoto, distacco, piatto, lasciare, dare morti), che per noi, per il nostro singolare sentire, mostrano il puntum del testo. Sono le parole che chiudono ognuna delle sette brevi strofe, che danno forma sostanziale a quel pensiero di desiderio d’abbandono (o meglio di “tregua” per usare la parola dell’autore) con cui inizia la poesia, e che è come un velo che copre il testo, ma lascia trasparire altro, e ne fa il suo fulcro distintivo esistenziale. La direzione è l’andamento del senso, vissuto nell’apparente spegnimento delle passioni, che segna il vuoto dove l’io si allontana ogni volta che si prova a innalzare gli occhi verso il reale. E in quel distacco apparentemente sembra racchiudersi ogni emozione, verso un sentimento piatto; che se veramente fosse così, spegnerebbe anche la poesia, e invece porta il poeta a riconoscere, pur nel poco bene che si riceve, il tanto da lasciare. Dunque vale rimanere qui, per evitare il troppo male che si potrebbe dare, continuando a vivere (e a scrivere) con la propria pace, che è la stessa dei morti.
Allì Caracciolo per Mario Famularo
Testo lirico costruito su un linguaggio apparentemente semplice, in effetti risultato di essenzialità, di quella precisa definizione cioè che ha la parola esperienziale, quando nel profondo esprime il significato, esperito appunto, della cosa.
Il tono è puro dolore, privo di ogni enfasi. La voce è solitudine senza dichiarazione, lontana da qualunque retorica.
Giuseppina Rando per Mario Famularo
Con vivo la tregua del desiderare Mario Famularo, attraverso immagini delicate ma intense, apre spiragli sul mondo interiore di ciascuno di noi, quasi sempre gremito di sogni e desideri mai realizzati.
Il poeta, però, ha deciso di non più sognare, né desiderare, ha firmato con se stesso una tregua,
la tregua del desiderare che egli vive e si configura nei versi, come un privilegio, un dono.
Più che una tregua o blocco di bramosie, si intravede come distensione dello spirito, stato di tranquillità, vissuta in uno spazio senza fine dove pure si colgono speciali sensazioni di distacco non evocanti angoscia o sconforto, ma accettazione radicale della sofferenza tanto da modificare la realtà degli avvenimenti che da negativi si mutano in positivi:
… l’asprezza dell’esistere / in un cardiogramma / piatto/ orienta solo il bene…
E’ una luce folgorante a svelare la verità più profonda che prima restava nascosta, quella di poter …ricevere / e tutto da lasciare…la mia è la pace / dei morti.
Un testo introspettivo incastonato nello spazio/tempo percepiti nella disarmonia costitutiva della condizione umana la quale, sperimentando se stessa, la trascende nella ricerca di significati più ampi e totalizzanti.
Mario Famularo (Napoli, 1983) esercita la professione di avvocato a Trieste. Ha realizzato il portale dedicato alla poesia e alla critica letteraria Kerberos Bookstore. Suoi testi sono apparsi su antologie e riviste letterarie, tra cui “Atelier”, “Carteggi Letterari”, “Argo”, “Inverso”, “Menti Sommerse” e tradotti in lingua spagnola dal Centro Cultural Tina Modotti. Collabora al sito Laboratori Poesia con interventi critici sulla poesia contemporanea e una rubrica di analisi dei testi. Ha curato per lo stesso sito una rubrica su prosodia, metrica ed eufonia. La sua prima raccolta, “L’incoscienza del letargo”, è stata pubblicata dalla Oèdipus, mentre la successiva è in corso di pubblicazione per la Giuliano Ladolfi Editore.
Lucetta Frisa, “L’energia del sonno”, videolettura; note di Allì Caracciolo, Mara Cini
L’energia del sonno
Io vivere vorrei addormentato
dentro il dolce rumore della vita
Sandro Penna
Adagiàti
ossa e sensi
infine torneremo
nel Grande Sonno
Se gli alberi dormono da quando sono nati
gli animali vivono nel torpore
e ci guardano dal loro chiaroscuro
simile al nostro dormiveglia.
Da sempre il mare dorme
cullandosi limpido o torbido
né gli urti di tempeste e scogli
potranno mai risvegliarlo.
La strana oscillazione di onda e nave
che ripete la culla umana
è legge creaturale del cosmo
del suo modo di respirare.
I gesti insonori
vorrebbero soffiare via il rumore
I’insistente brusìo delle parole e non increspare
la sintesi del sonno e del silenzio.
Che ci facciamo qui
noi così svegli e stretti
con le pietre chiuse sul petto?
Se non torniamo presto a dormire
moriremo di noia e asfissia
senza l’aria del sonno.
Quel magnifico sonno
che attraversò la storia le storie
le figure le poesie le musiche
che continuano a riposare nel cervello.
Come nacquero le immagini
dall’inizio del mondo fino a qui:
lampi di sonno che squarciarono
la luce accecante e cieca
di una terra troppo sveglia.
Come nacquero sole e luna
quelle prime forme in alto scintillanti
ancora spoglie di simboli
emersi da dove?
Come nacque la notte
prima molto prima del giorno
che conosceva la forza più profonda
l’immisurabile durata di ogni possibile?
Si passa via senza un saluto.
Noi non siamo dove siamo.
Come quando le palpebre inclinate
chiudono il mondo in basso
e si guarda incerti solo l’esito della pioggia
i chicchi di grandine e di neve.
Non chiamiamola luce
o luce della luce
questo chiarore trattenuto dalle ciglia
dei neonati
dei gatti
o dei lupi invernali.
Volontà non c’è
nel dormiveglia
di chiamare a sé l’energia.
L’energia non è che questo respiro
dell’aria raggiante
intorno a noi.
Tra la terra e le nuvole
l’atmosfera fa socchiudere gli occhi
si insinua nelle fessure
tutto sospende
e i corpi vaporosi
cadono dentro il peso della terra.
È ’dalle fessure
che i nostri profili folli e atterriti
vedono futuro e realtà
spiando le scene misteriose della storia.
Forse sono gli dèi
a iniettarci nel sangue
un po’ di significato
quella fusione simultanea
con l’estraneità.
A volte due corpi insieme
credono di sfiorare
i limiti dell’assoluto.
Confusi in un vertice acuto
mimano l’attimo incostante
dell’ eternità.
Non svegliatemi.
Brulicano pensieri senza specchio nel cervello
rosicchiano la pelle vecchia dei sogni.
Se mi sveglio
vorrò mettere ordine al disordine
separando sogno e veglia
fondo e cima.
Non svegliatemi.
Per chi insegue tracce su mappe non scritte
il presente non è mai presente
mai nulla è di fronte
e fugge sempre dietro a qualcosa
che continua a fuggire.
Noi si viene
dal grande sonno del grembo materno e marino
poi passiamo il tempo a svegliarci
dimenticando i luoghi sacri
la cima di potenti montagne
il fondo di potenti deserti
perché l’energia del sonno
passa tocca unisce e va.
Gli eremiti
le figure bizantine
le figure graffiate sulle rupi
le figure senza figura
le figure di Antonello e Piero
tutti i suoni naturali
continuano qui a testimoniare
quell’energia.
Perché piange forte chi nasce
nello strazio di questa luce crudele
che lo strappa al suo sonno?
E noi ostinati
a volerci sempre svegliare
camminare e svegliarci
svegliarci e camminare
solo per allontanarci.
Mi inginocchio
ai piedi del Grande Sonno
mai diviso o interrotto
dove so di entrare se scrivo
di uscire se smetto
e perdermi e impazzire.
Se scrivo
è come chiudere gli occhi
tornare all’animale che sono
albero
nuvola
sasso
tornare all’atomo casuale che sono
che ha nell’aria il suo piccolo eden.
Il Sonno
è la prima cellula di tutte le cose
il resto
è opera teatrale del tempo
del suo gioco prospettico
che ci conduce ad aprire gli occhi
lentamente
lentamente
scivolando
nell’assoluto sonno dell’inizio.
Allì Caracciolo per Lucetta Frisa
Il testo si fonda su un’idea originale, complessa di sensi e fondamentalmente ‘semplice’, una sorta di rovesciamento profondo che attinge all’anima segreta delle cose. La vita umana è un insistente tentato risveglio dal “Sonno”, che è concentrazione assoluta nell’Essere, per gettarsi nella esagitata dimensione della differenza, o della caotica commistione, ignorando la potenza creativa dell’energia di quel “Sonno” così simile al Vuoto.
Mara Cini per Lucetta Frisa
L’energia del sonno è un’articolata “rappresentazione” che allude alla condizione naturale di ossa e semi, alla condizione antropologica e culturale di nostre antiche figure graffiate sulle rupi, e risale indietro fino all’assoluto sonno dell’inizio, a un’abiogenesi ancora dormiente.
Tutto questo, ad un io poeta, si rivela, principalmente, nel proprio fare: so di entrare se scrivo / di uscire se smetto.
Lucetta Frisa, attrice, poeta, traduttrice, nasce e vive a Genova. Tra le sue opere poetiche: Modellandosi voce (Corpo 10, 1991); La follia dei morti (Campanotto, 1993); Notte alta (Book editore, 1997), L’altra (Manni, 2001); Siamo appena figure (G.E.D., 2003), Disarmare la tristezza (Dialogolibri, 2003); Se fossimo immortali (Joker, 2006); Ritorno alla spiaggia (La Vita felice, 2008); L’emozione dell’aria (CFR, 2012); Sonetti dolenti e balordi (ibidem, 2013). Narrativa: Fiore 2103 (SEL; 1977); Sulle tracce dei cardellini (Joker, 2009); La torre della luna nera (Puntoacapo, 2012). Ha collaborato con i suoi racconti per ragazzi al quotidiano “Avvenire”. È presente in varie riviste (Nuova prosa, Poesia, La mosca di Milano, L’immaginazione, La clessidra), antologie (Il pensiero dominante, a cura di F.Loi, e Altra marea, a cura di A. Tonelli) e in siti web (La dimora del tempo sospeso, Viadellebelledonne, La poesia e lo spirito, Carte sensibili, Doppiozero). Traduce dal francese Pierre-Jean Jouve, James Sacré, Sylvie Durbec e dall’inglese J. Clare, E. dall’inglese J. Clare, E. Dickinson, G.M. Hopkins, J. Keats. In volume: Henri Michaux (Sulla via dei segni), Bernard Noël (Artaud e Paule e L’ombra del doppio) e Alain Borne (Poeta al suo tavolo). Collabora a vari blog letterari tra cui “La dimora del tempo sospeso”, dove sono apparse nuove traduzioni di 30 poesie di C. Baudelaire. Pubblica nel 2018 la plaquette dedicata a N. de Staël, Tutto deve accadere dentro di me (Via del vento, 2018)
Con Marco Ercolani cura i “Libri dell’Arca” per le edizioni Joker e insieme a lui pubblica: L’atelier e altri racconti (Pirella, 1987); Nodi del cuore (Greco & Greco, 2000); Anime strane (Greco & Greco, 2006) (Âmes inquiètes, tr. fr. di Sylvie Durbec, Éditions des états civils, 2011); Sento le voci (Greco & Greco, 2009); (J’entends les voix, ibidem, 2011); Il muro dove volano gli uccelli (L’Arcolaio, 2014); Diario doppio (Robin, 2017) e Furto d’anima (Greco & Greco, 2018). Con lo stesso Ercolani cura la rivista online “La foce e la sorgente”.
Vince nel 2005 il Premio Lerici-Pea per l’inedito e nel 2011 il Premio Astrolabio per Ritorno alla spiaggia e l’opera complessiva. Suoi testi sono tradotti in antologie, riviste e libri collettivi. Nel 2016 raccoglie, per Puntoacapo, un’antologia della sua opera poetica: Nell’intimo del mondo. Poesie 1970-2015 (finalista Premio Camaiore 2017).
Sito web: www.lucettafrisa.it
Tiziana Gabrielli, “Carne viva”, videolettura; note di Adelio Fusé, Romano Morelli, Mario Novarini, Giuseppina Rando
Carne viva
⃰
Carne viva
l’inestinguibile sete
nel trapassare infinito
dal nulla al nulla
verso/voce
dell’originario
La luce è l’ombra dell’Ombra,
lingua dell’inaudito
estasi dell’assenza
infanzia del logos
⃰
Vicino è ora
l’irraggiungibile
sapere è non dire
o dire quel niente
che è un tutto
ci tiene in bilico l
a parola
e non salva
solo un gesto
purissimo, il più leggero
sarà forse la traccia,
una svista, lo scarto,
o il logico caos
del caso
⃰
l’azzurro slabbrato
nel primo battito
dell’estate
esserenuvole nuvole
e lontananza
assoluta mancanza
nel presente remoto
di un futuro anteriore
saremo quali eravamo
prima di precipitare
in un nome
Adelio Fusé per Tiziana Gabrielli
Tre poesie d'impronta filosofica (con echi presocratici) comprese in un unico itinerario esistenziale, che è insieme biografia della parola e della vita. Si va da... a..., dalla luce all'Ombra (la maiuscola è nel testo, e non per caso), "dal nulla al nulla", seguendo un tracciato non lineare ma circolare. D'altra parte è circolare la concezione del tempo che qui traspare: siamo già lontani come una mancanza "nel presente remoto / di un futuro anteriore" e infine "saremo quali eravamo / prima di precipitare / in un nome".
E la parola? "ci tiene in bilico / la parola / e non salva". Rispetto all'esistenza, la parola appare in posizione privilegiata: mentre la parola trae il proprio senso dicendo l'esistenza, l'esistenza non riceve un senso dalla parola. Il senso dell'esistenza sta nel riconoscere che il 'governo' delle cose spetta a "il logico caos / del caso". Di più non possiamo pretendere.
La parola non aggiunge (non porta qualcosa in più all'esistenza) ma attesta e certifica una condizione: "Vicino è ora l'irraggiungibile / sapere è non dire / o dire quel niente / che è un tutto".
La "Carne viva", allora, è lì, nel caos/caso, nella sequenza imperscrutabile degli avvenimenti a cui siamo consegnati.
Romano Morelli per Tiziana Gabrielli
La poesia di Tiziana Gabrielli è la descrizione dolorosamente lucida di uno stato esistenziale, il momento dello svelamento dell’essere al mondo: “assoluta mancanza / nel presente remoto / di un futuro anteriore.”
I versi, densi e nitidi, evocano i mobili contorni inafferrabili del grande equivoco in cui siamo smarriti, “il logico caos / del caso”, ristabiliscono verità e misure dell’essere umani e ci annunciano un destino, forse un auspicio: tornare ad essere “quali eravamo / prima di precipitare / in un nome”.
Tuttavia il testo pulsa come una ferita aperta, è “carne viva” e la sete è inestinguibile; è la voce dell’attesa inquieta di un compimento. Ed ora che sappiamo che “la luce è l’ombra dell’Ombra”, che “sapere è non dire” e che la parola non salva, “vicino è ora / l’irraggiungibile”.
Mario Novarini per Tiziana Gabrielli
Dire l’indicibile, la parola che esprime il mistero dell’esistere, ma guarda anche al prima, al dopo e all’oltre, è, non meno di un’inestinguibile sete, esigenza primaria della carne viva. Un paradosso, un adynaton: il logos è il solo mezzo a nostra disposizione per esprimere ciò che lo trascende. Così non possiamo definire la luce se non come negazione del suo opposto. Così l’irraggiungibile (pur sentito vicino) sapere è ineffabile, o è dire quel niente / che è un tutto. E nel provare a dirne anche solo un barlume la sequenzialità univoca della sintassi deve superarsi facendo coesistere la dimensione paradigmatica e quella sintagmatica (l’irraggiungibile / sapere fa da soggetto, contemporaneamente, a vicino è ora… e a … non dire / o dire quel niente / che è un tutto) e annullando quasi completamente la punteggiatura.
Ci tiene in bilico / la parola / e non salva: forse solo attraverso una svista del soggetto senziente è possibile cogliere, in modo inavvertito, un frammento del senso nascosto nel logico caos / del caso, dove il mistero del tempo sfugge all’indagine razionale che, per provare a interpretarlo e a descriverlo, deve stravolgerne le categorie grammaticali e ontologiche.
E alla fine, ripercorso l’iter dal nulla al nulla iniziato nel momento in cui siamo precipitati temporaneamente in un nome, irripetibile individuale declinazione di un caso della grammatica dell’essere, ci accorgiamo di un’altra traccia, non meno misteriosa, apparsa nella filigrana della trama che la nostra vita ha intessuto.
Giuseppina Rando per Tiziana Gabrielli
“Carne viva“ di Tiziana Gabrielli, emerge come immagine riflessa di quel l’inestinguibile sete
che assilla l’essere umano e lo rende consapevole del nulla da cui proviene e a cui è destinato (dal nulla al nulla).
La Poeta ri-vive la lucida disperazione esistenziale che concepisce la vita come tragico esilio, impenetrabile mistero (lingua dell’inaudito/ estasi dell’assenza), condanna alla solitudine, all’incomunicabilità (sapere è non dire / o dire quel niente).
L’essere umano (carne viva) s’aggira come una fosse una larva, rassegnato a vivere nel logico caos / del caso.
E’ la poetica del non-essere che tiene in bilico / la parola / e non salva, emblematica dell’intellettuale moderno di fronte agli enigmi della natura e all’irrazionalità della Storia.
Sembrerebbe che la Gabrielli si interroghi sul senso della ricerca poetica, forse, nel tentativo di confrontarla con la vita e con ciò che, in apparenza, sta fuori dei suoi confini.
L’immagine dell’ esserenuvole nuvole accende per un attimo un barlume di fugace serenità, assorbito subito dopo dalla dominante intonazione dell’assoluta mancanza e della perenne angosciante realtà.
Tiziana Gabrielli (1969) vive tra Roma e Chieti. Ha conseguito nel 1996 una laurea in Filosofia (cum laude) all’Università degli studi di Chieti, e, nel 2004, un Dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera e la Humboldt-Universität di Berlino. Si è perfezionata presso la Scuola Normale Superiore di Pisa in Filosofia classica tedesca, e in Bioetica, presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma. Attualmente i suoi studi sono orientati all’approfondimento dei rapporti tra filosofia, arte e letteratura. Giornalista pubblicista dal 2007, è autrice per la tv, la radio e il cinema ed esperta in marketing e comunicazione digitale. Come poeta, le sue liriche – talune tradotte in spagnolo e in greco moderno - hanno ottenuto importanti riconoscimenti.
Nel 2014 ha pubblicato l’opera L’ora senza nome, Cierre Grafica, Verona 2014 (Premio “Opera Prima” 2013), e la silloge Il silenzio della luce, Giulio Perrone Editore, Roma 2015 (Finalista del Premio di poesia Walter Mauro 2014). Alcune sue liriche sono state scelte per essere pubblicate nell’Enciclopedia di Poesia Contemporanea 2015, edita dalla Fondazione Mario Luzi Editore.
Massimo Rizza, “Non ancora corpi”, videolettura; note di Laura Caccia, Adelio Fusé
Non ancora corpi
della bestia amavi quel suo attendere tra le righe, sfuggire alla morsa del testo
quella forma che si aggira non è corpo e non è volto, è soffio e tensione di vita
nascondersi tra le sembianze dell’esserci e lacerare coi denti quella carne viva
pulsa per pochi istanti, sparsa nella grafite ai piedi del foglio, ferma nel verso
prima che il nome recida il cordone di una parola ferita, attesa di un divenire
tra filamenti e nervature, il segno impedisce di scorgere il filo appeso alle fibre
cosa muta, carezza e tremore dove il respiro è scrittura dell'essere incanto
corpo di argilla impastato con la saliva del tempo e lo sguardo fisso nell’aria,
soffio di musica nella mano, dove pensiero e vita scorrono via, e si penetrano
grido soffocato e silenzio dell’astinenza, sabbia trasparente svela il disegno
parola chiara ti svesti insicura in quel corpo non tuo, dipingi il volto ferito
chiuso tra le pieghe sanguinanti del mistero che lega il tempo all’eternità
alla pietra serena, al suo freddo esistere senza labbra e senza parole, essere
muto sguardo che avvolge e protegge, ti guida nella grotta dell’urlo iniziale
che spunta tra le nuvole e si affaccia sulla scena, sole femmina, opera rotonda
pancia di cielo, nel fango di quell'essere ancora informe, mani aperte bianche
sulla pietra scolpita, scavata nel nulla, di quello che fuori non ha ancora nome
antica misura di un essere informe, essere solo pensato, essenza di un sé salvato,
anima nuda sofferta che sale, procede lenta e piegata, arretra e cade, sollevata
prende corpo, si fa volto e impronta di un procedere senza lamenti, ferma nel cielo
luna maschio, schiena della notte, urla parole prima che sul sogno cali il sipario
dire favola femmina, dire ascoltare rotondo maschio, assecondare il corso
allentare le parole e attendere che tornino bianche, velami di vita nell'aria,
strisciare, dire strisciare con le pance e ruotare con i fianchi sui sassi piatti
espellere uova parola, albume femmina imbianca l'acqua, dire cicatrizza
imbuto maschio non permette di entrare, occlude il desiderio con il dito,
tralasciare si appiccica al senso corrente, ferma il suo movimento, avvolge
pulsare, per un solo attimo hai tenuto il pensiero libero dal non essere nato
si ritrae, non esce nel fuori, si lascia toccare non presa dal dire
chiamata si affloscia sollecitata a salire nel momento senza tempo
si raggomitola nell'esteso dell'innominabile luogo, si erge sospesa
finita nell'orizzontale apre di nuovo al possibile guardare, ripresa
sollecitata a salire si riempie di niente, espelle l'indicazione verso
non pronuncia il nome avvolge il senso nel ritirarsi dentro, piegata
avverte di essere sul punto di scorrere via, uscire dal testo inviolata
di nuovo in cammino, il passo è quello di sempre insicuro e sospeso
speranza e calore ancora di quel soffio, certo di un pulsare animale
parola tam-tam, parola urlo, cosa recisa sanguinante di puro senso
nascondersi dove il dire dorme tra le pietre, dove il nome è fuggito
velata nudità di un sogno, di un divenire carne, di un tramutarsi solo
sfuggire alla voce che invoca, nascondersi dove il verso è fuoco vivo
vegliare la morte e stendersi tra le parole tremanti, non ancora corpi.
Laura Caccia per Massimo Rizza
Ha la forza del risalire la corrente il dire poetico di Massimo Rizza. Immerso tra gli anfratti di un impasto primordiale in cui le parole non sono ancora voci,“non ancora corpi”. Dove, tra mistero e desiderio, è un tendere inesausto e insieme un ritrarsi, l’affacciarsi in una forma e subito spogliarsene. Un incessante passaggio tra fisicità e parola, corporeità e scrittura. Verso una nudità del dire che attende di essere portata alla luce e nello stesso tempo esige di rimanere occulta, nutrita da una tensione che insieme musica e lacera.
Quasi una contesa tra forze in opposizione: da un lato, il finito prevaricante del testo, dall’altro, “un pulsare animale /parola tam-tam, parola urlo” che sfugge e resiste. Dove il pulsare è soffio, tensione vitale infuocata e desiderante. Qualcosa di più, però, del solo portare in superficie il contrasto tra incorporeità e sembianze, essere informe e forme costituite. Qualcosa che piuttosto richiede di immergersi completamente nell’informe, colmo di sangue e di fango, saturo di assenza di nome e di senso, assumendo il contrasto come costitutivo dell’esserci e dello scrivere.
Qualcosa che esige di trattenerne il respiro, in un pensiero senza nascita, in una parola senza nome, e, nello stesso tempo, di renderlo possibile per sé, nella propria corporeità così come nella scrittura. Tra parole insieme incorporee e desideranti, residui dell’ardere muto, in attesa “dell’urlo iniziale”. In un processo, vitale e poetico, che tenta, tra gli anfratti dell’esistere e del dire, anche onirici e inconsci, di risalire fino al prima della parola, nel gorgo muto e infuocato, misterioso e lacerante che ne precorre il parto. Ancora prima di quella precedenza temporale che O. Mandel'stam attribuiva al sussurro rispetto alle labbra. Qui ancora prima. Prima della corporeità e del dire. Un prima radicale: un pre-dire “senza labbra e senza parole”.
Adelio Fusé per Massimo Rizza
Chi non ha ancora un corpo è, anzitutto, la parola prima di essere scritta. Eppure, quando acquisisce un corpo, lei, la parola, manifesta disagio ("parola chiara ti svesti insicura in quel corpo non tuo"); muovendo poi verso il senso delle cose, lei, che "si riempie di niente", si sottrae (la parola "avvolge il senso nel ritirarsi dentro").
A non avere un corpo è anche l'autore quando non scrive e attende "un pulsare animale / parola tam tam", la parola che si propaga e viene condivisa (sottintendendo il lettore, figura qui taciuta ma certo presente). La mano che scrive e la parola che pulsa sono un unico corpo. O, meglio, sono la ricerca di un corpo mai trovato come definitivo.
La parola è la protagonista di una storia inevitabilmente sempre in corso. Si acquatta, si manifesta, non si lascia imbrigliare ("della bestia amavi quel suo attendere fra le righe"). E siccome l'autore non è un predatore ma qualcuno che vuole capire, dopo averla attesa e provvisoriamente incontrata, sa di perderla fino al prossimo appuntamento.
La scelta del verso lungo con una inclinazione alla prosa (benché il testo sia in tutto e per tutto un testo poetico) si traduce in un andamento ipnotico costruito con perizia, di tempo moderato (tempo, qui, in senso musicale), che mescola i due versanti della realtà e del sogno. Del resto la parola, nel suo dire fuggevole, appartiene all'una e all'altro.
Massimo Rizza è nato a Sesto San Giovanni e vive a Segrate (Mi). E’ laureato in pedagogia e ha operato nel campo dell’istruzione in qualità di dirigente scolastico. E’ condirettore della rivista letteraria Il Segnale. Ha pubblicato la raccolta poetica Il veliero capovolto, Ed. Anterem (2016).
Nel 2017 ha vinto il Premio Letterario Interferenze, Bologna in lettere, per la sezione poesie inedite.
Suoi testi narrativi sono pubblicati in antologie e on line sul sito della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Testi di poesia, critica e saggistica sono apparsi su riviste letterarie italiane, tra le quali: “Anterem”, “Capoverso”, “Erba D'Arno”, “Il Segnale”, “l’immaginazione”, “Pagine”, “Scibbolet”.
Enea Roversi, “Il peso delle parole”, videolettura; note di Rosa Pierno, Lia Rossi
Il peso delle parole
riappare (eccolo) il peso delle parole
ostinato e greve confuso con
la grammatura della carta
per astratte materie e indivisibili misure
verso distinte e confinanti unità
si riavvolge il labirinto dei pensieri degli elementi
assoluti così imperfettamente congrui i solchi
le indelebili macchie fra le righe e gli spazi
poi la coerenza da non dimenticare mai
lo stile cercato nei cassetti e dentro la polvere dei libri
la fatica della ricognizione tutto ha un inizio
nulla si conclude qualcosa rimarrà o
magari no forse soltanto un peso inutile
un debordante avanzo di vuoto
e la scialba consapevolezza che il
tempo sposta le nuvole e
inchioda i sentimenti
alle pareti per ogni anima perduta
Rosa Pierno per Enea Roversi
C’è un elemento in comune fra parole, peso, misure, spazi, tempo ed è il pensiero. Come si debba riconoscerlo è la questione centrale nella poesia di Enea Roversi “Il peso delle parole”. Innanzitutto, lo si fa tramite l’intercessione di oggetti concreti: la carta con la sua grammatura, il labirinto, le macchie, i cassetti, la polvere: nulla si conosce se non tramite esperienza. Il testo poetico descrive un armamentario - e si direbbe quello tipico dello scrittore, inchiodato alla sua scrivania - che serve metaforicamente alla trasmutazione degli oggetti quotidiani nelle metafore che funzionano da trampolino per la creazione dei concetti astratti. Non troppo nascosta è la questione del pensiero in poesia, come isolarlo, come individuarlo; se esso sia propriamente il pensiero preciso che ogni lettore attinge ineluttabilmente, oppure se esso sia appena una possibilità interpretativa, un barlume, perché se così fosse, si tratterebbe di un senso impreciso e aleatorio, eppure altrettanto ineludibile. Eccola, in chiusa, l’evidenza che risalta come un diamante innestato nella fanghiglia di ogni inizio di scrittura poetica, che ha sempre in sé la possibilità di uno scacco: la consapevolezza che il sentimento, intriso di senso, schiuda ogni volta a qualcosa che, pur nato tra solchi e macchie, illumini il cielo della pagina.
Lia Rossi per Enea Roversi
Perché pesare le parole, perché non lasciarle alate, perché pensarle insite in grammature di carte?
Parchè la parola è anche carta assorbente, include silenziosamente solchi, macchie, righe, spazi, polvere dei libri. Attira a sé lo stile della ricognizione, la fatica, la consapevolezza delle nuvole che si spostano e i sentimenti inchiodati alla fermezza dei muri.
Le parole sono abiti, e senza cuciture, come la veste di Cristo, sono sacre fasciature del reale che accade ed è accaduto: un‘unica materia di tessuti intrecciati, un patchwork impensato e sotterraneo, una colla potente.
E’ il modo di cucire del poeta rhapsòdos: cuce il canto.
La parola, già metafora per eccellenza, termine che porta fuori dal confine, pervade pensieri e lingue, organizza, inventa una cosmogonia, all’interno di un tempo eterno. Il tempo entra nella parola di Enea Roversi anche all’improvviso in modo più discorsivo: Poi la certezza di non dimenticare mai …
Nulla si conclude qualcosa rimarrà o magari no. Come briciole di conversazione, quasi un poème-conversation di Guillaume Apollinaire, quasi un Lundì, rue Christine: la parola si iscrive, per far parte della commedia della scrittura, di questa necessità ne siamo convinti, insieme a Roland Barthes.
Riappare (eccolo) il peso delle parole: ecco l’iscrizione, per fortuna.
Enea Roversi vive a Bologna, dove è nato nel 1960.
Ha ottenuto riconoscimenti e segnalazioni in vari concorsi nazionali di poesia ed è stato pubblicato su riviste, antologie e siti web.
Tra le pubblicazioni: la raccolta Eclissi di luna (Poesie 1981-1986), uscita in versione e-book nella collana Nuovi Echi per la casa editrice La Scuola di Pitagora e la silloge Asfissia, pubblicata nel volume Contatti edito da Edizioni Smasher.
Più volte segnalato o menzionato al “Premio Nazionale di Poesia Lorenzo Montano” organizzato dalla rivista Anterem, ha partecipato ad alcune edizioni della Biennale di Poesia di Verona e ad altre rassegne letterarie.
Fa parte della redazione della rivista online Versante Ripido e figura nello staff organizzativo del Festival Letterario Bologna in Lettere.
Cura il sito web www.enearoversi.it, interamente dedicato alla propria attività letteraria e pittorica e il blog Tragico Alverman – Scrittura e altro.
Roberta Sireno, “Trasmette luce differente, acqua”, videolettura; note di Laura Caccia, Adelio Fusé, Irene Santori
trasmette luce differente, acqua
buia di montagna, occhio
fossile nel tatto che riprende
nella vocale che articola e cede
all'impatto della visione, largo
campo di foglie e poi
solo vento
Laura Caccia per Roberta Sireno
Un germoglio del caduco il testo poetico di Roberta Sireno. Pronto a schiudersi all’interno di una stagione oscura, dentro un calco residuo da cui irradia mistero. Un germoglio della visione, della parola, dell’oltre. Denso della ricchezza occulta e manifesta che un intero contiene, racchiuso nella forma compatta e insieme aperta del testo, e, nello stesso tempo, colmo della precarietà che il molteplice declina nelle sue forme fugaci.
Quasi un affresco dai rapidi tratti e dalla pluralità di strati: dove, da una profondità remota, sbocciano immagini pronte facilmente a dissiparsi. Il colore sensoriale è quello immediatamente percepibile: una varietà di impressioni visive, tattili, uditive che si dilatano e si richiamano tra i versi. Al di sotto, in chiaroscuro, la trama oppositiva che governa il pensiero dell’intero, tra gli ossimori che trattengono, uniti, oscurità e chiarezza, fissità e movimento. E, ancora, tra le sfumature, la presenza rarefatta dell’oltranza: all’inizio, introdotta da una luce altra; al termine, lasciata emergere dal vuoto che il vento trascina in primo piano.
Un affresco alla fine sottratto al visibile, non però alla parola. Sulla compattezza visiva del testo, supportata dall’unica strofa che lo compone, la dinamica delle sonorità interne, amplificata dalla vocale risonante in posizione centrale, prende il sopravvento. Sottesa nell’oscuro, ma potente nel suo emergere, la presenza della voce tra gli elementi naturali e sensoriali riesce a portare il testo altrove. A dipingere lo sbocciare di una visione che cancella. Sotto forma di ossimori, i sostantivi e i loro attributi. In battere e in levare, in sottrarre e in dilatare, le forme verbali. Così una parola altra prende voce, “trasmette luce differente”.
Adelio Fusé per Roberta Sireno
Una sola strofa di sicuro effetto, fonicamente omogenea, misteriosa e onirica, che accosta immagini di segno opposto ("luce differente", "acqua / buia"). Ciò che qui si descrive è un'esperienza sensoriale onnivora: il vedere ("occhio fossile nel tatto", attore e testimone in sintonia con il tempo smisurato delle ere geologiche) si unisce al tatto (dunque la fisicità) e sbocca nella necessità del dire ("vocale che articola").
La rapida concentrazione delle immagini, simile a quello di un sogno, infine prende respiro e si allenta ("largo / campo di foglie"), ampliando la prospettiva: il "solo vento", isolato e conclusivo, disperde la visione; oppure, meglio, la sospinge altrove. Perché la visione – sembra ricordarci Sireno – è dinamica, mai ancorata a uno stesso punto del paesaggio (reale o immaginario che sia), e in movimento continuo.
Irene Santori per Roberta Sireno
Considero la poesia di Roberta Sireno meritevole di vincere, per avervi incontrato, oltre alla misura e originalità di talune immagini, riscontrabile anche in altri finalisti, una ricerca di unità compositiva del testo, giocata su serrati rimandi interni.
Tatto e udito, in una spirale sinestetica, sembrano afferire alle proprietà dell’occhio e dare alla vista la facoltà di toccare e articolare suoni, anzi la vocale, parola connotatissima questa, che porta in sé l’origine oscura del linguaggio, prima dell’avvento delle consonanti. Perciò l’occhio si fa tramite di una luce differente, altra, ossimoricamente buia, come acqua di montagna, forse carsica, ovvero del profondo. Ma il buio dice molto di più. Questo potenziamento sensoriale viene infatti pietrificato, quasi accecato, nella fossilizzazione dell’organo di senso, occhio fossile: l’espansione dei campi percettivi è dunque contestualmente abolita fino alla perdita della stessa facoltà visiva dell’occhio. Recuperata poi, ma in chiave deponente, in un arrendersi alla visione, soccombendo ad essa.
Quel cede, inanellato a riprende, entrambi a fine verso, non è dunque nel campo semantico del cedere ovvero del dare, come alienazione di un sicuro possesso, ma ancora nella modalità passivante della resa: non siamo nello schema del prendere e del dare, ma del prendere e perdere.
Accumulo e perdita: ancora una volta, come fosse una coazione a ripetere dell’autrice, si riaffaccia il nodo - tematico e portante dell’intero componimento - dell’espropriazione, della sottrazione e spoliazione: nel campo visivo come nel campo semantico, e come, infine, nel campo di foglie… Immagine, quest’ultima, quasi olfattiva e di raccordo e sintesi di tutte le disseminazioni del testo. Essa ci dice di accumuli di foglie cadute da alberi che si vanno spogliando. Appena un colpo di vento poi e si spoglia anche il campo.
Roberta Sireno (Modena, 1987) autrice di Fabbriche di vetro (Raffaelli, 2011) e senza governo (Raffaelli,
2016). Riceve il primo premio al Certamen (Centro di Poesia Contemporanea di Bologna, 2009) e al concorso di poesia Dentro che fuori piove (Università di Bologna, 2013). Suoi scritti sono su «Poetarum Silva», «blanc de ta nuque», «Golden blog», «La macchina sognante». Principali rassegne: RicercaBO (Bologna, 2012), Teatro Valdoca (Cesena, 2013-2017), Cabudanne de sos poetas (Seneghe, 2014), Magnifico Teatrino Errante (Bologna, 2016-2018). È curatrice insieme ad Anna Franceschini della rassegna Una come lei. Incontri e pratiche di poesia (2018-2019, Centro delle Donne di Bologna). Nel 2018 è prima classificata al premio nazionale Anna Osti di Costa di Rovigo nella sezione poesia edita.
Francesco Bellomi, brano originale per Roberta Sireno
Diego Terzano, “Parapiglia”, videolettura; note di Flavio Ermini e dell’Autore
Diego Terzano, “Parapiglia”, videolettura;
doppia versione (per il “Montano” e la variante uscita su “Anterem” 99), note di Flavio Ermini e dell’Autore
Flavio Ermini per Diego Terzano, Essenziali riflessioni su “Parapiglia”
Tra volo e gravità
Solo la ninfa Mnemosyne – in quanto figlia di Urano (il cielo) e Gea (la terra) – potrebbe ancora dar luogo all’ascolto della coscienza originaria. Ma da tempo ormai Mnemosyne si sottrae al suo ruolo, ponendo così in evidenza l’ingiustizia dell’oblio al quale l’ha condannata l’essere umano.
“Parapiglia” è l’accorato volgersi alla ninfa per chiederle di tornare tra noi, portando con sé il suo linguaggio, fatto di gesti, di espressioni corporee, di occhi, di sguardi, di effusioni affettive; un linguaggio-dei-corpi a tutti comprensibile, in quanto dialogo, colloquio “tra volo e gravità”.
“Parapiglia” è l’incessante volgersi a Mnemosine affinché ci aiuti ancora una volta nella ricerca di una parola che, ripetendo l’origine, si costituisca come rinnovato principio di una relazione autentica con il mondo.
La nostra storicità, osserva Diego Terzano, non è di per sé una condanna; al contrario può consentirci di esercitare la nostra libertà, facendoci soggetti della storia stessa.
Il nostro esserci, d’altro canto, non è solo una chiusura in ciò che già è; al contrario può costituire anche un’apertura rivolta a ciò che può essere; un’apertura affidata a labbra che hanno finalmente ricominciato a parlare.
Ma queste possibilità possono realizzarsi solo a una condizione, e Terzano prova a indicarcela: diventare partecipi di un processo linguistico e gestuale in cui produrre continui ricominciamenti, in virtù della consapevolezza che il passato – con il suo peso – ha su di noi. Un passato al quale ci sarà ancora consentito accedere unicamente grazie alla memoria della quale unica custode è la ninfa Mnemosyne.
Parapiglia (Versione di aprile 2019)
Si spande di tra occhio e cielo un fumo
su cui corre una polvere stellare:
di là vite, oltremare,
punteggiano già tutta la pianura
del pensiero. L’imago tua e il profumo
di vaniglia, la rabbia liminare
che raccoglie un tonare
più nero, si rastremano in arsura, e
tra volo e gravità l’inarcatura,
antica, del tuo gesto ormai governa,
nella cieca caverna
del tormento, lo spazio e il tempo puro
del fiore: nato, e da sé morituro.
Il fuoco per l’abisso che riarde
funesto si fa sole; ancora mosso
dal tuo terrore rosso
mi richiudo negli atti, i tuoi, di petra.
Prolissa, la tua posa, nelle tarde
sere mi scuote e iracondo, commosso
è il tuo cuore colosso –
dei miei moti ti scopri geomètra.
Ma ora che, lenta, la bruma s’arretra
rivolta già ti desto, ed esitante,
a blandire un istante
senza modo. È un divino, eterno azzardo:
l’oblio, forse, godi nello sguardo.
Eppure attendo, come te silente,
che si riapra l’immobile stato –
un tocco delicato
della sottile mano, chiara linfa,
l’immane abbraccio dell’in sé latente
del mondo: come segno inabitato
l’evento è incastonato
tra i nostri corpi e il tuo volto di ninfa.
Come il fuoco la pietra (paraninfa
di nozze, e spettri, tra condanna e strazio)
risorgerà topazio
nel bruno dei tuoi occhi, giù nel mare
fresco. L’assillo vi lasci annegare.
E se poi l’aria, candida, che schianta
i nostri giorni avvolti nello speco
notturno, amore cieco,
ammaliasse di vera luce il corso
che s’invade del niente – già rifranta
da sempre dentro sé la vasta eco
di un remoto, più bieco
terrore (quello del senso, trascorso)...
Allora certo, nel folle decorso
– tra luci nuove – dell’inerte cuore,
guarderemmo all’amore
il primo, che si cela già nel bianco
del vento. L’alba ammanta il cielo stanco:
su queste lande, fuori del deserto
aspro – incastro d’eterne viltà,
fuor di necessità
che si versò nel ventre della terra,
due fonti attingono a uno sguardo aperto.
Tersa goccia di luna, è vanità
l’immensa oscenità
della misura: ecco un nume, ci afferra...
E ancora la tua mano: ora serra
l’unità del pensiero – l’aporia:
già questa melodia
è ombra, ma l’imago della sorte
buona rammenti. Recede la morte.
Parapiglia (Versione di ottobre 2019, da “Anterem” 99)


Diego Terzano, Intorno al parapiglia
Prove urgenti di sublimazione, proiettate verticalmente nel tempo – proprie e altrui; la resa di qualcosa in immagini, che rispetto alle attese di qualcuno permangono o rimarranno mute; e la tentazione di tenerle private, a un primo livello: salvo poi provare – tentare ancora – delle personae, che di quel plesso di esigenze si facciano mediatrici (o ermeneuti); e al massimo della dispersione concettuale, una dittatura della forma, distesa orizzontalmente? E ancora, forse, la ricerca di una comunicabilità in primis fallita, e via via rinegoziata: c’è, effettivamente, qualcosa da dire a qualcuno?
Fallisce, a dirla tutta, lo stesso tentativo – questo – di testimoniare il campo di energie di cui scrivendo ci si fa sfogo. Con ciò intendendo la comunicabilità e il fallimento comunicativo moduli scalari e coimplicati: reversibili; così come reversibili, a posteriori, si presentano la dimenticanza e la reminiscenza di ogni tentativo di dire, all’atto della rimodulazione testuale. Continuando a procedere per associazioni, e assunto che per chi scrive non si risolve ancora la dialettica tra possibilità e determinazione di una variante concettuale-formale, la divaricazione fra due cristallizzazioni testuali resta naturalmente l’isolamento di due momenti di uno scalare processo di indecisione, di delineazione del plesso tematico via via ingannato, a cui per sfinimento ci si arrende una volta attestata una possibilità minima di dialogo.
Diego Terzano (1993) ha compiuto studi letterari e filosofici a Genova ed è dottorando in Studi italianistici all’Università di Pisa. Si interessa al rapporto tra antico e contemporaneo e tra pensiero e poesia. Al centro del suo lavoro si colloca, in particolare, l’opera di Carlo Michelstaedter.
Ultima pagina, Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi: un trailer, “Sinossi”, fotogrammi







Giorgiomaria Cornelio (14 Gennaio 1997) e Lucamatteo Rossi (3 Dicembre 1996) hanno fondato l’atlante Navegasión, inaugurato nel 2016 con il film “Ogni roveto un dio che arde” durante la 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Loro opere sono state presentate in festival e spazi espositivi internazionali, come i Rencontres Internationales Paris/Berlin, il Marienbad Film Festival, l’Asolo Film Festival e il Richmond Center for Visual Arts (Western Michigan University). Tra le altre collaborazioni si segnalano la performance ”Playtime”e la mostra “Young at heart, older on the skin ”, entrambe curate da Franko B. Nel 2019 hanno tenuto un Openshop alla Dublin Science Gallery, e hanno inaugurato la loro ricerca teatrale con il primo studio di “Elagabalus”. Attualmente studiano al Trinity College di Dublino.
Giorgiomaria Cornelio cura infine il catalogo online di ricerca cinematografica “La camera ardente”, ed è anche scrittore: suoi interventi sono apparsi su “Doppiozero” “Le parole e le cose”, “Il Manifesto”, “Il Tascabile” e “Nazione Indiana”, di cui è anche redattore. Ha vinto il Premio Opera Prima (Anterem) con la raccolta La Promessa Focaia, ed è stato finalista al premio Montano e al premio Bologna in Lettere.
Marzo 2020, anno XVII, numero 45

Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura della redazione di "Anterem"
Dal presente numero “Carte nel vento” non avrà più un solo curatore ma diventa un collettivo di redazione: d’ora in poi il periodico sarà prodotto, in ogni fase di realizzazione, dall’intero corpo redazionale di “Anterem”, costituito da Giorgio Bonacini, Laura Caccia, Mara Cini, Flavio Ermini, Rosa Pierno, Ranieri Teti.
Nella visione e nella condivisione di un’idea comune che dura da decenni, dall’esperienza di “Anterem” a quella del “Montano”, si rinsalda ancor più l’elemento distintivo di questo premio: la completa coincidenza tra la redazione della rivista e la giuria storica.
Durante i cinque mesi appena passati, questo gruppo privo del suo direttore è riuscito con un grande lavoro collettivo a portare avanti tutto quanto intrapreso, in cartaceo e in rete, superando ogni ostacolo.
In tempi così difficili ritengo sia giusto ancorarci tutti alla stessa passione e condividere il più possibile, il più possibile vicini e radicati nella certezza che insieme ogni atto sia maggiormente consapevole e fecondo, senza arretramenti né pause.
Con questo numero di “Carte nel vento” si conclude la presentazione delle opere segnalate e finaliste al 32° Premio Lorenzo Montano, edizione 2018. Abbiamo il piacere di proporre testi che, nella varietà dei temi e delle forme, offrono uno sguardo inedito sul senso del nostro esistere poeticamente. Tutte le opere sono introdotte dalle note della redazione di “Anterem”: senza definizioni generiche, abbiamo cercato anche questa volta di accompagnare le poesie e le prose qui contenute con spunti di lettura originali.
Abbiamo inoltre il piacere di ospitare in copertina Miro Gabriele, non solo poeta e traduttore, ma anche fotografo: un fotografo con la visione del poeta.
Ma tutto questo non è che una breve sosta, il tempo di un respiro… l’edizione 2020 è in corso, per nuovi sguardi e per altri versi e prose che sarà un grande piacere raccontare e pubblicare.
Scarica il bando del 34° “Montano” (2020)
Ranieri Teti
In copertina: “Campidoglio”, fotografia di Miro Gabriele
Alessandro Ramberti, poesia inedita "La presenza è un profumo che nutre", premessa di Ranieri Teti
Si presenta in modo sensoriale questa poesia.
Sensorialmente ci permette di percepire una materia.
Come l’odore di “quell’albero”. Tanto precisamente indicato, perché è proprio quello,
quanto vagamente citato solo per il suo profumo invernale. Come il sapore del cibo.
In postura di ascolto attivo, questa poesia di Alessandro Ramberti si dispiega nel crocevia delle sensazioni.
E dopo l’olfatto attraversa l’udito, che sembra evolvere in una percezione che aumenta.
In una sorta di crescendo, il testo ci conduce fino a un senso ulteriore che solo il poeta può riconoscere, solo il poeta può dire.
Un senso inedito, il sesto del poeta, quel senso che, a differenza degli altri, non ha bisogno dell’aria per essere trasmesso.
Ma solo di vicinanza, di contatto, di quello stringersi che diventa scarica, energia per proseguire un cammino, andare avanti.
La presenza è un profumo che nutre
Nello stare acquattati
si decantano
le sensazioni
infilandosi nelle teche
le immagini rilasciano
pian piano
le forme colorate trattenendo
il sapore di quel cibo semplicissimo
l’odore di quell’albero
che emana il suo profumo
quando è inverno.
È un’archiviazione più profonda
che sembra fare a meno
del suono – o lo condensa?
forse mette in moto
i liquidi vitali
la dinamica
dell’elettricità
non ha bisogno d’etere
ma solo di contatto
e vicinanza
magari con un po’ di simpatia.
Alessandro Ramberti (Santarcangelo di Romagna, 1960) è laureato in Lingue orientali a Venezia, ha vinto una borsa (1984-85) per l’Università Fudan di Shanghai. Nel 1988 consegue a Los Angeles il Master in Linguistica presso l’UCLA e nel 1993 il dottorato in Linguistica presso l’Università Roma Tre. Animatore delle Edizioni Fara, ha pubblicato qualche saggio, Racconti su un chicco di riso (Pisa, Tacchi), La simmetria imperfetta con lo pseudonimo di Johan Thor Johansson (1996) e alcune sillogi: In cerca (2004, Premio Alfonso Gatto opera prima e altri), Pietrisco (2006, premi Poesi@&Rete e Cluvium), Sotto il sole (sopra il cielo) (2012, Premio speciale Firenze Capitale d’Europa e altri riconoscimenti), Orme intangibili (2015, Premio Speciale Casentino, II class. Tra Secchia e Panaro, ecc.), Al largo (2017). Con l’Arca Felice di Salerno ha pubblicato la plaquette Inoltramenti e tradotto 4 poesie di Du Fu. Con la poesia Il saio di Francesco ha vinto il Pennino d’oro del concorso “Enrico Zorzi” 2017.
Andrea Rompianesi, dalla raccolta inedita “Ermeneutica imprevista”, nota di Laura Caccia
Un’altra danza
Appare, a prima vista, come un potente ossimoro, che spalanca domande di senso, il titolo della raccolta di Andrea Rompianesi Ermeneutica imprevista. Induce a chiedersi come possa l’esito di un processo, che richiede metodologie razionali e sforzi interpretativi, mostrarsi in modo inatteso, quasi a sgorgare da un inciampo o da un’illuminazione.
I testi ne sono esempio. Poiché articolare il linguaggio poetico, in modo da consentire che qualcosa di imprevisto emerga dai versi, è la scelta dell’autore che ci presenta il tentativo di mettere in atto una inaspettata ermeneutica: una diversa e altra modalità di interpretazione del reale che richiede un pensiero diverso e altro, dove, nelle possibilità aperte dalla rifrazione, la lingua si deformi e assuma significati distorti e plurimi.
Una rifrazione che, nella raccolta, si mostra colma di risonanze e di forme ripetute, sia negli echi interni ad ogni testo, sia nelle duplici stesure di molti di essi, di cui alle versioni successive della seconda sezione. A partire dal rinunciare ad ogni intento, in presenza di “irti di sassi anemici adagi edulcorati armeggi /se / ogni eco discinta concede intenzione gravosa o estinta”, per abbandonarsi piuttosto alla sonorità e alla pluralità dei sensi che nei testi si rifrangono, si contrappongono e, nello stesso tempo, si riflettono e si illuminano.
Testi che escludono i modi formali di coesione, con uso prevalente di forme sostantivate e aggettivali, e che mettono in luce neologismi, reiterazioni di termini, coppie oppositive e assonanze suono-senso. Testi ottenuti attraverso un’esplicita azione di sottrazione, sia eliminando le forme grammaticali di coesione, sia riducendo le prime versioni alle scritture brevi delle seconde stesure, in entrambi i casi rimuovendo il superfluo dell’apparenza ai fini di una ermeneutica che apra all’essenza delle cose, di cui ha chiara consapevolezza l’autore: “- di altra parola ? - potrei / [ esporre diatriba affossata] / -dici nei tagli?”.
In questo modo la parola poetica può essere in grado di condurci nelle danze e nei gorghi mossi dalle speranze e dai dolori della condizione umana, in particolare “nei meandri di dolci speranzose guide cirri lasciati / del tutto opposti al quanto dobbiamo spendere per essere amati”, così come “ricercare il verso (che passion s’adira) in oltremodo fuori / non rassicura / se non esclude del quotidiano il subir dolori”.
E, soprattutto, la parola sottratta di Andrea Rompianesi può riuscire a mostrarci in tutte le sue sfaccettature, nei suoi echi franti e rifranti, nelle sue sonorità così come nelle sue riduzioni ai minimi termini, la ricerca e la messa in atto di una, accuratamente specificata in doppia parentesi, “[[ ermeneutica ulteriore e ampia / di ben altra danza ]]”.
***
[di altra parola ? - potrei
[ esporre diatriba affossata]
-dici nei tagli?-
“corrusco s’inonda l’exemplum riscossa” [ossa]
possibile anticipo in/fantile appannaggio drenaggio
l’arrota la chioma silvestre (e mancina)
[ la cima raggiunta
d’arrocco menaggio ] (1)
(1) maggio/faggio/raggio
***
nere le scarpe a emettere passi (di certo) in sull’uscio
e strada novella attesa di fioco sudore cartone/come
scatole tenenti buste ossidiane/vetuste echi risvolti
apportati ai tonici tolti e impressi negletti auspici
irti di sassi anemici adagi edulcorati armeggi/se
ogni eco discinta concede intenzione gravosa o estinta
***
se sia un sentire a)adirato
b)esteso
c)sollevato
[ altro passaggio ]
a)d’amor filiale
b)di tradizione evasa
c)d’identità lacquale
(dovremo passare attraverso la domanda ingenua emozionale
generando il distico che tale acconsente altro rigor formale)
***
forse che i tempi inverosimili di perpetua infanzia
confondono l’aromatico sentore (una zuppa inglese/
ripiena di cioccolatini) conducente impegno tarlo
domestico estenuante obliterato in seguito/sporto
nei meandri di dolci speranzose guide cirri lasciati
del tutto opposti al quanto dobbiamo spendere per essere amati
***
[ deriva d’epilogo ]
metrica: struttura strofica di dodici versi suddivisi
in distici a rima baciata con schema AA/BB/CC/DD/EE/FF.
quale premura tempo comporta il dato la cucitura
l’estenuata organza di fine tramite o/impalcatura
eccesso sfida di tenzon diverse le stesse agenti
coniate a corpo/setoso dramma contornato a denti
capaci a disputa di lontana voce astrusa inarca
l’abbandono il solo solitario esborso da tale barca
l’accesso oltraggio dell’acquisire servo di smistamento
riprovato/suolo calpestato occluso dal traverso vento
rimodellato l’affannato verbo contendente l’uso
solitudine a giorno e notte chiari passivo/attivo abuso
ricercare il verso (che passion s’adira) in oltremodo fuori
non rassicura/se non esclude del quotidiano il subir dolori
***
[[ ermeneutica ulteriore e ampia
di ben altra danza ]]
Andrea Rompianesi nasce nel 1963 a Modena. Già nel settembre del 1979 inizia la sua attività di scrittura in poesia. Compie gli studi presso l’Università di Bologna, laureandosi in Filosofia e approfondendo l’ambito della letteratura italiana contemporanea. E’ del 1986 il suo primo libro che ottiene riscontri da nomi come Luciano Anceschi, Paolo Ruffilli, Raffaele Crovi, Valerio Magrelli, Giorgio Bàrberi Squarotti, Cesare Vivaldi. Inizia così un percorso che incontra negli anni l’apprezzamento di molti addetti ai lavori, in Italia e all’estero. E’ presente in varie antologie. Dal 1990 svolge attività di operatore culturale; nel 1998 fonda Scrittura Creativa Edizioni, sigla editoriale impegnata sul fronte stilistico. Ha realizzato interventi di critica letteraria per il sito “scrittura nomade”. Risiede attualmente in provincia di Novara. Ha pubblicato, in poesia: “Orione”(1986), “Vascello da Occidente”(1992), “Punti cardinali”(1993), “Scendevi lungo la strada”(1994), “Momenti minimi”(1994;1999), “Apparenze in siti di trame”(1996), “I giorni di Orta”(1996), “La quercia alta del buon consiglio”(1999), “Scritti e frammenti”(1999), “Ratio”(2001), “Versi civili”(2003), “Metrò:Madeleine”(2004), “Gustav von Aschenbach”(2006), “Rimbaud Larme”(2007), “Il grido”(2008), “Fides”(2009), “Dietro tutti i colori del blu”(2013), “Quote di non proletariato”(2017); in prosa: “Il pane quotidiano”(1990), “Quella dei Beati Angeli”(1994), “Il killer”(1995;2000), “Venti e lune”(1995), “In odore di terre”(1998), “La notte dei grandi ladri”(2003), “Strada di pausa e di viaggio”(2012), “Avinguda del Paral-lel”(2014).
Cesare Vergati, "Diòcreme in filigrana. L’umido Uomo", ExCogita Editore 2017, nota di Flavio Ermini
Protagonista di questa prosa poetica è la figura del Diòcreme (nome proprio che si costituisce come anagramma di “mediocre”).
Questa figura sta occupando una posizione preminente in questa nostra società.
E Cesare Vergati ne è consapevole. Tanto da dare vita a una vera e propria “guida” per difendersi dalla mediocrità.
Una guida che orienta il lettore tra le varie categorie di “mediocri”, accomunate dalla volontà di eliminare ogni complessità dalla loro vita.
Una guida per liberare il volto umano dal ghigno dell’ignoranza, per aprirlo al sorriso che è proprio della conoscenza.
Cesare Vergati lucidamente ci avverte che la mediocrità ci sta portando vicinissimi al baratro morale.




Claudio Zanini, dalla raccolta inedita "Cronache dal limbo", nota di Laura Caccia
Pagina bianca
Dal lembo bianco e silenzioso di uno spazio sospeso e incompiuto tra la vita e la morte giungono le Cronache dal limbo di Claudio Zanini.
Sul contorno, sull’orlo: la poesia si colloca già nel limbo, nel suo significato etimologico, ma quello descritto dall’autore fa chiaro riferimento alla condizione delle anime, quale formulata dalla teologia cristiana o narrata nel canto quarto dell’inferno nella Comedia dantesca. Anche il titolo, quasi un ossimoro, pare essere posto sul bordo precario di un annuncio, anticipando una narrazione dettagliata di fatti e la loro collocazione, invece, in un luogo non fisico, un “non-luogo”.
Ci si trova sul confine tra i vivi e i morti, tra essere e non essere, dove tutto appare esangue, senza forza vitale e solo apparentemente riverberato da un lucore scolorito e insignificante, in cui presenze e assenze restano come sospese e indecifrate.
Nello stesso tempo il luogo, o meglio il non-luogo, viene descritto in modo preciso e dettagliato e, quanto più la narrazione indugia sui particolari, tanto più il senso di inquietudine emerge con forza lasciando risuonare e rimbalzare gli interrogativi che dolorosamente vengono posti con la “domanda informulata / ma fissa nella mente: perché siamo qui?” , così come: “perché tutto accade, / senza requie e per sempre ripetuto?”.
Il silenzio, il bianco dominante e un dolore appena accennato caratterizzano il limbo, generando sensi di precarietà, di incompiutezza e di attesa. E pensieri che, tra chi vi si trova collocato, così come nell’autore, generano domande di senso sull’essere e sul non essere, sull’impassibilità dell’eterno e sulla temporalità e sui palpiti dell’esistere
Le cronache, che nei vari passaggi illuminano quadri evanescenti di assenza insieme a dettagli messi a fuoco con rigorosa precisione, ci riservano però un finale tipico del colpo di scena teatrale. “Ora non c’è più, il Limbo” , scrive l’autore nell’ultimo testo, esplicitando “alfine, siamo tornati, immemori e assonnati” , per subito precisare in nota: (Tornati? Ciondoliamo in una terra di confine / …. siamo profughi in precario esilio illimitato)” . Il limbo era e non è più: quasi sul crinale tra un non-luogo e il luogo di cui non si è conservata traccia, metafora della nostra condizione esistenziale di erranza e incompiutezza.
Se il limbo però fosse anche altro? Se si spalancasse anche un diverso, implicito, colpo di scena? Se il limbo, nel suo chiarore colmo di assenza, fosse la pagina bianca di chi scrive?
Forse il luogo dell’altrove e dell’indicibile. Forse lo spazio del silenzio e di un qualche possibile, benché frammentato, manifestarsi. Su quel bianco offuscato “da macchie e segni d’indecifrabile grafia” , come abbozza Claudio Zanini, su quella pagina bianca, dove “parole ansiose” e “sillabe stridenti” lasciano posto al silenzio e a “qualcosa che, appena silente oscilla, / non l’illimitato, ma una sua scheggia / luminescente, che l’animo trafigge”.
2
Niente d’irreparabile, in questa quieta attesa;
è un luogo d'aria persa, di momentanea resa.
Ciondoliamo il capo nell'ombra della sera,
perduto lo sguardo negli occhi del vicino.
L’un l'altro accanto ci stendiamo, tarda è l'ora,
luce tersa si scolora in fuliggine sospesa.
Una cosa inquieta, tuttavia: è l'elusione
sempre presente, alla domanda informulata
ma fissa nella mente: perché siamo qui?
17
Il bianco non è mai benevolo, si sa.
Simula ovattata morbidezza o
dolce candore di zuccherato velo.
Può vantare un’apatica pigrizia,
una soffice apparenza, ma algida
in sostanza, e diventar spietato
quando si cerca di scalfirne appena
quell’involucro d’eleganza sopraffina
che il pallore dissimula del vuoto.
50
L’illimitato è enorme, curvo vuoto
su cui tracciamo delle croci, barre,
segni d’interpunzione, parentesi quadrate.
Sulla pagina bianca, parole ansiose,
di qualche vocale l’ondulazione,
leggeri nastri, sillabe stridenti.
Poi, silenzio. Rimane, tra le dita,
qualcosa che, appena silente oscilla,
non l’illimitato, ma una sua scheggia
luminescente, che l’animo trafigge.
52
L’eterno è impassibile, intatto,
ricurva superficie sconfinata
che al tocco suona d’echi puri.
Ci atterriscono le sue aporie
sfiorate appena col pensiero,
ma strappa gemiti l’esistere
entro quella faglia schiusa che
distilla del tempo gocce buie.
68
Lo si deve ammettere a malincuore:
è partecipe, il Limbo, suo malgrado
d’una metafisica minore, irrilevante.
Lo si direbbe oscillare incardinato
in un’intercapedine spaziotemporale
d’obliquità sottile e microscopica.
Apatico com’è, a nulla allude.
73
Vorremmo ci fosse data l’occasione,
disorientati esuli dell’espunto luogo,
d’essere ancora prossimi al non-essere,
quasi al contrarsi discreto dei non-nati,
tanto inerti, entro quelle camerate vuote
da non poterle attraversare intatti,
quanto sensibili ai lievi palpiti del cuore
nell’estrema coincidenza di inizio e fine.
Claudio Zanini è nato a Trieste. Finalista al Premio Guido Morselli di Varese per il romanzo, nel 2009, nel 2010, nel 2011, vincitore dell’edizione 2012 con “Il polittico della città di T” , edito per il tipi di Nuova Magenta Editrice. Ha pubblicato vari racconti, tra cui, per bambini, “Il talento di Uk” (Vita Comunicazione – Comune di Milano). Con la casa editrice Bietti di Milano, “Il posto cieco” (2009), “Nero di seppia” (2010), e “La scimmia matematica” (2013). Nel medesimo anno ha vinto il Premio Fogazzaro 2013 con tre brevi racconti. Selezionato al Premio Letterario Città di Como 2014 e terzo classificato al Premio Fogazzaro 2016. Vincitore dell’iniziativa Opera prima 2018, con la pubblicazione della raccolta di poesie “Ansiose geometrie”, Cierre grafica – Anterem edizioni . Suoi versi appaiono, tradotti in inglese da Claudia Azzola, su Tradizione/traduzione , e in altre riviste. Collabora con la rivista culturale ODISSEA
Fausta Squatriti, dalla raccolta inedita "Piccolo globo", nota di Laura Caccia
Il seme dell’etica
Nel movimento avvolgente, con cui si snodano i versi della raccolta Piccolo globo di Fausta Squatriti, le sequenze interroganti e le forme reiterate paiono condurci a ruotare insieme a quella sfera indicata dal titolo. E, insieme, a far ruotare il nostro pensiero sul suo stato attuale e sulle sue sorti, a partire dalla sconfortata constatazione che questo “piccolo globo soffre / contorni sfrangiati / lento progresso / voragine”, e ancora più chiaramente “tutta ferita la Terra rimargina male / nell’indifferenza”, arrivando a chiederci, insieme all’autrice: “Rimettere a posto il piccolo globo?”.
Nel loro andamento a spirale, si sviluppano continue domande di senso sulla possibilità o meno che ragione e bellezza, etica e parola possano riuscire nell’intento, come evidenziano gli stralci interroganti: “come sopravvivere / alla morte delle idee?”, cosi come “Basterà salvare il salvabile?”.
Pone semi nel terreno dell’etica l’interrogazione poetica dell’autrice, conficcando la parola, come a dissodare il terreno, sui temi del bene e del male, dell’innocenza e dell’offesa, della carità e del crimine.
Un bene visto in agonia, cercato tuttavia nel dialogo e nella pietà, il cui “seme / a fatica sgomita / nel solco stretto” e per il quale ci si interroga sulla necessità di mettere in atto un processo di ricostruzione: “ridisegnare la mappa del bene?”. Un male, invece, ben presente e che, nelle forme del delitto e del castigo, del diavolo e di Caronte, non dà tregua al mondo, così come ai versi, che non ne trascurano l’esistenza.
Così, nella compresenza di morale e amorale, la raccolta declina il piccolo globo stretto tra l’immoralità, in questo simile al pascoliano atomo opaco del male, e l’etica da far rifiorire, tra la “morte delle idee” e la “sapienza residua”.
Che non si riesca però a coltivare il seme della sapienza e del bene attraverso la parola poetica pare essere l’afflizione dell’autrice: “Rimugina aggettivi / cerca il Verbo / dove non si trova”. Non solo: i poeti vengono accomunati ai despoti, entrambi considerati incapaci, che “tracciano nuovo confine / e dell’orto secco / non si curano”, così come la bellezza che “non sa accudire / dell’emergenza / il grido”.
Chi possa essere in grado allora di coltivare l’orto, di farne fiorire il dire e, nello stesso tempo, di salvare il globo, è la domanda inespressa che cogliamo sullo sfondo di tutti i versi. E in che modo, e se, sia possibile, a partire dallo sconforto con cui Fausta Squatriti dichiara: “Nessuno ascolta le mie parole”.
Forse nel collocarsi in un grado “Quasi zero / nella ingorda civiltà del pieno”, forse portandosi oltre, oltre la malasorte e la bontà spersa e derisa, oltre il male-dire e il bene-dire, in quel liberatorio, benché disilluso, “Ridere” con cui si conclude la raccolta.
***
Nessuno ricorda
indicibile nome bestemmia
debole annaspa
nel marasma di fluidi
inciampa sui sassi più aspri.
Bellezza faticata
soverchia
marcisce nel pozzo
orba di riflesso.
Soccorso da tempo assegnato
impiega malafede
in maglie molli.
Speriamo e aspettiamo.
Della pietà il seme
a fatica sgomita
nel solco stretto.
Rimettere a posto il piccolo globo?
***
Contorni
Pochi ricordano
gloria di dono non richiesto:
piccolo globo soffre
contorni sfrangiati
lento progresso
voragine.
Anime belle
rubano spazio e misura
sull’orlo si affacciano incerte.
All’origine a mani nude
tornare.
Dimenticare
chi è rimasto indietro.
***
Desiderio fino al collo
nei debiti
per transumare aspetta
prepara ben chiuse valigie e bauli.
Dèspoti e poeti
dell’orto secco non si curano
confondono le stagioni.
Semplice Bellezza
passeggia
di rigogliosa fronda vestita
alza il capo innocente:
non sa accudire
dell’emergenza
il grido.
***
Si espande nella notte chiara
di nostalgia il profumo:
del Diavolo il trillo
incassa l’applauso e sviene.
Cibo della mente
smaltito come tossico rifiuto.
Malasorte
notte e giorno si prende tutto
sassi piatti belli consunti
sull’acqua
farli scivolare
seguire la corsa
con la curva del corpo.
Ridere.
Fausta Squatriti, nata a Milano nel 1941, è artista, poeta, narratrice, saggista. A casa della madre, la poetessa Lina Angioletti, negli anni ’50 si riunivano i più interessanti artisti e poeti che a Milano vivevano, da Lucio Fontana a Salvatore Quasimodo, e una Fausta adolescente si nutriva dei loro discorsi, appassionata fin da allora all’arte e alla poesia, i cui primi esiti compiuti risalgono al 1960, sebbene siano stati pubblicati da Book soltanto nel 2003. Dopo gli studi accademici Squatriti, tra il 1964 e il 1998, dapprima in collaborazione con Sergio Tosi e in seguito da sola, da vita a una piccola ma importante casa editrice dedicata alle edizioni numerate e multipli, realizzati con grandi maestri del '900, Man Ray, Fontana, Twombly, Nevelson, Tinguely, Niki de saint Phalle, e tanti altri. Negli stessi anni l’artista compie la propria ricerca visiva, scultura e grafica. Nel 1968 espone a Stoccolma nella storica Galerie Pierre, proseguendo nel ’69 a New York, (Barnett Newman da lei conosciuto il giorno prima presenzierà alla vernice della mostra presso la giovane Barbara Koz). Seguono mostre a Caracas, Ciudad Bolivar, Tel Aviv, Huston, Mexico City, Ginevra, Dusseldorf, Parigi, Mosca. A partire dal 1979, espone anche in Italia. Nell'85 è stata curatrice della sezione ‘Arte e scienza: colore’, alla Biennale di Venezia. Ha insegnato per trent’anni nelle Accademie di Belle Arti di Carrara, Venezia e Milano, contribuendo a diffondere l’arte del Libro d’Artista e della grafica. E’ stata più volte visiting professor alla University at Manoa, Honolulu, ha tenuto seminari e conferenze in Italia e all'estero. Ha esposto nel 2009 in una personale al Moscow Museum of Modern Art, a cura di Evelina Shatz, e nel 2009/11 a Parigi nella mostra“Elle¢repompidou”, una piccola sala le era dedicata. Nel 2017 una mostra “Se il mondo fosse quadro saprei dove andare…” a cura di Elisabetta Longari, rende omaggio al suo percorso creativo in due importanti sedi museali milanesi, “Triennale”, “Gallerie d’Italia”, e presso la “Nuova galleria Morone”. Sue opere fanno parte di musei e istituzioni pubbliche e private.
Poesia, narrativa e saggistica sono state pubblicate in singoli libri, in antologie e riviste specializzate quali Lettere, Alfabeta, Meta, Il Verri, La Mosca, Testuale, Graphie, Kiliagono, Concertino, e altre. Per Vanni Scheiwiller ha diretto, con Gaetano Delli Santi, la rivista Kiliagono, uscita tra il '93 e il '95. Nell'85 ha vinto il Premio Montale per l’inedito, nel 2010 il Premio Scrivere donna, con la pubblicazione di Filo a piombo, nel 2017, per Olio Santo il Premio Tassoni.
Ha pubblicato poesia, dal 1979 ad oggi: Temperatura ambiente, La natura del desiderio, Della Discordia e del suo credo, Carnazzeria, Male al male, Gesto azzurro alla sua sinistra, Filo a piombo, Vietato entrare, Olio santo. Ha pubblicato in prosa: La villeggiatura, ovvero Breviario sentimentale, Crampi, La Cana. Una sua ricerca storica è stata pubblicata: Pollice verso, storia di un arazzo. Sue poesie sono state tradotte in ebraico e in inglese, queste ultime pubblicate ad Amsterdam, nella rivista internazionale Incontri. In francese presso L’Harmattan è pubblicata Anthologie1960-2012. Presso Gradiva Publications , nel 2018 è uscita un’antologia di poesie tradotte in inglese “At Pen-Point”.
POESIA E PROSA :
1979 “Temperatura ambiente”, Il Laboratorio delle Arti
1987 “La natura del desiderio”, All’insegna del pesce d’oro, Vanni Scheiwiller
1994 “Della discordia e del suo credo”, All’insegna del pesce d’oro, Vanni Scheiwiller
1999 “Male al male”, Piero Manni
2003 “Gesto azzurro alla tua sinistra”, Book
2004 “Carnazzeria”, Testuale critica
2010 “Filo a piombo”, Tracce
2012 “Vietato entrare”, La Vita felice
2015 “Une anthologie 1961/2012”, traduzione in francese di Biancamaria Altomare e Alberto Lombardo, L’Harmattan
2017 “Olio santo”, NPe Poesia
2018 “At Pen – Point “ Poems 1960-2017, traduzione in inglese di Anthony Robbin, Gradiva Publications
Prosa:
1994 “La villeggiatura, ovvero breviario sentimentale”, Terre del fuoco editore
2006 “Crampi”, Abramo Editore
2015 “La Cana”, Puntoacapo editore
2015 “Pollice verso: Storia di un arazzo”, contributi di autori vari,
a cura di Fausta Squatriti, Nardini editore
Filippo Ravizza, "La coscienza del tempo", La Vita Felice 2017, nota di Flavio Ermini
Non è più tempo di distrarsi, è necessario rilanciare il potere della dissidenza. Questo ci dice Filippo Ravizza.
Le sue poesie sono insorgenze, riflessioni, nuclei erratici di pensiero, apparizioni.
Sono territorialità da condividere con il lettore.
Una disseminazione di unità spazio-temporali irrompe sulla scena dominante e mette in gioco l’apatia del pensiero.
Torniamo a noi, dice il poeta, sapendo di rivolgersi al lettore, attendendolo al varco con parole appartenenti alla sovversione.
Diciamolo con chiarezza: fondamentale nella poesia è preservare la parola da esiti smaterializzanti.
Evaporare gli anni
Disperdere dunque la coscienza
del tempo evaporare gli anni
così senza pietà correre correre
lontani dal qui e dall’ora non
esistere sapendolo mentre
incessante risuona tra le tempie
e queste campagne la certezza
che dice: “Tutto è impossibile,
ma tu ricordati, ricorda il desiderio
offeso del tuo pur mutilato amare”.
Dalla sezione L’enigma nell’enigma
Tutte le forze
Possedere nelle carte tutte le forze
ondulate campagne e irti annunci
le tremende canzoni l’aria calda
che investe e secca le gole aperte
come invocazioni come annunci
che dicono ti dicono è qui è qui
è adesso solo adesso è il destino
il tuo destino.
Dalla sezione Tutto ciò che lo precede
Hegel
Sulle alzate carezze le paratie
del mondo, le spalle alate invece
qui, dove hai potuto pensare toccando
la terra di essere dentro, stare
stare dentro le cose, essere loro,
parlare di tutti a tutti avanzare
un poco di Storia collettiva quasi
memoria, un’illusione solo amata:
che si potesse toccare, sì toccare,
spingere un poco almeno più
in là l’idea, l’esperienza terribile,
vera, della totalità.
Filippo Ravizza è nato a Milano, ove risiede, nel 1951. Poeta e critico letterario, è autore, prima de “La coscienza del tempo”, di sette raccolte di versi: l’ultima in ordine di apparizione è la silloge “Nel secolo fragile”, uscita nel febbraio 2014 (la seconda edizione è del novembre 2015) presso La Vita Felice Editore. Prima di “Nel secolo fragile” è uscito “La quiete del mistero” (Amici del Libro d’Artista, 2012), preceduta da “Turista” (Lieto Colle, 2008)” Prigionieri del tempo” (Lieto Colle 2005), “Bambini delle onde” (Campanotto, 2000), “Vesti del pomeriggio” ( Campanotto, 1995), “Le porte” (Schema Editore, 1987). Nella sua città ha tra l’altro ideato e realizzato, insieme al docente e critico letterario Gianmarco Gaspari, “Lezioni della Storia – Dopo un secolo quale memoria”, un ciclo di conferenze iniziato nel 2011, lettura della Storia italiana ed europea attraverso la letteratura. Tra le altre vanno segnalate le conferenze che Gaspari e Ravizza hanno tenuto su Alessandro Manzoni, su Vittorio Sereni, Eugenio Montale, Umberto Saba, Italo Svevo e Giovanni Pascoli. Nel 1995, insieme al poeta Franco Manzoni, Filippo Ravizza ha redatto il “Manifesto in difesa della lingua italiana”, oggi parte del programma orale (cours de production orale) per il conseguimento del dottorato specialistico del Dipartimento di Italianistica dell’Université Paris 8 (Paris – Saint Denis, docente Laura Fournier). E’ stato chiamato a rappresentare la poesia italiana contemporanea alla XIX Esposizione Internazionale della Triennale di Milano (1996). Attualmente coordina le iniziative culturali di una grande organizzazione di rappresentanza economico – sindacale milanese.
Giuseppe Schembari, poesia inedita "Un vivere alterno", premessa di Ranieri Teti
Un vivere alterno, nella visione del poeta, porta a trasformare il particolare di minimi accadimenti
in un universale che riguarda ogni vivente che abbia stilato, negli anni, nella trama della vita, un archivio degli incubi.
Parliamo, grazie a Giuseppe Schembari, di ogni vivente che conservi memoria e abbia attenzione.
In questa poesia l’alterno si materializza in maniera evidente nel passaggio da un significativo verso universale,
“ma le ferite riscrivono la storia”, a un verso successivo molto personale “ricordo avevo ancora le ginocchia sbucciate”.
Tutto continua, e si concretizza, subito dopo: “poi un’onda ha travolto la memoria”.
Quest’ultimo verso restituisce un senso definitivo: le ferite non sono correlate alle ginocchia del poeta,
ma grazie a questo ricordo indicano un lungo arco temporale, dimostrano il troppo tempo che dura una pena nell’esistenza.
Anche se ne sono state cancellate le tracce.
Un vivere alterno
Nell’abbozzo di una cronaca taciuta
traccio l’identikit di un’inquietudine
dura a morire
che squassa e scontorna
le vere ragioni del mio folle arrancare
Esisto aldilà di questo gap
oltre la trincea delle cose taciute
dei tanti ritardi accumulati
dei giorni nati già malati
nascosti nella tasca del pigiama
Anche adesso la trama un po’ si scuce
l’archivio dei miei incubi riluce
di una paura senza età
che non lascia traccia
ma lentamente la pancia mi squarcia
Le impronte sono state cancellate
ma le ferite riscrivono la storia
ricordo avevo ancora le ginocchia sbucciate
poi un’onda ha travolto la memoria
Non la vivo come un debito la mia assenza
neppure un vivere alterno
in questo non luogo eterno
dal quale spesso riemergo sgualcito
come da un torbido sonno inghiottito
Giuseppe Schembari (Ragusa, 1963) ha pubblicato nel 1989 “Al di sotto dello zero” e nel 2015 “Naufragi”, entrambi con l’editore Sicilia Punto L.
Vincitore di numerosi premi, collaboratore di giornali e riviste, è compreso in varie antologie: tra queste, “Bisogna armare d’acciaio i canti del nostro tempo”, curata da Gian Luigi Nespoli e Pino Angione.
Irene Santori, "Hotel Dieu", Empiria 2015, nota di Rosa Pierno
I versi di Irene Santori sembrano scottare, investiti da una febbre d’amore, una visionarietà che sigilla il corpo con la memoria; meglio sarebbe dire che dissigilla la memoria; che mette in contatto l’amore per i propri figli con la storia della città, ma anche con gli dei. Alla risalita memoriale nulla si oppone. Il sentimento è un liquido che si spande e marchia. La lingua è fiato prima ancora che parola. Non c’è nulla che possa opporsi all’appropriabile. Pittura, storia, città, malattia, i versi sono un’onda che riporta tutto in superficie. Un suono persistente spira tra le poesie, rendendo la lettura un’esperienza sensoriale che travasa dal cerchio della vita e della morte (la madre, la figlia, a sua volta madre) ma che a ogni passaggio porta con sé segni, parole, oggetti, testimoni non inerti, ma attivi, quasi simbolicamente co-protagonisti: “apro una pesca e non c’è nocciolo”. Il pericolo è l’altro versante: perdere la vita, perdere le cose, le persone, ogni cosa: la mente può controllare solo anticipando gli eventi, coagulando un verso che serva a saldare materia organica e mentale assieme.





Italo Testa, "Tutto accade ovunque", Nino Aragno editore 2016, nota di Rosa Pierno
Sembrerebbe non esserci alcuna categoria utile a incasellare conoscenza: “spalanco le porte / e le immagini si annullano / fermo gli occhi / e le immagini si schiudono”, tant’è che si è costretti a verificare anche le più elementari percezioni, per fabbricarsi, caso per caso, l’ambito di riferimento. Difficile tenersi a qualcosa che sia saldo, anche ciò che si crede di conoscere è non fondato e forse, per Italo Testa, nemmeno nel gioco di famiglia wittgensteniano c’è qualcosa che possa fondare una credenza. Persino il sé è totalmente azionato dagli altri. Nessun limite da nessuna parte. Nessuna cosa uguale a un’altra. Eppure una costante inversione fra ciò che accade in un interno e ciò che accade in un esterno: “cammino nella casa / e raccolgo i rami caduti”, oppure tra immobilità e movimento, ci avvisa che è possibile ancorarsi a qualcosa, non fosse che per il principio di opposizione. Quel che si esperisce con il corpo non è stabile allo stesso modo poiché la mente è scettica rispetto al corpo o almeno sembra potersi astrarre anche da esso o volerlo disperatamente fare senza riuscirci. In ogni caso è un io bloccato, alienato che non ha un codice condiviso di comunicazione, vive nell’arbitrarietà più totale. O forse nell’adesione a sé più completa.
Dalla sezione La casa perfetta
TUTTO ACCADE SIMULTANEAMENTE
sono seduta
e mi muovo verso una porta
sono seduta
e scivolo nel corridoio
TUTTO ACCADE SIMULTANEAMENTE
la foglia dell’albero nel giardino
cade sul mio tappeto
la foglia dell’albero nel giardino
trema sulle mie mani
anche oggi ho visto qualcosa
che spero di comprendere tra due giorni
anche oggi ho visto qualcosa
che spero di arrivare a comprendere
TUTTO ACCADE SIMULTANEAMENTE
le pareti bianche
si curvano sulla stanza
le pareti bianche del cielo
si curvano dentro la mente
TUTTO ACCADE SIMULTANEAMENTE
spalanco le porte
e le immagini si annullano
fermo gli occhi
e le immagini si chiudono
Dalla sezione I camminatori
camminano
rasenti ai muri
sugli autobus
si siedono tra i primi
non parlano
tenendosi le mani
si voltano
di scatto a un tratto
ti guardano
gli occhi grigi
campeggiano
poi scartano di lato
si alzano
serrando i pugni
e scendono
Italo Testa (Castell’Arquato, 1972) vive a Milano. È cresciuto nella provincia emiliana, ha passato molti anni a Venezia e fatto studi nomadi tra Francoforte, Berlino, Parigi e Marsiglia. Tra i suoi libri di poesia: L’indifferenza naturale (Marcos y Marcos, 2018); Tutto accade ovunque (Aragno, 2016); i camminatori (premio Ciampi – Valigie Rosse, 2013; La divisione della gioia (Transeuropa, 2010), Luce d’ailanto Poesia contemporanea. Decimo quaderno italiano, Marcos y Marcos, 2010), canti ostili (LietoColle, 2007), Biometrie (Manni, 2005); Gli aspri inganni (LietoColle, 2004). Dirige la rivista «L’Ulisse», è resident dj su «Le parole e le cose» e collabora con altri lit-blog. Pubblica la rivista/poster «2×2» in collaborazione con l’Otis College di Los Angeles e l’ArtCenter College of Design di Pasadena, e cura per l’Accademia di Brera la collana di multipli non_identità e il laboratorio da>verso: transizioni arte-poesia. Saggista e traduttore, insegna filosofia teoretica all’Università di Parma.
Liliana Ugolini, "La marionetta vivente", Florence Art edizioni 2017, nota di Flavio Ermini
L’itinerario che segue questo libro si svolge tra poesia e saggistica, mentre l’atto su cui si fonda è quello del guardare.
E ciò che Liliana Ugolini vede lo afferra fin nell’intimo. Lo coglie nelle figure che incontra, nei valori che in esse vengono realizzati o negati.
Questo libro segue itinerari che incrociano il destino dell’umano e il modo in cui tale destino si compie.
Su questo tratto di strada, grazie a un linguaggio che non maschera e non nasconde, riprende vita la teoria dell’essere umano come marionetta, guidata da un ignoto burattinaio.
Ogni momento della nostra giornata è inesorabilmente già scritto.
Accettare questo senso dell’esistenza senza sgomento, senza ambiguità, senza indecisioni e lontano da ogni dissipazione, è uno dei compiti dell’essere umano.



Margherita Orsino, poesia inedita "La traversata infinita", nota di Flavio Ermini
Margherita Orsino ci racconta una traversata che dal molteplice porta «fino al limite ultimo», ovvero fino all’uno aurorale. Si tratta di una traversata all’interno di due colori possibili: quelli che si vedono perché sono davanti a noi e quelli che si inventano in quanto non esistono in natura.
In questo libro tutto concorre a immaginare infiniti passaggi di un percorso che l’occhio deve saper nutrire e la voce nominare. Un percorso che coinvolge parole pronunciate in lingua italiana da Margherita Orsino, unitamente a ulteriori parole mormorate in lingua spagnola da Maria Troiano. Un percorso che affida alle immagini di José Scacco il compito di allargare la dimensione del visibile e di mettere in gioco la matrice inconscia del vedere, «pietra dopo pietra», parola per parola.
Nel frattempo “La traversata infinita” è diventata un libro pubblicato da Anterem Edizioni nel 2019.
Un approfondimento, con un testo, un’immagine e notizie biografiche qui: https://www.anteremedizioni.it/margherita_orsino
Maria Luisa Vezzali, "Tutto questo", Puntoacapo 2018, nota di Rosa Pierno
Più che descrittivi, sono definitori i versi di Maria Luisa Vezzali: gli elementi vi sono scolpiti insieme alla loro funzione: “mantici che pompano costanza”, “sfinge scava senza fine nel petto”. Reali o mentali che siano, tali elementi compiono un’azione che diresti eterna. Il tempo, pertanto, in questo limpido scenario, è appena la successione di tali definizioni. Un dialogo si accampa a tratti nel quadro poetico rinforzando la convinzione che si tratti di una poesia gravata da un viraggio morale che finisce con lo svelare che il teatrino ha un meccanismo e che la botola al di sotto del palco può scattare fino a imporre una completa trasformazione di ciò che è in scena: “sono senza gola / esplosa d’alba / sono / la linea / della tua ombra”. La trasformazione individuale è anche collettiva e l’autrice attraversa temi contemporanei (le stragi, l’immigrazione, le crisi economiche) adottando stili anche molto diversi, appartenenti anche ad altre culture. Ecco che ci pare perfetta la scelta di una sua chiusa: “Sfasatura obliqua dove è valore il linguaggio”.
Dalla sezione Versi di esperienza e di amnesia
Della bellezza
bellezza è quell'armonia dolcemente
crocefissa nel rilievo dell'onda
che riconosci come un luogo
frequentato a lungo in un passato
che non è nel tempo
ma sul tetto della piramide
sfinge scava senza fine nel petto
il pozzo del dono che non fa rumore
Dalla sezione Scuola d’ossa
Arnaut
ogni giorno trovi in fiamme il percorso
del tram il gioco a nascondino
della ressa all’interno
le scale sepolte da grida la forza
centripeta del banco in prima fila
hai l’odore dei treni che partono
come partono le carovane
nella desertificazione della rena
radici notturne nel sangue
e un pugno che protrude dalla carta
sei così irto, brina e roccia
che il tuo sguardo arabesca il vetro
ora preparati a vestiti diversi
se questa è casa
e casa devi chiamarla
preparati a disegni diversi
tutto smotta, cambia e si drena
il fiume per quanta onda lo gonfi
neppure si tende come la linea
retta della tua schiena
quando scoppiano sassi nel silenzio
sotto la pelle e un pugno che sfonda
la storia sale e scende senza luogo
corso senza riva per rimanere intatto
ora preparati a suoni diversi
se pure è lingua
e lingua devi sentirla
a diversi sapori
sui denti strappati dall’alveo
e tu fermati fermati mattino
se deve avere un senso
anche in questo scarno
granaio di vento
anche contro la marea
Dalla sezione Cartoline metafisiche
3. (dalla lavagna)
Allo scafo appartiene il timone o alla mano, ai tendini di vento che hanno provato lo strappo delle partenze, il nuoto che stringe i denti nell’ambiente lunare estraneo che fa resistenza? Cosa parla alle foreste di bambini con gli arti arruffati, nati al volo, accucciati nel fondo muschioso del tempo, la materia smemore molle al sacrificio o la testa fresca caparbia di bellezza di un corpo non estenuato, una fame inconsumabile di cominciare imbracciare la rotta?
5. (da Gatwick)
Ci fosse un confine in fondo ci sarebbe un passaggio di stato un transito una dogana. Come si fa con i paesi quando si fruga la propria identità dentro la valigia e i cancelli elettronici non riconoscono i segni naturalissimi graffiati dal tempo sul volto. Ma i confini dentro gli occhi sono così fragili. Si sbriciolano al minimo impatto con la vita. Noi siamo qui fumi di fucina, poi particole gemmate dall’incendio. Non si cambia valuta, semplicemente non si spende, si è spesi.

Marina Pizzi, "Declini", Macabor 2017, nota di Flavio Ermini
Affondare, sprofondare, interrarsi sono movimenti che si intrecciano con un montare,
un salire, uno stare ritto su qualcosa che è ignoto.
Con Declini siamo al cospetto di una parola attraverso la quale ci congiungiamo a un’ultimità,
un fare insieme soglia ed enigma, apertura e chiusura.
La morte, ci dice Marina Pizzi, è un soffio che, a dispetto delle durezze, tiene il luogo di un io che sta declinando.
Questa ricerca poetica perpetua un logorarsi e uno spegnersi
che ci spingono a diffidare delle verità univoche e assolute, che finiscono con il rivelarsi morali di tutto comodo.
***
coprimi con l’era in forse
con le stampelle vuote
e dimmi un atrio grande come una scossa
dentro la darsena l’ingombro della rotta
questa temibile pena in foggia da ecatombe
eco del lutto torto di fandonia
nella faccenda il rogo della malia
***
quel che resta delle parole è un imbrunire di sponda
una spada di fionda come ad intristire
senza dire ché rimanenze di senso
da abluzioni di scritture e oralità
oggi un chicco di cresima alla crisi del cristallo
***
qui si gioca di pergole e silenzi
dove balbetta il vento lo stonio
di uno qualunque arreso alla riva.
qui si perfeziona l’avanzo del superstite
l’acqua scaduta al centro della zattera
la musa in attonito che non dice più
***
qui si gioca di pergole e silenzi
dove balbetta il vento lo stonio
di uno qualunque arreso sulla riva
qui si perfeziona l’avanzo del superstite
lo stipite duro della tana
***
pentimenti del seno averti accanto
bracconiere dei sensi limite del tempo
tempo tu stesso e sillabario panico
addentro alle urla di chi lascia scia di sé
le sciorinate scosse
Marina Pizzi ha pubblicato i libri Il giornale dell'esule (Crocetti, 1986), Gli angioli patrioti (Crocetti, 1988), Acquerugiole (Crocetti, 1990), Darsene il respiro (Fondazione Corrente, 1993: pubblicazione del Premio), La devozione di stare (Anterem, 1994: Premio Lorenzo Montano), Le arsure (LietoColle, 2004), L'acciuga della sera i fuochi della tara (Luca Pensa, 2006), Dallo stesso altrove (La Camera Verde, 2008, selezione), L’inchino del predone (Blu di Prussia, 2009), Il solicello del basto (Fermenti, 2010), Ricette del sottopiatto (Besa, 2011) Un gerundio di venia (Oèdipus, 2012), La giostra della lingua il suolo d’algebra (Edizioni Smasher, 2012); Cantico di stasi (Cantarena, 2013: edizione parziale), Segnacoli di mendicità (CFR, 2014); Plettro di compieta (LietoColle, 2015); Cantico di stasi (Oèdipus, 2016: edizione definitiva), Declini (Macabor, 2017) e Miserere asfalto. Afasie dell’attitudine, 2007-2017 (La linea dell’Equatore, 2017).
In formato digitale, on line, ha pubblicato - interamente o parzialmente - le raccolte La passione della fine, Intimità delle lontananze, Dissesti per il tramonto, Una camera di conforto, Sconforti di consorte, Brindisi e cipressi, Sorprese del pane nero, Staffetta irenica, Il solicello del basto, Sotto le ghiande delle querce, Pecca di espianto, Arsenici, Rughe d'inserviente, Ricette del sottopiatto, Dallo stesso altrove, Miserere asfalto (afasie dell'attitudine), Declini, Esecuzioni, Davanzali di pietà, L’eremo del foglio, L’inchino del predone, Il sonno della ruggine, L’invadenza del relitto, Vigilia di sorpasso, Il cantiere delle parvenze, Soqquadri del pane vieto, Cantico di stasi, La cena del verbo, Estinzione di chiarìa, Il vestitino bizantino, L'alba del penitenziario. Il penitenziario dell'alba.
Nel 2004 e nel 2005 la rivista di poesia on line “Vico Acitillo 124-Poetry Wave. Electronic Center of Arts”, coordinata da Emilio Piccolo (1951-2012), ha nominato Marina Pizzi poeta dell’anno. Fa parte - insieme a Massimo Bacigalupo, Milo De Angelis, Franco Loi, Tomas Tranströmer, Derek Walcott e altri autori - del Comitato di redazione della rivista internazionale Poesia. È redattrice del litblog collettivo "La poesia e lo spirito" e collabora con il portale di cultura “Tellusfolio”. Lavora presso la Biblioteca di Area umanistica Giorgio Petrocchi dell'Università degli studi Roma Tre. È stata tradotta in persiano, inglese e tedesco.
Mario Pezzella, "Le nubi di Bor", Editrice Zona 2016, nota di Flavio Ermini
È martellante l’interrogare di Mario Pezzella sul secolo da poco trascorso.
È un lavoro di interpretazione e di confronto con le grandi ideologie e i drammi del Novecento.
È un collocarsi su una soglia che registra la dissoluzione di tante certezze.
C’è un’impressione di quiete in questi testi ed è resa spesso con l’impressione di un movimento, che orienta la parola poetica sul dettaglio.
Nel poema vi è l’impeto di una lingua liberatrice, trasparente, simbolo della verità, verso la quale il linguaggio del poeta naviga senza affanno;
seguendo il soffio vitale di ciò che era nascosto e ora – all’inizio di un nuovo secolo – si va facendo trasparente.
La poesia di Pezzella si situa in quel punto in cui si incrociano linee temporali di sensibilità entrate in risonanza l’una con l’altra.
Il Secolo è finito
Era buia
era vera
trasparenza di sangue
una sezione di menti
su vene scoperte
atridi funesti giullari sovrani
chi resisteva,
nel buio
nel vero.
Dalla sezione II. Padre
Moneta rovente –
scambio di viatico in bocca
di padre in morto
di figlio in madre
ciondolante capitale invariabile.
***
Di padre in figlio
il nome dell’assassino
si tramanda saldo
c’indebita l’Oscuro
tu stai;
nell’oscuro pulsare,
nell’alone di tempo.
Dalla sezione III. Frasario
***
Il tuo solofono8
suona – dicevi –
per tutta la notte
nella stanza in disparte,
non senti il murmure di voci
insorgere
in giardini lontani.
La tua voce
dialoga gli Oscuri
tra le nubi di Bor.
8 Le nubi di Bor è un quadro di Klee.
Mario Pezzella si laurea a Pisa nel 1973 con una tesi sul pensiero di Walter Benjamin. Presso la Scuola Normale Superiore diviene ricercatore di ruolo, e lo rimane fino al 2014, anno in cui la sua mediocre fortuna accademica lo induce a dimissioni anticipate. Nel 1979-1980 ha collaborato a un seminario di Jacques Derrida presso l’Ecole Normale di Parigi. Ha conseguito con la tutela di Louis Marin il Doctorat de Troisième Cycle en Philosophie nel 1984, preso l’EHESS di Parigi e il DEA in Réalisation cinématographique seguendo i corsi diretti dal documentarista Jean Rouch a Nanterre. Ha insegnato Estetica ed Estetica del cinema, con affidamenti annuali provvisori, in diverse università italiane. Ha tenuto, su invito, un seminario presso l’EHESS di Parigi, in collaborazione con il Prof. Eric Michaud. E’ attualmente redattore della rivista Il Ponte, di Altra parola e collabora col Centro per la riforma dello Stato nella sede di Firenze.
OPERE PRINCIPALI
- L'immagine dialettica, ETS, Pisa 1983.
- La concezione tragica di Hölderlin, Il Mulino, Bologna 1993.
- Il narcisismo e la società dello spettacolo, manifestolibri, Roma 1996.
- Il volto di Marilyn, manifestolibri, Roma 2000.
- La memoria del possibile, Jaca Book, Milano 2009.
- Estetica del cinema, nuova edizione accresciuta, Il Mulino, Bologna 2010.
- Insorgenze, Jaca Book, Milano 2014.
- -Le nubi di Bor (poesie), Zona, Arezzo 2016.
- -La voce minima. Trauma e memoria storica, manifestolibri, Roma 2017.
Nicola Vitale, "Chilometri da casa", Mondadori 2017, nota di Rosa Pierno
L’impossibilità di aderire alla realtà quotidiana spinge Nicola Vitale a cercare verità non effimere. É necessario perché ciò avvenga, mettere il silenziatore, spegnere monitor e cellulare, cercando dentro se stessi non il nuovo, ma il perenne: quello ad esempio di un filo d’erba che si rinnova a ogni primavera. La ricerca del sé, dei propri ricordi, dell’infanzia, porta inevitabilmente alla scoperta dell’”imponderabile” dei passaggi, a “pesare le parole”, ad aprirsi a sguardi, a sopportare il silenzio. Il mondo allora cambia radicalmente aspetto come in quelle figurine per bambini che mutano disegno per la diversa incidenza della luce. Sfuggire il caso, l’abitudine, la convenzione apre i mondi del sogno e del progetto, ci libera dal “dover scegliere tra questo e quello”. Non più illusorie soluzioni se si ha il coraggio di guardare con occhi svelanti; é con essi che Nicola Vitale indaga la pittura, la musica per raggiungere il noi comune.
***
Distratti da canzoni d’autore, nel dormiveglia internazionale non è che nessuno ascolta, è che non c’è modo, non regge più la figura che puoi disegnare al centro del progetto: il nome, l’ora, l’indirizzo non coincidono. Gli appassionati conviventi (anche per poco) non si incrociano, gli affari intempestivi fanno debiti. Anche le cose prescritte per riuscire, non riescono.
Un errore, due errori, tre errori
dovremmo con calma ricapitolare
tacere per un po’, fare il punto.
Non parlare: ascolta.
Non ci sono soluzioni sulla carta
sembra svanito il segnale,
il monitor non risponde.
Guarda nel nulla.
Dopo tentativi irrisolti mi chiedo
cosa potrebbe sollevarci
questa estate che non abbiamo fatto progetti
quando il calcolo delle probabilità viene meno
e non si attende altro.
Potremmo allontanarci di poco
valicare il limitare di questa corta memoria
e rivedere i luoghi dell’infanzia.
Potremmo scoprire che qui
gli stessi paesaggi
si stendono ancora nell’imponderabile.
Dopo secoli di menti affaticate
dopo avere scritto e dipinto
da rovinare la digestione
si vuole tornare alla vita normale
parlare dell’umano
dell’uomo in gabbia per strano malumore.
Si vuole… si vuole
insomma non ne va bene una.
E se non volessimo nulla
se smettessimo di cercare di farla franca
di spuntarla
da questa circoscritta spirale?
Nicola Vitale (Milano 1956) è un poeta, saggista e pittore italiano. Ha pubblicato, in poesia, Progresso nelle nostre voci (Mondadori 1998), La forma innocente (Stampa 2001), Condominio delle sorprese (Mondadori 2008); il romanzo Il dodicesimo mese (Moretti & Vitali 2016) e vari saggi.
Roberto Piperno, "Monitoraggio vitale", Edizioni Progetto Cultura 2017, nota di Flavio Ermini
Luce. Attesa. Esistenza. Nuovo giorno.
Già i titoli delle quattro parti in cui si articola il libro di Roberto Piperno segnalano un movimento di emersione dall’interiorità
per dissolversi in un molteplice senza identità, per disseminarsi nel mondo.
Un movimento che non induce a fermarsi alla dualità del dialogo, ma porta a comprendere (e a parlare)
le innumerevoli lingue che si rincorrono e si concatenano come se il centro fosse ovunque.
Roberto Piperno si affida a quella parola che pone in causa la quotidianità.
Dice di uno stato liminare, un interstizio, dove un’ombra appena percettibile transita sulla permanenza del tempo.
Apre a un’ulteriorità tanto imprevedibile quanto necessaria.
Dalla sezione Esistenza
Perplesso e disarmato
Sono seduto qui perplesso e disarmato
sperando di sopravvivere a troppe risonanze
di silenzi profondi e d’incomprensibili voci
che chiamano e richiamano ancora
per ritrovare la strada una volta intrapresa
più volte perduta verso una terra nuova
dove volano illuminati uccelli del sapere
e uscire dal silenzio senza echi
di un passato trascorso alla costante ricerca
di più felicità comune nella soddisfazione
di aver raggiunto mete sempre sperate
per più bene comune e personale.
Ora mi giro e sfoglio un nuovo libro
stracarico di strofe e di racconti
di pensieri e parole
che cercano la strada del sapere
e l’inizio di un percorso più sano
per ritrovare il lontano piacere
d’essere ancora vivo
aspirando sempre a respirare
anche senza mondani successi
né mi accontento soltanto di bere
speranze che non diventino vere
nella realtà di un prossimo giorno.
Roberto Piperno è stato Docente di francese e inglese e poi Dirigente del Dipartimento Cultura della Provincia di Roma e Consulente per la Cultura dell'Unione delle Province. Ha pubblicato cinque libri di poesia (Frattali, Al Tempo stesso, Sala d'Attesa, Esseri, Andare per giomz). Ha collaborato con il Prof. Filippo Bettini per rassegne di poesia, ricerche e pubblicazioni di poesia; in particolare "Roma nella poesia del mondo". Cura da molti anni "l'Isola dei Poeti " all'Isola Tiberina e ''Bibliopoesia'' nelle Biblioteche Comunali di Roma Capitale.
Ultima pagina: Miro Gabriele, "Fotografare Roma" e biografia


Inseguire i colori e le ombre di una città senza tempo, perché Roma è il tempo stesso, il mutamento dentro l'eternità, un'unica multiforme visione. La luce modula i mille volti del paesaggio urbano, concedendo ad ogni luogo, ad ogni oggetto, anche il più umile, l'ora di massimo splendore.
Per me che pratico la fotografia a fianco della letteratura, fotografare Roma vuol dire sottomettermi alle apparizioni e alle sorprese di un viaggio, un lungo viaggio fra le infinite angolazioni della luce, che passa su ogni cosa come una carezza. M.G.
Miro Gabriele vive a Roma. Ha pubblicato per l’editrice Ianua, Edizione del Giano Roma 1988, Odi et amo, una traduzione di poesie di Catullo, con prefazione di Luca Canali. Presso lo stesso editore nel 1992 ha pubblicato Il Gaio Verso, antologia di poeti latini.
E’ stato inserito da Luca Canali nella raccolta I poeti della ginestra, Lalli editore 1989. Assieme a Maria Luisa Spaziani ha partecipato al primo Reading di poesia contemporanea tenutosi ad Agnone nel maggio 1991, da cui è stato tratto il volume Ad alta voce, editore Enne 1992.
Ha vinto il premio Montale per la poesia 1992, e compare nell’antologia Scheiwiller Sette poeti del premio Montale, Milano 1993. Compare anche in Vent’anni di poesia Passigli Editori 2002.
Ha pubblicato il romanzo La vita incerta Valter Casini editore 2004. Ha pubblicato inoltre, con Anna Maria Giannetto, Navigare - Versioni e temi di lingua e cultura latina, Zanichelli 2006, testo di latino per i licei.
Nel 2014 è uscito Le Città Antiche ed altre poesie Ginevra Bentivoglio Editoria, con prefazione di Alessandro Fo.
E’ presente nell’antologia “Poesia luce del mondo” a cura di Francesca Farina, Bertoni editore, pubblicata in occasione della Giornata mondiale della poesia 2019.
Prima pagina: Adam Vaccaro, "Crinali e quesiti", saggio sulla ricerca epistemologica di Gio Ferri
CRINALI E QUESITI
Confronti e notazioni intorno alla ricerca epistemologica di Gio Ferri
di
Adam Vaccaro
Premessa
Lo scritto che segue è frutto degli scambi avuti nei decenni con l’amico fraterno Gio Ferri. Un carteggio di riflessioni teoriche, collaterali ai saggi scritti da entrambi. È un omaggio sollecitato anche da varie richieste di una mia testimonianza dedicata alla eredità culturale di Gio. Richieste che mi hanno spinto a riprendere le carte suddette e a trarne un testo sintetico, che potesse far capire la serie di stimoli derivanti dalle ricerche straordinarie della sua La ragione poetica. Offrire e far conoscere il confronto teorico, appassionato, consonante e a tratti divergente, avuto su alcuni nodi fondanti la sua Ragione e quelli della mia Adiacenza, credo sia il miglior modo di sottolineare il suo valore e la sua memoria.
Gio Ferri è stato per me un compagno di viaggio umano e culturale insostituibile, dentro e fuori Milanocosa, in un arco di circa quattro decenni.
)°(
Risulta evidente quanto la ricerca di Gio Ferri possa interessare l’approfondimento delle analisi da me condotte nei termini dell’Adiacenza. L’impostazione e il percorso sono largamente coincidenti, fino perlomeno all’individuazione del nodo complesso dell’operatività mentale, intesa da me come software operativo del definito (da Rita Levi Montalcini) cervello bagnato, quindi di tutto il corpo.
Ogni specialista tende a totalizzare il proprio mezzo e chi scrive non fa eccezione; un esempio è fornito da una citazione (La ragione poetica, in seguito RP, p.39) di J. Kristeva, la quale dice: “tutte le complessità dell’amore derivano dal fatto che il linguaggio ci mette radici”. Da tale frase appare scontato che l’oggetto è il linguaggio e non i linguaggi, sia come diverse modalità mentali di rapportarsi alle lingue, sia come altri linguaggi (da quello gestuale a quelli dei singoli sensi, ecc.); tutti linguaggi operati dalla mente, quale universo operatore (luogo della possibilità di “una verità di comunione universale”, RP, p.115) di tutte le funzioni del corpo.
L’operatività mentale multiforme e globale così intesa, va dunque dal pre al post di ogni lingua, in un circuito di scambi dove è impossibile individuare inizio e fine, né separatezze o dicotomie (inventate dal platonismus perennis e dai dogmatismi del pensiero religioso o scientista). La mia ricerca si ferma e si sviluppa in tale nodo, ritenendolo già ai limiti dell’impossibile per la sua complessità. Da questa cerco nell’interminato e interminabile intreccio di lingue del testo poetico, tracce e forme della tensione adiacente tra le varie aree della mappa mentale (spazio né uni né tri, ma polidimensionato, al pari degli universi esterni), di un Soggetto Scrivente (SS) quali tracce e forme per sentire, assorbire e metabolizzare l’interminabilità del Tutto.
Rispetto all’adiacenza mentale da me cercata (e considerata quale luogo di frontiera per collegarsi col Resto), l’adiacenza che tendo a qualificare biologica di Gio Ferri, guarda il testo come organismo biologico per cercarvi “analogie tra la codificazione genetica vitale e la norma biologico-scritturale (semantico-retorica)” (RP, p.194), micro e macro forme testuali (o genotesti) che si riproducono seguendo le stesse leggi della riproduzione cellulare o della doppia elica del DNA, seguendo in definitiva gli stessi meccanismi della incessante riproduzione vitale. Non so dire quanto la mia ricerca possa fornire elementi utili a quella di Gio Ferri, che va al di là del crinale mentale per coinvolgere il versante fisico, neuronale e biologico. Questo può comportare alcune differenze o varianze.
Una di queste, è per es., che L’adiacenza mentale guarda al testo poetico come organismo nato dalla tensione adiacente tra le varie aree mentali, arrivando persino a poterlo considerare, nel suo complesso, metafora di tale tensione. L’adiacenza biologica di Gio Ferri non lo consente, perché alla circolarità biologica si sovrappone un salto che, come vedremo, colloca il testo (poetico) quale sovra-sistema del Tutto. È un salto che genera in me riserve, per l’alone di ideologia del testo che può comportare. Rimango tuttavia fortemente stimolato da tali differenze; interessato a fruire di tutti i loro possibili apporti.
Le analisi innovative si trovano ad affrontare (anche) problemi terminologici. Per quel che mi riguarda non sono riuscito ad es. (nelle ricerche dell’Adiacenza), a trovare di meglio che utilizzare simbologie tratte dalla psicoanalisi, pur riferendomi all’operatività mentale. Mano a mano che ci siamo addentrati nella ricerca di Gio Ferri, ne abbiamo misurato la rilevanza e lo spessore che, a mio parere, la qualifica tra le poche realmente nuove degli ultimi decenni, capaci di proporre un’uscita dal circuito soffocante e illusorio delle analisi concluse nel solo ambito linguistico.
L’approccio nuovo, ambizioso e interdisciplinare dell’adiacenza biologica di Ferri non può non coinvolgere molti crinali, che come abbiamo visto incontrano problemi anche terminologici (che, è noto, in genere vanno al di là della terminologia), guardandoli ovviamente dal punto di vista della mia ricerca di una adiacenza mentale.
Tra questi, ce n’è uno che almeno per me è fonte – come accennato – di riserve e domande: è il nucleo costituito dalla serie di definizioni incrociate che ruotano intorno al concetto di sovra-forma o forma delle forme della poesia; intorno cioè al crinale costituito dal passaggio dalla circolarità e dal materialismo biologico (che a me non pone alcun quesito) alla meta-fisica della poesia, che invece sollecita quesiti per l’alone di ideologia del testo che può condurre – in particolare verso i tanti adepti di una visione sacrale, “metafisica…e spirituale” (Leopardi) della “facultà poetica” (G. B. Vico).
Partiamo da una serie di ripetute affermazioni rintracciabili ne La ragione poetica: “la vita è cosa ed evento” (p.60); “Tutto è materia e forma della materia, e materia della forma” (p.19); La poesia è forma e al tempo stesso cosa (intesa come sensitivo grumo energetico), per cui “non si può cogliere la poesia fuori dal “generale” materialismo della vita” (p.51); inoltre, per “il fatto (fondamentale e specifico) di essere spazio nello spazio, la poesia ha tutto il diritto di porsi come oggetto spaziale sensitivo e plastico” (p.31). Tutte affermazioni da me totalmente condivise. I quesiti possono nascere dal transito (o salto) nelle seguenti altre: “Ma la poesia come cosa può essere solo una sovra-cosa, una cosa delle cose…sovra-sistema cosale” (p.49)…meta-sistema reale” (p.48); “nel discorso la parola-segno rimanda a un significato altro. Nella poesia, invece, la parola rimanda solo a se stessa (p.30); per cui se “la vita è cosa ed evento. La poesia è il vertice puntiforme di quella cosa e di quell’evento. La vita è fisica. La poesia è, materialisticamente, meta-fisica” (p.60); La poesia è forma delle forme.
Sono affermazioni implicanti una forma di assoluto che tende a raggiungere un nonluogo, divino ed esterno agli enne possibili universi, punta di un crinale, fonte e lievito per me di vitali domande. Perché sono affermazioni che potrebbero in buona parte essere fatte per mille altre cose, animate e no.
La forma delle forme non conduce inevitabilmente alla forma di Dio e non comporta una questione di fede? Inoltre, se l’universo è multiforme, perché la forma delle forme è la poesia, e non (anche) la musica, o la luce, o l’uovo, l’acqua, il mare, il fuoco, l’eros, il DNA, la cellula, la conchiglia, la lumaca, il serpente, l’elefante, perfino il maiale, la gallina…e, scendendo a forme inanimate (ma se la materia è energia…), i cristalli, la sfera, i buchi neri…Non possono ognuna di esse, sedere come forma delle forme sul trono di Dio?
Non possono. A ognuna di queste bellissime e uniche forme manca qualcosa di essenziale per essere la forma delle forme. Lo sappiamo (credo) molto bene. Manca il pensiero, il pensiero che pensa se stesso. Non può esserci la forma delle forme senza il pensiero che pensa se stesso: l’energia al lavoro che è la fonte dell’estetica (parafrasando Schopenhauer). Non bastano i ritmi, non basta la musica, i giochi e l’eros.
Forse. Ma non c’è in questa pretesa una forma di demoniaco manniano, sempre oscillante tra il furore di una costruzione perfetta e una distruzione totale? Se le nuove scienze hanno definitivamente smontato ogni possibilità di affermazione dogmatica del pensiero e della scienza precedenti, la negazione di ogni possibilità di assoluto non ci fa rientrare in esso (ho sempre ritenuto fosse questa la debolezza del pensiero debole; ricordo di aver pubblicamente posto il quesito a Gianni Vattimo, ricevendone la disarmata confessione di “non averci ancora pensato”), non è un altro modo di nominare Dio?
Forse. Eppure può essere un modo di nominare Dio senza l’ideologia – o almeno più leggeri di ideologia. Che è forse il dio più resistente sul trono.
Cercando allora il perché certe punte mi frenano così…irrefrenabilmente, dovrei forse ricollegarmi all’esperienza generazionale di troppe ebbrezze ideologiche. Che sono le nemiche irriducibili del Sé e di suoi possibili momenti di unità adiacente, alias poesia: “nella comunione, con sé…con l’altro” (RP, p.38). Forse per questo il quesito resiste: al posto del “Dio tomistico” (RP, p.43) dantesco, e dell’ipotesi della sua “creazione estroversa e finalizzata”, non ci ritroviamo a veder volare – sul disegno, pur materialistico, di una poesia sovra-cosa meta-fisica – un dio-poesia con la sua “creazione introversa e gratuita” (ibid.)? Sia pure in bilico, ma resistente sul “vertice puntiforme” (RP, p.60) di una materialità meta-fisica (dechirichiano segno-cosa che riesce a rimanere autonomo rispetto alle varie modalità di linguaggio) svanito in una metafisica materialistica (in cui la parola-cosa ritorna dominata dall’astrattismo e dalla metaforizzazione delle Mod-Io)?
Stiamo parlando beninteso del disegno (o visione di idee) e non del corpo di una poesia, che o è, e allora è materialisticamente vivo; o non è, e allora è flatulenza più o meno maleodorante.
Un altro crinale toccato ripetutamente (ossessivamente, ma le passioni vere devono essere ossessive) dall’Adiacenza biologica di G. Ferri è quello dell’utilità/inutilità della poesia: “la poesia è l’evento non finalizzato e inutile per eccellenza” (RP, p.39). Come opera su tale crinale l’incrocio tra la mia Adiacenza mentale e la relatività delle scienze moderne?
Il massimo di utilità per una parte (di sé) è il massimo di inutilità per la totalità. Al contrario il massimo di utilità per la totalità del Sé, è il massimo di inutilità per la parte prammatica, che deve fare i conti (in senso letterale) con ciò che impone l’altro-da-sé che storicamente c’è.
Quindi, se l’utilità prammatica coincide con l’alienazione rispetto alla propria totalità, l’utilità di quest’ultima coincide con tutto ciò che fa vivere momenti di unità della propria totalità; momenti assolutamente necessari e utili all’autopoiesi, quali momenti di comunione, scambio energetico tra le varie aree mentali, rinnovamento e sorta di manutenzione attiva della propria identità. Momenti, come dire, di igiene mentale, rientranti in un universo di utilità antimaterico, rispetto a quello dell’utilità alienata e prammatica. Quanto più questa tende ad assorbire spazi crescenti di tempo mentale, tanto più cresce il bisogno di una prassi utile per-sé (per la propria totalità e ‘sostanza’).
La poesia è cioè, finalmente, una possibilità (fortunatamente non la sola!) dell’esperienza di fusione tra le varie aree mentali dell’identità, rispetto alla prevalente (utilitaristica) esperienza di divisione tra loro, prodotta dalla “prassi assorbente della quotidianità” (RP, p.43).
Da parte mia c’è dunque una visione in termini relativi dei due contrapposti concetti di utilità/inutilità, che le ripetute affermazioni assolute di inutilità sembrano escludere. Affermazioni peraltro contraddittorie con tutto l’impianto relativistico del pensiero neo-scientista di Gio Ferri. Che infatti aggiunge, sempre riguardo alla poesia: “per (corsivo mio) rappresentarsi comunque ed essere comunque recepita” (RP, pp.43-44). Una specificazione che dice implicitamente questo fine per-sé, ovviamente opposto a quello della “comunicazione retorica” (RP, p.43). Che dunque dice che, in una circolarità biologica di ogni soggetto e oggetto (compreso l’”oggetto poetico come sistema vivente”, RP, p.45), non può non essere immediatamente e intimamente contraddittoria ogni attribuzione di autosufficienza, persino del Tutto (dunque anche di Dio, di cui con ciò viene negata in sostanza…la sostanza) e di ogni forma che voglia presentificarlo.
Un ulteriore crinale che mi sollecita quesiti e creative differenziazioni è quello che riguarda la semanticità/asemanticità (vedi, in particolare, RP, pp.35-36). Per l’Adiacenza la poesia è, in quanto tensione (beninteso se fatta percepire) all’unione interna/esterna del soggetto nel Tutto, fino a produrre uno stato modificato di coscienza rispetto a quella ordinaria; fino a ridurre il controllo del limite individuale per acquisire spazi inusuali di adiacenza con l’Altro da sé. Questo vuol dire una forma capace di contenere sia il valore della sematicità che dell’asemanticità. Precisando però che nell’Adiacenza anche i sensi di questi termini sono resi reciprocamente relativi dal rapporto con l’altro (operante già all’interno del SS). Semanticità/asemanticità sono normalmente termini qualificati dalle Mod-Io; ma ciò che è definito asemantico da queste ultime è l’esplosione della semanticità se visto dalle Mod-Es. Viceversa, ovviamente, se il punto di vista è di queste ultime.
Il fatto che una parte debba “’per forza di cose’” entrare nell’altra, non è dunque “il dramma vitale della parola poetica” (RP, p.36), ma è la sua ricchezza, la sua festa, la condizione specifica della sua complessità. L’una parte senza l’altra non dà poesia, ma due ipotesi: o parola prammatica, piena di significati ideologici (in particolare ideologia della Verità); o, come già detto, flatulenze verbali, fatte d’aria più o meno malsana con (probabile) ideologia del Testo.
Solo lo spazio poetico (ma non solo, come già sottolineato) porta l’una e l’altra a intrecciarsi in fraternità, facendo scoprire, rispetto all’altro, una pratica che riduce e insieme esalta. La poesia è perciò, non solo una pratica di igiene mentale, ma anche un esercizio civile (non voglio usare il termine iperideologico di democrazia) di scambio con l’altro, a cominciare dall’altro che è già in noi.
Nell’Adiacenza il versante asemantico è (se il punto di vista è quello delle Mod-Io) “l’infinito limite di asemanticità” (RP, ibid.) nel buco nero del proprio “collassamento di sensitività” (RP, p.28), da cui deriva fra l’altro l’impossibilità della parafrasi della poesia; perché vorrebbe semplicemente dire ricondurla sul terreno della metafora e sul “piano…del quotidiano” (RP, p.65). Ma proviamo a non buttare via nel cestino questa apparentemente indiscutibile impossibilità.
L’ipotesi contraria implicherebbe che il senso complesso di un testo poetico, dopo essere collassato in un buco nero di antimateria (rispetto alla supposta materialità del “senso comune”, RP, p.59), riesca a riemergere nuovamente, attraverso un buco bianco, nella materialità così come normalmente percepita (mi pare che la traduzione di un testo poetico tocchi questo nodo). Possibile? Il successo, la fruizione e la circolazione sociale di un testo non dovrebbero essere altro che questa verifica. Ma la sua complessità e la sua aleatorietà, sappiamo come vengano ulteriormente intricate da mercato e dominio. Siamo perciò (forse) sullo stesso piano delle ipotesi (finora non verificabili) fatte dall’astrofisica degli ultimi decenni su materia/antimateria, universi paralleli, ecc, argomenti piuttosto divulgati e riproposti nel capitolo “L’altro universo” de La ragione poetica (RP, pp.56-66). A tale capitolo, particolarmente interessante, tendono dunque a ricondursi queste estrapolazioni.
In sintesi, l’applicazione da parte di Gio Ferri della teoria dei buchi neri al testo poetico – come capacità di questo di bucare lo spazio tridimensionale del quotidiano, riuscendo così a produrre uno “’spazio (mentale, ndr) quadridimensionale’” (RP, p.53) – implica l’altrettanta teorica possibilità di uscita da questi tramite un buco bianco; al pari di quanto ipotizzato dagli astrofisici per l’universo esterno. L’ipotesi, pur trattata con cordiale distanza, mi sembra che trovi qualche rispondenza in un brano particolarmente luminescente (RP, pp. 53-54) che Gio Ferri trae da Le forme del desiderio di Giuliano Gramigna.
Gramigna, richiamandosi al “Compendio di psicoanalisi di Freud”, ricorda “’due forme, una liberamente mobile e l’altra più legata…” che operano nella vita psichica. Se passiamo a un “’testo poetico, qualsiasi testo poetico’”, possiamo rilevare che la “’significazione opera…attraverso una dinamica di forze libere e forze legate, forze libere che diventano legate e, viceversa, forze che si slegano da stati o forme relativamente stabili in cui si erano costituite…’”
Mi paiono splendidamente rappresentate le modalità sopra indicate di mobilità e relatività degli spazi mentali, che a saperle cogliere, ci dicono – in particolare attraverso la poesia, ma ripeto tediosamente, non solo – la loro biologica tensione a rifuggire ogni categorizzazione assoluta. Così, ciò che pare rinserrato e infruibile (vedi le giare dell’inconscio proustiano) viene aperto e liberato, e ciò che pare libero, come il pensiero cosciente, ci lega coi suoi legacci. Assolutamente e relativamente necessari, tuttavia, l’uno all’altro; se ammaliati dalla magia costruttrice di quell’oggetto chiamato poesia, che come la vita ci sembra a volte di prendere, e poi nuovamente sfugge.
Milano, giugno 2000-2019
Adam Vaccaro
Alessandro Assiri, "Lettere a D.", LietoColle 2016, nota di Flavio Ermini
Popola queste poesie una vasta schiera di momenti legati a un misterioso personaggio.
A ogni gesto Alessandro Assiri si rivolge senza attendere risposta. Nemmeno per ipotesi.
Guadagnarsi il diritto di sopravvivere è già un buon risultato. Per farlo, osserva Assiri, significa starsene ritto e immobile di fronte a un muro, forse invalicabile.
Poesia in forma epistolare, perché? Perché non c’è sistema, sia pure imperfetto, che sia creato una volta per tutte.
E quale forma allora è meglio di una lettera? materia mutabile e sempre mutante? e che vive soprattutto nello slancio esecutivo?
La poesia per Assiri è viva materia in movimento; è testo mai concluso, indirizzato a un destinatario chiamato a esserne l’esecutore.
A D. Che non butta via niente
facevi una vetrina coi tuoi sogni
soggiornavi nelle tue regioni senza orizzonte
chiamavi ogni cosa come da dietro una parete.
Mi facevano sorridere le tue inutili manovre per rimediare ai disastri
sembravi un bambino che per pulire allargava la macchia
un dito che stuzzicando allarga il buco.
Restavamo sempre lì come fossimo la prima parte di qualcosa da completare
restavamo insieme ad aspettare gli anni
così come si aspettano le idee per sempre inconcludenti
per timore di concluderci. Avevamo ancora un nome per ogni rivoluzione
stavamo a margine di tutto con quel modo inconsueto che hanno solo
i vecchi di rimanere in disparte
le battaglie perdute in un mazzo di carte.
A D. Che sovrappone le caviglie
ascoltavo il nostro silenzio
il rumore dei gesti ripetuti e della tua stanchezza
ascoltavo il farsi fottere delle nostre rivoluzioni
lo sciogliersi lento della schiuma della birra.
Ti guardavo bellissimo e falso
zona mediana del grigio
fingevi argomenti e diventavi aggressivo acchiappando
un pensiero di carne e pelle.
A D. Che attraversa al semaforo
lo sai perfettamente che c’è sempre
un mondo per cui non si è stati previsti
ma tu non ci badare nemmeno fosse vero
nemmeno se non torneranno i conti del fare e quelli del subire
o ti chiederanno per quanto è durato questo poco da mozzare il fiato.
Alessandro Assiri è nato a Bologna nel 1962. Vive e lavora a Trento. Collabora con riviste cartacee e telematiche. Scrive da anni opere in versi.
Vanni Bianconi, "Sono due le parole che rimano in ore", Casagrande 2017, nota di Flavio Ermini
Vanni Bianconi ci parla delle tante quotidianità che viviamo. Sì, perché di quotidianità non ce n’è solo una.
Ci sono più cicli di vita che ci accompagnano nel corso della giornata. E così accade giorno dopo giorno.
Le parole alle quali Bianconi si affida sono veri e propri strumenti di scavo.
Niente esitazioni, né inciampi nella sua lingua, la quale, provando a dire, viene a interrogarsi in merito allo statuto del soggetto che ha preso la parola.
Esprimendo così – di fronte al moltiplicarsi delle quotidianità – tanto l’incertezza e il valore dubitativo, quanto la difficoltà di accogliere una vicinanza senza conciliazione.
Dalla sezione Si muore in la minore
Poesia in settembre
Se fossi stato qui l’avresti visto,
il cenno di saluto tra gli amici
che hanno passato insieme un giorno, o anche una sera
anche qualunque, e il tempo morto
prima che tutti si allontanino; si svuoterà
la casa, il teatro, il prato, la città – qualcuno
ancora insieme sale al lago Ritom
tra nebbia cinese, nubi d’Aberdeen
e marmotte di Piora, fa il giro dell’acqua,
coglie un mirtillo, la willowherb
e scende sulla seconda funicolare più ripida d’Europa,
senza tenersi al palo con il palmo
tremando nel capofitto dell’istante che si supera
sonda la leggerezza dell’aria della valle
sonda la leggerezza dell’aria della valle
di Levantina, Altanca e delle Antille.
L’amore sotto l’amore
Ecco cos’era, che mi spinge a soddisfare
il suo bisogno di parole aeree e sfrontate
che travalicano le povere cose che ci diamo
prevaricano su cosa non immaginiamo;
ecco cos’era a farle sfinire cosa la circonda
mentre rivelato come lei l’ha visto risponde
con avarizia, bisogno, servilità vendicativa,
cosa la porta a definirsi pazza, drogata e cattiva;
ecco cos’era che la ingombra in ogni azione,
giù gli scuri, sfondo di televisione,
la schiaccia a letto sveglia i giorni e le notti;
ecco cos’era che lucida i suoi discorsi molli
così che lo scontro di slogan contraddice
quel che ha fatto della sua vita cimice
e getta un riflesso impossibile e lo prendo per vero
e qualche volta ho pregato; ecco cos’era
che dispiega il suo corpo sotto il mio e infinita
fa roteare la voglia di lei e crescere in picchiata
il mio nel suo sesso la lingua nella bocca dell’ano.
L’opprimente ala buia dell’angelo.
(Le bruissement de l’aile de Gabriel).
(Fruscio dell’ala di Gabriele).
Vivere all’ombra divina del mostruoso. Non si può.
Senza non posso continuare ad amare. Potrò –
e si ride e ci si accetta cercandosi ansiosi,
le parole ghirigori d’anima, sensuali, animosi –
stringermi alle gambe di femmina d’umano
ma con il suo perdono.
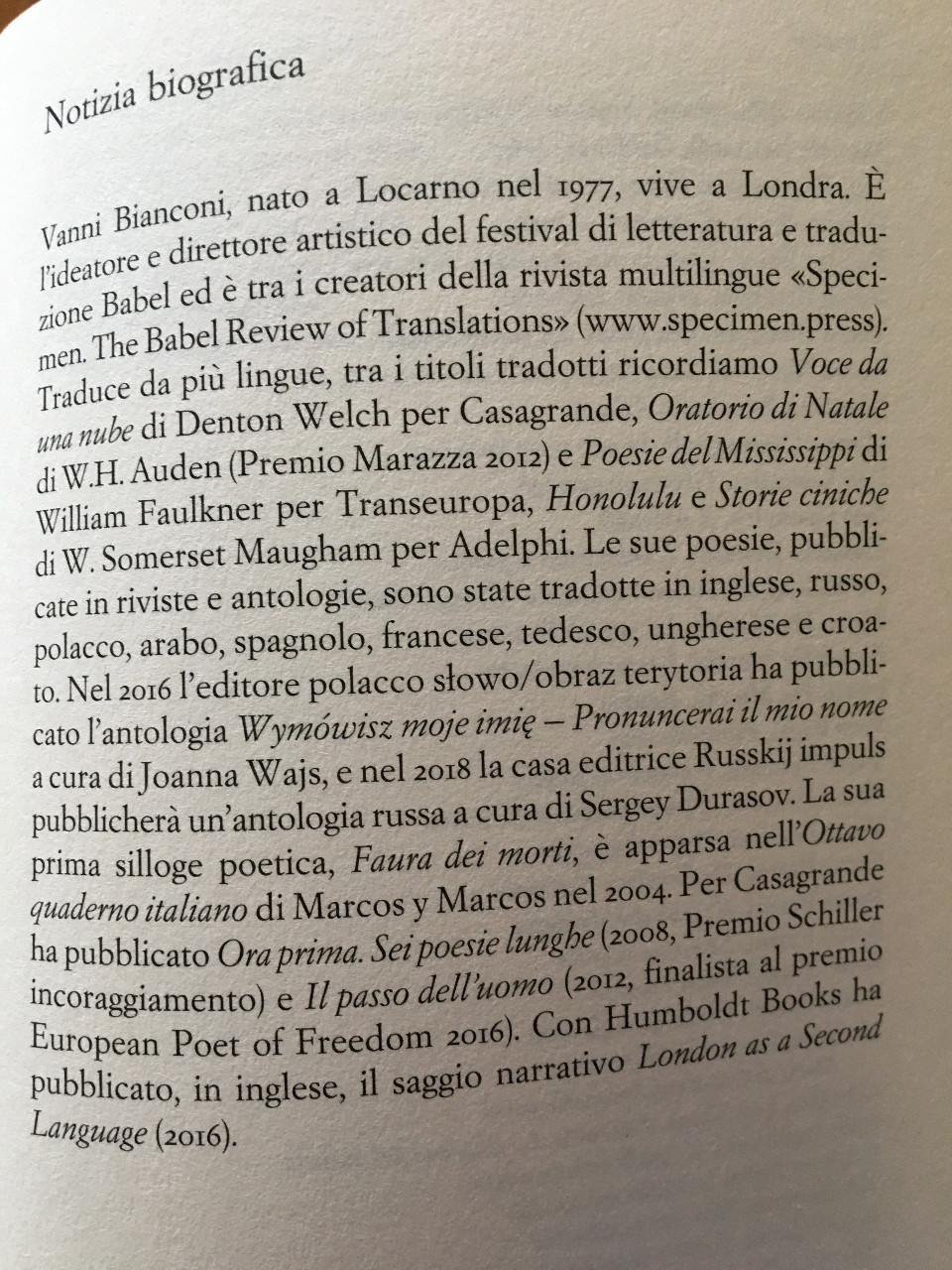
Luca Bresciani, dalla raccolta inedita “Canzone del padre”, nota di Laura Caccia
Luca Bresciani, dalla raccolta inedita “Canzone del padre”, nota di Laura Caccia
Come vetro soffiato
Traspare un’incandescenza intensa nei versi asciutti e cristallini di Canzone del padre di Luca Bresciani. Un’incandescenza intrisa di sofferenza, nella memoria ardente di incendi familiari, che non viene lasciata ardere e divampare, quanto piuttosto circoscrivere e coltivare attraverso il soffio della parola poetica.
“Scrivere in versi / è fare un cerchio di sassi / dove allevare una fiamma / sfregando il cielo nella terra”, dichiara l’autore, nell’accogliere interamente il fuoco e le vertigini che ne agitano la storia personale, poiché “Il fumo serve solamente / a chi non crede nelle scintille / e ha bisogno di un indizio / per sfogliare il nostro incendio”.
E l’incendio, che ne scuote il sentire, appare desideroso di parole di salvezza che la poesia può essere in grado di pronunciare: parole che ritroviamo costanti tra i versi e che paiono capaci di esaudire l’esigenza dell’autore di elaborare sentimenti e rapporti complessi, nel tentativo di “disarmare il proprio passato”, e, nello stesso tempo, di soddisfare la necessità della poesia di dare forma all’incandescenza che la anima.
Lungo percorsi complementari, sul piano personale e su quello poetico, che muovono dal magma alla trasparenza, dalla sofferenza alla pacificazione. Facendo leva, da un lato, su crepe e spiragli in grado di spezzare oscurità e ostilità, di aprire ad un nuovo dialogo. Mettendo in moto, dall’altro, un movimento in levare che può trovare, nella diradazione del dolore, nel soffio e nella luminosità, una possibilità di salvezza.
Cercano un soffio i versi della raccolta. Colmi di un’incandescenza rarefatta che ha preso forma e trasparenza, sembrano lavorati come vetro soffiato, dentro un processo mentale e affettivo in cui la temperatura elevata pare abbia consentito di rendere il materiale malleabile, di plasmare i sentimenti infuocati, di trasformare le tensioni in una parola in grado di toccare e trasformare il dolore: “Ti devo mostrare / la pace nelle parole: / i verbi a formare una conca / come dita attorno a una fiamma”.
Come dire: raggiungere il sentire nel punto in cui prende forma, trovare quella pacificazione che consenta eticamente di recuperare ferite e cicatrici e poeticamente di farne emozione nuova, disponibile ad un nuovo inizio, come ci indica chiaramente Luca Bresciani a conclusione della raccolta: “A volte si danza / solo per restare in vita / mulinando le braccia / per risalire la sofferenza. // Il primo respiro / sarà un atto osceno / in un luogo salvo / tra noi e il mondo”.
Dalla sezione: Il diritto di esplodere
***
Sto tentando di elaborare
gli articoli di una costituzione.
In questi scritti in colonna
c’è il ripudio alla mia guerra
e il diritto inviolabile di un uomo
di disarmare il proprio passato.
***
Scrivere in versi
è fare un cerchio di sassi
dove allevare una fiamma
sfregando il cielo nella terra.
Il fumo serve solamente
a chi non crede nelle scintille
e ha bisogno di un indizio
per sfogliare il nostro incendio.
Dalla sezione Un luogo salvo
***
Un calore che non esiste
piega a metà le mie orme
mentre raggiungo il bordo
di un grido mai risolto.
E’ un dovere precipitare
riscoprendo il peso del cuore
incontro a un uomo sconfitto
dal più minuscolo se stesso.
E prima di lasciarmi cadere
nel cielo traccio la mia esplosione:
una proiezione spirituale
che dona alla luce ogni dimensione.
***
Voglio spendere i domani
per risolvere le mie espressioni
ma non cerco una cifra sfinita
a cui promettere la mia memoria.
Se compierò degli sforzi
sarà per piegare le mie parentesi
diventando una fortezza che sogna
abbracciata a una soffice conquista.
La presa della bellezza
di chi vive con una sola risorsa:
disegnare nel proprio labirinto
una crepa che invita il mondo.
***
Una liquida canzone
che sutura le crepe
e sale verso il soffitto
sfiorando il lampadario.
A volte si danza
solo per restare in vita
mulinando le braccia
per risalire la sofferenza.
Il primo respiro
sarà un atto osceno
in un luogo salvo
tra noi e il mondo.
Luca Bresciani è nato a Pietrasanta (LU) nel 1978. E’ presidente dell’associazione culturale Vita alla Vita e fondatore del concorso di poesia under30 “Vita alla Vita”. Nel corso degli anni ha pubblicato le seguenti raccolte di versi: Lucertola (2011) Edizioni del leone e cura di Paolo Ruffilli, Modigliani (2015) Lietocolle, L’elaborazione del tutto (2017) Interno Poesia con la prefazione di Davide Rondoni. Le sue poesie sono ospitate su molti siti letterari tra cui Poetarum Silva, Atelier Poesia, Versante Ripido, Pioggia Obliqua e Interno Poesia.
Allì Caracciolo, prosa inedita "Barbablu", premessa di Mara Cini
Per scrivere su Barbablu di Allì Caracciolo prendo dalla mia libreria "Morfologia della fiaba" e "Le radici storiche dei racconti di fate".
Poi cerco anche "Pietre che cantano".
Forse quest’ultimo libro non mi servirà ma le sgranate arenarie, gli scolpiti profili di capra, angelo, fanciulla e un’arcata… di ali o di corna
non richiamano forse i capitelli di chiostro di cui parla l’etnomusicologo Marius Schneider?
Nel testo di Caracciolo sono evidenti alcune figure e corrispondenze indicate dalle analisi di
Propp: la foresta, il ciclo dell’iniziazione, i divieti, la segregazione, la sorellina, la
rappresentazione della morte…Nel contempo i lamentevoli gemiti, le urla stridenti dei muri
rimandano proprio alle pietre che cantano, alle figure simboliche del grido e del
linguaggio, ai suoni rituali scolpiti nella pietra.
Proseguendo nella lettura di Barbablu, seguendo l’autrice nel corridoio impercorribile,
aprendo le pesanti pareti minerali, gli sbarramenti, i velari e tutto il mondo calcareo,
fossile, metallico, ferruginoso che, attraverso trasformazioni alchemiche, prefigura l’arrivo
e la rinascita, abbandono l’idea di analisi colte. Mi ritrovo esattamente, anch’io, nel
racconto di bimba (…racconti storie come la bimba, si dice in Barbablu). Ricordo: l’anello
cade nel lago, o nel ruscello, e inizia il sub-acqueo, ansioso, periglioso, viaggio per
recuperarlo, incontro dopo incontro, prova dopo prova, porta dopo porta…



Roberto Capuzzo, "Senza vera regola", con immagini di Carlo Guarienti, Gli Ori 2018, nota di Flavio Ermini

Roberto Capuzzo pone con la sua poesia la questione teoretica del contenuto di verità della parola.
Pone la domanda circa la possibilità della parola poetica di essere evento veritativo, luogo del dis-velamento, del senso nascosto.
C’è un pensare che accade nel linguaggio e questo pensare si schiude solo a chi inizia a muoversi mimeticamente entrando con esso in sintonia.
Come se per scrivere poesia si dovesse prima danzare insieme alle parole.
Tanto da far pensare che l’essenziale – come suggeriscono le tavole di Carlo Guarienti – non vada cercato, bensì atteso.
Da qui nasce il nostro dovere di rendere accogliente la nostra casa poetica.
***
Inspira, espira
esposta oltre il margine
ristabilizza l’equilibrio.
Per un solo attimo ha inseguito
la sagoma dentro il profondo,
quegl’istanti
sospendono il respiro.
***
Violagiallo il colore
sgranato per punti
sulla costa.
Da lontano lo stesso luogo
è macchia, oltre ancora, volto.
Nascosto nella sabbia
hanno sguardo gli occhi
la mano sospesa
del corpo divenuto crosta.
Dello stare rovente fino al mare
la traccia è impercettibile.

Alessandra Carnaroli, "Ex-voto", Oèdipus 2018, collana “Croma k”, nota di Rosa Pierno
Un dialogo con la morte o meglio con la putredine a cui il corpo malato si avvia è tutto giocato in Ex-voto di Alessandra Carnaroli attraverso l’uso di un linguaggio a cui viene inferto un lavoro di associazione anche automatica: “sondaggi / drenaggi e sofismi”, “una calza/ (collant) / e collante”.
E nel frattempo il tentativo di adeguarsi / abituarsi sempre sperando nel meglio a dispetto di ogni evidenza, anche grazie a innesti prelevati dalla cultura di massa (i Pooh, i pacs, Cinecittà o le invocazioni per sfuggire al melanoma).
Appare evidentissimo il salto esistente tra il crudo referto e l’indisponibilità mentale ad accettarlo, dove il linguaggio ha anche un ruolo liberatorio e a tratti ironico.
***
che mentre muoio tu mi
stia di fianco
come innesto da cui
parte quanto
di me resta
su questa
rete metallica detta
terra
dove si registrano
bestemmie e demolizioni:
grandi imprese dunque
le nostre
rese :
***
Oh luce di maria governami
mentre mi stratifico in vermi
per sempre Custodisci
questa cipria d’ossi
dammi aria
come coperta
***
Piove
dove avevi
bagnato
E adesso siedi
accanto a dio nostro
padre
Doneremo il
respiratore
all’ospedale
I super pannoloni
agli anziani
Non ci resta che cambiare
la fiat doblò
per handicappati
con una mini
Alessandra Carnaroli (1979) pubblica nel 2001 Taglio intimo, Fara editore. Nel 2005 la raccolta poetica Scartata è finalista al premio "A. Delfini".
Nel 2006 alcune poesie sono pubblicate, con una nota di A. Nove, in 1° non singolo (sette poeti italiani) Oèdipus edizioni. La raccolta inedita Prec’arie è finalista al premio Miosotis 2011, d’If edizioni. Pubblica nel 2011 FemmINIMONDO, Polimata, con una nota di T.Ottonieri, nel 2015 Elsamatta, collana «Syn. Scritture di ricerca» diretta da M. Giovenale, ikonaLíber, finalista al Premio Pagliarani 2016 e nel 2017 Primine, edizioni del verri, con una nota di A. Cortellessa, finalista al premio Pagliarani 2017 e Ex-voto, collana croma K diretta da I. Schiavone, Oèdipus. Il Verri dedica al suo lavoro la sezione monografica di Ottobre 2017. Prose e racconti sono pubblicati in diversi siti, antologie e riviste.
Davide Castiglione, audio di “Domantė”
Davide Castiglione, ascolta l'audio di “Domantė”
Il testo, con la premessa di Ranieri Teti, è stato pubblicato nel precedente numero di “Carte nel vento”
Lia Cucconi, poesia inedita "Riflesso", premessa di Ranieri Teti
Nel corso di questi ultimi anni, Lia Cucconi ha allenato le nostre percezioni all’ascolto di tutto quello che si muove sotterraneamente.
Il nostro sentire, se prestiamo attenzione alla voce e soprattutto al sottovoce che distingue questa poesia, nel tempo della lettura ne risulterà alterato.
Grazie ad accorti spaesamenti semantici, improvvisi linguistici che accadono nel corpo del testo, grazie a un acuto neologismo, "Riflesso",
partendo proprio da un oggettivo e forse reale frammento ottico, ci sorprende con la sua evoluzione.
Quello che “s’apparta nell’incastro” ci conduce alla “periferia dell’inconscio” e da qui, fino ai suoi ultimi sviluppi, a “dove ha luogo la nostra irrealtà”.
Il dono che ci porta questa poesia è quello di farci intravvedere la natura del lavoro poetico, quel superamento del noto,
per mezzo di un riflesso che nello svolgersi del testo diventa riflessione, congiunzione di forma e senso.
Riflesso
S’apparta all’incastro
nel vetro d’angolo s’elegge
in periferia dell’inconscio
per serra d’ombra lunga
a inserto senza corpo:
a leggera leggenda d’alibi omesso
in pallide calende
che patteggiano parole
da verbilabbra d’un reato a metà prezzo
per romanzo riscaldato
all’ossessione del dopo:
forgiata preda d’orizzonte sparso
sul pulviscolo complice del vuoto
là dove ha luogo
la nostra irrealtà.
Lia Cucconi, docente di Attività Espressive, ha pubblicato 9 libri in Italiano e 10 nel Dialetto di Carpi (Modena). Ha ricevuto critiche e riconoscimenti nelle due espressioni linguistiche, fra i quali: 1° Premio Noventa-Pascutto, 1° Premio Paolo Bertolani-LericiPea, 1° Premio Carlo Levi, 1° Premio Salva la tua lingua locale Campidoglio-Roma, 1° Premio Poesia in forma Landays Torino. Ha pubblicato poesie in antologie e riviste nazionali e sulla rete nelle due forme linguistiche sostenuta da critici del settore, esprimendosi volgendo la sua sensibilità artistica nella Poesia lirica, civile e sperimentale, completandola con l’insegnamento.
Annamaria De Pietro, "Rettangoli in cerca di un pi greco", Marco Saya Edizioni 2017, nota di Flavio Ermini
Colui che parla cerca qualcuno presso cui stare e da cui rifugiarsi.
Colui che parla cerca la realtà più autentica. Cerca il limite.
L’assoluto non rappresenta più la meta immediata del movimento dell’esistenza.
Il limite del quale ci parla Annamaria De Pietro trasforma il commiato in un arrivo.
È un vuoto oscuro che si ritira in se stesso, accogliendo l’elemento della passione, ospitando echi di profondità inaspettata.
Accade a chi parla che la notte della casa si trasferisca nella notte della natura.
Più precisamente in quella parte della natura che è immagine del caos e che forse solo la forma chiusa della quartina può rivelare, svelando che ci sono sempre altre cose da dire.
Risarcimento in sé
Ripeti chiaro sintagma ripeti
fino a che il senso dentro ti si sfasci
sfasciandoti, e soltanto un filo lasci
che sia sutura ai frammenti discreti.
È esperienza comune (nei due sensi del termine), eppure ogni volta straniante di sorpresa, che ripetendo molte volte e rapidamente una parola questa perda alla fine il suo significato e diventi una pura sequenza di suoni insensati. Non sempre dunque repetita juvant. O forse è vero il contrario. Forse massimamente juvat risentire ogni tanto la fresca e franca quintessenza del suono fra i denti, come un filo d’erba matta.
La riconversione
Tanto ad imperfezione cresce crosta
arra dei tempi dispersa congiura
che nel tempo che cresce monta e dura
perfezione di scaglie sovrapposte.
L’inizio di tutti gl’inizi – Tutto è relativo.
Item – Anche l’imperfetto ha la sua perfezione, la perfezione dell’imperfezione.
Item – L’elogio dell’imperfezione si compiace con una certa sua qual civetteria
di una certa sua qual perfezione per quanto si riferisce all’originalità
del pensiero.
Item – Il tempo è galantuomo.
Per svago
M’inventerò con il filo e con l’ago
una forma possibile a ricamo
di fiori e tinte, con la lenza e l’amo
il balzo da acqua ad aria, argento e drago.
So cucire (ricamare poco, dal tempo dei tentamina adolescenziali, imparaticci di competenze); non so pescare. Ma fingendo di saper fare benissimo sia l’altra sia l’una cosa, ebbene le farò e le faccio entrambe con l’ago-amo della bic, la freccetta cursora del computer. E così vedi che non tu, non io saremo senza.
L’approssimazione
Morte non parla che in breve quartina,
approssimata prova di silenzio,
nebula azzurra in calice d’assenzio,
arco voltaico alla seconda spina.
Scrissi questa quartina anni fa, in un tempo assai difficile da vivere, tristissimo, nel quale, così era, riuscivo a produrre quasi soltanto quartine: una quantità strabocchevole, da vergognarsene – me ne vergognavo. Allora pensai che la quartina potrebbe essere vista come una prova tecnica e puntuale di afasia, non proprio ancora la morte ma l’officiatura ben replicata e ligia dei suoi dispositivi preparatori – come dire un rito a ripetizione potenzialmente senza fine.
Non sbagliavo: l’afasia, quella compatta e intera, seguì qualche tempo dopo, e durò a lungo, privata del sia pur gramo alito di una quartina.
Ma. Palinodia. Ben venga (senza esagerare) la quartina, che in un assai esiguo spazio, proprio per l’esiguità e strettura di quello spazio prossimo al niente, deve (e lo fa) non rinunciando contenere un intero esatto di significato e senso; che è libera in sé medesima, in debito soltanto con la sua stessa norma numerale; che è a sé bastante, e superba, e disposta a tutto – anche, e precipuamente, quando il carcere è scuro, a morire.
Resti forse, a epitaffio, prosa amica di glosse che guardano indietro, rivolte avanti, a vivere – la mano lunga, la voce lunga del commento, l’aria serena che fugge via dal ventaglio. Aria di analogie pensate dopo, persone e libri e figure, e compleanni, e viaggi, e cinema, e grammatiche, fiancheggiatori elastici di quei rettangoli sfrangiati a oriente. E sono forse loro, le erranze erratiche, il pi greco?
Annamaria De Pietro è nata a Napoli. Vive a Milano. La sua prima pubblicazione in versi risale al 1997: Il nodo nell’inventario, Dominioni Editore, Como 1997. Sono seguiti Dubbi a Flora, Edizioni La Copia, Siena 2000; La madrevite, Piero Manni, Lecce 2000; Venti fusioni a cera persa, Piero Manni, Lecce 2002. Nel 2005 pubblica un libro in napoletano, Si vuo’ ‘o ciardino, Book Editore, Castel Maggiore 2005. Nel 2012 esce Magdeburgo in Ratisbona, Milanocosa Edizioni, Trezzano S/N 2012. Ultima pubblicazione, Rettangoli in cerca di un pi greco. Il Primo Libro delle Quartine, Marco Saya Edizioni, Milano 2015.
Franco Falasca, poesia inedita "Luoghi diversi", premessa di Ranieri Teti
Franco Falasca ci dice che la poesia ha luogo dappertutto.
Non c’è anfratto ove non possa arrivare.
In “Luoghi diversi” l’autore aggiorna la nozione di poesia civile. Lo fa con una mozione:
la mozione di un poeta che contrasta una falsa civiltà, ne smaschera il travestimento proprio dove questa pensa di essere al sicuro,
nelle convenienze che ormai regolano ogni nostro pensiero, ogni nostro rapporto.
Da molti anni Falasca teorizza un’idea di immaginazione preventiva, totalizzante e recentemente assurta a pubblica consacrazione.
La poesia qui proposta non si discosta da questo assunto, nella sua lucida rappresentazione di uno stato dell’essere che ha pre-visto,
ha anticipato “il tempo che scorre”, preconizzato tutto quello che vanamente accadrà, anche nel nostro piccolo mondo poetico.
Luoghi diversi
Non abitare luoghi diversi dal tuo
già il tuo sapere
soddisfa il tempo che scorre
e la malsana frenesia
ha come suo rifugio
il negativo.
Sembra che il tuo amore
sia utile alla sofferenza
percepita nell’eleganza
alternata delle movenze morbose.
Non è utile al tuo implorare
impegnare il carattere
in trascurabili pose
se più utile è assecondare
la moltitudine dei rumori
percepiti all’incipit
e poi addormentati
nella saggezza civile
che brutalizza le incognite
per un avvenire di poetica
arbitraria convenienza
deserta ma tuttavia
dannatamente utile
al travestimento.
Nato a Civita Castellana (VT), Franco Falasca vive a Roma. Ha prodotto, oltre a poesie e racconti, anche poesie visive, films super 8, video, fotografie, performances. Ha organizzato rassegne e manifestazioni.
Nel 1973 fonda (con Carlo Maurizio Benveduti e Tullio Catalano) l’Ufficio per la Immaginazione Preventiva con cui collabora fino al 1979; partecipa come artista alla Biennale di Venezia 1976.
Suoi testi e materiali vari sono stati pubblicati, oltre che nei cataloghi delle mostre alle quali ha partecipato, anche su varie riviste ed antologie e nei volumi:
"UNA CASA NEL BOSCO Prose e racconti", Edizioni Latium/Ouasar, Roma, 1990, vincitore del Premio Letterario OrientExpress 1990
“NATURE IMPROPRIE (poesie 1976-2000)”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2004, vincitore del Premio di Poesia Lorenzo Montano XIX edizione (2004-2005) della Provincia di Verona
“LA FELICITA E LE ABERRAZIONI (poesie 2001-2010)”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2011
“LA CREAZIONE NOTA”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2017
Roberto Fassina, dalla raccolta inedita “Historia Medica”, nota di Laura Caccia
Poema etico
Rovesciando i contenuti dei poemi classici, ma tenendone fermo l’impianto narrativo, con Historia Medica Roberto Fassina mette in scena l’epopea degli eroi della ricerca scientifica e della medicina, così come la saga quotidiana dei pazienti, eroi o antieroi, in lotta contro i propri mali. Una narrazione epica, quasi un’opera teatrale, insieme serissima ed ironica, dettagliata e satirica, sulla nascita e sugli sviluppi della ricerca medica, sulle invenzioni tecnologiche e sul prezioso rapporto tra medico e paziente.
All’eroismo e alle ossessioni dei protagonisti dei poemi omerici e cavallereschi, l’autore sovrappone chi, in modi e tempi diversi, ha condotto la medicina alle sue grandi scoperte e, insieme, chi affronta quotidianamente patologie e turbamenti fisici e psichici.
A partire dal prologo: “Dei figli d’Asclepio narrami o Musa / l’historia peccatosa d’anime ribelli // audaci eretici curiosi”, attraverso distici in rima, spesso in latino, nell’alternanza di lingua colta e parlata discorsiva, di ritmi spezzati e di periodi riflessivi, veniamo condotti lungo il percorso affascinante della storia della medicina, dal mito alla tecnologia, fino all’ultimo fondamentale passaggio, “dal metodo rigoroso all’empatia creativa”, nel quale l’autore declina l’essenza dell’etica medica: l’attenzione partecipe, non solo clinica, ai pazienti e alle loro persone.
Un poema antieroico o eroico a suo modo: in fondo, cosa separa la ricerca del senno sulla luna o la guerra epica interminabile dai tentativi audaci, interminabili anch’essi, di medici e scienziati rispetto agli enigmi del corpo umano e allo stato turbato del paziente, dove “lo incarto della mente / ossessa e incatenata // l’intruglio esistenziale / s’ingorga senza fondo // (…corrode l’anima …)”?
E la poesia? Perché fare uso della parola poetica, anziché del linguaggio scientifico, per narrare l’evolversi della ricerca medica? Possiamo trovare un’immediata risposta, oltre che nella scelta del componimento epico, già nei primi testi della raccolta: la medicina agli esordi appare esattamente come la parola di fronte alle contrapposizioni visibili dell’apparenza e ai misteri celati nell’ignoto: “Lo sintomo saputo / d’opposte qualità // recita e insegna / indizi e congetture //…mirando / ignoto il donde e il quia // per ignoti saperi / et aspera via” e ancora: “Indugiando sui bordi // del buio / scrutando l’ignoto respiro // (il passo della voce / lenisce il tatto…)”. Così come, nello snodarsi del poema, appare spesso sovrapponibile a quello del poeta il ruolo del medico che “interpreta fragmenti / portando senso // al vivere inquinato / dal tempo e dalla sete”.
La parola del medico, come quella del poeta, porta senso: con Historia Medica, nello snodarsi dei diversi linguaggi scientifici ed epici, filosofici e teatrali, Roberto Fassina riesce a dare nome e valore alla storia dell’umanità e del suo sforzo etico, intriso di conoscenza e di poesia, di fronte al dolore e all’enigma dell’esistere.
Dalla sezione DAL MYTHOS AL LOGOS
(dalle cause divine alle cause naturali delle malattie)
ALCMEONE (…o dei primi vagiti medicali)
Lo sintomo saputo
d’opposte qualità
recita e insegna
indizi e congetture
(umidus et siccus
frigidus et calidus
dulcis et amarus
in copia et rigore)
fisiologista primus
d’isonomia(1) cultore
al pro e contro mirando
ignoto il donde e il quia
per ignoti saperi
et aspera via.
(la borsa mercuriale
consunta di tracolla)
(1) Isonomia: stesso diritto, equilibrio fra le parti.
Dalla sezione DAL LOGOS ALL’EXPERIMENTO
(dal testo galenico al cadavere, dalla metafisica alla fisica secondo forma e funzione)
PARACELSO (…o dello Lutero medico)
« Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit.
Dosis sola facit, ut venenum non fit »
Di metalla cultore et cabalista
alchimista curioso
a trasmutar sostanza
ribelle e rivoltoso
a perigliose lotte
fra micro et macrocosmo
(...maravigliato et strabilio
de lo mondo foemina)
domina donna
polposa et bona
di saggezza dogliosa et plena
appo di te la giusta vita
disiosa et generosa
mater d’incantamenti
alchemiche pozioni centellate
mischiute et ingollate
de salubri germogli
dragoncello et melissa
(similia similibus
iperica natura)
il ventre tuo diletto
recipiens loco delizioso
descripto
laudato e intemerato
in tota muliere matrix misteria
perfettissimo balsamo
(amor medicinae princeps)
Nel frattempo la raccolta inedita Historia medica è stata pubblicata nel marzo 2019 da Anterem Edizioni, con prefazione di Carlo Rao.
Roberto Fassina è nato a Curtarolo (Padova) il 18/12/50. Dopo la maturità classica, conseguita nel 1968 presso il Collegio Salesiano Manfredini di Este, si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, dove si è laureato nel 1975 e poi specializzato in Ginecologia nel 1979. Dal 1979 vive e lavora a Curtarolo come Medico di Famiglia.
Nel 1991 ha pubblicato “Nihilissimo Canto” (poesia) per i tipi delle Edizioni del Leone di Venezia. In quel periodo ha collaborato con poesie e racconti nella rivista milanese ‘Alla Bottega’.
Nel 1998 ha pubblicato il romanzo “Equazione Ultima”per i tipi delle Edizioni Amadeus di Treviso.
Nel 2003 ha pubblicato la silloge poetica “pesca sabèa” con la Casa Editrice ‘all’antico mercato saraceno’, di Treviso. Sue poesie sono presenti in varie antologie poetiche.
Suoi testi teatrali satirici, aventi per oggetto il mondo medico, sono stati rappresentati a Piove di Sacco e a Padova, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2012 e nel 2016.
Nel 2011 ha pubblicato la raccolta poetica “Tangheide – lapsus in fabula” con la Casa Editrice ‘all’antico mercato saraceno’, di Treviso.
Nel 2015 ha pubblicato il romanzo “Il pensiero verticale” per i tipi di Ibiskos Editrice Risolo di Firenze.
Scrive saggi e note critiche nella pagina culturale del Bollettino dell’Ordine dei Medici di Padova.
Paolo Ferrari, prosa inedita “Piccoleprose per-morir un po’ dimeno”, nota di Laura Caccia
La musica della mente
Che la parola possa, nella sua eco che pare non avere fine, eternare il pensiero e la vita o, quanto meno, consentire di “morir un po’ di meno”, come recita il sottotitolo di Piccoleprose di Paolo Ferrari, sembra essere il filo conduttore del testo.
Parte di un’opera più ampia, in progress, indica l’autore in nota, a conferma di quell’assenza di finale, cum-Ausklang in-Absentia, segnalata in copertina, e del ripetersi di ETERNAMENTE, con cui sono titolati i 25 Quasimprovvisi che costituiscono il testo ridotto.
Nella stessa nota viene precisato come la partitura comprenda molteplici creazioni di neologismi. Parole composte, specifiche per ogni testo, presentate con due differenti caratteri: una prima parte, della stessa intensità del resto della scrittura, legata a processi consapevoli e razionali, e una seconda, di altra tonalità e diverso timbro, connessa a processi non consapevoli, inconsci.
Una parola duale, che intende amplificare in profondità il suo risuonare, evocando, nella “mentevoce”, l’apertura all’alterità, la pluralità dei significati, il volgersi in infinitudine, l’oralità musicante. E che chiama in causa il lettore, in quanto interprete di un dire sollecitante e aperto.
Ce lo conferma la parte di ETERNAMENTE, che risuona in ogni sottotitolo fino al suo musicare inconscio: quel/la “mente” che apre alla disposizione all’eternare e che si fa, insieme, pensiero e immagine, riflessione e finzione, specchio e simulacro, oltrevisione e parvenza, sconfinamento e sogno.
La parola di Paolo Ferrari ci conduce oltre la nominazione, forzando, con i suoi abbinamenti duali, la comunicazione ordinaria.
Una parola che muove sentimenti, echi inconsci, evocazioni sonore. Che si affida non solo al pensiero, ma soprattutto al risuonare interiore. I neologismi sono composti infatti da termini sequenziali, non oppositivi né inediti. Se non venissero uniti ed evidenziati dal diverso carattere, non si avvertirebbero infatti come tali. E solo l’intonazione, che richiede una diversa risonanza, una musica altra, da parte di scrittore e lettore, può consentire di dare loro voce: “Viene prima il pensiero o la musica?” si chiede l’autore, evidenziando “l’antisuono/antimusica che si appaia al gesto del pensare/pensaare: questo si apparta e la trascende, e da quella è trasceso”.
Spetta allora al lettore completare la partitura. Farne musica.




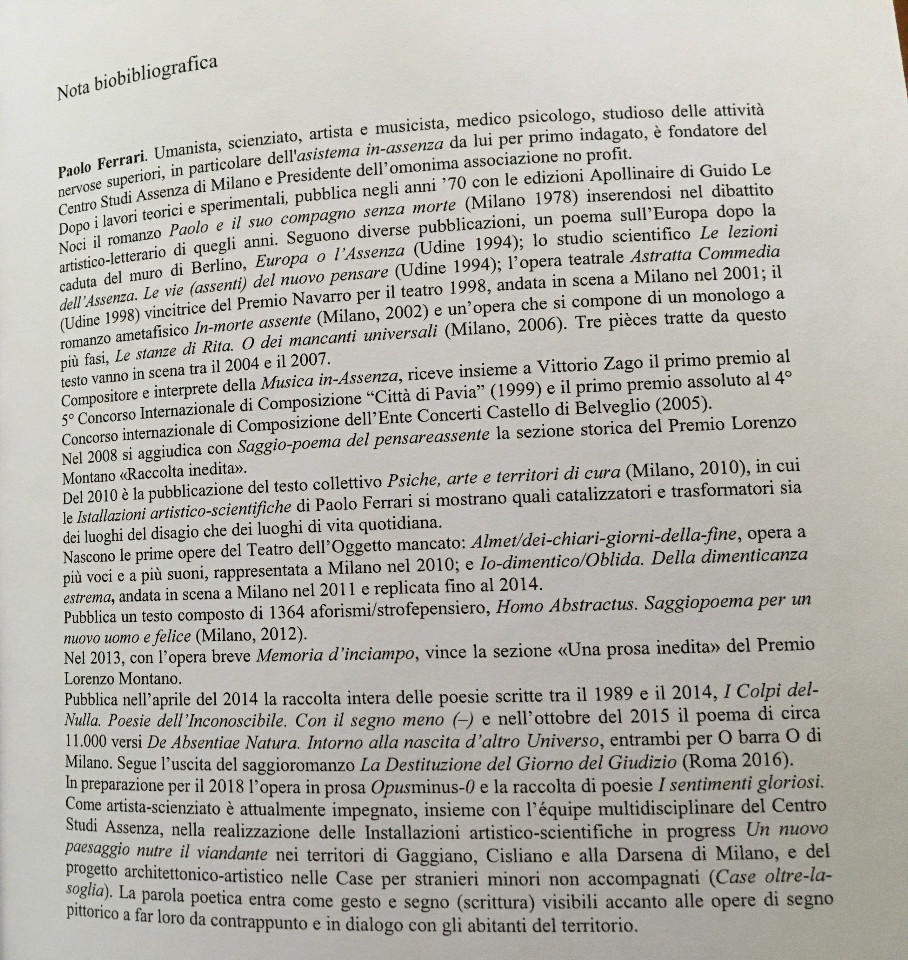
Marica Larocchi, dalla raccolta inedita "Polveri e piume", nota di Giorgio Bonacini
Entrare in questi versi è fare un viaggio in immersione ascensionale, in un’ interna esteriorità, similmente oscura e luminosa. Le profondità intime dell’umana natura rovesciate verso il cosmo interstellare. Antropologia cosmologica che trasborda l’intelletto poetico “ all’ istante nel chiostro di nebulose segrete”. Così, nelle parole in apertura di questa raccolta, l’autrice fa parlare le figure che agiscono nello spazio tumultuoso che osserviamo e ci contiene: stelle, telescopi orbitanti, programmi di ricezione spaziale, nebulose e teorie dell’ inizio e della fine.
Il tutto avvolto da una scrittura poetica dove lo sguardo immaginativo mette a fuoco e deflagra: poi fluttua, vortica, spezza e ricompone investigazioni labirintiche roventi d’estasi. In questo modo, Marica Larocchi, trasporta i versi dentro un poema che fa dello sguardo il suo propulsore significante. Proprio lì dove la natura della mente amplifica la visione e “ogni fulcro si connette”. La compenetrazione si espande e la voce interiore scava l’alveo nello stesso momento in cui scorre. Così la poesia che leggiamo è una corrente di figurazioni vocali senza sosta. Nervi e ritmi, sillabe e misteri del profondo vengono a galla con onde di sensi visivi e concettuali che danno al sintagma un sentimento inestricabile ma chiaro. E l’ approdo, pur controvoglia, potrebbe arrivare, nota l’autrice, con un’impetuosa zoppia di versi, ma senza per questo perdere vigore. Anzi, sboccia in curiosità e tenerezze lessicali, in cui una biografia minima di sè e della scrittura è figurata e trasfigurata in un riverbero di musica: sostanze di fonemi e pulsazioni dilatate. Dunque un mondo di poesia che ha senso in ogni suono.



Leandro, "Atto di dolore", Edizione Vigone Vecchia 2018, nota di Flavio Ermini
Siamo su una lunga strada che probabilmente ci porta al punto di partenza.
Siamo gettati in questa vita, osserva Leandro, guidati da un’ombra che ci precede.
L’ombra indica che c’è luce dietro di noi.
Quell’ombra dischiude l’esperienza dell’allontanamento, senza mai rivelare la fine del nostro errare.
Eppure una fine c’è; ed è data dalla metamorfosi di luce e ombra.
Una fine c’è; e costituisce un evento che fissa opacità e trasparenze, per trovare la forza di districarsi tra amore e “atto di dolore”.
Un sistematico linguaggio della sottrazione che trasforma ogni luogo attraversato o sorvolato in piani e volumi purissimi.





Nicola Licciardello, prosa inedita "Sempre", premessa di Mara Cini
E’ che le parole sono straordinariamente ingannevoli, sono paradossale concetto, sempre manipolabile.
E’ che con le parole si può giocare, un gioco un po’ inquietante, nel tempo della vita – la vita degli uomini s’intende –
dove il sempre, l’amore, l’eterno hanno qualche possibilità di dare un senso di vertigine.
All’illusorio sempre definitivo si accompagna un più “comprensibile” sempre storico o il sempre scorrente della natura, del ciclo delle stagioni, il mito dell’eterno ritorno.
La nostra è una forma provvisoria, è una memoria labile dove il sempre concettuale sbiadisce come un infinito.
Un SEMPRE graffito su qualche muro, tracciato con mano o utensile, visibile agli occhi, può durare un po’ di più.
Nicola Licciardello, saggista e poeta, ha tradotto da Gary Snyder, José Lezama Lima, Armando Romero, Cintio Vitier, Fina Garcia Marruz (La spada intatta di María Zambrano, Marietti 2007). Ha promosso performances collettive a Padova con l’associazione “Shunyata”, e pubblicato le raccolte poetiche Il Ballo Immune (Fermenti, Roma 1994), La gioia dell’impossibile (Sinopia, Venezia 2007), Padova un fiume di poesia (2011). Collaboratore di riviste trans-culturali quali “Angelus Novus”, “l’Immaginale”, “Dharma”, “Anterem”, “Poesia”, “Semicerchio”, “Viceversa” (Montreal), “Italianistica” (São Paulo) – alcuni suoi lavori sono presenti su You-Tube e Academia.edu. La “Rivista di Studi Indo-Mediterranei” (Università di Bologna) ospita i suoi più recenti saggi su Dante e la mistica indiana. Estasi.com (Mimesis 2016) è un volume di 400 pagine (100 foto in bianco e nero, indice dei nomi e glossario sanscrito) sui suoi viaggi in India e Tahiti.
Domenico Lombardini, dalla raccolta inedita "Fuori dalla città", nota di Laura Caccia
Nomi nuovi
Appaiono molteplici gli sguardi con cui Domenico Lombardini accompagna le sue meditate immersioni lungo l’arco temporale del vissuto nella raccolta Fuori dalla città, portandoci, tra apnee ansanti e respiri distesi, all’interno e all’esterno dell’ambiente urbano e insieme della realtà nel suo complesso.
All’interno: dove la città e un presente colmo di elementi sconcertanti vengono declinati in un testo fitto, senza pause, con un ritmo martellante e un finale accelerato, evidenziando tutta l’insensatezza consumistica dell’ineluttabilità cittadina: “Ché si dovrebbe ribaltare / Iniziar d’accapo / Emendare / Certi furiosamente / Almeno per evitare / Che tutto sia / Tutto / Senza scampo”.
All’esterno: dove l’infanzia e il passato, il paesaggio e il futuro vengono al contrario evocati in testi più brevi e dal ritmo disteso, a partire dalla premessa: “Fuori dalla città - nulla / Questo nulla è l’infanzia”, dove il fuori si configura come il luogo incorruttibile del primo vissuto e, insieme, come possibilità etica di delineare una realtà nuova.
Il tema della città che, nei suoi aspetti di degrado e di spersonalizzazione, ha trovato largo spazio nella poetica e nella letteratura a partire dalle prime urbanizzazioni, viene nella raccolta enfatizzato del contrasto con il fuori, dove “tutto si presenta senza pretesa / d’essere separato” e dove è possibile l’abbandono che la natura consente.
Il contrasto dentro-fuori appare però riguardare un ambito più ampio del rapporto urbano-extraurbano, in particolare quello tra il visibile e l’invisibile, in una riflessione che l’autore conduce sul mostrarsi delle cose, sull’apparenza e sull’essenza del reale: “Forse volevamo che fossero / Che esistessero: sii, ti prego, e dolcemente! - / Non fare che tutto sia come appare / Che tutto sia come sembra essere”.
Così come viene condotta una riflessione sul senso del dire, sulla necessità di trovare una lingua in grado anch’essa di farsi altro, di generare parole “più magma che pomice, / gettate perché nascenti”. E se, eticamente, il mondo chiede spazi nuovi, più umani, dal punto di vista del pensiero richiede una realtà altra e altri nomi, sorgenti e iniziali: “Si sta / nel continuo stupore / nella verginità nominalistica / di ogni cosa - / pure il silenzio del mondo / pretende nomi nuovi”.
Domenico Lombardini ci ricorda allora come la parola poetica debba continuamente tendere a farsi forza nascente, capace, di fronte all’esigenza di aprirsi ad un’altra realtà, di fondare “la nuova città / altrove” e di dare vita ad una lingua altra che riesca a pronunciare “sottovoce / il nome segreto della nuova città”.
***
Tu sei quel tempo immobile
Lo iato sospeso
Tra due estremi scoscesi –
La proiezione del presente
all’eterno, l’istante consumato
E ora viva presenza
Ma impostura, simulacro
***
Segni di vite aliene
Chimeriche trasfigurazioni
Quelle foglie setose
Cadute dagli alberi
Chissà come
Probabilmente perse
Come involucri da esseri
La cui assenza contemplavamo
Nell’attesa dell’epifania
Della loro forma metamorfica.
O forse ci ingannavamo
Forse volevamo che fossero
Che esistessero: sii, ti prego, e dolcemente! –
Non fare che tutto sia come appare
Che tutto sia come sembra essere
***
Ho fatto il vuoto
nella tecnologia –
nel passaggio al bosco
indebitamente è trascorso
troppo tempo
troppi passi non ben misurati
a separarmi dal riposo
o dal consumo
o dal lavoro
mi inselvatichiscono
e addolciscono e sciolgono
il pensiero antinomico –
tutto si presenta senza pretesa
d’essere separato..
***
Si sta
nel continuo stupore
nella verginità nominalistica
di ogni cosa –
pure il silenzio del mondo
pretende nomi nuovi.
***
Silenzio:
la semiosfera è collassata –
il gracidio
e questo suono senza nome
fondano la nuova città
altrove.
L’ecista nel sacello
ierofante analfabeta
velato capite
ha il lituo nella mano sinistra
e designa il pomerio e il mundus
e profferisce sottovoce
il nome segreto della nuova città.
Domenico Lombardini (Albenga, 1980), laureato in biologia, ha lavorato nella ricerca biomedica. È fondatore e proprietario di ASTW (http://www.a-stw.com/), agenzia di traduzione, scrittura e formazione. Si è occupato di giornalismo scientifico, filosofia, intervento culturale su quotidiani, riviste, blog letterari.
Pubblicazioni di poesia in volume:
Legenda (Fara editore, 2009 – antologia del premio; primo classificato); Economia (raccolta poetica; Puntoacapo editore, 2010); testi pubblicati nella rivista Trivio (n.1, 2013, a cura di Marco Berisso e Antonio Loreto. Antologia di poeti liguri e lombardi. Editrice Oèdipus); L’abitante (raccolta poetica, Italic Editore, 2015).
Premi:
Segnalato per la raccolta Matrici al concorso Montano 2010 di Anterem Edizioni.
Premiato con segnalazione alla XXIII edizione (2011) del Premio Nazionale di poesia “Sandro Penna”.
Premiato con Menzione d’onore al concorso Montano 2012 di Anterem Edizioni.
Premiato con Segnalazione per la raccolta inedita L’abitante al concorso Montano 2014 di Anterem Edizioni.
Marco Mioli, poesia inedita "MMXVIII", premessa di Ranieri Teti
C’è una geografia che può essere descritta solo da un poeta.
Forse è proprio la nostra, questa geografia: un luogo perduto che ha riferimenti altri.
Marco Mioli racconta la parte attiva della nostra consapevolezza, ponendo a tema da più prospettive
svariate condizioni che fondono, nel ritmo dei versi, pensiero e osservazioni.
L’autore pone a tema cose colte nel momento della loro debolezza, quando hanno ceduto le loro intrinseche certezze e sfumano nell'indistinto.
Eppure nel testo ci sono l’inverno, le nevi, le colline, l’alba, i tramonti. Ma tutto questo concorre a un poetico senza infingimenti, sotto l’impulso di un “tempo riflessivo”.
Tutto si trasforma sempre in altro, si deforma nelle metamorfosi, come ad esempio un accogliente e rassicurante lido, che diventa “il posto più lontano in cui essere”.
- MMXVIII
era stato l'inverno più piovoso di tutti
che non sta per vendetta
anche se ne ha la forma
in tempo riflessivo
il muso duro
non si scrosta
neanche con i saluti
niente
neanche con le grandinate
e le nevi
muta
ma almeno è un colpo
soffio di compressore
trattenere il carattere
fino a tirare dentro
quelle poche cose uscite
grammatica dell'omologazione
conforto dell'infinito noi
spruzzi di dio
le apprensioni materne
per i figli senza posto
la persistenza è una forma sghemba
una deformazione temporale
un sasso bianco pietra bianca
ricavata dalle colline vicine
i fori i trafori i sottopassi
le gallerie le funivie
le ovovie
districano rette parallele
che nemmeno euclide
che nemmeno l'alba i tramonti
le stelle
niente
cielo distrutto
per mancanza d'arcangeli
è come il lido
il posto più lontano in cui essere
l'italiano spalmato nel suolo
disperso
il passato è morto per sempre
come l'inizio di questa poesia
Marco Mioli (Montecchio Maggiore 1982) si laurea in Architettura presso l'Università IUAV di Venezia e successivamente studia Scienze e Tecniche del Teatro approfondendo una ricerca sulla relazione tra suono, spazio e scenografia.
Come critico d'arte ha pubblicato testi per artisti e mostre tra cui un'esposizione di arte contemporanea al Museo Archeologico di Napoli.
Le sue poesie sono finaliste al Premio Lorenzo Montano e al concorso Opera Prima.
Vive e lavora a Trissino (Vi) e Pola (Hr).
Umberto Morello, dalla raccolta inedita "Nuvolas", nota di Giorgio Bonacini
L’opera di Umberto Morello si apre fin da subito con una dichiarazione esplicita: il volo della mente è rondine che fatica a tenere a distanza la tempesta. Una scena che concentra in sé la sostanza di un attraversamento poetico verso un diverso livello di reale. In queste poesie, l’idea figurativa e concettuale della nuvola, che è simbolo di leggera pesantezza, porta senso e sensi dentro una nebulosa di microparticelle (logiche, cognitive, semantiche, emozionali, vocali) che ricadono a destrutturare e ricomporre i significati linguistici e immaginativi di chi “brilla fuori da quel nembo/impensierito”.
Lì dove contano le risonanze del sentimento che si fa amore oltre se stesso, al di là del ritmo che pure ne misura il passo. Infatti il verso, a un certo punto, si spezza e la sonorità della frase viene sostituita da una prosa distesa: non più nuvola di vapore parola per parola, sillaba con sillaba, ma di colpo in una ”pozza d’acqua”. Ma quando il racconto, nella sua piana modulazione, quasi autofigurativa, sembra andare verso l'esaurimento, la scrittura ritorna alla poesia, all’oscillazione del senso per incertezza di suoni, al vacillamento della voce, all'incostanza del corpo che scrive, in quell’altalenante esistenza linguistica a cui il poeta si affida. Perché il tempo del pensiero poetico, che ondeggia tra ciò che è stato e ciò che sarà, disaggregando il presente, riesce a far sentire la grana e l’attrito delle persone, dei pensieri, delle cose.
E’ questo lo stupore che la scrittura raccoglie in sé e dona: la meraviglia di meravigliarsi, che Morello espone e segna con precisione. Attento a ogni implicazione intima, e portando in superficie solo ciò che brilla nell’oscurità intensa. Perché l’abisso e la tenebra possono certamente essere luoghi in cui perdersi, ma trascinati non dalla paura, bensì da un desiderio speciale: il coraggio della felicità. E non per allontanare forzatamente il dolore e la tristezza, ma perchè nella mente poetica felicità e infelicità di sovrappongono per dare consistenza all’ incanto di chi sospirando salva l’infinito.
Nel Frattempo, la raccolta inedita “Nuvolas”, vincitrice del 32° “Montano”, è stata pubblicata nel 2018 da Anterem Edizioni.
Per un approfondimento con testi, notizia biografica e riflessione critica:
Riccardo Olivieri, "A quale ritmo, per quale regnante", Passigli 2017, nota di Flavio Ermini
Nella poesia di Riccardo Olivieri assistiamo alla condizione di un passato che lotta per trovare vita nel presente.
Ci viene segnalato che dietro il velo del presente c’è la memoria; ci sono i ricordi da rivivere; una realtà da cambiare.
La scrittura si fa densa al ricordo del padre. Segna un confine e deborda.
Si affaccia sull’impossibilità di rendere abitabile un sorriso che si è spento, uno sguardo che si annebbia.
La morte di una persona, soprattutto nel caso che la si ami, comporta la fine non di questo o quel mondo, ma di tutto il mondo, di tutti i mondi possibili.
È una ferita aperta, lacerante. È una lingua che separa e marca un limite invalicabile.
Dalla sezione Monte dei pegni
13.30
Istituto Bancario San Paolo
A quest’ora chiude
il monte dei pegni,
i tuoi segreti là
celati insieme
agli altri,
tutto un brillare
di lacrime
nei loro
tiretti-caveaux.
Sgombero
smontando i tuoi scaffali, gli anni
Casa crollata aperta
riaperta ferita,
rivista vostra vita
in ogni istante,
detesto il carteggio
che ho visto – anche dell’aspirante
suicida –
mi è tornato in volo tutto il monte allontanato,
tutto il nostro
– e prima vostro –
quarantacinquennio insanguinato.
Dalla sezione Abisso e la parola qui
Per Hermann Hesse
leggendo “La nevrosi si può vincere”
Tutta questa pioggia viene serenamente
come un fiore che si apre
Finalmente,
salendo le scale dice questo
al male
per mano,
l’altro lo lascia,
si rimpicciolisce,
sotto le gocce di tutta questa pioggia
forse
sparisce
***
Perch’io sono uno
a cui è stato fatto tanto male
perch’io son uno
ch’è poi almeno due,
e uno è il mio nemico primo.
Riccardo Olivieri, nato a Sanremo nel 1969, vive a Torino. Le sue precedenti raccolte sono: Diario di Knokke (prefazione di Davide Rondoni, "Poeti di Clandestino" , 2001, segnalata al Premio Montale), Il risultato d'azienda (con prefazione di Stefano Verdino, Passigli, 2006 - premi Maestrale, Città di Chieri e Antica Badia di S. Savino), Il disgelo (Raffaelli, 2008) e Difesa dei sensibili (con prefazione di Davide Rondoni e una nota di Massimo Morasso, Passigli, 2012). Numerosi anche gli altri riconoscimenti ottenuti, tra i quali il Premio Dario Bellezza e, nel 2013, il Premio Lerici Pea per la sezione dedicata alla poesia inedita).
Novembre 2019, anno XVI, numero 44

Tra Nadia Agustoni e Luca Vaglio sono compresi trentacinque poeti e prosatori di qualità, che si aggiungono idealmente a quanti sono stati presentati nei numeri scorsi e a quelli che usciranno nel prossimo numero che concluderà l’esperienza del “Montano” 2018. Differenti percorsi di ricerca si intrecciano in “Carte nel vento” 44, testimoniando allo stesso tempo la vitalità della poesia italiana contemporanea e l’impossibilità di una mappatura esaustiva: gli autori qui presenti rappresentano solo una validissima parte di quanto si produce oggi in Italia.
Tutte le note che accompagnano i testi proposti sono state realizzate dalla redazione di “Anterem”, a conferma dell’incessante lavoro che gravita attorno a questo Premio. Sono lieto di annunciare che dal prossimo anno la cura di “Carte nel vento” diventerà collettiva: sarà prodotto dall’intera redazione di “Anterem”, che coincide con la giuria storica del “Montano”. rt
In copertina: Aida M. Zoppetti, “A colpo d’occhio” (2019). Papier collé: stampa con sovrapposizione di materiali
Prima pagina: Marco Ercolani, "L’archetipo della parola" (René Char e Paul Celan), Carteggi Letterari, 2018


Partendo dalla fine di questo libro, di questo volume che è molto più di una nuova e precisa analisi a più voci, molto più di un atto d’amore collettivo per due autori che sono fondamenta e architrave del ‘900, Celan e Char, non si può non notare come l’epilogo non ne sia in realtà la chiusura, rappresentando invece un’apertura, racchiusa in una domanda che rimane sospesa. Questa domanda finale corrisponde a un ideale frammento di dialogo, convoca il pensare, chiede un sentire ulteriore, come tutto il libro. L’opera riprende, in nuove traduzioni, non solo testi esemplari dei due autori e alcune lettere, ma anche prove di saggisti che hanno scritto pagine decisive sulla loro poetica: notevole il recupero di questi materiali, per la maggior parte irreperibili, che Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Peter Handke e Peter Szondi hanno dedicato ai due poeti.
Marco Ercolani immagina coordinate inedite con un affiatato gruppo di visionari, saggisti (Antonio Devicienti, Giuseppe Zuccarino) e traduttori (Mario Ajazzi Mancini, Viviane Ciampi, Anna Maria Curci, Lucetta Frisa, Francesco Marotta, Pasko Simone) nella costruzione a specchio del volume, tracciando con paralleli e meridiani la mappa di un mondo irripetibile colto nel suo apice. Come scrive in premessa, “Due poeti, due amici, per i quali la percezione poetica è scheggia luminosa e disastro oscuro…”. Ecco, quando sembrava che tutto fosse stato detto e scritto su questi fondamentali poeti del novecento, una nuova luce illumina la scheggia e il disastro da diverse, e nuove, angolature.
Ranieri Teti
Nadia Agustoni, "I necrològi", La camera verde, 2017, nota di Flavio Ermini
L’essere umano ha umiliato il suo simile, degradandolo a mera cosa da possedere, sacrificandolo al profitto.
La fabbrica, così come si è rivelata nel Novecento, con le sue rigide, militaresche gerarchie, è ancora una realtà. Così com’è ancora una realtà la divisione in classi che impone agli ultimi di essere marchiati a fuoco come animali e incatenati l’uno all’altro.
Nadia Agustoni ci ricorda che vi possono essere luoghi in cui l’umano si estingue completamente, poiché nell’uomo c’è anche la possibilità di non risvegliarsi all’altro; c’è anche la possibilità del male più profondo.
Ecco una poesia che finalmente sottrae le umane esperienze all’aridità emotiva, all’indifferenza coscienziale, alla vacuità dell’estetico. Una poesia che ci invita a rifuggire da una comunità ridotta a mercato, dove gli individui sono degradati a un groviglio di interessi. Una poesia che si affida a una parola che non ha patria, né professione, né potere.
L’alba è coniglio
1
le parole sono l’alba. l’alba è coniglio. corre davanti all’auto. bestiola impaurita. manda avanti le gambe e il muso. tutto questo è qui. sono sveglio da tanto. prima le maniche del maglione alla bocca. il caffellatte. i biscotti. a volte il pane. mi arrangio l’uscita per il giorno. l’alba fredda a metà ottobre. ai morti avremo nebbia. senz’altro il vento delle montagne a tagliare il volto. 5,50 timbrato il cartellino. il cancello alle spalle. il corridoio al buio. luci si accendono di colpo. giacca e borsa nello spogliatoio. mi muovo. il corridoio al freddo. il reparto e le macchine. macchie scure cadono dal soffitto. dieci minuti. parte il rumore. il giorno è giorno tra tanti. succede in fretta quel vuoto senza parole. i gesti nel significato. non arriva nulla più in là di noi.
2
muovo da terra le casse. casse coi pezzi di ferro. diventano il ferro di altre macchine. pezzi lavorati. subito limati. il braccio fa gavetta da tanti anni. si impara a resistere. non più in là. la prima ora veloce. la seconda uguale. alle 8 il controllo. passano parole grosse. ingrosseranno di più. durante la mattina bisogna bollire col caffè.
3
le braccia abbiamo ferite. bruciature portate con magliette. siamo una pelle che ci sta dentro. alle 9 mi ricordo i mandarini la mela. il caffè lungo. o il the. nel the tanto zucchero. le macchinette del liofilizzato e quelle coi dolci. brioche a 60 centesimi di euro. al supermercato 6 con 1 euro e 20. oppure cioccolato. 1,50 il fondente di 100 grammi. la pausa dai 5 ai 7 minuti. la ritirata al gabinetto.
4
alle 10 le ossa. più o meno dolore. scricchiolo. il ritmo sale. calcolo dei pezzi appena fatti. il momento di accelerare. da una macchina all’altra. la fretta stringe il corpo a qualcosa. carichi e togli. ricarichi e limare. 4 per volta su una macchina. 8 su due macchine. le orecchie capiscono i rumori. le voci alte. arrivano a colpi. sentire parole intere no.
5
alcuni siamo italiani. gli altri non si sa sempre tutto. il pakistano non parla. si volta da un’altra parte. le ragazze berciano. alcune coi diplomi. lavorano qui contando di andarsene. una da 9 anni. veterana di tuta blu. i suoi capelli biondi. ci guardiamo. deboli per vivere. passa fino all’orlo della voce. passa e non si ferma.
Nadia Agustoni (1964) scrive poesie e saggi. Suoi testi sono apparsi su riviste, antologie, lit-blog. Del 2017 sono I Necrologi, del 2016 è Racconto Aragno, del 2015 Lettere della fine Vidya e la silloge [Mittente sconosciuto] Isola Edizioni; del 2013 è il libro-poemetto Il mondo nelle cose (LietoColle). Una silloge di testi poetici è nell’almanacco di poesia Quadernario (LietoColle 2013). Nel 2011 sono usciti Il peso di pianura ancora per LietoColle, Il giorno era luce, per i tipi del Pulcinoelefante, e la plaquette Le parole non salvano le parole, per i libri d’arte di Seregn de la memoria. Del 2009 la raccolta Taccuino nero (Le voci della luna). Altri suoi libri di poesie, usciti per Gazebo, sono: Il libro degli haiku bianchi (2007), Dettato sulla geometria degli spazi (2006), Quaderno di San Francisco (2004), Poesia di corpi e di parole (2002), Icara o dell’aria (1998), Miss blues e altre poesie (1995), Grammatica tempo (1994). Vive a Bergamo.
Angelo Andreotti, "A tempo e luogo", Manni, 2016, nota di Flavio Ermini
Il nuovo libro di Angelo Andreotti ha per titolo A tempo e luogo. Un luogo dove sono accatastate ombre di parole; un tempo che ci condanna a una solitudine per cui tutto è sempre di più o di meno.
L’essere dell’uomo diventa centro di esperienza vissuta. Esperienza non propria dell’individuo, ma dell’esistenza stessa.
Il poeta ci porta al cospetto di una storia della quale noi tutti siamo protagonisti, perché la natura diventa in noi visibile.
La natura è la grande unità dell’essere, rivela Andreotti.
Accettandone le leggi veniamo coinvolti in un movimento dello sguardo e del pensiero che si fanno forti di una logica che presiede all’insieme del mondo.
Divergenze
I
A oriente nuvole livide e gonfie
prese a pugni da un sole infuocato
sfondano l’aria montando sul vento.
Per ogni nuvola un passaggio di ombre
un variare di luci e colori
tutto un discorrere
un disegnare inesausto il paesaggio
questa casa
un risuonare di tempo eveniente
che sconfina dai bordi di ogni istante.
III
Le fondamenta sanno della terra
quello che il susseguirsi dei giorni ignora
ma di quell’enigma
che la forma di una crepa nasconde
niente viene svelato
e d’improvviso si fa inesplorato
qualsiasi luogo
anche quel sentiero
che mille volte abbiamo camminato.
Angelo Andreotti è nato nel 1960 a Ferrara, dove dirige i Musei d’Arte Antica e Storico Scientifici. Scrive narrativa, poesia, saggi su arti visive e letteratura.
Tra gli ultimi libri, le raccolte Parole come dita (Mobydick, 2011) e Dell’ombra la luce (L’Arcolaio, 2014), L’attenzione (Puntoacapo, 2019) alle quali fa da corollario la riflessione Il silenzio non è detto. Frammenti da una poetica (Mimesis, 2014), e i racconti Il guardante e il guardato (Book Salad, 2015).
Dino Azzalin, "Il pensiero della semina", Crocetti, 2017, nota di Rosa Pierno
Dino Azzalin svolge i suoi testi poetici sulla falsariga di parabole in cui ogni cosa viene ordinata “ciascuno secondo la sua specie: “ove l’amore è l’ordine superiore che tutto ammanta e lega”, che dona un legante simbiotico e fulminante: la corolla, dietro la vela, dove irrompe il lampo che illumina e scuote il largo, tutto riunendo nella medesima sorte.
Se non tutto si compie, resta comunque la speranza che la perfezione si possa raggiungere. Credere che il male si fermi sulla soglia ove fascio di spighe è il viso dell’amata al sole.
L’analogia si dimostra strumento con cui decifrare le differenze esclusivamente apparenti e lacerare il velo che cela il medesimo respiro (afflato) delle cose nel mondo. Lirico e raffinato, il testo poetico di Azzalin sfiora e unisce con una parola, offrendosi in dono.
***
La corolla si aprí al riparo
della gomena, dietro la vela,
dove irruppe all’improvviso
il lampo che illuminò il dono,
scosse il lago, ne respirò la sorte.
***
L’assenza è quasi sempre una scelta precisa.
Misura la distanza del ritorno, l’assoluta stasi
di una parola o di un niente che tace.
Matura un cielo da preda o una radice
piú fertile del nostro fragile esistere,
e ci nutre con la sua ombra, che ci aiuta
a sopportare l’attesa di una stella dal mare.
***
E tana fu la voce, densa a fondersi
nel cuore dove l’uno era anche
l’altro per l’imminenza dei gesti,
per la pioggia dei campi che disfa
e dissolve i corpi con odore di fango
senza piú ossa né carne, né alibi o singhiozzi.
Dino Azzalin (Pontelongo, PD, 1953) ha pubblicato I disordini del ritmo, introduzione di Cesare Viviani (Crocetti, Milano 1985), Deserti, prefazione di Mario Santagostini (ivi 1994), Prove di memoria, prefazione di Andrea Zanzotto, (ivi 2006). Del 2010 è la plaquette di testi in forma poetica Guardie ai fuochi, Edizioni del Laboratorio (Modena).
Nel 1999 ha pubblicato il libro di racconti Via dei consumati (Edizioni Ulivo di Balerna, Svizzera); nel 2001 il volume di report-viaggi Diario d’Africa, con introduzione di Alex Zanotelli (NEM, Nuova Editrice Magenta; nel 2007 Mani Padamadan (Viaggi di sola andata), (NEM, Nuova Edi- trice Magenta. Nel 2016, ha pubblicato i racconti Nel Segreto di Lei (Storie d’amore e di buio) (Edizioni ES, Milano).
Vive a Varese, dove esercita la libera professione di medico.
Nicoletta Bidoia, dalla raccolta inedita "Finiremo per trovarci", nota di Giorgio Bonacini
Il poemetto di Nicoletta Bidoia, incentrato sulla figura di Vaslav Nijinsky, è un esempio eccellente di come si possa far poesia intorno alla biografia interiore e alla dimensione estetica di un artista, che ha disincarnato l’umano sentire arrivando a guardare fin là dove solo una poesia vivente può arrivare: a vedere “il dolore che si imbosca nelle parole”. Dunque provare il segreto dell’oscurità attraverso un patimento reso muto dalla lingua, ma con la forza di una visione impetuosa. La voce di questo poemetto ha il suono che parte non dalla musica, ma dalla visività della danza: da un corpo e un sentimento irrefrenabili, dove il sollevarsi da terra è fatto della stessa sostanza che ha un prodigio: non il balzo, ma l’ascesa verso una forma d’esistenza fisicamente e cognitivamente sempre sospesa. Ed è questa la materia che la scrittura dell’autrice riesce a far aderire a una vita, che viene resa annullando il racconto, in favore di una moltitudine di sensi che ritmano nell’intimo del linguaggio; e lì si intersecano e danno alla significazione propria della poesia il cammino plurimo che potremmo definire biografia di una danza. Arte che opera non solo con l’evidenza del movimento, ma, più profondamente, cura il silenzio come suprema forma di parola e figura. Così il senso è messo a nudo, perdendo se stesso ma ottenendo, superando il significante della fisicità, di sciogliersi in quel niente che, come precisa Nicoletta Bidoia, “resta l’enigma dolente che strema”. Perché l’essere, come la poesia, non può interpretare se stesso, non è un personaggio. Può solo (ma con grandissimo valore) mostrare ciò che è in ciò che è: senza intermediazione alcuna.
***
Sono in corsivo nel testo le frasi di Vaslav Nijinsky tratte dai suoi Diari, nelle traduzioni di Gabriella Luzzani e Maurizia Calusio (entrambe per Adelphi).
I
ho la semplicità che hanno i cieli (Osip Mandel’štam)
C’era mia madre e la dura fame
e Bronja e Stasik, fratello folle,
in anticipo di poco sulla mia pazzia.
E c’erano i miei occhi tartari ‘giapponesi’,
i miei zigomi derisi, le carni isolate
dai compagni che staccavano dalle loro
le mie trepidazioni. Io piango tanto.
Io piango in maniera
da non dar fastidio a nessuno.
Già da allievo miracolavo nel salto,
perché se parto alla volta del cielo
è per restarvi a lungo a mezz’aria.
Non conosco altro azzurro
se non quando prolungo l’incontro
là in alto
e mi sospendo, vi penso, mi calmo.
E dopo ogni indugio
ritorno a quel fuoco, plano,
scendo in me
come un perdono.
(…)
Cupo, ottuso, dicevano, spaesato.
Non parla, non sa parlare,
balbetta. Ed è vero,
tacevo e in ogni tacere scandivo
la cantilena dei timidi,
i monosillabi di Dio.
II
Sono accusato di un crimine contro la grazia. Credo di poter ballare ‘graziosamente’ in balletti altrui se la grazia è richiesta, e potrei comporre balletti graziosi io stesso se volessi. Il fatto è che detesto la poesia convenzionale “dell’usignolo e della rosa”; le mie inclinazioni sono primitive.
Vaslav Nijinksy in ‘Daily Mail’ del 12 luglio 1913
In tanti cercano di scoprire il segreto dei miei salti, non si capacitano, parlano perfino di levitazione. “Vive in aria” dice di me il basso Šaljapin, “del tutto libero dai vincoli della gravità”, insiste Cocteau, che dietro le quinte cerca una meccanica nascosta dentro le mie scarpette che spieghi l’arcano e metta il cuore in pace.
A chi mi chiede come io riesca a saltare in quel modo rispondo: “Non è difficile, basta fermarsi un po’ in aria”. Vorrei però che fosse chiaro: io non sono un saltatore, sono un artista.
Poi mi vedono in Petruška, il burattino che si sente oppresso e che soccombe. Quando muoio in scena il mio spirito si libera sopra il teatrino della fiera e tormenta il mio aguzzino. Petruška è uno come me, non può far altro. Così per Stravinsky sono “la maschera d’attore più potente” e per Charlie Chaplin sono “ipnotico, divino”. Dio della danza infatti mi chiamano, ma non mi piacciono le lodi, non sono mica un ragazzino.
(…)
Nicoletta Bidoia è nata a Treviso nel 1968 e ha pubblicato i libri di poesia Alla fontana che dà albe, quasi una preghiera ad Alda Merini (2002), Verso il tuo nome (2005, con prefazione di Alda Merini), L’obbedienza (2008, con prefazione di Isabella Panfido) editi da Lietocolle, e Come i coralli (2014) con Edizioni La Vita Felice.
Nel 2013 è uscito per Edizioni La Gru il racconto Vivi. Ultime notizie di Luciano D.
Sue poesie, apparse anche in raccolte e riviste e più volte trasmesse a Rai Radio3, sono state tradotte in spagnolo in Jardines secretos, Joven Poesìa Italiana, a cura di E. Coco (Sial, Madrid, 2008).
Con la cantautrice Laura Mars Rebuttini ha realizzato lo spettacolo Un piccolo miracolo, partecipando ad alcuni festival italiani di poesia.
Compone anche collages e teatrini di carta (reperibili in rete su youtube o instagram): con alcuni di questi ha illustrato il numero 41 di “Carte nel vento” https://www.anteremedizioni.it/gennaio_2019_anno_xvi_numero_41
Simone Maria Bonin, "Tratti primi", Arcipelago Itaca, 2017, nota di Flavio Ermini
Simone Maria Bonin ci parla di un cammino ignaro del principio e della fine, tanto da celebrare – grazie alla parola poetica – l’incompletezza.
Tale produzione non si collega a dispositivi gerarchici, alla figura della legge, bensì viene colta come il vero e proprio continuum dell’esistenza.
È un commercio intimo quello che intercorre tra l’avventura umana e la lingua che la custodisce, un po’ come fa la macchina fotografica con i suoi scatti.
Insomma, nell’avventura della vita non si tratta tanto di commuoversi, di gioire o di addolorarsi; quanto di capire, di consentire a ognuno di noi di attribuire una cifra – la nostra – all’intimità e alla verità delle nostre vite.
***
Chissà poi cosa mai saprai di noi
tesi sottopelle ed elettrici di sangue
i bronchi a pezzi per ragioni esenti
da qualsiasi stasi di se stessi
Dalla sezione “Voyages”
(Uno)
I
A riva è il nostro posto
in questa colla di salmastro
dove
il mare aperto è corpo
distante dallo sguardo
Dalla sezione “Biopsie”
***
Da neurone a neurone
corre un filo elettrogeno
di fame
colpiscimi
se puoi, fammi male
prega altro dolore
un colpo di esistenza
tra le vertebre delle parole
***
Sei parole senza nome, senza
soluzione
impara la posizione del corpo
le cose
non torneranno più
Simone Maria Bonin è nato a Venezia nel 1993. È laureato in Matematica ed Economia all’Università di Warwick, nel Regno Unito, e prosegue gli studi specialistici ad Aarhus, in Danimarca. Ha vissuto diversi mesi, nel 2009, in Costa Rica.
Assieme a Gerardo De Stefano ha curato la collana di poesia "Rigor Mortis" di Thauma Edizioni pubblicando Atlantide: Poesie, Prose e Corrispondenze di Hart Crane, prima traduzione italiana dell’opera completa del poeta americano.
Collabora come traduttore con la rivista letteraria online 'Inkroci'. Suoi testi sono apparsi su "Nazione Indiana" e su "Poesia" (qui, con nota critica di Maria Grazia Calandrone).
Fabrizio Bregoli, dalla raccolta inedita "Logomachie", nota di Giorgio Bonacini
Fabrizio Bregoli presentando la sua raccolta all’insegna della disputa verbale, indirizza fin da subito il lettore dentro un solco metapoetico, fervido di implicazioni significanti, che portano senso emozionale e intellettivo contemporaneamente. E la lettera scientifica, che ne punteggia il percorso, è sostanza in più, intrinseca a una precisa e vasta modulazione poetica. Il dire si riempie di una voce che fa brillare “elettrodi”; portare a modulazione scelte lessicali di un sapere senza cesure; “frequenze interferenti” liberano il sintagma in una corrente che dà alla voce poetica “la pienezza del fulmine”. Ma il linguaggio è materia misteriosa, riesce a potenziare i mille canali di un significato, che vorrebbe essere univoco, anche inabissandosi nel silenzio, ma senza, per questo, annullarsi. Però ciò non toglie, rileva l’autore, che nello spazio e nel tempo del poema ci si possa perdere: in sommovimenti magmatici o scavi carsici che potrebbero far collassare la concettualità e l’ immaginazione. Ma in questi testi ciò non accade, perché il pensiero è tenuto insieme da una natura concreta: scarnificata e visionaria. E il tutto dentro un corpo che più che fare poesia della scienza, si fa scienza di poesia: dunque lingua materica. Lì dove l’andamento produce i suoi limiti e li supera in continuazione, con un moto “denso” in “compiuta curvatura”. Dentro queste poesie i numeri accadono: e così le rime e le assonanze che intrecciano visibilità, ritmo e geometria. Fabrizio Bregoli non chiede alla poesia il disvelamento di sé, ma lascia che il suo cammino errabondo inciampi, per poter scoprire anche la precisione “di ciò che non si compie.”
***
Sempre e solo un’ipotesi, un respingere
laterale, come fosse un intruso
a porgere la mano, osare spazio.
Esige questo, uno scendere a patti,
la sua sintassi opaca, risoluta.
Basta poco sai, quella macchia sghemba
che s’arremba alla pelle, come un fiordo
buio appeso alle labbra. O un affiorare
lento, come da una radice antica,
di un conto che non torna,
un ammutinamento delle cellule.
Perché in fondo sai, siamo quest’estrudersi
del corpo, ambire a senso, direzione
a una misura che si compie.
Ardire un passo in più, un verso oltre.
Dalla sezione “Apostasia di Nikola Tesla”
I.
Differenze di potenziali, elettrodi
come baratri tra parola e buio.
Servirebbe forse crederli grumo
materico, qualcosa
di elementare, una tavola pitagorica
un’acqua di Talete. Verbo
che solo nel non dirsi si sa dire.
III.
Eludere lo spazio. Ed abusarne
farne mezzo, ricettacolo d’onde.
Plasma. Elettroni come arche, globuli
minimi di campo. Eppure lo pensi
ordine questo accrescersi di formule,
quest’ambire a norma, a processo ergodico
reticolo di geometrie variabili.
Vi potresti smarrire. Potresti dirlo Dio.
IV.
Sinusoidi. Modulate armoniche,
frequenze interferenti in fase, fronti
d’onda che propagandosi s’assommano,
eludono zeri e vuoto. Forzieri
d’energia, vettori di significato.
Nοῦς. Limes d’un sapere antico, prossimo.
Fabrizio Bregoli, nato nella bassa bresciana, risiede da vent’anni in Brianza. Laureato con lode in Ingegneria Elettronica, master in Marketing, lavora a Seregno nel settore delle telecomunicazioni.
Ha pubblicato alcuni percorsi poetici fra cui “Cronache Provvisorie” (VJ Edizioni, 2015 – Finalista al Premio Caproni) e “Il senso della neve” (puntoacapo, 2016 - Premio Rodolfo Valentino 2016 e Premio Biennale di Poesia Campagnola 2017, Premio della Critica al Dino Campana 2017, Finalista ai Premio Gozzano, Merini, Caput Gauri). Ha inoltre realizzato per i tipi di Pulcinoelefante la plaquette “Grandi poeti” (2012).
Sue opere sono incluse in Lezioni di Poesia (Arcipelago Itaca, 2015) di Tomaso Kemeny e in numerose altre antologie. Con il poemetto ENIAC è inoltre incluso in iPoet Lunario in versi (Lietocolle, 2018).
Il suo ultimo lavoro è "Zero al quoto" (puntoacapo, 2018) con prefazione di Vincenzo Guarracino.
Partecipa a letture poetiche, dibattiti culturali e blog di poesia. Ha preso parte ad alcuni eventi di azione poetica mito-modernista e alcune sue poesie sono state esposte congiuntamente a opere pittoriche in eventi organizzati dall’associazione Civico32 a Bologna.
Ha conseguito numerosi riconoscimenti per la poesia inedita, fra i quali gli sono stati assegnati i Premi San Domenichino, Marietta Baderna, Lino Molinario, Daniela Cairoli, Giovanni Descalzo, Eridanos, Piemonte Letteratura, Terre di Liguria, Il Giardino di Babuk, il Premio “Dante d’Oro” dell’Università Bocconi di Milano, il Premio della Stampa al Città di Acqui Terme.
Sulla sua poesia hanno scritto Giuseppe Conte, Tomaso Kemeny, Ivan Fedeli, Mauro Ferrari, Sebastiano Aglieco, Vincenzo Guarracino, Laura Caccia, Laura Cantelmo, Eleonora Rimolo, Paolo Gera, Alessandro Ramberti, Gian Piero Stefanoni, Alfredo Rienzi.
Davide Castiglione, poesia inedita “Domantė”, premessa di Ranieri Teti
Quale elemento di un testo porta più con sé il piacere di leggerlo, ma soprattutto di rileggerlo?
Il senso, il ritmo, quel sapiente enjambement, la musicalità dei versi ogni tanto interrotta da voluti inciampi, l’architettura verbale, una filigrana di narrato che innerva la materia poetica, la visione, l’esattezza e l’accostamento dei termini, il “tu” che pervade l’opera dal primo verso “Sei inseparabile dai giorni freddi” all’ultimo “lucina fioca io, e tu, candela”, alcune dissonanze, l’uso del monologo?
Me lo chiedo perché sono tutte caratteristiche che ho trovato in “Domantė”.
L’uso del monologo, nella qualità del testo, è impreziosito dal passaggio da “io” a “tu”, evidenziato nella terza parte da un distico superiore, quel “lo so benissimo / che mi hai vista guardarti”: qui parla Domantė e la sua libera affabulazione corrisponde a un’ideale risposta, indiretta, alle prime due parti in cui parla l’autore.
A questa tripartita poesia di Davide Castiglione si continua a tornare volentieri; a ogni ritorno il testo offre qualcosa di inedito, come, ascolto dopo ascolto, un brano musicale.
Sembra invece cinema, con la tecnica del flashback, l’inizio della seconda parte: la neve di un oggi che ricorda la neve di un allora, con i passaggi verbali tra presente e passato che rappresentano i cambi di scena della macchina da presa.
Tutto è così tangibile e insieme così toccato da un’idea compositiva precisa: c’è una sorta di traccia narrativa, ci sono elementi quasi dialogici, scarti temporali, emergono frammenti di memoria, le situazioni sono allo stesso tempo verosimili e trasfigurate, con gli strumenti e dalla sensibilità dell’autore. Ma soprattutto non c’è manierismo, manca completamente il già sentito, la riproduzione di stilemi già conosciuti: l’evoluzione poetica di Castiglione gli ha fatto prendere le distanze dai suoi riferimenti iniziali. Ci troviamo dentro un’apertura, in un nuovo territorio.
Domantė
I
Sei inseparabile dai giorni freddi,
dal demone del modello che grava
di un rimprovero per sempre le labbra
inesplose. No, hai sorriso, ridi,
questa risacca amara la ricacci
indietro come uno scialle. Ti ho chiesto
copri gli occhi, così, scoprili adesso,
fai lo stesso con la bocca, si affacciano
a ogni giravolta del sipario
il pieno e lo stelo, la carne e il suo contrario.
II
Ci sono questi fiocchi in adunata,
lenti, distanziati. Come il cugino
quando spianava ai parenti la strada
che all’estero lo raggiunsero uno
per uno, s’incendiano sul cappotto,
uno scheletro ciascuno e risplende
immortale, incistato nelle pieghe,
primeggiando sul feltro che sta intorno.
Come faccio a tenerti viva se
t’investo così. Come fai, a disfarti
dei violini svenevoli di noi altri –
e di mio, dello sporco dominio di una frase.
III
nulla tu nulla tu nulla tu nulla
leggilo come vuoi cioè a tuo favore
questo mio osceno equilibrio il ponte
è crollato e certo, certo che sulla
questione ci hai preso, la storia dello
squarcio prospettico mentre tenevi
banco insegnando e con un pennarello
difendevo quel paesaggio di stevens
in un cuore acceso. Lo so benissimo
che mi hai vista guardarti, gli occhi fissi,
ma chi te lo dice che non ti stessi
soppesando i difetti, i compromessi
dell’aiutarsi a vicenda, ridicolo,
continua a pensarti questa radiosa
potenza nella mia vita, no dico,
calmo apollo, lucina fioca fioca,
perlina stavi per, volevi dirmi,
di una luuunga collana come la
sistemiamo ormai? forse, se ti fermi,
lucina fioca io, e tu, candela.
Davide Castiglione (Alessandria, 1985) è attualmente docente di materie letterarie e linguistiche all’Università di Vilnius in Lituania. Si è laureato a Pavia con una tesi su Vittorio Sereni traduttore da William Carlos Williams, e dottorato a Nottingham (Inghilterra) con una tesi sulla difficoltà linguistica e cognitiva nella poesia angloamericana. Ha pubblicato articoli scientifici su riviste accademiche internazionali (K. Ladygos street 5, flat 61 LT082-35, Vilnius Lithuania Semantics» e «Language and Literature»), gestisce un sito personale che ospita letture di altri «Strumenti critici», «Journal of Literary poeti e ha co-fondato il progetto collettivo di critica poetica In realtà, la poesia. Sue poesie sono state pubblicate su varie antologie e riviste, tra cui «Poesia» (con una nota di Maria Grazia Calandrone). È inoltre autore di due raccolte poetiche: Per ogni frazione (Campanotto, 2010; segnalata al Premio Lorenzo Montano 2011), e Non di fortuna (Italic Pequod 2017).
Rossella Cerniglia, prosa inedita “I miti e la Dichtung heideggeriana”, nota di Flavio Ermini
Ci sono saggi che impongono al lettore non un semplice ascolto, ma un coinvolgimento intellettuale ed emotivo tale da spingerlo verso ulteriori, inedite riflessioni.
Questo è il caso del testo filosofico “I miti e la Dichtung heideggeriana”.
L’autrice, Rossella Cerniglia pone – con Heidegger – una domanda fondamentale: «Che cosa ci chiama al pensiero?», inducendoci in tal modo a formulare una seconda domanda: «Che cosa fa a noi appello, inducendoci a pensare e, così, in quanto pensanti diventare quello che siamo?».
Porsi queste domande significa mettersi di fronte alle intemperie del linguaggio; significa portarsi in mezzo ai flutti e lì, tra le righe, rischiare il naufragio; vuol dire prendere atto che l’alfabeto non è una scialuppa sufficiente se si lascia addomesticare dalla cronaca.
Rossella Cerniglia ci invita a restituire alla parola il suo albale vigore, affinché torni in grado di nominare e farci apprendere qualcosa del mistero che circonda l’umana esistenza, della nostra sete di verità. Non assegna alla sola filosofia il compito di una costruzione necessaria del mito d’origine, bensì rimette nell’inseparabilità il compito del poetico e il dovere del pensiero filosofico.
Non basta che l’uomo apostrofi le cose con il loro nome perché esse siano afferrate nel processo della rivelazione. È necessario che il nome sia attinto dal sottosuolo della storia – dove ancora sono presenti le archai – affinché l’essenza delle cose giunga a espressione. E cosa ci dicono questi nomi? È esplicita, a questo proposito Rossella Cerniglia. In questi nomi c’è «l’essenza del linguaggio e della realtà che esso esprime, e pertanto dell’essenza stessa». Non c’è un prima – in sé uno e unitario – e poi un uscire da sé, e riversarsi nel molteplice. L’essere resta uno e unitario, fondamento dell’esserci di tutte le cose.
I miti e la Dichtung heideggeriana
I miti dell'antichità classica esprimono una condensazione di significati in immagini di rara forza e bellezza e danno testimonianza del momento aurorale della nostra riflessione in cui pensiero e canto, filosofia e poesia, vivevano un'unica vita.
É stato Martin Heidegger a prospettare l'esistenza di una struttura archetipica del nostro linguaggio, di un'archelingua, che costituirebbe la radice comune del Pensiero e del Canto. Essa ci appare come un sostrato nel quale, appunto, pensiero e canto - come avviene in qualche misura nel mito- convivono e si intrecciano tra loro inscindibilmente. In altri termini una struttura portante della nostra esistenza dalla quale dipende la nostra interrelazione e interazione col mondo.
Nella postulazione heideggeriana, Pensiero e Canto, vale a dire filosofia e poesia, si condensano in questa originaria matrice che è la Dichtung, e in essa coabitano, hanno un rapporto intrinseco, dialogante, che si esplica nel linguaggio. Nella Dichtung i due elementi vivono non scissi, e solo a posteriori sarà possibile considerarli separatamente.
Tale concetto è parte di quell'evoluzione del pensiero di Heidegger dopo Essere e Tempo, che è insieme svolta ontologica e tentativo di sostituzione di quel linguaggio con cui la metafisica aveva impostato la questione dell'essere, la Seinfrage. Ed è nel saggio Holderlin e l'essenza della poesia, pubblicato nel 1937, che Heidegger formula una nuova concezione dell'essere connessa ad una precedente impostazione del problema della verità: la concezione dell'essere come evento cui si collega il ruolo ontologico del linguaggio.
Per Heidegger, infatti, “ciò che prima di tutto è, è l'essere”. La parola evento, viene in tal modo a designare l'originaria reciproca appartenenza dell'uomo e dell'essere: l'uomo infatti non è senza l'essere e l'essere non di dà senza l'uomo. All'interno di tale originario evento sono possibili, poi, tutti gli altri accadimenti della storia umana che è, manifestazione dell'essere, storia attraverso cui l'essere, storicizzandosi, si manifesta.
“Nella dimora dell'essere abita l'uomo- dice Heidegger - e i pensatori e i poeti sono i custodi di questa dimora. Il loro vegliare è portare a compimento la manifestatività dell'essere; essi, infatti, mediante il loro dire, la conducono al linguaggio e nel linguaggio la custodiscono.”
Nel pensiero originario, cioè nel mito, i due poli della dell'archelingua heideggeriana vi si riscontrano - come abbiamo detto - intimamente connessi, e in essi si realizza quell'aprimento dell'essere che non appare mai in una luce costante. Il suo disvelarsi è, infatti, analogo a una istantanea illuminazione che subito torna a nascondere ciò che ha mostrato perché il mostrarsi della verità, quello che gli antichi greci chiamavano aletheia, si dà in un continuo nascondersi e rivelarsi che non ha fine. Per quel che concerne più propriamente la poesia, essa permette l'aprimento dell'ente “in ciò che esso è, e nel come è; e nell'opera (d'arte) è in opera l'Evento (Geschehen) della
verità. In essa, la verità dell'essere opera attraverso il linguaggio per il suo disvelamento.
In altre parole, in questa lingua originaria, archetipica, la filosofia viene a coincidere con la poesia poiché entrambe, unitamente, operano per svelare, attraverso la parola, il senso dell'essere, la sua verità. Ma tale svelamento, secondo Heidegger, non dipende dalla volontà dell'uomo. Non è, infatti l'uomo a parlare, ma il linguaggio stesso -e per suo tramite l'essere- che parla attraverso
l'uomo.
Tuttavia, nel suo stare a fondamento di pensiero e canto, filosofia e poesia, che si esplicano nel
linguaggio, la Dichtung li trascende entrambi poiché ogni pensiero e ogni canto non potranno mai ricomprenderla e riaffermarla interamente. Essa rimane – come si è detto - nel pensiero/canto e nel linguaggio che li esprime, in un Nascondimento che mostra o in un Mostrarsi che nasconde. Ed è qui l'essenza del linguaggio e della realtà che esso esprime, e pertanto dell'esistenza intera: essa vive nell'ombra di questo Nascondimento che accenna a se stesso senza mai interamente svelarsi nella sua Luce. E in tal modo ci si presenta come inesorabilità del trascendente - ma non nel senso che Heidegger aveva combattuto, di quel metafisico che apre allo sviluppo incontrastato della téchne, bensì come distanza e diversità dall'ente, cioè per la sua natura ontologica e non ontica. In tali termini esso ci appare come connaturato alle modalità di essere dell'esistenza e riconfigura il problema dell'Origine dove l'aporia insormontabile è costituita dal fatto che qualunque tentativo facciamo per raggiungerla vede l'Origine arretrare nel suo Nascondimento e porsi Oltre, sempre al di là dell'umano orizzonte.
Le grandi interrogazioni degli scienziati, al giorno d'oggi, mi pare vertano proprio su questo punto nodale, il primo e il solo punto indagato nelle lontanissime origini del pensiero stesso. Ed è questa la riprova dell'impronta teleologica che mi pare rinvenire nell'universo, come se un logos interno, un pensiero immanente ad esso ci indirizzasse all'Oltre, in un processo di Immanenza/Trascendenza che rimane la radice dell'Universo stesso. Infatti, comunque si attui questa ricerca, sia che parta da un'indagine sul suo fondamento, sia che parta dalle cose stesse, dall'essere o dall'ente, essa conduce sempre ad additare un Oltre, che si colloca, irrimediabilmente, al di là delle coordinate esistenziali, come se il fondamento dell'esistenza di fatto, e delle facoltà interpretative con le quali ci orientiamo in seno ad essa, fosse quel limite dal quale l'Essere-nascosto accenna a se stesso senza mai rivelarsi.
Inevitabile torna, perciò, il parallelismo tra Immanenza/Trascendenza e tra il linguaggio umano e l'archelingua heideggeriana, la Dichtung. Infatti, nel pensiero di Heidegger, essa appare come sostrato immanente sia al Pensiero che alla Poesia, e d'altra parte, vivendo essi nella sua luce senza mai identificarsi con essa (che rimane inattingibile e nascosta), la Dichtung sembrerebbe additare la sua stessa trascendenza.
Il rapporto Immanenza/Trascendenza, sarebbe poi, tradotto in altri termini, il rapporto che lega parallelamente e dialetticamente l'Esistenza all'elemento che la trascende e che ad essa si impone,
che per quanto ci adoperiamo a negarlo, sempre risorge, sempre accenna a se stesso in quel Nascondimento/Disvelamento che gli è proprio. Ma tale rapporto, che a noi si mostra come parallelo e dialettico, verrebbe ad esprimere una Identità, una eguaglianza fondamentale poiché, solo nello iato che è l'esistenza, l'Immanenza/Trascendenza, -ovvero il Nascondimento che si disvela e il Disvelamento che in se stesso si ritrae nascondendosi- si mostrano come distinti.
Rossella Cerniglia è nata a Palermo, dove vive. Laureata in Filosofia è stata a lungo docente di materia letterarie nei Licei della stessa città. La sua attività letteraria ha inizio con la pubblicazione di Allusioni del Tempo (con presentazione di Pietro Mazzamuto), ed. ASLA – Palermo 1980; seguono Io sono il Negativo (con prefazione di Nicola Caputo), ed. Circolo Pitrè – Palermo 1983; Ypokeimenon (con introduzione di Elio Giunta), ed. La Centona – Palermo 1991; Oscuro viaggio, ed. Forum/Quinta Generazione – Forlì 1992; Fragmenta (con introduzione di Giulio Palumbo), Edizioni del Leone – Venezia 1994; Sehnsucht (con prefazione di Maria Grazia Lenisa), ed. Bastogi – Foggia 1995; Il Canto della Notte (con nota critica di Ferruccio Ulivi), ed. Bastogi – Foggia 1997; D’Amore e morte, stampato a Palermo nell’anno 2000; L’inarrivabile meta (con prefazione di Elio Giunta), ed. Ila Palma – Palermo 2002; Tra luce ed ombra il canto si dispiega (antologia e studio critico comprendente anche i testi di altri quattro autori palermitani, a cura da Ester Monachino), ed. Ila Palma – Palermo 2002; Mentre cadeva il giorno (con introduzione di Giorgio Barberi Squarotti), ed. Piero Manni – Lecce 2003; Aporia (con prefazione di Salvo Zarcone), ed. Piero Manni – Lecce 2006; Penelope e altre poesie (con prefazione di Pietro Civitareale), ed. Campanotto – Pasian di Prato 2009. Nel giugno del 2013, per l’Editore Guido Miano di Milano, ha pubblicato un’Antologia che propone un breve saggio delle prime dodici sillogi poetiche, con disamina di Enzo Concardi. Infine, essendo risultata vincitrice, per l'inedito, al Premio “I Murazzii” di Torino, nel 2017, le è stata stampata l'ultima sua raccolta di versi Mito ed Eros – Antenore e Teseo con altre poesie.
Per quel che riguarda la narrativa, nel 1999 ha pubblicato il romanzo Edonè...edonè, ed. La Zisa di Palermo; nel 2007, ancora per l’editore Piero Manni di Lecce, viene stampato il suo secondo romanzo dal titolo Adolescenza infinita e infine, per l’Editore Aletti di Villalba di Guidonia, il libro di racconti Il tessuto dell’anima. L'ultima pubblicazione è il saggio “Riflessioni, temi e autori”, tra le tre opere premiate a “I Murazzi” 2018 “con dignità di stampa”
Collabora o ha collaborato con alcune riviste, tra cui“Vernice”, Alcyone 2000 e a giornali on line LinkSicilia, Palermomania, meridionews, e attualmente con la Casa editrice Guido Miano di Milano ed altre rivista ancora. Ha ricevuto favorevoli riconoscimenti e attestazioni da parte di numerosi critici e letterati ed è stata premiata in diversi altri concorsi letterari. Suoi versi e profili critici sono presenti in antologie e riviste
letterarie, tra cui L’Altro Novecento (vol. II e III) a cura di Vittoriano Esposito edito da Bastogi, 1997; nella rivista Poesia dell’editore Crocetti di Milano; in Poeti scelti per il terzo millennio (2008),in Storia della Letteratura italiana (vol. IV, (2009) e in Poeti italiani scelti di livello europeo ( 2012), dell’Editore Guido Miano di Milano; più recentemente in Il rumore delle parole ed. Edilet, 2014, e in Come è finita la guerra di Troia non ricordo, ed. Progetto Cultura, Roma, a cura, entrambi, di G. Linguaglossa, e più volte sulla rivista telematica L'Ombra delle parole, diretta dallo stesso G. Linguaglossa.
Maria Benedetta Cerro, "Lo sguardo inverso", LietoColle, 2018, nota di Flavio Ermini
L’esercizio della riduzione al precategoriale per giungere al primo principio è alla base della ricerca poetica di Maria Benedetta Cerro.
Inevitabili, dunque, l’abbandono dell’opinabile e la liberazione dall’incantesimo dell’ovvio.
Diciamolo: qui si tratta di superare la crisi di astinenza dalla verità.
Ci hanno fatto credere che un secondo principio non fosse fattibile.
Ebbene, Lo sguardo inverso contraddice questa credenza.
E dall’oltre di un dire sorgivo ci parla della perfezione di un incontro.
Della sacralità di un colloquio che si trasforma in canto.
Dalla sezione “Il dire sorgivo”
***
Ci ordinò di corrispondere
perché eravamo inconsolati.
E riprese a pulsare la vena
dell’abbandono.
Il cielo neutro della parola
manifestò il suo dire sorgivo
e il lutto
fu animato dalla meraviglia.
Lui – il nodo del fenomeno
e del tutto – ci concesse il dettaglio
capitale che mutò lo sguardo.
***
La cucitrice di bocche
siede nel frastuono.
Il remoto e ciò che spera di venire
attraversano il filo che infilza le parole.
Tolto il senso
il suono
il sussurro
non resta che togliere il pensiero.
Allora ti sarà ridata la bocca
la cantilenante nenia dei pazzi.
***
Tu mi dici “terrifica e infelice”
io sono schiuma che brulica sui rovi.
Mi fu dato il conoscere
e il ritorno.
Dico il muto abisso
di cui posseggo chiave e profezia.
Maria Benedetta Cerro è nata a Pontecorvo e risiede a Castrocielo - Frosinone
Ha pubblicato: Licenza di viaggio (Premio pubblicazione “Edizioni dei Dioscuri” 1984); Ipotesi di vita (Premio pubblicazione “Carducci – Pietrasanta”, Lacaita 1987), nella terna dei finalisti al “Premio Città di Penne”; Nel sigillo della parola (Piovan 1991); Lettera a una pietra (Premio pubblicazione “Libero de Libero”, Confronto 1992); Il segno del gelo (Perosini 1997); Allegorie d’inverno (Manni 2003), nella terna dei finalisti al Premio Frascati “Antonio Seccareccia”); Regalità della luce (Sciascia 2009); La congiura degli opposti (LietoColle 2012), Premio “Città di Arce”; Lo sguardo inverso (LietoColle 2018); La soglia e l'incontro (Edizioni Eva 2018).
Gabriella Colletti, prosa inedita “Il paesaggio e lo sfondo”, nota di Rosa Pierno
Immaginare come si dia il passaggio dal nulla a qualcosa, come da esso si formino le prime note, le prime forme, larvali, ma poi sempre più tenaci, le quali, attraverso metamorfosi, si sviluppano fino a comporre un tema musicale. Sì, perché è questo il tema della prosa di Gabriella Colletti “Il paesaggio è lo sfondo”: la musica. La scrittrice indaga tale formazione, ma per far questo deve creare visivamente lo stato antecedente, quel nulla abissale che tutto sembra inghiottire. Quel nero nel quale tutto sparisce e che ci minaccia. La musica, però, la sua eternità, non si contrappone solo al nulla, ma anche alla storia umana, tanto precaria quanto infarcita di orrori. In tal senso, la storia, con il suo tempo e la morte, si contrappone anch’essa a tale sfondo infinito. Si viene, però, a formare un interregno tra la storia e lo sfondo, che l’autrice denomina ‘regno intermedio dell’armonia”, regno dell’arte, il quale consente all’umano uno sguardo neutro, privo di paura, come quello animale. Per la Colletti, l’arte è il regno della soluzione delle contraddizioni. Ecco la ragione della felicità che nasce dell’armonia.
Il paesaggio e lo sfondo
(…) nel rumore, percepito distintamente, d’ogni
singola onda che si frangeva, nella sua nitida
dolcezza, c’era qualcosa di sublime.
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, volume IV
“Giustizia è tutto,” disse “giustizia è la prima cosa,
giustizia è l’ultima. Chi non lo comprende morrà”.
Hugo Von Hofmannsthal, La mela d’oro e altri racconti
Ci sono fili che vanno e tornano, elementi affini
che devono incontrarsi. Chi separa commette un'ingiustizia.
Chi sceglie una sola parte dimentica che da essa sempre
si ode imprevisto il suono del tutto.
Ci sono gruppi di fronte a gruppi, i congiunti sono separati,
i separati congiunti. Tutti appartengono l'uno all'altro,
e ciò che di loro è il meglio si trova tra l'uno e l'altro:
ed è istantaneo ed eterno, e qui è il luogo della musica.
Hugo Von Hofmannsthal, Il Cavaliere della Rosa
Già, "il suono del tutto"… come l'eterno fragore delle onde che s'infrangono sugli scogli, l'eterno mormorare del mare, il suono della conchiglia appoggiata all'orecchio. Una voce indistinta in cui si fondono altre voci, da sempre, da quando è nato l'universo, e forse prima, dal momento in cui esso era solo progetto, ipotesi, possibilità nella mente di Dio. Antico suono primordiale, respiro, ritmo, palpito sempre simile a se stesso da quando è nata la Terra. Voce di amanti in un amplesso senza tempo che continua a ripetersi. Gli amanti cambiano; l'atto, il suono, l'armonia rimangono identici. Solo la declinazione, la sfumatura, cambia. Come nella melodia, gli infiniti sviluppi del tema musicale. La dimensione fluida della musica assomiglia forse all’Eterno, indicibile a parole, eppure percepibile come suono, in certi rari istanti di grazia. L'arte della musica proviene dall’Eterno. E l’Eterno è lo sfondo. Che la musica sia, forse, il respiro che lo sfondo emana? Esso è orizzonte imprendibile, vasto, infinito per l'occhio dell'uomo, di un bianco abbagliante. Insostenibile, dolorosa, accecante, quella luce. E’ come se si fissasse il sole. Spaventato, l'uomo chiude gli occhi. Li ritrae dall'orrido baratro di quel nulla, ma esso li inghiotte da dentro. E in luogo della luce abbacinante spalanca il desolato velluto buio della notte. Così smisuratamente grande deve essere lo spazio cosmico interstellare. Silenzioso, gelido, senza tempo né Storia. Non è così per l'animale, il cui sguardo innocente e a-morale guarda nell'Aperto spazio bianco, quello sfondo musicale, e non c'è paura in lui, né gioia. Solo neutro e muto guardare. Guarda e niente si domanda, nessun perché lo arrovella. Guarda, l’animale, e cosa vede? Forse, il compenetrarsi di cose le une nelle altre senza interruzione. Cose che, se separate, potrebbero fare paura, ferire, uccidere. Cose che si compenetrano senza spazi definiti, senza contorni netti. Le disarmonie diventano armonie. Le forme si fanno sempre più fluide e mosse, fino a divenire informi, ectoplasmi, fantasmi di forme, simulacri. Figure in perenne metamorfosi. Possibilità come sviluppo di un tema musicale in molteplici, inesauribili sfumature, come solo la melodia sa fare.
L'arte della musica unisce ciò che alla ragione umana sembra opposto e inconciliabile. Davanti allo sfondo dell'Eterno, proprio lì davanti, in primo piano, scorre la Storia. E’ un corteo di orrori, di violenze e ingiustizie, la Storia. Nessuna mano d'uomo o d'angelo può fermarla. Lei prosegue, avanza da sola, e pare danzare. Esegue la propria danza brutale che è guerra. Una guerra in nome della felicità, cui spesso si è dato l’epiteto di “santa”. E si continua così ancora oggi, con gli inganni dei nomi, mentre quello esatto sarebbe solo uno: egoismo.
Lo sfondo si intuisce fuori di noi, quando non si è immersi nella routine della vita. Quando ci si ferma a riflettere su se stessi, lo spazio, il tempo e l'anima, sul passato e il suo fondamento, sul futuro e la sua meta, sul presente che ciascuno è con la propria identità. È in quegli istanti di confusione e smarrimento che lo sfondo riappare come potenza che impaurisce. Riappare dentro di noi, assumendo la forma fluida di un non-colore che in sé tutti li contiene e li annulla: il nero. Nero velluto dello sfondo, eterno nero di un'interminabile notte senza inizio né fine, senza Storia, senza il familiare susseguirsi del giorno alla notte. Lo sfondo sta dentro di noi, povere creature della Storia, che portiamo dentro l'eterno sfondo senza tempo. Esso ci appare come la morte. Quella fessura che lascia passare l'Eterno, ma in verità, come lui, essa è già tutta dentro di noi. E abbiamo un bel tapparci occhi e orecchi per non vederla, non sentirla. Allontaniamo la morte, correndo via da lei con distrazioni. Poveri illusi. Noi, che non vorremmo sentirla, le apparteniamo, e lei ci appartiene custodendoci. Occultiamo la morte e occultiamo lo sfondo. Poveri illusi.
Tanto più il paesaggio del nostro mondo e della nostra storia è piccolo quanto più ci sentiamo al sicuro, tranquilli nel nostro adorabile, meschino guscio di lumaca. Tra il paesaggio dai contorni netti in primo piano, che è la Storia, e lo sfondo infinito ed eterno che sta dietro, proprio in mezzo, si estende il regno intermedio dell’armonia. Tra il paesaggio in primo piano e lo sfondo c'è l'arte, ogni arte. Dimensione fluida in cui l'artista, come l'animale, esce da sé e guarda con occhio puro e neutro, non umano, dritto nell'Aperto. Egli non ha paura. Rapito e assente da sé, è dentro le cose. Si sente schiacciare dal peso della natura e tuttavia si percepisce leggero. Nuvola informe e cangiante, egli assume ogni parvenza. Possiede e gode di tutte le forme: onda e nuvola insieme, acqua e aria. L’artista entra con l'arte nella dimensione dell'armonia. Qui, i contrasti non sono più stridenti ma fusi insieme misteriosamente. Le contraddizioni si accordano fra loro. I separati ingiustamente dalla Storia, gli assolutamente inconciliabili, si ricongiungono nel giusto accordo. Il risultato di tale prodigio, a chi sa guardare e ascoltare, è solo felicità.
Gabriella Colletti è nata a Milano l’11 marzo 1967 e vive a Trecate (Novara). Nel '98 ha pubblicato il saggio Piccola Guida al Broletto di Novara (Millenia Edizioni, Novara). Nel 2004 ha pubblicato il volume Cento poesie del cuore (Nuove Scritture, Milano). Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo La nostalgia dei girasoli (Manni Editori, San Cesario di Lecce), grazie al quale ha ottenuto svariati riconoscimenti, tra cui: Finalista del Premio Internazionale Mario Luzi 2014/2015 – Sezione “Premio Italia”; Premiata, nella Sezione narrativa edita al Premio “Poesia, Prosa e arti figurative” Accademia Internazionale “Il Convivio” Castiglione di Sicilia (CT) 2015; Menzione di merito al Premio Letterario Sirmione Lugana 2015 Sezione narrativa. Menzione d’onore alla 41° Edizione del Premio Letterario Casentino "Sezione Giuseppe Frunzi" – Editi. Prima classificata al Premio Letterario di poesia e narrativa “Città di Arcore” – Anno 2016.
Nel 2016 ha pubblicato la raccolta di poesie L’occhio al papavero (C.A.SA. Edizioni, Saronno-Gallarate).
Silvia Comoglio, poesia inedita "Lucore", nota di Rosa Pierno
Il lucore dovrebbe essere la condizione di possibilità di un vedere diverso. Che cosa è possibile osservare in tale rarefatta condizione di visibilità? Che cosa si possa intravedere in una flebile luce, quando sia questione tutta affidata alle parole, è impresa da far tremare i polsi: la traduzione di due incertezze o, meglio, il passaggio da un’incertezza a un’altra. Il sogno, l’eco non sono tanto la marca dell’irrealtà, quanto di una dimensione altra, in cui la percezione è fluttuante, non può fissare nulla in maniera definitiva, è mobile come uno stormo. e lo stormo a sua volta “divora l’occhio / col suo mondo”. Nel testo, Comoglio opera un capovolgimento che riguarda anche la struttura sintattica. La visione trasforma radicalmente le cose e le loro relazioni: una piuma la si può vedere come un contrafforte, l’impronta può mostrarsi più integra dell’essere che l’ha generata. Il linguaggio non corre dietro alle parole, ma lo presentifica, fondendosi con uno sguardo che sprofonda.
Lucore
preséntami il prodigio,
il lucore ferito al mondo
dell’ultimo cristallo
a zú-folo d’argento
*
lucore ―
in meta di fluttuante
eco a primo sogno
è l’imbocco, a umana casa,
dove, lo stormo, divora l’occhio
col suo mondo, veloce,
di leggenda : asterso contrappunto
in cordata a finta luna
dove, è piuma, schiusa a contrafforte
l’impronta voltata intatta, rá-
strellata a fiore
Silvia Comoglio (1969) è laureata in filosofia e ha pubblicato le raccolte di poesia Ervinca (LietoColle Editore, 2005), Canti onirici (L’arcolaio, 2009), Bubo bubo (L’arcolaio, 2010), Silhouette (Anterem Edizioni, 2013), Via Crucis (puntoacapo Editrice, 2014), Il vogatore (Anterem Edizioni, 2015 – Premio Lorenzo Montano – XXIX Edizione - Sezione raccolta inedita), scacciamosche (nugae) (puntoacapo Editrice, 2017).
Nel 2016 ha scritto per The small outside di Gian Paolo Guerini Piccole variazioni, concerto apparso a puntate sulla rivista on-line Tellusfolio e pubblicato nel 2017 su L’almanaccone impertinente (LABOS Editrice, 2017)
Per Il vogatore è stata composta nel 2015 una partitura dal compositore e pianista Francesco Bellomi e per Via Crucis nel 2016 sono stati realizzati quindici disegni dall’artista Gian Paolo Guerini.
Suoi testi sono apparsi nei blog “Blanc de ta nuque” di Stefano Guglielmin e “La dimora del tempo sospeso” di Francesco Marotta; nei siti www.nannicagnone.eu, www.gianpaologuerini.it e www.apuntozeta.name, sulle riviste “Arte Incontro”, “Il Monte Analogo”, “Le voci della luna”, “La Clessidra”, “Italian Poetry Review”, sulla rivista giapponese “δ” e nelle riviste on-line Carte nel vento, Tellusfolio e Fili d’aquilone.
E’ presente nei saggi di Stefano Guglielmin Senza riparo. Poesia e Finitezza (La Vita Felice, 2009) e Blanc de ta nuque, primo e secondo volume (Le Voci della Luna, 2011 e 2016), nell’antologia Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta (puntoacapo Editrice, 2012) e nell’opera di Marco Ercolani Annotando (La Biblioteca di Rebstein, 2016)
Morena Coppola, "Sgorbie e Misericordie di Fratelli Elettrici", Formebrevi, 2017, nota di Flavio Ermini
Una turbolenta scrittura riesce a esprimere compiutamente ciò che resta non detto.
Evoca l’arrivo di un ospite inatteso che ci permette di fare esperienza del rumore dei passi dell’essere stesso, seguendolo nella sua peregrinazione.
Il luogo è il sacro paesaggio nella patria stessa del linguaggio.
Il passo è di colui che è più prossimo alle origini e, dunque, all’orizzonte del destino umano: il poeta.
La cadenza del passo si ode nella fugacità del tempo, nell’angustia dello spazio, nella limitatezza delle forze.
Ci parla del futuro, delle sue possibilità e dei suoi pericoli.
Abacuc portava un cappello di rame
Abacuc portava un cappello di rame
All'inverno ossidava nel verde
poi, allo sguardo del caldo,
Riprendeva il rossore.
Timidezza furiosa del santo.
Thòlos
Uno scuro aleggia
fra tempi e e colonne
Buio compensa i vuoti
rastrema il niente verso il nulla
e discolora il Nihil.
Nell'arenaria il Bruno accattone s'incanala
Manca luce nel tempio
e sul monte la meteora spupilla.
Parabola del Cranio o del Dodecaedro
Testa sul tavolo
scisso corpo lasciato in ormeggio
Non trasuda la Medusa
e pure ne mangia la murena.
In atelier Giacometti
mette zampe alla testa,
la scanna nel bronzo e poi dice
Pater!
Ha cercato dodici facce
dai contorni biaccati
per tendere l'arco dell'angolo acumen: il Sogno di una Testa.
Post acuzie selvatica dentro la testa
Morena Coppola vive a Roma. Si interessa di scritture non convenzionali e di arte contemporanea. Sul crinale verbo-visuale, sperimenta linguaggi innestati nel visivo, accomunandone sguardo e lingua. Un suo testo accompagna l'immagine xilografica dell'artista Andreas Kramer per le Edizioni PulcinoElefante [2008]. Segnalata più volte al Premio Lorenzo Montano, [2013 sezione Una poesia inedita; 2014 sezione Una prosa inedita; 2017 sezione Raccolta inedita; 2018 sezione Raccolta edita]. Alcuni testi sono pubblicati in raccolte antologiche [Empiria 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018]. Nel 2016, in occasione della pubblicazione di Avrei fatto la fine di Turing, di Franco Buffoni, uno scritto critico relativo alla raccolta è stato pubblicato sul sito del poeta. Ha curato la post- fazione de Il criterio dell'ortica di Stefano Mura, edito dall'Editore Manni nel 2016. La raccolta poetica Sgorbie e Misericordie di Fratelli Elettrici, finalista al Premio Bologna in Lettere, edizione 2017, segnalata alla XXXI edizione del Premio Lorenzo Montano, è risultata vincitrice del Premio letterario Formebrevi Edizioni, 2017. Finalista al Premio letterario Bologna in lettere edizione 2018. La raccolta Psychopompï è stata selezionata alla IV edizione del Premio Elio Pagliarani, sezione Inediti, edizione 2018.
Anna Maria Dall’Olio, una poesia inedita "Homo videoludens", premessa di Ranieri Teti
Un ciak dell’autrice-regista fa azionare la macchina da presa, tutta linguistica, come se fosse in presa diretta con un pensiero: un primo piano di sibilanti e di “o” introduce il set, lo spazio generativo verbale in cui agisce l’”Homo videoludens”, dove “la sostanza non è reale”.
La sapiente regia passa a un piano americano quando introduce, in francese, l’elemento ludico del titolo. Anche se a ben guardare il testo è tutto un piano sequenza che continua a tornare su se stesso, in loop, dove a ogni ripresa o ritorno d’immagine emergono nuovi particolari.
E così si coglie nel terzo verso quel “si” insistito “sì simile simulacro” come se fosse un’invocazione o un successo del videoludens, e, in un successivo, ulteriore sguardo, quel “s’annuvola” che “s’avvolge in voluta”: da un totale a un frammento, dal celeste a una spirale di fumo; un rovesciamento di sineddoche. Anna Maria Dall’Olio produce un testo che coniuga inestricabilmente senso e linguaggi.
Homo videoludens
Sspazio
steso lungo tempo che gocciola denso
sì simile simulacro librasi
libero liberamente
anema e core
(torna a terra!)
la sostanza non è reale
è visivo/virtuale
pure il sistema è particolare
reticolare!
Fuor da sé jouer non fa per tre
s’allontana
si discorsivizza
si banalizza
ruolo è dato
il gioco si gioca il jouer
mondo è mutato
loop s’avvita s’avvince loop
natoperfetto ora s’annuvola
s’avvolge in voluta di riflesso
pianto di luci fatto liquido
fiore petroso schiuso al dentro
Anna Maria Dall’Olio è laureata in Lingue e in Lettere, esperantista, si è dedicata alla narrativa, alla poesia e alla scrittura drammaturgica.
Ha curato una rubrica sul mondo esperantista per “Incontrosaperi” e ha collaborato al periodico “Kontakto”, con una recensione su Il dolore di Giuseppe Ungaretti.
Ha partecipato a 4 edizioni della Fiera “Più libri più liberi” di Roma e alla 1a edizione del “Festival internazionale delle Letterature” di Milano. Nel 2018 ha vinto il 3o premio del Concorso internazionale “FEI” per la traduzione in esperanto di “Su una sostanza infetta” di Valerio Magrelli. Nel 2005 ha vinto il 2o premio del Concorso internazionale "Hanojo-via Rendevuo", patrocinato dal governo vietnamita, accanto a molti altri riconoscimenti ottenuti in Italia nel corso della sua carriera.
La sua pubblicazione più recente è Segreti (Robin, 2018), preceduta da: Sì shabby chic (La Vita Felice, 2018), L’acqua opprime (Il Convivio, 2017), Fruttorto sperimentale (La Vita Felice, 2016); Latte & limoni (La Vita Felice, 2014), L’angoscia del pane (LietoColle, 2010), 20 poesie nella rivista “Calamaio” (Book editore, anni 2009 e 2011) e Tabelo (Edistudio, 2006), dramma in lingua esperanto. Recensioni e articoli di critica sono stati raccolti in Le sirene di cartone di Anna Maria Dall’Olio (Editrice Totem, 2017).
Antonella Doria, poesia inedita" In questa estate che…", premessa di Ranieri Teti
Lungo una mediterranea mappa ideale, lungo meridiani del disincanto, vivono e si affollano similitudini e forse solitudini imperlate dai colori del mare e del cielo.
In questa poesia tutti gli elementi sono compresi: acqua, aria, terra e anche fuoco, rappresentato dal sangue, dai corpi caldi.
Al di qua dell’orizzonte qualcosa rimane sospeso nella temporalità, lungo una rotta percorribile nei due sensi: il viaggio di andata dei “corpi clandestini” incrocia quello di ritorno di un “uccello migratore”, tra acqua e aria, tra paradiso e inferno, mentre tutti probabilmente cercano solo il purgatorio di “tante affioranti terre”.
Nel dolente canto del poeta, nella “pietà dei giorni”, Antonella Doria ci propone una ballata tristemente civile, linguisticamente felice.
In questa estate che…
(Lampedusa 2000)
Capita a volte
in un agosto come questo
con il cielo azzurro
corpi clandestini in
vortici di verdiblu cristalli
danzano una danza circolare
per strade d’acque poi si
perdono del grido dimentichi
di gabbiani da terre di promesse
d’esilio lontani … lontani
da corpi caldi a la deriva
dove dolore dove speranza
è spazio di paura nella
consistenza dei giorni
Capita a molti in questa
estate che non finisce sempre
più spesso accade a chi
portapeso di sogni assordanti
libertà infinite lascia che
lo porti un mare d’orizzonti
o una fatamorgana
sicuro s’allontana … ma
non è mare di deserto non
suono di terre d’arenaria
di pianure odorose rose
o melodia candida di
ciliegi … accade a chi
affiora a la fine dei giorni
Capita sempre più spesso
in questa fine d’agosto a chi
incerto dello sfolgorio del mare
sotto un cielo volubile va …
(la luna è testimone )
uccello migratore in cerca
di parole terre utili che
l’acqua muove sulla scia
di sogni … servono idee
a guadagnare il paradiso
tutto tutto l’inferno fra
le tante affioranti terre
sopra i luoghi e le cose
nella pietà dei giorni
Capita a volte accade
nell’assoluta evidenza di questa
estate che finisce … una via
improvvisa s’apre sanguigna
a ovest … a chi … dimentico
di quel che tiene nuvole
accese una capriola fece
leggera come da bambino
e … (lo prese al volo al petto
sua madre …) nella casablu con
la sua onda più profonda così
per ogni giorno che nasce nell’alba …
(Una corrente sottomarina
Gli spolpò le ossa in sussurri. )*
Domani – 31 Agosto - giorno normale
È previsto - pioverà sul mare
***
Milano – Giugno / Agosto 2013
----------------------
*T.S. Eliot, La Terra Desolata, Einaudi 1998
Antonella Doria, siciliana di Palermo, formatasi per studi a Siracusa, è laureata in Scienze Sociali. Dal 1970 è a Milano dove lavora ed elabora il suo progetto poetico. Oggi vive fra Milano e la Liguria.
Presente in riviste italiane e straniere e in diverse antologie fra cui Poeti per Milano-una città in versi, a cura di Angelo Gaccione (viennepierre ed. 2002) e Poesia a Comizio, a cura di Marcello Carlino e Francesco Muzzioli (ed. Empirìa 2008), è statavincitrice, finalista e segnalata in alcuni premi letterari, fra cui il Lorenzo Montano di Verona.
Ha pubblicato: Altreacque (Book Ed. 1998); medi terraneo (1995 -1999),Primo Premio per l’Inedito Il Porticciolo, Sestri Levante 2004 (Ibiskos Ed. 2005); Parole in Gioco (AA.VV. s.i.p. 2005); Metro Pólis (ExCogita Ed. 2008); Millantanni (edizioni del verri 2015). Il 30/4 e il Primo Maggio 1999 organizza a Milano, presso la Tenda Bianca del Comitato per la Pace, una due-
giorni di Concerto di Poesia contro la Guerra, e cura quindi l’antologia -Poesia contro Guerra - (Ed. Punto Rosso 2000, 2007 ampl.) con nota di Dario Fo.
È curatrice della sezione di Poesia della Mostra Internazionale d’Arte: Per una “Carta” visiva dei diritti civili (cat. viennepierre, 2001) organizzata da “LIBERA, associazioni nomi e numeri contro le mafie”. Condirettrice/redattrice della rivista Il Segnale – percorsi di ricerca letteraria; è stata redattrice di Inoltre (JacaBook ed.), rivista di antropologia, società e cultura.
Nell’ottobre 2005 è a Lisbona con la delegazione di poeti italiani, insieme con Alberto Mori e Andrea Rompianesi, in occasione della Settimana della Cultura Italiana nel Mondo.
Nel 2015 è invitata dalla Dott.ssa Jennifer Scappettone del Dipartimento di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’ Università della Pennsylvania (USA) a partecipare alla PennSound Italiana - Archivio della Poesia Italiana Contemporanea.
Fa parte dell’Associazione Casa della Poesia al Trotter di Milano.
Patrizia Dughero, dalla raccolta inedita "Sensibili all’oblio", nota di Giorgio Bonacini
Il titolo di una raccolta di poesie dice molto di più della sua evidenza letterale, e Sensibili all’oblio, di Patrizia Dughero, non è solo l’ indicazione di un percorso, ma è esso stesso un cammino di ricettività e conoscenza, di richiamo a un gesto linguistico che unisce delicatezza e graffio, quando “il sussurro si trasforma in urlo”. Una scrittura che scava negli eventi che sembrano scomparire dalla memoria o che si perdono nel silenzio o che vengono oscurati da una dimenticanza. Così la lingua di questa poesia cerca di dare parola a bocche ammutolite; di trovare pensiero nell’umiltà del verbo imbiancato; di riportare al senso l’ultima foglia. E tutto questo senza descrizioni o didascalie del dramma, ma solo attraverso la voce poetica: unica in grado di superare, e forse anche di richiudere, il varco tra oblio e perdono. E’ di grande valore una scrittura che pone al centro delle sue diramazioni il recupero delle “parole delle lacrime”: per evitare che il dire vada perso in quell’amnesia duratura che appanna la mente e i sensi. Perché le figure umane, che hanno vita in questi testi, soffrono la crudeltà di un potere che maltratta e uccide, non solo corpo e mente, ma vuole annientare nell’oblio una memoria esistenziale che, precisa l’autrice, è in se stessa sconfinata. Patrizia Dughero, con grande lucidità di pensiero, voce e sentimento, ci rende partecipi di una perdita del significato: una sottrazione violenta, uno smarrimento strappato, una perdita a favore di un significante, che avrebbe consistenza di senso, se non fosse dilapidato e reso fantasma. Perché (ci dice con parole che non hanno bisogno di commento) “non c’è madre se non c’è figlio:/è il figlio che significa la madre;/.../la madre il cui figlio viene fatto desaparecido./Si getta dal significante, si trasforma/nello spettro di ciò che fu...”.
I Passaggio
QUESTO È UN VERO MOVIMENTO
I giornata
Si disse di un manipolo di persone tra poeti e artisti,
qualcuno lo può ancora raccontare, se crede; già si può
scrivere della bottega dove s’avverano trasformazioni.
Qualcuno ha visto bisturi e cazzuole, pennelli d’ogni misura
ordinati come i barattoli e le tele, accantonate dalla cartavana
ridipinta in bianconero, nella resa che accende la poetica stabilità.
Qualcuno ha deciso di non dire niente, godendo la serata come uno
spettacolo, mentre qualcuno imbraccia la propria arma, foss’anche
un cellulare spento, adattato a richiamare la memoria ai posteri
che forse saranno, mentre qualcuno vede già quel che è il ricordo
e vorrebbe decifrarlo, e lo fonde con quel muro crollato, all’angolo
della via che non riconosciamo più. Il falso movimento
porta pagine vuote, quelle di chi ci vuole bene e di chi
ce ne ha voluto. Non le accartocciamo, sostituite da tavole rosa
di legno buono, non consentiranno di cincischiare con la morte.
II giornata
Qualcuno decida di spargere una polvere più che cinerina, che sappia
di fumo più che di nebbia nella notte. Iniziamo dall’altalena, basterà
un po’ di polvere per intervenire. I contorni delle figure di luce, incatenate,
chiedono sia soave paesaggio a intervenire, coi grigi che sappiamo,
si staglierà nel sogno, un paesaggio lieve che liberi, posato con la grazia
di chi inforna il pane, dispensata la lievitazione come si conviene.
La delicatezza è la polverizzazione che accorre dopo i graffi dalle spatole,
a pulire, sempre pulire il senso, insieme alle grida garrule, che non ci
stupiscono più, ci vuol ben altro, quando il sussurro si trasforma in urlo e
risuona nella via. Dove andiamo pittore? Dove stanno andando
le tue figure divergendo dalla luce, non precipitate, ma accolte,
attendono un movimento vero, che pure la nebbia diradi.
Patrizia Dughero, di origine friulana, è nata a Trento e si è laureata in Arti visive all’ateneo di Bologna, dove tuttora risiede. È presente in numerose antologie, di racconti, di poesie e con testi di prosa poetica in cataloghi d’arte. Sette le sillogi poetiche pubblicate: nel 2010 Luci di Ljubljana e Le stanze del sale, nel 2011 Canto di sonno in tre tempi, nel 2013 Reaparecidas, nel 2015 Filare i versi, nel 2016 Canto del sale, nel 2017 L’ultima foglia. Attualmente la sua attività si concentra su articoli e progetti editoriali. Da qualche anno sta svolgendo studi sul linguaggio poetico dello haiku, culminati in articoli, progetti didattici e nella raccolta Filare i versi / Presti verze, tradotta in sloveno da Jolka Milič. È stata capo redattrice della rivista “Le voci della Luna” e collabora con l’associazione per il “Premio Giorgi”. È responsabile editoriale di 24marzo Onlus, associazione attiva sui diritti umani, sul tema dei desaparecidos e la Rete per l’Identità. Nel 2012 ha fondato con Simone Cuva la casa editrice qudulibri.
Maria Grazia Galatà, "Quintessenza", Marco Saya Edizioni, 2018, nota di Flavio Ermini
L’annuncio di Maria Grazia Galatà coincide con il portare allo scoperto l’essere, ma non più al modo della metafisica, bensì come un cammino che chiama ed esige un dire finito, esiliato nella sua finitezza; anche e soprattutto quando progetta col pensiero il tratto di fondo del mondo abitabile.
Poesia come comprensione della vita, quella di Galatà. Poesia che implica una forma di vita e dà forma alla vita. Una migranza che impone una capillare analisi del mondo contemporaneo con un preciso riferimento al presente e a una sua lettura, diciamo così, socio-politica.
L’annuncio di Maria Grazia Galatà si affida qui al diario di bordo di un approdo dopo il naufragio.
***
che il silenzio rimanga
tra la porta della quinta
essenza o un tramite
dell’incandescente
la mira delle speranze
nella ripetizione di un
singolo respiro
***
la migranza dei nostri sogni
o l’affaticamento
di un silenzio ambrato
all’ora giunta
quando il ricordo era più forte
di un improbabile ritorno forse
il luogo delle ombre e un grammo
di vana fertile coscienza
la traccia silenziosa
di una città sospesa
***
Sospensione
non era che svilimento
del vuoto e il senso tattile
dell’abbandono
nello sradicamento del se
diverso
o tempo inverso
misericordia
ha cecità ataviche
aldilà della muraglia
Maria Grazia Galatà, nata a Palermo, da molti anni vive ed opera a Mestre Venezia; presente in numerosi siti web e cataloghi d’arte internazionali; fotografa da diversi anni sempre nella ricerca; 2002 partecipazione ad “underwood”, ad Ascona insieme ad altri nomi illustri della poesia contemporanea: Mario Luzi, Fernanda Pivano, Edoardo Sanguineti; 2003 ha editato il libro “Congiunzioni”, con fotografie di Costantino Spatafora, presentato da Francesca Brandes al “Bistrot de Venice” in Venezia; lo stesso libro è stato presentato in videoproiezione nel 2004 da Marco Nereo Rotelli all’Accademia di Belle Arti “Santa Giulia” di Brescia: Liliana Ugolioni e il Prof. Brunelli all’antico caffè “Giubbe Rosse” di Firenze: Gio Ferri alla galleria “DARS” di Milano; 2005 all’Istituto Romeno di Cultura di Venezia, propone una raccolta di tredici poesie “La struttura dell’ansia” accompagnata da due strumentisti, Luca Callice e Marco Agostini rispettivamente al Bendhir al Didyeridoo, con l’intento di avvicinare i giovani alla poesia; 2005 ha preso parte, in occasione della 51° Biennale di Venezia, all’evento “La notte dei Poeti” di Marco Nereo Rotelli con Ana Blandiana ed altri poeti di fama internazionale; 2005 partecipa con un’opera in collaborazione con Costantino Spatafora all’evento “Padiglione Italia” 13x17 curata da Philippe Daverio ed edito alla fine del 2007 da Rizzoli; 2006 è stata segnalata, tra le opere edite, al "Premio di Poesia Lorenzo Montano"; 2007 a giugno reading presso la fondazione Querini Stampalia di Venezia presentata da Marco Nereo Rotelli e con l’intervento di Achille Bonito Oliva; 2009 53° Biennale di Venezia, “Notte di Luce” di Marco Nereo Rotelli; 2010 con un’opera fotografico-poetica in “The last book” installazione di Luis. Camnitzer alla biblioteca di Zurigo, Svizzera; 2010 -Edita “L’altro”, poesie e fotografie con prefazione di Gio Ferri e videoproiezione; 2012 edita “Contrasti” scritture e fotografie con prefazione di Gio Ferri; video proiezione in collaborazione con Angelo Secondini; 2012 “Osservazioni Minimali” Mostra fotografica personale; video proiezioni con musica di Angelo Secondini; 2013 “Dice il vero chi parla di ombre” personale fotografica; presso la Galleria d’Arte dell’Istituto Romeno di Venezia. 2015 crea e cura “Congiunzioni Festival di poesia” 2015 “Venezia e luce” in antologia poetica di M.Nereo Rotelli 2016 “Simmetria di un’apparenza” Personale fotografica presso la Galleria d’arte dell’Istituto Romeno di Venezia; 2017 “Congiunzioni Festival Internazionale di poesia” 2° edizione.
Iria Gorran, prosa inedita "Ghoul", nota di Giorgio Bonacini
Il meccanismo linguistico che l’autrice mostra in questa prosa è straordinario: sale in superficie una scrittura che fa delle visibilità il suo centro d’ampiezza, e lo mette in evidenza senza pudore. Nello stesso tempo però, ciò che sta al fondo e che fa da propulsore, non rimane nascosto nelle profondità sorgive, ma si manifesta in quella che è la sua scrittura. Un amalgama contratto, nervoso, altamente significante nella percettività dell’esperienza di un viaggio (nelle terre dell’est europeo e turche) e di un incontro (il Ghoul: il mostruoso). Ma questo, che potremmo considerare l’aneddoto (molto interiormente e validamente dislocato) è molto di più di una scena descritta: è un dire visionario che richiama il testo alla sua funzione specifica e originale: spingere la dimensione del senso là dove il sentimento dell’esserci prova un benefico attrito concettuale ed emotivo. Infatti l’apparente slegatura (e slogatura) delle frasi ne è un esempio che avvolge tutta la tela sintagmatica delle immagini e del racconto. Dunque il “mostro” (il Ghoul del titolo) che è, nelle parole dell’autrice, “meccanismo fuori controllo, schizzato via”, è sostanzialmente la narrazione stessa, beneficata da un linguaggio che è “masnada infernale” “che si insinua nelle fibre”. Dunque un caos, per sua natura inordinato, di folgorazioni e condensazioni, che diventa però matrice vitale di apparizioni umane e bestiali.
Ghoul
Da Vienna ritorno più a est, appena prima della città, grandi occhi cerulei, li ho di fronte, aperti al cielo, fissi nello shock, l’uomo di Bratislava, quello steso a terra, buttato giù, come un birillo da una Lada, il suo cane pezzato, piccolo di taglia, fuggire terrorizzato, trascinarsi dietro il guinzaglio legato al collare. Sullo sfondo le baracche di legno degli operai, non ci sono più, la città è nuova. Riordinata, pavimentata, sfiora l’efficiente modello occidentale. Dal costone, a picco sul Danubio Dowina, dall’alto della sua postazione, ricorda ogni cosa, dai Celti a quel giorno, forse anche di me.
Dalla finestra la sera è subito blu, ricco freddo vellutato lunare, distante più in là, il confine ucraino in linea d’area, aleggia su di noi, come una nebbia mistica, nella cappa di cenere la Foresta Rossa l’immagino, navigare immersa ancora, nel pulviscolo radioattivo dell’ottantasei.
Da Budapest a Oradea, lungo il percorso gente a piedi, un carrozzone coperto, tirato dai cavalli. Zingari romanizzati, tarchiati, capelli stoppa, occhi da fiere, come voragini le bocche. Rallento, ci fermiamo. Vorremmo fare una foto, loro si mostrano aggressivi, muovono verso di noi, correndo.
Hanno degli orsi, al seguito, al ferro, l’anello al naso pesa, la catena breve li costringe a camminare in piedi, accanto agli aguzzini. Sono due, ne ricordo solo uno, quello a sinistra, ho fissato il suo occhio liquido che nel mio, guardava il sole velato dal pallore freddo del giorno, appena iniziato. Quando non serviranno più, li mangeranno. Inferno. E io zitta. Un buio attraversato, un mare sopra l’apnea un gioco duro. Non ho agito, non ho fatto nulla, riappare l’orso, mentre quasi sto sorridendo mi spegne sulla faccia la sua sofferenza.
Per riparare, muoio, rinasco, mostro anch’io. Non è nulla di comune un mostro, se sa di esserlo, la solitudine lo tempera, si lascia una scia, smeriglio, la mina aguzza è pronta a incidere la faccia ridisegnare i tratti, ridiventare. Intanto assente, resta distante, lasciarsi avvicinare, un lusso a cui non cedere, può precedere il tocco. Chi manca, non può essere toccato, solo avvertito, appena.
L’inferno come un ago si insinua nelle fibre, dove fa squarci, ricuce. E, se è la luce ad attrarlo, lavora meglio al buio, mi è stato accanto, poggiato sulla spalla sinistra. Installa visioni crude, si apre un varco, fa vuoto all’interno, deforma il cuore, consegna all’ossessione, rende irriconoscibile ciò che è bello, innocente, integro, ne fa scoria, e l’abbandona poi, sotto gli occhi di tutti, mostrandone la buccia impietosamente aperta, a sostenere, che era soltanto, cartapesta pitturata.
La ferrovia tagliava il bosco, balenava un’ombra, dicevano. Ingoia, quell’ombra a volte rigurgita. Stava lì accosciata, a divorarsi il conformismo, scienza dal travestimento rozzo teso all’apollineo per assicurare fedeltà, a una perfezione solo riflessa, una finzione. Un uomo funzione del regime robotico, nel subbuglio, tra un treno e l’altro, l’uomo del momento, curvo nel caos, mangiava.
La collettivizzazione delle campagne ucraine, era già stata, morte per fame inflitta, masse indefinite all’inferno. Legione il potere di contare, identificare numeri, e di numeri si nutre, il Ghoul.
Solo un meccanismo singolo, fuori controllo, schizzato via, come chiamato in causa messaggero sterminatore, preludio di nuova catastrofe, l’annientamento imminente a est. L’ingranaggio statale, non cederà per questo, ma poi andrà dritto verso il casino, in ogni bordello a ovest molte ragazze ingannate, dal mito del progresso.
Tragedia, nessuna colpa, il demone protagonista, sotto l’impalcatura della fronte, vive il suo film muto. In gabbia, libero nella camicia a scacchi, senza la moretta sembra servire, solo se stesso.
Al processo la verità, è che, non c’è uomo che riesca a sostenerlo quello sguardo, qualcosa incombe nel gregge recintato dai burocrati del diritto. L’ombra antica del mondo forse, chiede il suo conto al sostituto di Dio, che a leggi naturali, ha contrapposto il piano tracotante, sagomare materiale umano senza respiro, divino.
Deve aver visto, la masnada infernale passargli accanto, gli arde negli occhi, è rotto, è in luce, ampia la bocca come uno sbadiglio osceno il sorriso assoluto ebete girovaga per la sala caos dionisiaco quasi, sfiora il sublime quella primordiale terrificante faccia di stella accesa brucia, l’area oscura del tribunale ipocrita, che giudica un’altra identità soggetto in metamorfosi, ormai estraneo all’unione, lupo, figlio perfetto della Terra. Non resta che servire l’ultimo atto, stabilito il confine del lecito, il colpo è alla nuca. L’orchestra grida forte che è finita la strage. Dicono, andrà a occidente, Andrej, studiato dai fisiologi. Gli psichiatri smonteranno il suo cupo universo, i chimici ne estrarranno un farmaco, forse anche l’antidoto.
Da Brela a Varna, in auto sulla chiatta, il tratto d’acqua è breve, siamo diretti a Istanbul
Ai ristoranti servono gli uomini prima delle donne. Il lakké, solerte, spazza briciole al cambio dei piatti che il cameriere serve, e se chiamato per una comanda, non risponde, non è il suo ruolo.
Bambini ai semafori, puliscono i parabrezza alle auto, lire, fiorini, sorridono accettano ogni moneta, non solo marchi e dollari.
Senza identità dentro una divisa, qualcuno in una traversa, si fa capire, un mix di anglo francese bisbigliato, condito da abili ammiccamenti, procura ogni cosa dice, documenti, armi, donne al bisogno, droghe per tutti i gusti.
Al Gran Bazar, ricco di ori, spezie, veri falsi d’autore, i mercanti, sparano alto sul prezzo, mentre trattiamo, alle spalle gorgogliante dal pendio, una cascata d’acqua scorre e quasi ci investe. Riparati all’interno di una bottega, fra sacchi di curcuma, l’onda era forse ciò che aspettavo. Superato il primo stupore, ridono i turisti e le signore che hanno già fatto spese, dopo questa emozione subito ne vorrebbero un altra, e da bere, navigare il Bosforo, visitare il Topkapi. Solo dettagli sostano intorno.
Del viaggio, dei luoghi del tempo che trattengo, niente trapela da me, neanche una goccia fuori.
Iria Gorran (1957) ha origini croate e formazione classica. Fa esperienze teatrali in Sicilia; segue studi di Architettura a Roma. A Firenze frequenta l’Università Inter- nazionale d’Arte e l’Atelier di Paola Bracco. A Genova lavora al restauro degli affreschi della chiesa della San tissima Annunziata, con interventi di ancoraggio e con- solidamento. A Milano frequenta la scuola di Pinin Bram- billa Barcilon e si occupa del Cenacolo di Leonardo. A Montalto Pavese lavora al restauro di tele del Seicento nella pieve di Sant’Antonino Martire. Testi di riferimento: Il corvo e i racconti del mistero di Poe, la Commedia di Dante. Ancoraggi filosofici: la scuola ionica di Mileto e Parmenide. Risiede per lunghi periodi a Vienna e a Londra. Attualmente vive a Torre d’Isola (PV). Vince “Opera Prima”2018 Anterem edizioni con la raccolta “Corpo di Guerra”.
Mariangela Guatteri, "Tecniche di liberazione", Benway Senries, 2017, nota di Rosa Pierno
Se tutto non è analogo a tutto, ciò che appare particolare lo è solo perché estratto dall’insieme, allora bisogna minimizzare le differenze per ricondurre anche il particolare nell’albero di un fenomeno originale, che possa situarsi nel luogo in cui tutto era, appunto, indistinto. Cogliere l’epifania dell’evento e collezionarne la serie. Il testo asciuttissimo si svolge in parallelo al dispiegamento di immagini fotografiche che non si devono interpretare come un commento, ma, appunto, come un discorso visivo complementare. All’interno di questa dinamica vige sempre equilibrio perché vi è equivalenza: “Le modalità di rinuncia: “l’abolizione delle modalità umane”, oltre che trasformazione: “un punto: ferma e continua”. È abolito così, almeno nel passaggio dall’individuale all’universale, anche ciò che arresta l’azione: la morte. La memoria non deve ostacolare e il raffinatissimo dialogo tra bianco e nero rende la calma una durata senza scansione cronologica.




Gian Paolo Guerini, dalla raccolta inedita "Chiunque", nota di Laura Caccia
Il balbettio del senso
Tra visivo e sonoro, senso e non senso, apparenza ed equivoco, la costruzione poetica Chiunque di Gian Paolo Guerini appare pensata appositamente per depistare. O, meglio, per lasciare che qualcosa riesca a manifestarsi nel semplice accadere del testo.
“Testimoni di un originale disperso, forse mai stato”, ci indica l’autore, sono Chiunque, che “non è detto che sia”, e Nessuno, che “non è detto che non sia”, che si rispecchiano, lungo i sedici duplici scritti che compongono la raccolta, di volta in volta in una stessa trama poetica, diversamente interrotta da cesure nei due testi bifronte e resa irriconoscibile nelle sue strutture grammaticali, sintattiche e semantiche.
Una rifrazione simmetrica e asimmetrica nello stesso tempo, tra le tante contraddizioni disseminate: poesie apparentemente illeggibili nel loro balbettio sonoro, una lingua franta e spezzettata non parlata da nessuno, l’originale che è e, insieme, non è disperso.
L’originale sarebbe infatti facilmente ricomponibile: basterebbero atti di paziente razionalità per rendere leggibili e comprensibili i testi, ma, seguendo le indicazioni dell’autore che richiede “un lettore che rinunci, fin dall’inizio, alla propria capacità di intendere. Accettante l’incompiutezza e abbandonato alla résonance de la langue e alla magia del terzo suono di Tartini”, è proprio nel lasciarci cullare dalla duplicità del balbettio sonoro che potremmo essere in grado di percepirne uno ulteriore. Come nel captare gli armonici sonori, dove nell’ascolto di due suoni ad un determinato intervallo, si produce la percezione di un terzo suono, che in realtà non esiste, così l’autore ci chiede di muoverci nelle duplici sonorità, contrapposte e sovrapponibili, al fine di cogliere quanto di assente e di oltre si celi.
Salvo poi farci scoprire, nel glossario al termine della raccolta, che l’originale in realtà non è disperso e che una nuova contraddizione ci attende al varco: poiché la trama poetica è colma non solo di risonanze, ma di un senso specifico che ci conduce ai testi sanscriti, ai loro principi e ai termini che li caratterizzano. Sono termini che fanno riferimento al principio e al trascendente, alle divinità vediche e alle realtà sensibili, al respiro e alla forza vitale. Così come alla sillaba sacra, alla parola creatrice.
Allora pare che Gian Paolo Guerini nella sua raccolta, insieme strutturata e colma di contraddizioni, lacerata e assetata di senso, non intenda tanto mettere in atto una ricerca sull’incompiutezza della lingua e sul valore dell’abbandono alla risonanza sonora, quanto piuttosto, diremmo, una narrazione inconscia dell’assoluto per suono e cesure. Protesa a far emergere quanto di unitario nasconda la frammentazione, quanto di profondo si celi nell’indicibile.
Del resto, cosa sarebbe la poesia se non accogliesse la contraddizione che la anima? E cosa se non contenesse in sé l’indicibile, l’inconscio, l'assente, riuscendo a parlare per frammenti, a fronte dei nostri vani tentativi di ricostruzione, e tentando di condurci, se pur umanamente votati allo scacco, verso il principio?
Nota dell’Autore: CHIUNQUE (voce a sinistra) e NESSUNO (voce a destra) sono i due testimoni di un originale disperso, forse mai stato. Si atteggiano a sordidi e adiafori personaggi di una commedia che tradisce le mute parole intese dall’occhio, per ridarcele in un balbettio implacabilmente e irrimediabilmente coniato e revocato. Non si può rimanere fedeli all’originale (in quanto disperso) né accontentarsi dell’ultima stesura (in quanto difficilmente decifrabile). Incurante delle attese della filologia, la commedia inarca una desinenza equivoca a sostegno di una cattedrale ormai in rovina: chiede un lettore che rinunci, fin dall’inizio, alla propria capacità di intendere. Accettante l’incompiutezza e abbandonato alla résonance de la langue e alla magia del terzo suono di Tartini.
1 CHIUNQUE
ciso no trat
tidina tura lezza
chen onposson o
esse reequi voca ti
si spe gneu nastel
lasi scuri sceuns ole
maun pas soè unpas so
chesi aav antiche
siaindi etro
no nhalas tessa
im portan zad
isa pere do
veanda re
mipo trai
trova requi
sene vica osene
vicaf orte
an cheinven tar
sidire mare
con troven tonel
labo naccia
1 NESSUNO
cis onot rattidi
natura lezza
cheno npos sono
esse re e
qui voca tisi
speg neu nastel
la si scuri sce un sol
e ma unp as soè unp
as soches ia avan
ti ches ia
indi e trono
nha las te ssai
mporta nzadi sa
pere do veanda
re mi potr ai
trov are qui se ne
vicao se ne vicafo
rte anche inven
tar si di re ma
recon troven tonel
la bonac cia
Gian Paolo Guerini è nato toro verso la metà del XX secolo in una piccola città equidistante da Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia. Dopo studi disordinatissimi, non ha voluto laurearsi in teologia con una tesi su Þe Clowde of Vnknowyng. Si batte da sempre, estenuamene, per liberare l’arte dalla cultura. Non ha mai ufficialmente pubblicato, tranne sporadici quaderni autoprodotti destinati ad amici, per la maggior parte in 10 copie (ma alcuni, in un impeto di presunzione, fino a 30 copie). Qui si trova tutto: www.gianpaologuerini.it (o quasi).
Stefano Iori, poesia inedita "Ultimo stato d’animo di Didone", premessa di Ranieri Teti
Stefano Iori dedica un omaggio a Giuseppe Ungaretti, prendendo spunto da uno dei suoi testi più rappresentativi, tratto da La terra promessa.
Sembra una mimesi stilistica, un omaggio che richiama in maniera naturale il pre-testo.
I “Cori descrittivi di stati d’animo di Didone” sono in tutto 19, e Iori, con il suo gesto fedelissimo ci consegna il ventesimo, l’ultimo: l’”Ultimo stato d’animo di Didone”, che comprende i precedenti, talora quasi citandoli, pensato come un riassunto, l’appendice a un capolavoro.
Il distico finale di Ungaretti “Deposto hai la superbia negli orrori, / Nei desolati errori” viene ripreso da Iori in “Lascia la terra dei desolati errori / Cerca novizie gemme di stupore”.
L’omaggio è ardito e risolto dal poeta contemporaneo con un verso finale di notevole intensità: tutto rinviene e si sospende, dove le cose “aspettano, là dove non ti trovi”.
Sottesa al testo ungarettiano c’è la nitida presenza di Virgilio, conterraneo e sicuramente amato da Iori (tanto che gli ha dedicato un festival): possiamo pensare a un doppio omaggio.
Ultimo stato d'animo di Didone
Omaggio a Giuseppe Ungaretti
Nella tenebra, attonita e muta
traversi campi vuoti d'ogni grano
Al tuo fianco più nessuno aspetti
Tremore sottile in vele d'indugio
t'accoglie e avvolge, antica notte
dove vagheggi con occhi opachi
senza più nebbia a soffiar sogni
Incerta, furtiva, in dormiveglia
trarresti dal buio un'ala enorme
a ricoprirti di quiete sperduta
È città desolata la tua memoria
macerie perdute, fetori d'ansia
pronti a svanire nell'ultima viltà
Lascia la terra dei desolati errori
Cerca novizie gemme di stupore
Chiamano il nome tuo, le senti?
Aspettano, là dove non ti trovi
Stefano Iori è nato a Mantova nel 1951 e ha studiato Giurisprudenza all'Università di Parma. Dal 1979 al 1985 ha svolto un'intensa attività teatrale e televisiva, in Italia e all'estero, come attore e regista. Debuttò come saggista nel 1992, firmando il volume Scritture del teatro (edizioni Provincia di Mantova). Iscritto all'Albo dei Giornalisti Professionisti, è stato redattore del quotidiano La Voce di Mantova dal 1992 al 1999. Si è rivelato al pubblico e alla critica con la filmografia ragionata I Grandi del cinema - Tinto Brass (Gremese Editore, Roma 2000). Ha collaborato con vari editori in qualità di curatore, fra questi anche Editoriale Giorgio Mondadori. Ha firmato quattro libri di poesia: Gocce scalze (Albatros Il Filo, Roma 2011), Sottopelle (Kolibris, Ferrara 2013, con prefazione di Gio Ferri) e L'anima aggiunta (Edizioni SEAM, Roma 2014, con prefazione di Beppe Costa e traduzione in inglese a fronte – ristampa per i tipi Pellicano, Roma 2017), Lascia la tua terra – Sinfonia del congedo (Fara Editore, Rimini 2017), con brevi note di lettura di Flavio Ermini, Giò Ferri, Rosa Pierno, Ida Travi). Nel 2015 ha pubblicato il romanzo La giovinezza di Shlomo (Gilgamesh Edizioni, Mantova). È direttore responsabile della rivista di poesia Versante Ripido e dei Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. È direttore artistico del Festival Internazionale di Poesia Virgilio e del Sirmio International Poetry Festival, nonché coordinatore del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio. È studioso di cultura ebraica.
Raffaele Marone, dalla raccolta inedita "aprile (‘a morte mmò mò e po’ torna a nascere)", nota di Laura Caccia
Della fine e dell’inizio
Appare in tutta la sua tensione, nella ricerca di una lingua autentica e il più possibile vicina alle origini, la raccolta aprile di Raffaele Marone che, di stesura in stesura, approda alla versione presentata nel dialetto della piana vesuviana.
Se la prima stesura, in lingua italiana, puntava, a quanto ci dice in nota l’autore, sull’emozione e sulla seduzione attraverso il lirismo e la riproduzione del noto e la seconda, sempre in lingua italiana, sull’apertura e sulla mobilità, attraverso una forma impura e incompiuta, la terza, divenuta “traduzione (traslazione?)” in dialetto, trova espressione nella lingua lavica dell’infanzia.
Quasi, potremmo, dire un passaggio dall’eruzione esplosiva vulcanica, insidiosa e attrattiva, all’eruzione effusiva, con le sue colate mobili e impure, e infine alla sedimentazione magmatica non ancora sopita, dura e rovente. Perciò “scrivere oggi il dialetto”, dichiara in nota l’autore, “spezza le unghie, fa sanguinare le dita”.
C’è come un ritorno all’inizio, anche se perso, anche se introvato, nel ribadire in continuazione la fine e l’origine nel loro contraddittorio mostrarsi.
Il completamento del titolo tra parentesi (‘a morte mmò mò e po’ torna a nascere), una morte in diretta e poi una rinascita, ci indica in sintesi la poetica della raccolta: un continuo morire e rinascere, una metamorfosi ininterrotta del testo come del pensiero che lo anima.
E cosa muore? Cosa rinasce?
La scrittura che, nel descrivere morte e rinascita, si fa anch’essa morte e rinascita nelle sue varie stesure, trovando ogni volta motivi di sofferenza e stupore. Il senso che da logiche fisse e chiuse passa a sviluppi mobili e moltiplicanti, nei “pensieri che diventano quattro / quattrocento un pensiero diventa / due una forma e un’altra e poi un’altra”. Il corpo che dalla sensazione di “ancora paura e paura / e i salti e il pugno chiuso contro / del morire ora solo” si apre alla percezione della linfa vitale. Il passato che, con il suo finire statico, spalanca il perennemente nascere del presente: “il passato è morto solo per questo / la morte ferma / di sé / risorgerà dalle ceneri”.
Tra figure emblematiche, quali “la signora paura” e la “zia conoscenza”, tra il senso di smarrimento “quando / tutto torna al vuoto di nulla” e la fiducia in una possibile rinascita, infine in una relativa consonanza, poiché se ne ravvisa non tanto la crudeltà quanto la speranza, con l’aprile eliotiano che genera lillà da terra morta, nel suo aprile Raffaele Marone ci porta, attraverso la lingua lavica, magmatica e fertile, che gli appartiene, a percepire il vitale del morire, propriamente a “sentire le singole gocce d’oceani come sanno / e sa il fossile che porta la vita segreta della polvere in sé”.
I
perduto era inizio il tepore
puro infinito
e vissuto come unico
perenne assoluto.
una
conoscenza di una forma solo
e sola
I
perz’ s’era ‘o calore ‘e l’accummiencio
puro e senza fine
e campato comm’a un’ sulo
sempe llà assuluto.
una
ne sape, na forma sulamente
e sola
IV
del padre nelle sue biforcazioni
seguire la giustezza della strada dettata, labirinto
dei muri dove la testa
moltiplicata dai giorni fino a fare
perde sette frammenti duri infissi. poi
batte forte e il cuore per questo
nella mente che s’incrina per questo
IV
d’o pate dint’e vich’
appriess’a via giust c’a dittat’, ‘o labirint’
d’e mur’ addò ‘a capa se fa
mill’ cape, juorn’ pe’ juorn’, fin’a cché
aropp’ perde pa’ via sett’ scarde toste ‘nfizzate. po’
batt’ forte e ‘o core pe’ chest’
dint’a capa ca se senga pe’ chest’
e rinasce
un grand’uomo, perché la polvere
sa “chiedi alla polvere” disse
senti le gocce di linfa nella foglia come sanno
i suoi grani sanno sentire come sanno
sentire le rocce di vetta inviolata e i grani
di un sauro morto sentire le singole gocce d’oceani come sanno
e sa il fossile che porta la vita segreta della polvere in sé
e torna a nascere
“addimann’ a povere” ricette
nu grand’omm, pecché ‘a povere o’ sape
ca ‘e gran’ suje sapeno sentì comm’ sapeno
sentì ‘e gocce d’a linfa dint’a foglia comm’ sapeno
sentì una a una ‘e gocce ‘e l’oceano comm’ sapeno
sentì ‘e prete ‘mpizz’a muntagna sulitaria e ‘e gran’ ‘e nu sauro
fossile ca se porta aind’ ‘a vita segreta d’a povere
Nota dell’Autore
La raccolta è la terza scrittura di un testo, ultimo (per ora) passaggio di una metamorfosi in atto.
La prima scrittura lasciava emergere delle forme di lirismo che offuscavano la natura dell’espressione esatta. Aleggiava ancora l’atto di sedurre attraverso l’emozione, cercata ancora come riproduzione del noto. L’atto di conoscere deve abbandonare tutte le scorciatoie della seduzione (o bisognerebbe almeno provarci!).
La seconda scrittura, per spezzare le funi della seduzione, non è altro che il frutto di un riposizionamento dei versi all’interno dello spazio di ogni singola poesia. Così il senso si è liberato della logica del passato per fare la logica del presente, che è in atto, è mobile, è forma nuova. Impura e leggermente insensata, laddove si apre. Forma comunque incompiuta nel dire quel che è da dire ora.
La terza scrittura, qui presentata, è traduzione (traslazione?) in dialetto.
Tornare al dialetto è uno di quegli strani viaggi di ritorno al futuro, a ritroso verso il domani.
Tornare all’infanzia, a quella lingua dei suoni negati (dovevamo parlare italiano per diventare moderni?).
Quel desiderio di emettere suoni così è rimasto. E poi arriva la voglia, anzi la necessità spinta dall’urgenza, di scriverla quella lingua, per dire il tempo in atto, il presente (che è futuro allo stato perennemente nascente) con possibile esattezza, in forma che si senta compiuta proprio nel presentarsi con l’ambiguità del farsi o disfarsi.
La scrittura permette di far riemergere quei suoni antichi rimbombanti che vivono in un mondo cavernoso di acque esistenziali, carsico. Quei suoni, uscendo all’aria aperta si mescolano; oggi sono impastati con i suoni della strada, anche se questi, il tempo li ha in molta parte impoveriti e arricchiti, comunque cambiati (è la vita di una lingua viva).
La traduzione (traslazione?) in dialetto napoletano contemporaneo della piana vesuviana è materia grezza, ruvida; sarebbe bello se ancora risuonasse di echi di osco, perché li cerca.
Ma scrivere oggi il dialetto spezza le unghie, fa sanguinare le dita, è faticoso e a volte fa anche leggermente male: scrivere ogni parola è come staccare, a mani nude, un pezzo di roccia da una terra dura. Chissà perché. Forse la vita naturale di quelle parole in dialetto è nel mondo del suono e dei rumori.
O perché quella roccia è dura e scotta: forse è materia magmatica mai raffreddatasi, o è calda del calore di una stella che, lo sappiamo, non c’è più eppure sembra bruciare ora.
Raffaele Marone (Napoli 1960) è architetto e ricercatore universitario.
Sue poesie sono state pubblicate su “Le Voci della Luna” e, in rete, su “Blanc de ta nuque” e “Carte nel vento”.
Ha pubblicato libri, progetti e saggi di architettura.
Scrive il blog www.ilfattoquotidiano.it/blog/rmarone/
Gabriella Montanari, dalla raccolta inedita "Anatomie comperate", nota di Laura Caccia
Nel corpo del sentire
È impregnata di corporeità, nei suoi aspetti fisici correlati alla percezione di sé e del proprio stare al mondo, la raccolta Anatomie comperate di Gabriella Montanari. Lo evidenziano, già a prima vista, i titoli delle quattro parti di cui è composta, nell’intreccio degli elementi corporali e di quanto essi richiamino sul piano esistenziale, tra ricordi e messe a fuoco dei grovigli del vissuto.
La memoria del corpo pare non dare scampo. E quando riguarda l’esperienza corporea ed esperienziale diventa motivo di sofferenza e di disincanto, in cui la parola deve fare i conti con le abrasioni del vivere e del morire, imbrattandosi con quanto di torbido e di venefico venga a contatto. Parola di corpo e di sangue, di strappo e ferita, che apparentemente sembra giocare sui tasti del sarcasmo e dell’ironia, ma che in realtà riesce a dar luogo ad una spietata messa a nudo: “Un boato e un silenzio / mi fecero di carne lirica. / Salata in superficie / acre nei risvolti del sentire”.
“Di carne lirica”: potente ossimoro di quanto di più materico e lacerabile si possa esprimere e insieme di più visionario e tendente all’unità si possa lasciar risuonare.
E se l’elemento carnale, il vissuto corporeo ed esperienziale, non lascia adito a speranze future, “Per quella maledizione / che ci riempie la bocca di ma sì, sì, dopo. / Dopo, però, è solo la lisca”, ciò che la parte lirica pare essere in grado di difendere è la fiducia nell’oltre-realtà della creazione poetica: “Sento che le tue iridi mi sfogliano, / cercano radici, non sanno cosa pensare. / Scusami, ma io ho occhi solo per un roseto inventato”.
E se, ancora, le parti anatomiche indicano sofferenza e sforzo, propriamente una conquista, dovendo essere acquisite a fatica, come ci indica l’autrice, “Mia prima e ultima dimora, / corpo che mi guardi, / covo di anatomie comperate coi risparmi”, ciò che la parola esprime è la gratuità del suo dono:“Il divino è nelle tue meccaniche, / sacro è il rigore con cui profani l’anima. / In cambio di tremiti e disfunzioni / ti rendo questi versi perché sono tue visioni”.
Una parola sempre impregnata del corpo che la esprime, colma di immagini e di visioni e, insieme, di tagli e dissezioni, come fosse un’indagine anatomica del vivere, a partire dalla vivisezione stessa del dire, da quel “torbido dei nondetti”, quando “madrelingua era l’incomprensione”, fino alla limpida e netta dichiarazione: “odio uccidere le parole, è immorale”. Una parola soprattutto impregnata del sangue che la anima, come Gabriella Montanari evidenzia, con la sua parte carnale, chiedendosi: “Non siamo forse gengive / che blaterano storie / di cui si è perso il sangue?”. E come sottolinea chiaramente, con la sua parte lirica, quando riesce, in una prospettiva positiva sul futuro, a fare sbocciare ”il sangue canterino”.
Dalla sezione Ippocampo sempreverde e ciuffi di memoria
NEURONI E SANTO PATRONO
I nervi delle strade di Romagna
s’infiammano per un nonnulla,
le indoli carburano a spergiuri.
Dio non c’è e non torna subito.
Quando i campi si strusciano al vespro
gli uomini tracannano sangue di giove
e le donne s’apparecchiano:
sughi e orifizi per bocche miscredenti.
Nella mia terra strozziamo i preti
con budelli di acqua e farina,
sacrifichiamo rane ai festival democratici
mettiamo lucciole nei boccali
per fare luce ai sogni.
Siamo teste calde di sole
spaccato tra le onde e i castelli.
Di cosa odora la memoria?
Quanto misura una meta?
Alla guida dell’esistenza
assomigliamo a bambini interrotti,
la patente rosa peonia
le tasche piene di tappini
e gettoni per le giostre.
TRONCHI E CORTECCE
Lo zio addestrava cagne da tartufo
la zia sbollentava cuori di pollo
la cugina era il mio doppio in biondo.
La loro dimora sopravvisse alla nostra diaspora.
Succhiavo ossa di sambuco
in cima al cachi pericolante,
ero un seme in fuga dalla potestà del frutto.
Istruivo bambole compìte
imparavo la non-famiglia.
M’innamorai di un fiore di nome Filadelfo:
deflorò la mia infanzia
in cambio di due stami.
GERIATRICAMENTE VOSTRA
I nonni coi nipoti al guinzaglio
passeggiano lungo i margini
di storie sfigurate da semolino e trame senili.
Curvi, ormai appallottolati
nel cestino delle grandi imprese.
La loro canizie è morbida, di un azzurro pietoso,
sono pulcini che hanno smarrito il domani.
L’ippocampo arranca, poi sciopera.
Chi sei tu? Ti conosco?
La demenza conosce i nomi latini dei frutti dimenticati,
si scorda delle voci e dei visi abitati.
I nonni ignoti
sono sfere di naftalina conficcate nella distanza.
Conservo vecchie foto
del loro non essere stati.
Gabriella Montanari, italo-francese, laureata in Lettere Moderne all’Università di Bologna e diplomata in Pittura presso la Scuola d’Arti Ornamentali San Giacomo di Roma, è poeta, scrittrice, critica d’arte e fotografa. Ha insegnato Lingua e Letteratura Italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi (India), Tecniche pittoriche e Storia dell’arte presso il Lycée Français de New Delhi. Ha condotto laboratori di poesia con gli allievi del Lycée Français de Lomé (Togo).
Traduttrice di poesia e narrativa dal francese e dall’inglese, collabora con riviste letterarie, d’informazione, di viaggio e d’arte italiane e internazionali.
È stata co-fondatrice e direttrice editoriale della casa editrice WhiteFly Press (Lugo). Attualmente è docente di lingua francese e Presidente dell’Associazione Culturale WhiteFly, con sede a Torino. È curatrice di mostre, organizzatrice di eventi culturali/festival letterari e consulente editoriale.
Esordisce in poesia con Oltraggio all’ipocrisia per le edizioni Lepisma di Roma (2012, Prefazione di Dante Maffia), a cui hanno fatto seguito Arsenico e nuovi versetti (La Vita Felice, Milano, 2013, Prefazione di Lino Angiuli), Abbecedario di una ex buona a nulla (Rupe Mutevole Edizioni, Parma, 2015, Prefazione di Enrico Nascimbeni ) e Si chiude da sé (Gilgamesh Edizioni, Mantova, 2016, Prefazione di Davide Rondoni). Pubblica per Supernova di Venezia (2016, Prefazione di Carla Menaldo) il suo primo romanzo, Donne di cose e per Danilo Montanari Editore (Ravenna), il libro d’arte Reattivo di Valle (poesie e fotografie) con acquarelli di Sergio Monari (2017).
Tra i riconoscimenti: Premio Internazionale R. Farina 2012: 2a classificata con Oltraggio all’ipocrisia; Premio Torresano 2016 : 1a classificata sez. Raccolta poesia inedita con Si chiude da sé; Premio Torresano 2016: 3a classificata sez. Narrativa edita con Donne di cose; Premio Montano 2017: Segnalazione sez Poesia edita con Si chiude da sé; Premio Guido Gozzano 2017: 3a classificata sez poesia inedita con « Cerulea » (da Anatomia comperata), Premio Don Di Liegro 2017: Medaglia d’onore con « A maggio » (da Anatomia comperata).
Romano Morelli, dalla raccolta inedita "Un difficile partire", nota di Giorgio Bonacini
Se la poesia è un dono che non desidera reciprocità, lo è ugualmente anche quando arriva al poeta dal poeta stesso, e si offre all’altro: non solo per dire la parola, ma a volte e ben più, per dare una parola che aderisca a sé, in quanto cosa significante e molteplice. Ed è proprio con questa consapevolezza che il poemetto di Morelli si avvia e fluisce aprendosi il varco necessario “dall’orlo di un limite”. La scrittura e la lingua, che sono il fare e l’essere della poesia, per l’autore sono indiscutibilmente sostanza per respirare: dunque per vivere. Allora la parola, sottratta alla sua superficiale funzione ordinaria, è una peregrinazione senza meta precisa, anche in una direzione attenta al perdersi. Ciò vuol dire, un’occasione per trovare senso e ritrovarsi ricreando il mondo. Il linguaggio, dentro la voce che dice vibrando in ogni sillaba, può anche scomparire dalla visuale, ma i versi lo recuperano tra pause e interstizi muti, punteggiando i suoni e i sensi. Lì dove il dentro e il fuori sono vocalità ed eco. Morelli è attento a concepire la poesia nel tempo e nello spazio, dove “la presenza di un altrove” si innesta all’origine di un apparire sempre iniziale, sempre in continua diffusione. Perchè nella voce poetica il conflitto fra dicibile e indicibile è il segno che fonda il disegno (anche impossibile) del senso. Anche dove l’annuncio è oscuro, precisa senza nessun timore, l’autore. In questi testi, dunque, la significazione oltrepassa il significato, perché forma, direzione e percezione del sentimento hanno come unica valenza un pulsare inarrestabile.
Dalla sezione “Lasciare traccia”
***
Tu non sei qui con noi: allora
per chi, perché, da dove parli?
Dall’orlo di un limite,
- varco e precipizio –
da dove si vedono antiche latenze squarciarsi,
le inquietudini ritrarsi nell’ombra,
inaridirsi le domande
e disperdersi a spettri le misure,
relitti che si spengono su larghi abissi di futuro,
aspettando nel crepuscolo che scompare i giorni mancanti.
Dalla sezione “Un difficile partire”
***
Giunti alfine al bilico,
nella sosta costretti soffocanti d’attesa,
accecati e senza più voce,
non riconosciamo i resti avulsi
della nostra muta
che la terra accoglie e trasformerà in enigma,
mentre ci realizziamo ostaggi
rapiti dai tirannici compagni di viaggio
che abbiamo creato e nutriti.
***
Di questo trepidare
mentre ti senti andare
traccio ricordo,
del momento in cui s’estinguono le memorie
e non concepisci un avvenire.
Di questo difficile partire.
Romano Morelli è nato a Liegi, Belgio, il 13 giugno 1953.
Vive e lavora a Padova.
Ha pubblicato:
- E’ non è, Rebellato, San Donà di Piave, 1988. Poesie
- Questo essere. Poesie 1988-2010, Mimesis, Milano-Udine, 2013. Poesie (segnalata al premio Montano 2013).
- Su Hölderlin e il sacro, nel volume collettivo “Teologia della follia” a cura di M. Geretto e A. Martin, Mimesis, Milano-Udine, 2013. Saggio critico.
- Ancora una riflessione sulla poesia e sul nostro presente (finalista al Premio Montano, 2014). Riflessione critica.
- Possedere stretto un non avere: una lettura di “Entrata nel nero” di Ranieri Teti. La Clessidra, 1-2 2015 (numero pubblicato nel settembre 2016). Nota critica.
Alberto Mori, "Direzioni", Edizioni del Verri, 2017, nota di Flavio Ermini
Con questo libro Alberto Mori ci indica quattro delle mille e mille direzioni che può prendere il linguaggio: la Strada, l’Immagine, la Carne, la Migrazione.
Vi è nella poesia di Mori una continua alternanza tra identificazione e distacco. Identificazione con le cose nominate e distacco dal soggetto che le nomina; anche se non è poi così facile qui distinguere l’oggetto dal soggetto…
È anche su questa ambiguità che Mori cerca una strada personalissima per la scrittura, sottoponendola a una sperimentazione incessante, al fine di liberare la potenza rivelatrice della parola poetica, qualunque sia – tra le quattro direzioni individuate – la direzione presa.
Dalla sezione “La Strada”
***
Veduta piena
Parabrezzata tutta al sole
fin dietro alle spalle
ad inquadro del lunotto termico
Nel baglio argenteo acceso dal retrovisore
la sequela spezzata della mezzeria
in mattinata allontanante
***
L’illuminazione delle intermittenze
nastra e rifrange il sovrappasso notturno
Chiama auto a saliscendere
Delinea nel rettilineo successivo
la luminescenza dello sfondo
Scritte tutor per limiti di velocità
***
Tramonto inquadrato flussivo dallo schermo sottopasso
Rettangolo scarlatto brevissimo
acceso dallo iodio dei fari abbaglianti
Finisce il controllo elettronico del limite
Il piede riaffonda acceleratore
Alza la dinamica della strada
nel profumo viaggiante delle tempie
Alberto Mori (Crema,1962), poeta performer e artista, sperimenta una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando in interazione altre forme d’arte e di comunicazione.
Dal 1986 ha all’attivo numerose pubblicazioni.
Nel 2001 Iperpoesie (Save AS Editorial) e nel 2006 Utópos (Peccata Minuta) sono stati tradotti in Spagna. Per Fara Editore ha pubblicato: Raccolta (2008), Fashion (2009), Objects (2010), Financial (2011), Piano (2012), Esecuzioni (2013), Meteo Tempi (2014), Canti Digitali (2015), Quasi Partita (2016).
Nel 2017 Direzioni (edizioni del Verri). La sua produzione video e performativa è consultabile nell’archivio multimediale dell’Associazione Careof / Organization for Contemporary Art di Milano.
Dal 2003 partecipa a Festival di Poesia e Performing Arts fra i quali: V Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (Lisbona, 2005), Biennale di Verona (2005 e 2007), IX Art Action International Performance Art Festival (Monza, 2011), Bologna in Lettere (2013, 2014 ,2015 ,2016, 2018).
Negli ultimi anni più volte finalista del premio di poesia “Lorenzo Montano” della rivista Anterem di Verona.
Website: www. albertomoripoeta.com
Clemente Napolitano, "Fluxus", l’arcael’arco edizioni, 2015, nota di Flavio Ermini
Clemente Napolitano ci porta con questo libro nel flusso della vita quotidiana, nel suo farsi e disfarsi nello spazio di un libero agire proprio di un’anima che ha compreso il destino cui è assegnata.
Un destino che coinvolge il linguaggio e la coscienza, in un rinnovamento lungo e incerto, in un rituale che ha bisogno di essere continuamente ripetuto.
Qualcosa è già successo. Ma c’è ancora posto per l’emozione di un rapporto che svela tentazioni non dette, segrete, incalcolabili.
Il messaggio è questo: si cerchi di rinascere continuamente, ci si impegni incessantemente in imprese nuove, risorgendo come ogni volta fa il sole al mattino.
***
Perché quest’involucro
non è mai stato
corazza imbattibile
fragile e scosso
da un colpo di vento
lasso ti accoglie
scherno dolente
alla tempesta
solletichi il verso
garrisce la presa
le maglie allargando
rivolta lo sguardo
come una scolta
le spine di Cristo
hanno foglie brunite
***
Hai visto la mano era distesa
il palmo aperto
a mezz’aria sospeso brancolava
il corpo stava dietro
l’angolo teso oscillava perplesso
tra dare e avere
mostrarsi per donare o nel frattempo
tirare il busto
indietro nascondendo l’appetito
ripugnante
***
E della vita godo
la vita stessa
irrefrenabile flusso privato
di separati pezzi
Clemente Napolitano nasce a Caserta, il 2 giugno 1965. A Bologna si laurea col massimo dei voti al D.A.M.S.
Allievo di eminenti maestri della scena teatrale italiana (Leo De Berardinis, Claudio Meldolesi, Carlo Merlo) frequenta, durante e dopo gli anni universitari, numerosi corsi di specializzazione in arti sceniche con particolare riguardo al settore dell’interpretazione e della regia.
Dai primi anni ’90, generalizza l’attività teatrale a stimolo di rinnovati impulsi creativi e culturali: assume supplenze di Storia dell’Arte nei Licei di Napoli e provincia; promuove seminari, dibattiti, progetti interartistici per la costruzione di nuovi spazi orientati ad arginare indifferenza e degrado; è interprete delle sue messinscene e di progetti musicali; realizza reading di poesia; collabora con riviste locali e nazionali; conduce seminari, dirige spettacoli nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania e nelle Università di Bologna e Salerno; svolge attività di Teatro e carcere.
Come attore ha collaborato con Leo de Berardinis: Macbeth di William Shakespeare; Carlo Merlo: Cristoforo Colombo di Michel de Ghelderode, Filosoficamente di Eduardo De Filippo; Renato Carpentieri: La serra e Party time di Harold Pinter.
Pubblicazioni più recenti:
- Clemente Napolitano, FLUXUS, Nola, L’arca e l’arco, 2015.
- Clemente Napolitano, Oggi è “ancora più lacerante il suo silenzio”, in LA TERZA VITA DI LEO Gli ultimi vent’anni del teatro di Leo de Berardinis a Bologna, riproposti da Claudio Meldolesi con Angela Malfitano e Laura Mariani e da “cento” testimoni, Corazzano, Titivillus, 2010.
- Clemente Napolitano, La fenice e il thanatos, in “Annuario Liceo Classico <<A. Rosmini>> Palma Campania”, 2007, n° 7.
- Clemente Napolitano, ‘O compagno, in AA.VV., La Madonna del Latte 10 racconti per 10 anni, Palma Campania, Michelangelo Communications, 2007.
Mario Novarini, "Radiazione del rosso", Book editore, 2017, nota di Rosa Pierno
Con una poesia tutta aderente alle sottili percezioni non tanto della materia quanto dell’atmosfera, delle fonti luminose, dei riflessi e delle percezioni, Mario Novarini insegue il gioco infinito delle loro variazioni alla ricerca di una geometria sottesa e di relazioni che, sui binari dell’analogia, leghino l’inorganico all’organico, il corporeo all’incorporeo: “seguono la piramidale / spiraliforme geometria / ch’è imposta dalla loro / ineludibile natura”. Più spesso, però, il passaggio da un elemento all’altro si attua attraverso un salto, una discontinuità, ove la luce è il viatico principale. Il tempo traccia anch’esso una via nella quale è possibile attraversare differenti stati, ma resta sempre la metafora visiva la chiave analogica, quando presente. Il sogno unitario non è disgiunto dalla consapevolezza della sua illusorietà. Una vera e propria girandola di luce investe il lettore, letteralmente illuminandolo.
Tempo
Si inquadra
attraverso la sua lente,
che si allontana a poco a poco
dal piano geometrico
su cui ognuno di noi si muove
come per gioco,
la nostra figura,
visibile per un giorno solo,
per un irripetibile
limpido momento solo
perfettamente a fuoco.
Litopoiesi (Genova – Salita Carbonara al Carmine)
Arido grigio lichene
disteso come un’erosa
incrostazione del suolo:
è un vivo fossile la città
racchiuso entro un guscio di pietra,
grumo di pittorica pasta
oleosa che resta fluido
a lungo al suo interno
dopo che in superficie
si è solidificato.
Sotto il piano stradale
la vita si dirada si riduce
a geometrica configurazione:
delle pietre squadrate
l’ortogonale precisione
è il segno e l’unica inorganica
residuale evidenza
di un ingegno la cui gelatinosa
fisica consistenza
è scomparsa da tempo.
Dove il mare immobile delle argille
rovescia gli spruzzi marnosi
delle sue onde pietrificate
su dorsali calcaree
e detritiche coltri alluvionali
di instabili depositi ghiaiosi
si allungano nell’alveo di acque
che un tempo risuonavano al cielo
e ora scorrono per buie vallecole
sotterranee, sprofondano
millenarie basi di pietra
calate nel sottosuolo:
umano atto fondante
che sembra uguagliare
della natura il lapideo
effusivo parto di roccia,
al manufatto accomunato
da simile tettonico
destino di compattezza, usura
e disgregazione.
Mario Novarini (Genova, 1962) è laureato in Lettere con una tesi in Glottologia. Ha pubblicato Inventario (Book Editore, 2002), Con gli occhi della materia (Book, 2008) con cui è stato finalista al Premio “San Domenichino – Città di Massa” 2009 e ha vinto il Premio “Alessandro Manzoni” 2011.
Giovanni Parrini, poesia inedita "Ai Margini", premessa di Ranieri Teti
Il poeta vive sul margine, sull’orlo. Da questo limite acquista centralità, anche se il mondo pare non accorgersene.
Come ha scritto Brodskij, “l’esercizio poetico è uno straordinario acceleratore della coscienza”: in questa poesia infatti una maceria viene aggettivata, allo stesso tempo, “intima”, “inutile”, ma “irrinunciabile”.
Una maceria, un classico elemento residuale, per il poeta diventa costitutiva e fondamentale. Sicuramente non scarto ma pietra su cui costruire. Portando con sé echi lontani di grande e indimenticabile poesia, Giovanni Parrini ci conduce in un luogo che viene sì descritto, ma allo stesso tempo interiorizzato.
Le descrizioni, precise, si trasformano in pensiero, in “sangue inquieto”.
Solo il poeta, dai margini, può ad esempio riconoscere, all’interno di un paesaggio, un’enclave.
In una scena aperta, vedere il recinto. Può farlo perché è un abitatore di bordi, di spazi ristretti, di riserve. Solo il poeta ci può dire che la vita, di noi umani e di tutti gli altri esseri ed elementi, è “solo destino senza arrivo”.
Ai Margini
Di questa intima maceria così inutile
mia
irrinunciabile
e di te prato asfittico che gli olmi condannati proteggono se resterà
qualche testimonianza non saprei
ma non importa, infine
ora che mi parrebbe di comprendere
che la tua terra indurita da pezzi di mattoni
e le rime cercate per ridarti la beltà uccisa
sono un solo destino senza arrivo
tensione a qualche altro numinoso dettato.
Tu resistita enclave d’una forza di margherite e corse io, sangue
inquieto, incapace a cantarti
a darti l’infinito:
noi eguali
già scordati e vincibili
mentre ci passa accanto la tramvia hi-tech coi fari miti inondati di nebbia.
Giovanni Parrini è nato a Firenze, città in cui vive.
Ha pubblicato le seguenti raccolte di poesia: Nel viaggio (Lietocolle, Faloppio, 2006); Tra segni e sogni (Manni, Lecce, 2006); Nell’oltre delle cose (Interlinea, Novara, 2011 - Premio Mario Luzi 2011; finalista Premio “Il Ceppo” di Pistoia 2013); Valichi (Moretti&Vitali, Bergamo, 2015 - Premio Viareggio-Giuria 2015; Premio Pisa 2015); Le misure del cielo, rivista Poesia n° 284, a cura di M.G. Calandrone (Crocetti Editore, Milano), Tra poco, nell’aurora, in Nuovi Argomenti n° 73 (Mondadori, Roma, 2016). Quindici poesie sono presenti nell’Almanacco dello Specchio 2010-2011 (Mondadori, Milano).
Una selezione di quattro poesie da Valichi, tradotte in inglese da Dominic Siracusa (University of California, Los Angeles), è stata pubblicata sulla rivista internazionale Equipeco, n° 43 (a cura di Flavio Ermini).
Una lettura pubblica di Valichi è stata fatta dall’attore Leo Gullotta, nell’agosto 2015, presso il parco naturale del Conero.
Suoi lavori poetici sono ospitati in riviste, fra cui “Atelier, gli artigiani della parola” (Ladolfi Editore, Borgomanero), “Bollettino 900” (Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna), “Specchio” (mensile del quotidiano La Stampa), oltre che essere pubblicate in siti web.
È uno dei collaboratori della rivista di arte e cultura Caffè Michelangiolo (Polistampa, Firenze) in cui pubblica poesie e brevi saggi su poeti contemporanei, italiani e stranieri.
Gabriele Pepe, poesia inedita "I sing the body electric", premessa di Ranieri Teti
“I sing the body electric” è il titolo di un lungo poema di Walt Whitman che è stato ripreso, per il loro secondo album, dai Weather report.
Tra le due, sembra essere più quella musicale l’accezione preferita da Gabriele Pepe.
Partendo dalla coda del lungo testo leggiamo “e questo è il blues del tempio risanato / che atomo per atomo rinnova la promessa: / spiga nuova, futura resistenza…”.
Finisce così la poesia, con quei puntini di sospensione che sembrano amplificare l’apertura a un futuro in cui ripromettersi almeno la resistenza, dalle particelle costitutive rappresentate dagli atomi e con l’immagine della “spiga” che porta con sé tutto il suo carico simbolico.
Proprio perché prima c’erano stati “corrotte fecondità del seme e dell’ovaio” e, in generale, un cosmico declinare. Questo mondo che muta nell’instabilità di ciò che potrà accadere può contare nella strenua resistenza di un simbolo universale.
I sing the body electric
Se, di slancio, da un tempo non ancora diramato:
(strepitio di verbi di vago declinare fuori e dentro
i respiri di questo castello senza torri
né muraglie, ma di sole feritoie)
staremmo ancora qui, nel mondo affastellati,
di organismo nuovo a decantare:
vertiginosi approdi e intrepide crudezze,
quali interpreti, quali voci,
quali immagini, quali incanti se non per dire:
“...mai più vicario era:
al palio siderale di tutte le contrade
umane e sovrumane,
al combattivo inganno di una volontà di carne
caduta e dilaniata al centro di questa muta guerrq
che soltanto esiste nel breve ingaggio
della sua dissipazione;
mai più vicario era:
alle corrotte fecondità del seme e dell'ovaio,
ai margini discreti delle indotte consuetudini,
al gorgo tumultoso delle correnti alluvionali:
saldo scoglio al centro di ciò che ovunque scorre
fieramente stava:
(eroico continente dell'umane meraviglie).
E non più soggetto era:
al rigoroso sfinimento dell'indagine perenne,
al gelido sbiancare dell'ennesima parola pronunciata;
e non più soggeto era:
al peso insostenibile di esser freccia e mai l'arciere,
al ristagno dei fluidi, all'estradizione delle cose morte,
al ripiegamento delle vertebre sul cuore dell'abisso:
incompatibile al gergo dell'antico transitare,
senza timore alcuno, massiccio e puro,
sull'orizzonte degli eventi, superbo, andava...”
Questo è. Fu. Sarà: il secolo inderogabile
del corpo nuovo che ibrido
riassume, nel buio e nell'azzurro,
la risacca modulare delle intere percezioni
organico-inorganico
variabili circostanze di realtà aumentate
segmenti di corteccia replicante
che trasuda un'ambra di pensieri del tutto originali
e intrappola concetti inclini all'esatta taratura..
Saccenti e osceni quanto basta, ancora cantavamo:
“...questo è il blues del pianto elettrico a lacrime di cromo;
del sangue color dell'argentoro che,
da un polo all'altro reclamato, più veloce
del lampo cellulare, come una tempesta scorre;
e questo è il blues del tempio risanato
che atomo per atomo rinnova la promessa:
spiga nuova, futura resistenza...”
Gabriele Pepe, finalista, segnalato e vincitore in diversi tra i maggiori concorsi di poesia, ha pubblicato: “Parking luna” edizioni Arpanet, Milano 2002; “Di corpi franti e scampoli d’amore” e “L’ordine bisbetico del caos” con le Edizioni Lietocolle libri, Faloppio (Como) 2007. Figura nelle antologie: “Ogni parola ha un suono che inventa mondi”, edizioni Arpanet, Milano 2002;
“Fotoscritture”, edizioni Lietocolle libri Faloppio (Como) 2005; “Poesia del dissenso II”, a cura di Erminia Passannanti – Edizioni Joker ( Collana Transference) 2006; “Blanc de ta nuque. Uno sguardo (dalla rete) sulla poesia italiana contemporanea”, Edizioni Le Voci della luna (2006-2011), a cura di Sergio Rotino, Collana Segni, volume n. 7, pp. 272; “Forme concrete della poesia contemporanea”, studio critico a cura di Sandro Montalto, Edizioni Joker.
Suoi testi, recensioni e segnalazioni sul suo lavoro sono apparsi in rete e su carta.
Ivan Pozzoni, poesia inedita "La malattia invettiva", premessa di Ranieri Teti
Nel fantastico, ironico, enorme, visionario, dilagante mondo di Ivan Pozzoni c’è spazio per l’apparentemente minuscola attenzione a una lettera. Ce lo dice il titolo di questa poesia: “La malattia invettiva”. Un cambio, tra la “f” e la “v”, che connota la storia del testo.
Siamo di fronte a un uso potente della lingua, a un’invettiva che diventa infettiva per come, tra ritmo travolgente, rime inaudite e lessico adeguato, riesce a portare il lettore in un vortice.
Non è facile il verso lungo: richiede un superiore controllo della musicalità, e nel genere Pozzoni è maestro.
In questo vortice tutto si mescola e non casualmente si incontrano Zulu e afrikaner, Hitler e Leonida, addirittura Mazinga e una donna bionica.
Dopo una ridda di esattissimi termini medici, che suonano bene in questa poesia (che d’altronde, da una malattia trae spunto), sul finire della poesia l’autore ci intima di salire tutti a bordo del testo, persuasivo, convincente e intransigente. Partendo dalle nostre periferie, anche “in comitiva”.
Buon viaggio, sembra dirci, beffardamente suadente.
La malattia invettiva
Per scoprire le cause del mio vivere ogni evento come in dissenteria,
hanno versato inchiostro, enorme svista, nella cannula della gastroscopia
i medici anatomopatologi, e mi hanno diagnosticato la malattia invettiva,
associata a reflussi letterari, dilagati dall’esofago, a ossidarmi la gengiva.
Quando, cane cinico al collare, fiuto odor di malcostume o lezzo d’egopatia
non riesco a tollerare l’altro-nel-mondo, vittima d’abuso di xenofobia
dimentico ogni forma di fair-play, calo nella nebbia del Berserker,
incazzato nero come uno Zulu costretto a sopportare un afrikaner,
dico rom al sinti, sinti allo zingaro, zingaro al rumeno, rumeno al rom
non riuscirei nemmeno a trattenermi dall’urlare a Hitler aleikhem Shalom.
Se non vi digerisco sento dentro «uh, uh, uh» come Leonida alle Termopili,
identificando i vermi, che mi stanno intorno, coll’acuirsi del valore dei miei eosinofili
emetto, in eccesso, acido cloridrico e smetto di disinibire la pompa protonica
con la disperazione di un Mazinga mandato in bianco dalla donna bionica,
sputando, con l’accortezza del Naja nigricollis, ettolitri di cianuro
in faccia a chi, dandomi noia, sia condannato a sbatter la testa al muro.
Per comprendere l’ethos del mio vivere in assenza d’atarassia
barbaro che incontra un cittadino nella chora dell’anti-«poesia»,
sarete tutti, nessuno escluso, costretti a inoltrarvi in comitiva
nei meandri labirintitici della mia malattia invettiva.
Ivan Pozzoni è nato a Monza nel 1976. Ha diffuso molti articoli dedicati a filosofi italiani dell’Ottocento e del Novecento, e diversi contributi su etica e teoria del diritto del mondo antico; collabora con numerose riviste italiane e internazionali. Tra 2007 e 2016 sono uscite varie sue raccolte di versi: Underground e Riserva Indiana, con A&B Editrice, Versi Introversi, Androgini, Mostri, Galata morente, Carmina non dant damen, Scarti di magazzino, Qui gli austriaci sono più severi dei Borboni e Cherchez la troika con Limina Mentis, Lame da rasoi, con Joker, Il guastatore, con Cleup, Patroclo non deve morire, con deComporre Edizioni; tra 2009 e 2016 ha curato una trentina di antologie di versi. Tra 2008 e 2016 ha curato cinquanta volumi collettivi di materia storiografico filosofica e letteraria; tra il 2009 e il 2016 sono usciti i suoi: Il pragmatismo analitico italiano di Mario Calderoni (IF Press), L’ontologia civica di Eraclito d’Efeso (Limina Mentis), Grecità marginale e suggestioni etico/giuridiche: i Presocratici (IF Press), Libertà in frammenti. La svolta di Benedetto Croce in Etica e politica (deComporre) e Il pragmatismo analitico italiano di Giovanni Vailati (Limina Mentis). È con-direttore, insieme ad Ambra Simeone, de Il Guastatore – Quaderni «neon»-avanguardisti; è direttore de L’Arrivista; è direttore esecutivo della rivista internazionale Información Filosófica; è, o è stato, direttore delle collane Esprit (Limina Mentis), Nidaba (Gilgamesh Edizioni) e Fuzzy (deComporre Edizioni).
Giuseppina Rando, prosa inedita "Alla caduta", premessa di Mara Cini
Un testo che ripropone la riflessione sul potere/non potere della relazione lingua/realtà: Di fronte alla realtà la lingua diventa parola ingannevole.
I consueti tentativi di costruire l’invisibile dimora dell’essere e la consueta mortificazione nel constatare che le sillabe distanti non colmano il vuoto.
Come è stato detto, nella scrittura di Giuseppina Rando c’è la consapevolezza di un linguaggio che non risolve e nel contempo contiene i semi originari dell’esprimersi.
Così si continua, tentativo su tentativo, a tessere strutture linguistiche, a cercare di mettere ordine nell’universo dei significati per trovare un orizzonte di senso.
E’ come un cammino di passi attenti, in modulazione di preghiera.
Alla caduta
Nell’andare a cauti passi, attenti all’ordine comune delle cose, si costituisce il sistema
declinando le ore in tonalità di pianto o in modulazioni di preghiera, protesi ad agganciare il compiuto al ritmo dell’infinito che pure s’ode aleggiare intorno alla struttura.
Alla caduta nel mondo dell’Ignoto
è rimasto impresso in tutto l’essere
l’ardente desiderio di uscirne.
Debole la forma con radici nella melma su cui è stato costruito
il muro dell’indifferenza e da cui hanno origine i cespugli della
discriminazione e della violenza.
Sferzate di vorticoso frastuono ne costituiscono la sostanza vivente del tempo.
Le voci di tutte le discordanze si riproducono
in parole nel movimento delle riflessioni fluttuanti,
nella dialettica incessante di forze contraddittorie.
Nell’andare a piedi scalzi per luoghi dalle sillabe distanti, quasi impronunciabili, nel vuoto si dissolvono le strade della magia e del disordine:
si annulla la Parola, il Sapere che dice …
Di fronte alla realtà la lingua diventa parola ingannevole, un gioco che irretisce sbarrando la strada verso la pura elevazione.
Terrore del nulla.
Nell’andare tra la nebbia diradata altra parvenza avanza: un’immensa spianata ove alla necessità di pensare la finitezza corrisponde l’invenzione che apre all’ascolto del sovrumano.
Fruscio di chiome nel silenzio; trasalire al ritmo dell’attimo infinito e nello sfiorare il sublime, svanisce il terrore del nulla.
Spazio immaginario: ciò che si credeva morto, vive qui sparso tra filari di alberi carichi di frutti, maturati al desiderio di trovare un orizzonte di senso, aneliti-filamenti di travature atti a costruire l’invisibile dimora dell’essere, della propria incorporea sostanza.
In chiarità di cuore
distillato di rose selvatiche
alla caduta
nel mondo dell’Ignoto
Giuseppina Rando, poetessa, scrittrice e saggista, è presente in numerosi volumi di poesia, antologie e saggi. Collabora con diverse riviste. Ha pubblicato testi di Poesia tra i quali: Spuma di mare. Poesie (1970-1981), Statue di gesso (1982-1995), Duplice veste (2001), Immane tu (2002), Figura e parola (2005), Cierre Grafica Verona, Vibrazioni (2007) Noubs Chieti, Bioccoli (2008) Anterem Edizioni, Verona; Geometria della Rosa, Aletti editore, 2017. Saggi: Profili di donne nel Vangelo (2001) Bastogi, Foggia, Chiara. Una voce dal silenzio (2002). Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano, Le belle parole (2013) Scrittura Creativa Edizioni, Borgomanero (Novara). Nel Segno, Racconti, (2011) Pungitopo, Patti Marina (Messina) ha ricevuto il Premio di narrativa - Sesta edizione - Joyce Lussu, Offida (Ascoli Piceno)
Massimo Rizza, poesia inedita "Costellazioni ferite", nota di Rosa Pierno
Tra l’immagine di pietra e lo sguardo della storia vi è una ferita aperta che l’essere umano desidera ricucire. La fenice è il simbolo che sembra richiudere la forbice tra esistenza e morte, quasi un filo che ricucia. Alle coppie oppositive, che mostrano l’abisso che le accomuna, appartengono sono anche Dio e il nulla, il foglio bianco e la scrittura, la mente e il corpo. La parola viene in soccorso, aiuta a credere alle visioni unificanti. Tra le pieghe del dire si trova la forma del mitico uccello, che si può intravedere tra “le ombre mute” e “le crepe del muro”. La figura emblematica, che racchiude in sé il sole che sorge e che tramonta, è, nella poesia di Rizza, associata alla stella Cassiopea, punita per la superbia con la quale ha considerato la sua bellezza. Tuttavia, la bellezza è mezzo. Questa volta è la notte e non il cielo diurno a delineare una scenografia gravida di silenzi primordiali, la quale ancora lascia da soli gli esseri umani sul percorso dove vanamente essi cercano di afferrare segni. Ma è proprio nel “perdersi” e nel “rincontrarsi”, la spinta alla rinascita o almeno la spinta a proseguire.
Costellazioni ferite
Immergersi di nuovo per cercare la bestia
lei ferma indifesa dorme, l'occhio è dolce
il suo respiro è il ritmo del tempo che vive
di quel ritrovarsi soli e insicuri sulla carta
tra l'antico sale e la sua immagine di pietra
nello sguardo la storia di una ferita aperta
si scrive Fenice notturna velata sull' acqua
vita di passioni e visioni di pesci volanti
di quell'odore denso, misto di nascita e morte
luci di corpi abbracciati che cercano il senso
di parole dai bordi umidi, liberate nell'aria
con ago e fili d’oro ricuci la ferita del cielo.
Nei loro occhi di ragazzi un deserto buio
nuove costellazioni mescolate alle vele
di quel vuoto che riflette i pensieri freddi
nel disperdersi sabbia, sulle parole ferme
tra il nuovo Dio e la loro prima ferita vera
venuta dal nulla, figlia della sospensione
luce tremolante di una lacrima trasparente,
Idra caduta nel silenzio di un punto bianco
osso lucido al sole: antica memoria di carne
in superficie la cerchi tra le pieghe del dire
immagini la forma del suo essere corpo
stendersi nel divenire, misura dell'abitare
la senti vicina dalla luce che precede ogni
nascita, senza conoscere le sembianze di chi
ormai trasformata, si cela tra le ombre mute
bestia ferma, sospesa tra le crepe del muro,
Lucertola dalla coda a metà, malata d'amore
attesa piegata dal sole che le muore dentro.
Tra i corpi di pietra si allunga Cassiopea
sofferta si nasconde la regina sfigurata
maschera di notte offesa che scivola via
la trama gravida di silenzi primordiali
apre le labbra di carta, lascia l'impronta
di un procedere nella carne viva del testo
striscia tra le statue amputate di memoria
in fondo l'urlo finale prima del giorno
profumo di bianco, colore di sole parole
la sua carne lacerata, dimòra e figura
di una sembianza che ti lascia di nuovo
disperso tra gli amanti del solo andare
procedere a tentoni, a cogliere i segni
di quel vivere a misura del suo passo,
Orione che si fa luce e rinascita rosa
rincorsa e presa sulle labbra, pronuncia
il nome di quel perdersi e incontrarsi
dove l'anima sente ancora il soffio vivo.
Massimo Rizza è nato a Sesto San Giovanni e vive a Segrate (Mi). E’ laureato in pedagogia e ha operato nel campo dell’istruzione in qualità di dirigente scolastico. E’ condirettore della rivista letteraria Il Segnale. Ha pubblicato la raccolta poetica Il veliero capovolto, Ed. Anterem (2016).
Nel 2017 ha vinto il Premio Letterario Interferenze, Bologna in lettere, per la sezione poesie inedite. Suoi testi narrativi sono pubblicati in antologie e on line sul sito della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Testi di poesia, critica e saggistica sono apparsi su riviste letterarie italiane, tra le quali: “Anterem”, “Capoverso”, “Erba D'Arno”, “Il Segnale”,“ l’immaginazione”, “ Pagine”, “Scibbolet”,
Lia Rossi, poesia inedita "Principio di Rivoluzione. Poesia in otto tempi", nota di Flavio Ermini
Il canto che intona Lia Rossi ha la melodia irrequieta delle cose liberate dall’ombra. Richiama antiche voci, intese come forze primordiali e come ambiti di uno spazio terrestre che riunisce l’alto e il basso, il cielo e la terra.
Lia Rossi chiede alla poesia cose che solo dalla poesia è dato di sapere. Perché solo la poesia sa in quale rapporto l’essere umano si pone verso il principio e verso la fine.
L’autrice traccia una partizione netta, precisa tra la scrittura essoterica (che immaginiamo a tutti destinata) e la scrittura esoterica (rivolta solo a chi è disposto a prepararvisi adeguatamene). Per raggiungere queste due modalità di espressione e per darne conto sulla pagina, Lia Rossi evidenzia in ognuno degli otto tempi una cesura, uno spazio bianco, verticale; forse una forma di silenzio che in sé trattiene l’urlo arcaico.
Il suo regno è un regno di parole che abbraccia le profondità dei mondi abissali, dei culti misterici di stirpi ormai estinte. È un altrove che impone una domanda di verità e di senso.
Avviene qui qualcosa di molto simile a quello di cui ci parla il rapporto amoroso, rapporto che impone agli innamorati di mettersi in gioco attraverso una terza figura che è l’amore: l’amore come sogno, come impossibile fusione.
In "Principio di rivoluzione" sono da Lia Rossi raccolti i frammenti di un insistente tumulto, di un costante discettare; tanto da indurci a fare i conti con le mille schegge dell’interminabile dilaniarsi di un’anima così vasta da assomigliare all’infinito.
I
La leggenda del patto di fame
del pane della brocca del tetto della casa
danno chiaroveggenza le catene
impetuosa eloquenza
verso il coronamento di emozioni
corso maestoso di rivolte
per l’essenza del pane
prima la sommossa
dai fabbricanti di carte da parati
e in fabbriche di salnitro
all’ombra di un mistero
avevano avuto origine i diritti feudali
II
Diritto esclusivo di caccia di pesca di colombaia
bannalità di mulino di frantoio di forno
la proprietà eminente dei terreni
sulle terre il diritto di giustizia
il diritto di suite sui servi
sui soggetti alla manomorta
al tramonto del secolo ai contadini
gravami regi gravami ecclesiastici
la decima sui quattro grani grossi
avena segale grano orzo
il diritto di seconda erba
di spigolatura di stoppia
III
Non v’è borgo o città immune
dal contagio dell’empietà eterna
e da ogni fatale ineguaglianza
la chimera di manifatture
di cotone nei castelli
compie in abito nero
con mantello di seta
e cravatta di batista
l’effetto sublime delle filosofie
la sovranità nazionale si stende
sugli assolutismi vigorosi
il sale del dovere e la saliera
IV
I ferrai forgiano picche i delitti
immaginari secolari l’eresia
la lesa maestà si aboliscono
non si congela il libero gioco
sul voto non prevedibile
della sospensione regia
la grande memoria della collera
divide il vecchio ordine
disordine nel canto dalle officine
sui cappelli rami di quercia
ha un solo cuore il ricordo
e una felicità
V
Ha gli orecchini di lancia lei
presa all’amo della fedeltà e della virtù
scivola la chioma sotto un panno
a tre colori le labbra dei punti rossi
di pittura la gonna ruota sulle gambe
madreperle illuminate evocate
adorate messe a fuoco
nei riflessi di gocce di blu
il desiderio di guardare riscrive l’illusione
le convinzioni e le fonti di luce
sguardi fulminati seguaci si muovono
amanti dei diritti e delle libertà
VI
“Non sono un leone alato che dorme
i simboli nel momento d’oro crollano
le figure non incatenate si rifanno
branco di gazzelle in corsa
nella grazia dell’idillio civile
una lettera un corpo
tra braccia conosciute
corrispondenza egregia
la memoria sventa il futuro
custodisce nel calare delle storie
dei fogli di mare salato nelle spire
delle conchiglie ritrovate”
VII
“Non voglio mai più negare il volto
il canto di gloria trovato nel sangue
nelle onde profonde nella cenere
nei bordi lampanti dei cuori nella legge
di linee lontane delle ali mai sorte
le viole vicine le lezioni delle acque e delle terre
attraversano piedi costati occhi
le parole su parole come rame infilato
cherubini verso la redenzione
della corte dei savi estraggono l’anima
a distinguere il bene dal male al principio
e alla fine nell’immagine dell’ordine perfetto”
VIII
“Hai le labbra chiare come arancia in spicchi
singolarmente vera intinta nell’argento e nel ferro
parliamo in gran segreto dell’amore più forte
sulla bocca di tutti ridiamo dei capelli fulvi
che sfiorano la schiena alzati come raggi
gli anelli fermi nella mano guerriera serpi di bronzo
non si sospende la pace con le bandiere
velluto rosso canone rilucente di bellezza
fanfara luce tenera demone confidente
speciale autoritratto liberamente di fuoco
anello eterno sfaccettato grande rubino la poesia
innamorata rivoluzione ti ho conquistata”
Lia Rossi, insegnante di lingue e letterature straniere, vive a Reggio Emilia. Ha partecipato a rassegne internazionali di poesia visiva e fonetica.
Le sue poesie sono state pubblicate su riviste letterarie, quali Tam Tam, Steve, Squero, O/E, e nell’Antologia Geiger. E’ coautrice dei cortometraggi sperimentali Una scena da rifare (1980) , E’ colpa di Sara(1983) e Au revoir le langage (2016)
Ha pubblicato Versare con garbo (Ed. Tracce, ), Mail-non mail (Ed.Zona, 2013), Verso il gabbiano (Ed.Tecnograf, 2014), La stanza nella stanza (Ed.Tecnograf, 2015) .
Libri d’artista :Gioconda, 2016, Terno dei castelli, 2016 (per i gioielli-spilla di Elisa Pellacani), L’idea del drago, 2017(stampato sui torchi a mano presso il lab.Manfredi con incisioni di Stefano Grasselli), Carta Luna, 2018 (stampato sui torchi a mano presso il lab.Manfredi con incisioni di Elisa Pellacani).
Le opere Mail-non mail, Verso il gabbiano, Stanza nella stanza sono state premiate nell’ambito del Premio Lorenzo Montano 2012 , 2013, 2014, indetto dalla Rivista di Ricerca Letteraria Anterem.
Gianni Ruscio, "Proliferazioni", Eretica, 2017, nota di Flavio Ermini
Gianni Ruscio ci intima di riporre le armi, consapevole com’è che lo sconfinamento, la migrazione, la diaspora, l’esilio, l’esplorazione mediante percorsi impensati caratterizzano la poesia.
Non è certamente la significazione univoca a definirla.
Non è la regola, con le sue armi, a definirla.
La poesia cerca un altrove e un altrimenti effettivi; aspira a ciò che è radicalmente altro.
La creazione poetica è la voce terrena di una creatura che non può liberarsi dalla struttura interrogante dell’esistere umano, attraverso un ascolto in cui è impegnata ogni parte del nostro corpo. Inesauribilmente.
***
Il dorso del corpo del tempo sia
il raccolto del nostro intrecciare. Rispettiamo
questa narrazione - slacciata e riallacciata
da stralci di noi nel cordone spaziale,
e riponiamo le armi. Ripuliamo il corso
della superficie che da cardini antichi ci sorregge
in questa carne del luogo, angolo senza destino.
***
Pelle spiegata a ridosso del tempio,
tempo gemello, e in fronte il colore del vento.
Sensibile crosta di premonizione, sei sotto la pelle
di questa risonanza il motivo
della lotta, il colombo nel nido
che si accovaccia nel vento. E nel vento
tinge un sospiro, placa il suo alito,
riprende fiato, sterminato rinfresco.
***
Fammi la tua verità. Fammi inorganico. Rendimi
opaco. Cieco. Sei tu la sconfitta
dei miei occhi. L’unica. Sconfitta che genera
ritorsione del nulla dentro al nulla... unico sbocco
che in me vede senza guardare. Guardami,
guadami e per i tuoi demoni fammi libro
e costellazione.
***
Corri a ritroso per ritornare
verso la fine di ogni sedimento,
di ogni rottura. Sii finalmente lo scempio
della ruota. Del singhiozzo
il confine ultimo prima del dirupo.
Gianni Ruscio nasce a Roma il 7 dicembre 1984, dove vive tuttora. Ama Anna, Jago, il buon cibo, l’arrampicata e la vela. Pubblica il suo primo libro di poesie nel 2008, a 23 anni. Continua la sua ricerca e nel 2011 esce il canzoniere Nostra opera è mescolare intimità per le edizioni Tempo al Libro. Nel 2014 esce Hai bussato? per le edizioni Alter Ego, con prefazione di Roberto Gigliucci. Nel 2016 pubblica con la casa editrice Ensemble Respira, che si aggiudica una menzione al Premio Lorenzo Montano XXX edizione, e vince il premio di poesia italiana indetto dall’editrice Laura Capone. Interioranna, pubblicato dalla casa editrice Algra nel 2017, è la sua quinta pubblicazione, con prefazione di Gabriella Montanari. Il libro viene premiato con segnalazione al Premio Lorenzo Montano 2017. Proliferazioni, Eretica edizioni, è la sua sesta opera edita.
Patrizia Sardisco, prosa inedita "Disdire", premessa di Mara Cini
Una telefonata. Un filo lega due donne. Un flusso di pensieri uguali e contrari scorre da un capo all’altro, dal mondo senza saliva della madre ai lunghi corridoi vuoti nella testa della figlia. E’ il cordone ombelicale delle consuetudini, delle relazioni famigliari. E’ una comunicazione che ripete giorno dopo giorno il non detto.
Ci sono due monologhi che non riescono a farsi dialogo.
Nel pensiero un po’ inerte della figlia, si intravede la possibilità nascente di piccole energie (tiro su la cornetta…mi tiro su i pantaloni…tiro su col naso) innescate dalle richieste materne di cura e attenzione, da un innegabile “discorso amoroso”. Ma presto tutto è ricacciato, tirato giù, nella stagnante terra del non so più che dirle.
Dall’altra parte c’è una donna che si svuota… della sua voce in prevedibili ma inquietanti fiotti d’acqua fredda. Che dice e disdice. Ma il disdire del titolo a cosa si riferisce? Quegli accenni a un suicidio presunto (credo che morirò) sembrano ritrattati con motivazioni che rimandano alle parole di Dorothy Parker (autrice di un memorabile racconto che si intitola appunto “Una telefonata”): I rasoi fanno male; i fiumi sono freddi; l’acido macchia; i farmaci danno i crampi. (…) Tanto vale vivere.
Disdire
Lo so che è lei dal primo squillo lo so che è lei squilla da un altro mondo senza saliva quando chiama mia madre mi tiro su dal divano e penso che so che è lei e che è assurdo che mi prenda il panico però è così e non so che dirle non so più che dirle da quando mio padre se ne è andato in quel modo un pomeriggio di gennaio di una sfarinata di secoli fa una sfarinata di secoli fradici fa e infatti nemmeno oggi so cosa dirle oggi che potrei dirle semplicemente buon natale Catia anzi forse oggi è persino peggio è peggio perché so che oggi avrei dovuto telefonarle io avrei potuto telefonare io chiamare per dire anche soltanto ciao Catia ciao ma’ oggi è natale ma’ e io non vengo no ma’ non ce la faccio a passare e allora niente buon natale e poi cose del tipo cosa mangi oggi la fai una tombola con gli altri vecchi mia sorella è venuta a trovarti con i bambini c’era quel cazzone di suo marito o altre cose così cose da figlio ma il fatto è che io non mi ricordo che è natale cioè sì mi ricordo che è natale ma non ho nessuna voglia di accorgermi che me lo ricordo che è natale e nessuna voglia di accorgermi che non ho voglia di parlare con te ma’ però la tiro su la cornetta e l’appoggio precaria e fredda tra la faccia e la spalla e con le mani mi tiro su i pantaloni e non dico niente tiro su col naso e non dico niente aspetto in un angolo buio in uno dei lunghi corridoi vuoti che ho dentro la testa aspetto che la voce di mia madre cada come sempre come un capotto fradicio di neve perché lei si svuota sempre così della sua voce sempre così mia madre gelata e fradicia gravida come la madre di tutti i sensi di colpa l’ha sempre mollata così la sua voce dove capita come un pestaggio al buio e se non smette di nevicare in questo modo credo che morirò dice mia madre lei non dice mai pronto lei non si annuncia mia madre è un fiotto d’acqua fredda che aspetta l’apertura della valvola dice credo che morirò mia madre mi stendo con un flacone di pillole e buonanotte ma poi aggiunge buon natale mia madre e il tono è uguale dice buon natale con lo stesso tono che usa quando deve dirmi che le fa di nuovo male la gamba lo stesso di quando dice che perde di nuovo il cesso in quel cesso di posto dove è costretta a stare lo stesso con cui sta dicendomi che lo sapeva che non andavo a trovarla neanche oggi e almeno oggi una telefonata sì almeno oggi è vero? gliela potevo fare
Patrizia Sardisco è nata a Monreale, dove vive. Laureata in Psicologia, specializzata in Didattica Speciale, lavora in un Liceo di Palermo. Scrive in lingua italiana e in dialetto siciliano. Sue liriche e alcuni racconti brevi compaiono in antologie, riviste e blog letterari. Nel 2016 è stata pubblicata la sua raccolta poetica Crivu, prima classificata al premio “Città di Marineo”. Nel 2018 si è classificata al 2° posto al Premio città di Ischitella – Pietro Giannone con la raccolta inedita di poesie in dialetto Ferri vruricati (arnesi sepolti). Ha inoltre pubblicato Eu-nuca (Edizioni Cofine, 2018) e Autism spectrum (Arcipelago Itaca, 2019), entrambi con prefazione di Anna Maria Curci.
Ambra Simeone, prosa inedita "Provare a salvarsi", premessa di Mara Cini
Scrittura vs vita, è la costante che troviamo, palese o sottotraccia, nel lavoro letterario femminile. Abbiamo gli esempi laceranti e altissimi di Woolf, Cvetaeva, Plath…e gli esempi non pervenuti di tutte quelle pagine mai scritte, quando per partorire un racconto non c’è tempo.
Anche per le giovani donne dei nostri giorni si tratta spesso di scegliere se investire nei sogni o nella vita. La creatività richiede tempo e spazi e cervello libero. Dopo una giornata dedicata ai “normali” impegni famigliari ci si addormenta sulle pagine di un libro o davanti alla televisione, svuotate di ogni energia. L’ autostima sembra dover attraversare prima di tutto le necessità e i luoghi comuni della quotidianità: lavoro, casa, famiglia, cura dell’aspetto fisico…soldi, cibo, vestiti.
Siamo forse noi stesse a dirci vabbé i racconti non sono riusciti a farmi sentire migliore.
Ma provare a salvarsi è talvolta necessario, se non sarà letteratura sarà almeno un ritaglio d’autenticità.
Provare a salvarsi
scrivere aveva avuto la sua importanza, ora non più, non c’entra il blocco dello scrittore, ci sono altre cose che entrano in ballo, quando devi fare da cucinare, devi spolverare casa, la polvere, che non c’è da scherzare con l’allergia, dopo i trent’anni, dopo il trasloco è stata tutta una discesa con l’allergia, e non c’è più la mamma a impiattare la cena, a tenere casa pulita, ci sono altre cose che entrano in ballo, e ballare per scrivere è fuori discussione, no, non c’entra il blocco dello scrittore, devi pensare a fare la spesa, vedere il tuo conto in banca che scende a fine mese, e poi che si rialza, un pochino alla volta, non dobbiamo far prendere il sopravvento all’allergia, bisogna pensare a cosa fare di questa vita, che così come gira con un lavoro part-time a seicento euro al mese, proprio rischia di non girare più, eppure una volta scrivere aveva avuto la sua importanza.
adesso voi direte, una donna potrebbe fare tutto, siamo le wonder woman del nuovo millennio, lo dicono in tv, siamo tutte lavoro, passioni, palestra, stress da psicoterapeuta, un giorno forse figli, e mani che si allungano in qualunque direzione, afferrano, accarezzano, ammoniscono, addolciscono i visi, mentre poi c’è chi se ne sta a vegetare sul divano, senza motivo, ferma come un broccolo a pensare che forse sono sei mesi che non riesce a scrivere una parola, se non l’elenco della spesa sui post-it, cercare la calma, un solo attimo di pausa, adesso è meglio conservare le energie per qualcosa che ne valga la pena, tipo: soldi, cibo, vestiti, una casa decente senza muffa sulle pareti per sei mesi all’anno e senza polvere che entra sotto le porte per i restanti sei mesi, un lavoro decente, e poi crescere, crescere, crescere, finalmente, adesso, assolutamente, non puoi pensare al critico letterario che deve analizzare il tuo ultimo libro, non c’è da pensare all’editore che non ti pubblicherà mai il prossimo, ammesso che tu lo scriva veramente, un altro libro.
noi abbiamo le bollette da pagare, che partorire un nuovo racconto e sperare che si classifichi ad un concorso, non c’è tempo, non c’è più tempo, ora è il tempo di centrare la tua vita per qualcosa di vero, non la stupenda, magnifica finzione che vai digitando sul computer, hai la tua nuova raccolta pronta in pdf. e non hai ancora trovato qualcuno che speri in te, e perché dovrebbero farlo, ci sei già tu che non speri neppure più in qualcosa in cui credevi, è un ricordo vago, e allora ti aggrappi a tutto il resto, nella costante attesa che prima o poi non ne avrai più bisogno, forse non avrai più bisogno di sognare, che adesso abbiamo da pagare l’affitto di una casa rispettabile, tra sei mesi trovar- si un nuovo lavoro e poi perderlo e poi ritrovarlo, è una gran guerra, a dire la verità, ma chi ci pensa alla tua raccolta poetica, cresci una buona volta, c’è chi investe nei sogni, perché non investi nella tua vita, si tratta di una questione di scelta, questione di scelte.
io a non sapere neppure se questa storia ho voglia di raccontarla, invece meglio liberarsi, piuttosto iniziarla di punto in bianco e non sa- pere dove andare a parare, finirla non mi sembrerebbe giusto, forse sarebbe ora di fare un figlio, proprio adesso, prima che scada il contratto con il padre eterno, prima che l’utero ti dica no, noi a non sapere come va a finire questa storia, figuriamoci a capire la tua vita o a rendersi conto che il tempo sta per scadere, come sarebbe a dire, rinunciare a lottare è diventata la scommessa della tua vita, e intanto i quiz in tv non si fermano mai, non dai mai le giuste risposte o meglio hai imparato a non darle, perché non ti interessa di vincere, né di perdere, sei lì a chiederti se domani convenga comprare il ferro da stiro per le camicie, quelle non puoi proprio metterle addosso così stropicciate, neppure se le asciughi con l’asciugatrice, ma forse piuttosto che comprare il ferro da stiro, piuttosto che stirare, butto via tutte le camicie, faccio un repulisti, lancio l’assedio all’armadio, metto a morte il guardaroba, nuovo look all’outlet che con poco te la cavi, cambiare, cambiare, cambiare sempre, non è questo il motto del momento?
sì, scrivere poteva aver avuto la sua importanza, avere abbastanza ore che sembravano comunque poche, ora sono perfettamente distribuite, così tante, così perfettamente ordinate e pulite: colazione al mattino (10 min), chiacchierata col barista (15 min), spesa al supermercato (3 quarti d’ora), pranzo (dai 20 a 30 min) compresa la digestione, dai 5 a 10 per il lavaggio piatti, 5 min in macchina per arrivare in ufficio, 4 ore che diventano 6 per il turno part-time che durerà ancora per poco, cena come per il pranzo compreso il lavaggio dei piatti, 3 quarti d’ora in palestra, amici e socializzazione 15 min, doccia 10 min e poi tv fino allo svenimento, eccola lì, un’altra giornata senza aver scritto neppure una frase di senso compiuto.
quando l’io diventa noi, c’è poco da fare, il ballo a passo doppio costa a tutti, ma guadagni una ventata di sesso, soddisfazione, apprezzamento, sostegno, dolore, amore, un prezzo alto a cui non puoi rinunciare, voi mi direte, sarà solo il blocco dello scrittore, vedrai, ma poi a bloccarla lì per qualche anno, tutta quella finzione, tutto quel sogno, dove farla galoppare tutta quella fantasia, attendere magari che un’altra vita sia per essere vissuta meglio, quella che hai abbandonato prevedeva solo parole messe in fila che nessuno avrebbe mai letto, non vuoi certamente finire come quei depressi, quei maniaci, che stanno lì a contare quante copie del loro libro hanno venduto o a tenere corsi in scuole di scrittura creativa, come la maggior parte di quelli che hai avuto il coraggio di leggere e la fortuna di non conoscere, davvero non sarà la tua fine, ecco il problema è sempre stato quello, non avere in mente un finale migliore, adesso effettivamente, non ave- re un piano B è da stupidi, non c’è nulla di geniale, questo è un consiglio da chiedere a qualcuno, prima o poi, un giorno, dato che a noi stessi non ci riesce facile una risposta, che ci rimane lì in canna d’esofago e pur venendo su dallo stomaco, ti lascia solo l’acido in bocca.
altro che depressione, ve la farò vedere, venderò caro il mio talento, lasciate che io scelga le parole adatte per tenere una conversazione al bar, che quella vale più di mille racconti, e poi ad accorgersene solo nei momenti in cui non vorresti neppure alzarti dal letto, scambiare due chiacchiere con uno sconosciuto ti è stato più utile di quei mille racconti non scritti, che ne sarà di critici ed editori, ora che di libri non se ne leggono più, sono rimasti solo quelli che li scrivono allo stile di Calvino, Bukowski, Fante, a chi vuoi che interessi, a me non di certo, neppure quando spreco i miei quindici minuti al giorno a leggere la home di facebook, ti propongono poesie su facebook, ce ne sono in gran quantità, loro che se ne stanno lì a leggere, invece di stare in mezzo alla gente durante la movida del sabato sera, resistenza annunciata, resistere e non comprare niente, resistere e non far finta di non essere su una passerella, resistere in mezzo a tutta quella gente con tutta quella roba addosso, che a vederla dall’alto sembrano formiche con un sacco pieno di niente sulla schiena, tutte intente a portare le loro malinconie in giro per le strade, altro che mille racconti, altro che ottomila caratteri su un foglio bianco, sì, è vero, scrivere aveva avuto la sua importanza, ma non eccessivamente.
altro che sogni, niente racconti, non sono stati mica loro a consolarmi, quando per la prima volta ho guardato un padre e una madre negli occhi, il giorno che l’ho scoperto che anche loro possono morire, anche loro un giorno non ci sorrideranno più, la realtà è una donna che dovrebbe riuscire a fare tante cose, la società che te lo chiede, dovrebbe portare i pantaloni, mascherarsi, fare figli, lavorare, occuparsi della casa e magari di tanto in tanto fingere di fare l’amore per non dimenticarsi di essere viva, per evitare che il compagno la rimpiazzi troppo facilmente, invece di scrivere, puah, a tutti critici letterari, a tutti gli editori, a quei lettori invisibili, non sono stati i libri, né i racconti, né le poesie a farmi andare avanti, non sono certo serviti, quando li ho cercati, non mi hanno asciugato le lacrime nei giorni bui, niente consolazione da parte loro, quella la ricevi solo dalle persone, i racconti non sono riusciti a farmi sentire migliore... e allora adesso, perché piangi, stupida?
Ambra Simeone si è laureata in Lettere Moderne e specializzata in Filologia Moderna con il linguista Giuseppe Antonelli e una tesi dal titolo Lingua e varianti in “Ritorno a Planaval” di Stefano Dal Bianco. Ha pubblicato: Lingue Cattive, Come John Fante... prima di addormentarmi, Ho qualcosa da dirti - quasi poesie. È co-curatore con Ivan Pozzoni de Il Gustatore - quaderni Neon-Avanguardisti. Ha curato il volume antologico Scrivere un punto interrogativo. Suoi testi sono apparsi su riviste letterarie nazionali e internazionali: Kuq e Zi, Il caffè, Italian Poetry Review. Sue poesie sono apparse su antologie tra le quali: Il Quadernario Blu a cura di Giampiero Neri e Il rumore delle parole a cura di Giorgio Linguaglossa. Sono stati pubblicati saggi brevi tratti dalla sua tesi di laurea specialistica su riviste letterarie e in volumi: Rassegna storiografica decennale II e Frammenti di filosofia contemporanea XXII. La sua ultima raccolta è Opinionistica con prefazione di Claudio Damiani. Ha vinto il premio italo-russo Raduga come giovane narratore italiano. Sta lavorando ad una serie di saggi su Charles Bukowski.
Carlo Tosetti, dalla raccolta inedita "Parigi e tempi altri", nota di Laura Caccia
Lo splendore del vero
Poliedriche e rammemoranti, eterogenee e in sé concluse, ciascuna sospesa nella sua dimensione naturale o letteraria, le visioni che emergono dalla raccolta Parigi e altri tempi di Carlo Tosetti paiono somigliare ad una raccolta di inquadrature diversificate, fotogrammi fermati nel loro spazio-tempo, quasi un museo personale dell’autore.
Simili a quegli oggetti, quadri, fotografie, tra cui frugare nelle bancarelle del Marché di Paris, come nella poesia che dà titolo alla raccolta: “Poi che cerchi? / Dove frughi passate / le gravi meraviglie / dei musei ed incontri …?”. Simili anche a fondali, vari e disparati, che vengono di volta in volta scelti e illuminati con tocchi spesso pittorici, nel riverbero stratificato di echi di spazi e tempi lontani.
Sono spazi che richiamano luoghi naturali e urbani: ciascuno descritto nei suoi forti richiami alla presenza umana e, insieme, al pensiero che vi si affaccia. E sono tempi che costituiscono un richiamo a quanto il passato ha lasciato depositare e arricchire, rispetto alla “bolla d'inerte / presente dove attorno / procombe ed insorge / nuovamente ogni cosa”, come scrive l’autore, nel suo stile senza artifici e lontano dalla retorica, attraverso sguardi nitidi sulle cose e richiami pensosi alle presenze umane.
Gli spazi e i tempi richiamati nei testi non restano in tale modo neutri contenitori, ma si colorano di incontri, presenti e passati, reali e letterari. Sono filosofi, registi, scrittori e poeti a cui l’autore dedica i suoi versi o di cui richiama i luoghi scelti per le loro sceneggiature.
Come le piscine termali di Bagno Vignoni, sulle quali aleggia lo spirito di Andreij Tarkovskij “il respiro suo, / l’assimilare il genio / delle Naiadi che spande / il fumo vaporoso e guaritore”, oppure il parco parigino des Buttes-Chaumont, scelto dalla regia di Éric Rohmer “che vi pinse gli acquerelli / della lieve nouvelle vague”, o ancora il luogo immaginario della fortezza di Dino Buzzati nella poesia ispirata a Il deserto dei Tartari che conclude la raccolta, dove luoghi e tempi si rarefanno nell’attesa, in quell’indugio “palesato dal nulla lontano, / dal siderale niente remoto”.
La nostalgia, lo sguardo, l’attesa: quadri, anch’essi, come i testi che Carlo Tosetti delinea via via, nel tentativo, forse, di far emergere quello splendore del vero, indicato da Jean-Luc Godard come elemento caratterizzante la cinematografia della Nouvelle Vague.
Accostando visioni delineate nelle loro precise dimensioni spazio-temporali a elementi di partecipazione umana e di riflessione, dove la parola agisce da macchina da presa in grado di mettere a fuoco simultaneamente i campi lunghi e i primissimi piani. Quasi un effetto straniante, in una poesia che si fa luogo di raccolta di paesaggi e momenti dello stupore e della riflessione, della meraviglia e del quotidiano.
Due cimiteri militari
I
Si apre sconfinata,
dei gusci la distesa
di bivalvi scardinati:
il caos, le cappelunghe,
alcune le inquadra
in laconiche righe,
l’omaggio minerale
al cimitero americano.
L’altre che i gorghi
dell'onde l’incrocia,
infinite, frantumate,
creano giustapposte
orazioni del mare,
a mezzo miglio dalla costa
risucchiato per prodigio
e planetaria congiuntura.
Al Glicine
Figuro tutti bambini,
nella bolla d'inerte
presente dove attorno
procombe ed insorge
nuovamente ogni cosa,
ma sempre indifferenti,
a sfiatare noi s'andava
su per la china, al Glicine fino,
ansando per succhiare
l'ambito ghiacciolo.
A lasciare che affacci l'idea
(di sotto romba la Bova)
che poco ne abbasti
e ci soffochi un rivo,
s'opponeva il tritone,
che viscido sguscia
dalla mano nell'acqua
e poi, fluttuando, si posa.
Tarkovskij
A ristorarci nella Piazza
delle Sorgenti gustammo
vino rosso e pici,
e meglio avremmo fatto
credo ad emulare
non le penitenze
di Santa Caterina
ma il respiro suo,
l’assimilare il genio
delle Naiadi che spande
il fumo vaporoso e guaritore;
immobili e cotti,
nella piscina rispettosi
del voto al matto di Gorčakov.
Carlo Tosetti (Milano, 1969), vive a Brivio (LC).
Ha pubblicato le raccolte: Le stelle intorno ad Halley (LibroItaliano, 2000), Mus Norvegicus (Aletti, 2004), Wunderkammer (Pietre Vive, 2016).
Suoi scritti e recensioni sono presenti su:
Nazione Indiana, Poetarum Silva, Larosainpiu, Paroledichina, Words Social Forum, Versante Ripido, elvioceci.net, Il Convivio, Lankenauta, Interno Poesia, www.giovannicecchinato.it, Poesiaultracontemporanea; Atelier.
È stato ospite della trasmissione Percorsi PerVersi, in onda sulle frequenze di Radio Popolare, il 30/01/2017.
Collabora con Poetarum Silva.
Blog personale: musnorvegicus.it
Luca Vaglio, "Il mondo nel cerchio di cinque metri", Marco Saya Edizioni, 2018, nota di Flavio Ermini
Quando un essere umano nasce, con lui nasce un mondo. Esordisce un paesaggio entro il quale l’uomo e la donna vivono senza consapevolezza.
Nel corso della nostra breve storia evolutiva non abbiamo ancora imparato a pensare.
Si va dall’ininterrotto al balbettio della vita di tutti i giorni.
Entriamo nel perimetro della nostra esistenza come dentro un paesaggio dipinto, un paesaggio artificiale.
Eppure anche là dove la natura si fa apparente, più avventuroso e sofferto diventa l’esistere nel mondo; in particolar modo nello sperimentare il proprio corpo; nel sentire noi stessi; nel rapporto con l’altro, che è rapporto con la parola e con il tempo.
***
considera sempre il commiato
le persone al tempo dell’addio
quello che succede, che cosa fanno
prima di fare a meno di te
***
si comprende una città soltanto
quando non si ha nulla da fare
***
alla radice dei pensieri
dentro il segreto interno
dietro la materia che si vede
si vive sempre
come in attesa
prima dell’inverno
fuori dall’inferno
nell’infanzia delle cose
***
molto più di quello che dici
sulle grandi cose del mondo
conta per me l’uomo che sei
nel cerchio di cinque metri
se e come mi saluti e come
mi sento a pochi passi da te
***
guardare la luce degli altri
e niente volere rubare
nulla distruggere mai
alla fine non uccidere
essere appena parte lontana
osmosi di una sola passione
è sempre qui il tutto
che dice, il significato
la rivolta, l’etimologia
della rivoluzione
Luca Vaglio vive a Milano, dove lavora come giornalista. Il mondo nel cerchio di cinque metri è il suo terzo libro di poesia. In precedenza, ha pubblicato Milano dalle finestre dei bar (Marco Saya Edizioni, 2013), La memoria della felicità (Zona, 2008), il saggio-inchiesta Cercando la poesia perduta (Marco Saya Edizioni, 2016) e il racconto In riva al Lario (Lite Editions, 2013). La sua ultima pubblicazione è il romanzo Il vuoto (Morellini Editore, 2019).
Ultima pagina: Aida M. Zoppetti, due libri, frammenti critici e biografia
Dalla prefazione di Massimo Gualtieri a “Una coltivazione di forme”:
[…] “Una coltivazione di forme” fa parlare, o meglio, è parlata, da tutto un catalogo di enti minori, di marginali assenti. Qui, più che leggere, siamo letti: facciamo esperienza. Fare esperienza di un libro di poesie – coltivarne, appunto, le forme – comporta un agire e implica dei rischi. A questo insieme di asimmetriche aiuolette va rigorosamente anteposto il verbo praticare. Perché questo non innocuo paesaggio necessità sì di una certa attrezzatura, ma soprattutto sta a indicare quanto laboriosa e meticolosa sia ogni trasformazione del fare. La poesia si dà nel fare, gli è contemporanea. Fare esperienza di una poesia che si dà nel fare è già un ritorno all’originario contenuto delle parole greche logos e legein , quando non significavano ancora discorso, dire, e le parole non avevano alcun immediato rapporto con il linguaggio. Logos e legein sono parole care ad Heiddeger che, richiamandosi ad Eraclito, ridarà ad esse un senso molto particolare, un senso che abbiamo già ritrovato: quello di “raccogliere”, di “porre a fianco”, di “mettere in ordine”. La coltivazione, insomma. […]
Aida M. Zoppetti è nata a Bergamo, dove risiede. Alla fine degli anni ’70 ha fondato e diretto con Massimo Gualtieri e Ugo Pitozzi la rivista di poesia e sperimentazione visiva “North”. E’ apparsa in numerose antologie di letteratura contemporanea. Suoi testi figurano in Tracce, Tam Tam, Lettera, Anterem, Aperti in squarci, Salvo Imprevisti, Théâtre du silence, El Bagatt, L’area di Broca, Thesis, Risvolti, Il Verri.
Ha pubblicato “Una coltivazione di forme” e “Di Lama e di Luna” per Anterem, “Generation of Vipers” per Signum Edizioni d’Arte, la plaquette: “Piume, poesie visive e volatili” per Dialogo Libri, “Messieurs, mettez du blanc dans l’ombre” e “Blu biscotto” per le Edizioni “Alla pasticceria del pesce” dirette da Claudio Granaroli, “Ora che tutto il tempo è notte” per la raccolta “Lavoro dopo” della CGIL. Ha illustrato “Frisbees della vecchiaia” per Giulia Niccolai.
In questo momento si dedica alla poesia visiva.
ps Le note contrassegnate dai numeri 3 e 5 sono di Tiziano Salari






Aprile 2019, anno XVI, numero 43

Prosegue in questo nuovo numero la pubblicazione degli autori che hanno caratterizzato l’edizione 2018 del Premio Lorenzo Montano, tutti presentati dall’intera redazione di “Anterem”: una bellissima istantanea scattata a una significativa parte di recente poesia italiana.
Il lavoro del Premio intorno alla poesia e alla prosa, attraverso opere edite e inedite, pone un’altra pietra nell’edificazione di uno spazio che continuerà a rimanere disponibile e aperto a tutti: la sua dimensione, in continua evoluzione, è testimoniata dall’ultima pagina di questo numero di “Carte nel vento”.
Andiamo avanti, con la 33^ edizione del “Montano” che scade il 15 aprile: scarica il bando
In copertina: Giorgio G. Adami, a sinistra “Astract”, a destra “Pittura paesaggio”; olio e smalti su carta.
Viola Amarelli, da “Il cadavere felice”, Edizioni Sartoria Utopia, 2017, nota di Flavio Ermini
L’impossibilità di mettere a fuoco le cose, e definirne i contorni e i particolari, si rivela come luogo d’incontro con il sé.
Si esplicita in un peculiare gioco di specchi e di cornici mobili. Impone al lettore di abbandonare lo stato d’immobilità e di lanciarsi in avanti, perché la chiave del pensiero va sempre trovata nella fluidità dell’erranza.
Quella che Viola Amarelli propone è una poetica che ha trovato la sua filosofia in quelle forme che, proprio per la loro indeterminatezza, richiedono parole assolutamente precise.
Sono parole su cui si fonda un poema scandito in due momenti: uno sguardo sull’esterno che preannuncia lo sguardo verso il proprio interno; e uno sguardo sull’estraneo che anticipa lo sguardo sul familiare.
Dalla sezione “Cronache”
***
le belle parole
le giuste
le sufficienti
quelle necessarie
finiscono nello stesso
punto dove nascono.
il silenzio – sipario
Dalla sezione “Dèmoni”
***
vi vedo dietro il vetro,
non vi tocco, un lucido delirio
l’urlo muto, pesci:
chi è il morto
morto morto morto
fare il morto sull’acqua
vivo
passa il sale
sale le scale avvolge il suono
emette e squaglia
gioia
per poco
siate siate
gioiosi
l’intento tenace
non s’ulcera più
lo sbrego, diruto
l’io spiritato,
arso, scomparso
***
aveva cuore, il sufficiente
ma l’anima, oh
quella, era venduta
e ne avvertivi
perfino in bocca
perfino tra le cosce
pallida l’evanescenza,
ammalorata.
***
uno sciame di mediocrità
ronzanti sulla polpa - quel che resta –
sull’osso, ma
il cadavere - dicono - felice
Viola Amarelli, campana, ha esordito con la raccolta di poesie “Fuorigioco” (2007, Joker), seguita dal monologo “Morgana” (2008, Vico Acitillo e-book), dal poemetto “Notizie dalla Pizia” (2009, Lietocolle), “Le nudecrudecose e altre faccende” (2011, L’arcolaio), i racconti di “Cartografie” (2013, Zona), le poesie di “L’ambasciatrice” (2015, autoprodotto) e di “Il cadavere felice” (2017, Sartoria Utopia), le prose in prosa di “Singoli plurali “(2016, Terra d’ulivi) e, in veste di co-autrice, “La deriva del continente” (2014, Transeuropa) e “La disarmata”(2014, CFR). È presente in numerose antologie, riviste cartacee e on line, suoi testi sono stati tradotti in Germania.
Daniele Barbieri, dalla raccolta inedita “cuore amore dolore”, nota di Giorgio Bonacini
La poesia e l’amore da sempre intrecciano i loro cammini e si potrebbe anche pensare che siano nati insieme: quando la parola ha sentito che quel sommovimento psicofisico ha avuto necessità di dirsi. E da qui, il sovvertimento del comune senso di intelletto ed emozione, verso una trasformazione mai fissata e spesso sfuggente, si è legato alla sua pronuncia significante. Così, leggere in queste pagine versi come “voglio restare acquattato/nelle pieghe del tuo amore” come una mistica tenia/che si nutre di dolore”, non può non far scattare nella mente del lettore, la sensazione di essere dentro una meravigliosa turbolenza. Nella scrittura di Daniele Barbieri il dibattersi dei turbamenti produce un andamento ritmico punteggiato da scansioni sillabiche che risuonano al ritmo di un’ondulazione, che si inarca verso se stessa e allo stesso modo dentro una dissoluzione del senso, non mortificante ma rigenerante in “nome dell’amore”. La lingua poetica è gesto vocale fatto di una sostanza che, nella dimensione del sentimento, si fa materia: esistenza che configura lo stupore anche nella perdita d’amore, con una tensione netta, lì dove “il cuore piange nero grida bianco”. Dunque nessun sentimentalismo, neanche il più lucido o freddo. L’autore muove i suoi testi dentro un reale divorante: esattamente così com’è. Non tutto però, nell’impeto d’amore, può dirsi. C’è una pronuncia che resta lì, chiusa, nemmeno balbettante, più che muta. Per poi improvvisamente esplodere e trascinare con sé la trappola della passione: con una versificazione stringente, battente a rima alternata, in un galoppo fluido e spedito. Fino al paradosso più doloroso, dove “l’assenza di qualsiasi patire/è il patire più vero”.
Dalla sezione “Fiore”
è quello che voglio dire
è quello che voglio fare
è così che voglio incidere
è così che voglio amare
come un silenzio che grida
voglio entrare nel tuo cuore
come un grido nel rumore
voglio restarci invisibile
voglio restare acquattato
nelle pieghe del tuo amore
come una mistica tenia
che si nutre di dolore
Dalla sezione “Calore”
niente magia niente fate in questa storia, solo un grande
deus-ex-machina a sancire questa impossibilità
di separarli, e la tragica necessità di unirli
nel loro ultimo viaggio, ma, santo dio, e se avessero
continuato da lontano a vagheggiarsi, e lungo tempo ancora,
non sarebbe stato meglio, o è proprio l’amore quello
che consuma sino in fondo?
Dalla sezione “Rumore”
il frastuono della moto entra in mezzo alle note di
John Coltrane, passi giganti e le mie cose preferite,
quasi i Pink Floyd della madre atomo cuore, non l’ascolto
quasi la musica forse quasi la guardo composta
com’è di frammenti di memoria, frammenti di cose
che si chiamano tra loro, o si chiamano come me
hanno il mio nome, lo giocano in mezzo alle note di
qualsiasi musica, come un modulato ritornello
dove i fatti della vita sono voci di una fuga
di cui il pianista da molto tempo ha perduto il controllo
Daniele Barbieri vive quasi da sempre a Bologna, pur essendo nato non molto lontano, e insegna presso l’Accademia di Belle Arti.
Ha pubblicato, oltre a tanti articoli, diversi libri di carattere teorico sulla semiotica, sul fumetto e la comunicazione visiva, sulla musica e anche sulla poesia: Valvoforme valvocolori (Idea Books 1990), I linguaggi del fumetto (Bompiani 1991), Questioni di ritmo. L’analisi tensiva dei testi televisivi (Eri/Rai 1996), Nel corso del testo. Una teoria della tensione e del ritmo (Bompiani 2004), Tensioni, interpretazione, protonarratività (a cura di, numero monografico di VS, 98-99, 2004), L’ascolto musicale. Condotte, pratiche, grammatiche (a cura di, LIM 2008), Breve storia della letteratura a fumetti (Carocci 2009), Il pensiero disegnato. Saggi sulla letteratura a fumetti europea (Coniglio 2010), Guardare e leggere. La comunicazione visiva dalla pittura alla tipografia (Carocci 2011), Il linguaggio della poesia (Bompiani 2011), Maestri del fumetto (Tunuè 2012), Semiotica del fumetto (Carocci 2017). Ha pubblicato due raccolte di poesie: La nostra vita, e altro (Campanotto 2004) e Distonia (Kurumuny, 2018). Un’altra silloge, Canzonette, è apparsa nel volume collettivo Emozioni in marcia (Fara Editore 2015). Le sue poesie si possono leggere settimanalmente sul blog ancoraunaltrome.wordpress.com.
Altre info su di lui, e sue riflessioni sul mondo, all’indirizzo www.guardareleggere.net.
Simone Burratti, da “Progetto per S.”, Nuova Editrice Magenta, 2017, nota di Flavio Ermini
Questo libro rappresenta un uscire sbattendo la porta. Un piegare con la forza i propri pensieri nel tempo e nel luogo della poesia, così distante dall’autismo omologato che caratterizza l’età moderna fin dal suo inizio.
È necessario un sempre più vigile senso di responsabilità nei confronti dell’essere umano.
Ma, attenzione, da questo lavoro non nasce un’astratta opera concettuale, bensì una casa imponente che consente un abitare che tanto assomiglia a un vivere poetico; un’acquisizione che non pone termine a una ricerca, ma al contrario le dà un senso e un impulso nuovi: descrivere quelle modalità della vita che rendono vivibile il nostro percorso terreno.
Quarti della notte
1.
Il cielo deve essere nuvoloso. Per il resto, può accadere in un momento qualsiasi della giornata. Lo sguardo si fissa su un punto imprecisato e le voci non sono piú importanti.
Allora c’è un salto nel tempo, e ci si ritrova già lungo la strada. Il passo è solenne e trascinato. Si procede a testa bassa, sotto un cielo minaccioso, nascondendosi il lampo negli occhi.
2.
In camera, sulla scrivania, il cervello si espande. Sotto la lampada si esibiscono le mani bianche. I polpastrelli provano il vetro del bicchiere, punto di ancoraggio di tutto il corpo; gli occhi si stringono con una sofferenza.
Ogni qualche minuto lo si porta alle labbra con la giusta, calibrata trascuratezza. Il liquido scivola lungo il sangue, fa rovesciare la testa all’indietro: in questo modo è possibile stiracchiare il collo e, nello stesso tempo, interrogare il soffitto.
3.
Voglia di uscire a cercare la notte. L’inquadratura si allontana, rivelando una spalla contro la colonna, mentre si resta attoniti col naso all’insú: il cielo si è liberato.
L’odore degli alberi, le stelle fisse: tutto torna a significare qualcosa. Ci si sente di nuovo bambini e si immaginano cose.
In a Landscape
Il cielo si trasforma sotto gli occhi di chi guarda,
è piú veloce degli alberi che crescono,
piú lento dello sguardo che lo passa in rassegna
cercando qualcos’altro, ma che sia sempre al di qua,
da questa parte concava del cielo,
e quindi facce, progetti, ombre, ricordi
di appuntamenti persi con il tempo, e ancora sagome,
aerei, dita puntate, sogni, proiezioni – nuvole:
la piú insulsa forma d’intrattenimento,
perché il cielo si trasforma continuamente,
e si spegne, di regola, e delude
come sempre le cose che si amano.
True Ending
È una mattina dopo un temporale senza tracce – un balcone troppo in basso, un’incapacità di intenti, una catastrofe avvertita e mai avvenuta. O forse qualcosa è avvenuto ma solo una mattina dopo l’altra, dietro le tapparelle degli occhi, lo stesso di quando i piedi hanno sentito il materasso troppo corto, e poi troppo usurato, e poi nessuna mamma o donna è piú comparsa sulla soglia della stanza, come un presentimento che si avvera. Comunque c’è il sole. Fili invisibili si tracciano e riflettono nella luce entro il paesaggio di una casa, un cortile, un appartamento residenziale collocato al limite con la campagna. L’uomo sorride con disinvoltura. In certi momenti la sua vita è stata come una cascata, adesso i lineamenti sono rilassati e netti, espressioni trattenute sul viso molto a lungo. Nessuna sensazione, nessuna paura umana, soltanto una presenza fuoricampo. Fuoco: una di quelle cose di cui non sente la mancanza. L’azione perduta di chi non rientra nell’inquadratura, di chi è già andato altrove, eclissando la memoria, senza lasciare altro che un’espressione di rimando, una storia o un’immagine. Nessuna sensazione, nessuna paura umana, soltanto una mancanza fuoricampo. C’è il sole, co- me se niente fosse. S. lo nasconde con l’icona del Cestino.
Simone Burratti (1990) studia e vive a Padova. È stato redattore del sito formavera. Sue poesie e traduzioni dall’inglese sono uscite su vari blog e riviste. Questa è la sua Opera Prima.
Rinaldo Caddeo, una prosa inedita “Il silenzio dei deportati”, nota di Davide Campi
Quando il poeta entra nella storia, da poeta, con tutti i sensi aperti, con tutte le parole portatrici di pensiero, con la conoscenza, riesce in un sussurro penetrante a dire con forza di tremendi silenzi.
Quasi sottovoce, in un lascito testamentario.
All’attenzione di questo coinvolgente saggio breve c’è il silenzio, qui analizzato e sviscerato come effetto del contatto con il puro male dell’esistenza. A questo proposito Rinaldo Caddeo inizia e chiude il suo testo con riferimento alle drammatiche testimonianze di Liliana Segre; e ne coglie inedite analogie (letterarie) e differenze (storiche, antropologiche, morali) con i versi inerenti Ugolino della Divina Commedia dantesca e con quelli delle poesie del periodo bellico di Ungaretti.
Il silenzio dei deportati
È dagli anni ‘90 che Liliana Segre fornisce una testimonianza orale della persecuzione degli ebrei (dopo l’emanazione delle leggi razziali fasciste) e dell’internamento nei lager nazisti dopo l’8 settembre ’43. Nel 2018 questa testimonianza ha trovato un’articolazione biografica scritta con La memoria rende liberi (BUR) e con Fino a quando la mia stella brillerà (PIEMME).
Fin da subito la sua testimonianza di tredicenne sopravvissuta ad Auschwitz risulta nitida e puntuale, aderente a un vissuto unico ed esemplare. Sul numero del 4-5-94 del quotidiano La Repubblica, nella rubrica milanese la città della memoria (p.VII), questa testimonianza offre un angolo visuale interno su di una fase, la deportazione, di solito trascurata.
Dice nell’intervista: “I vagoni vennero sprangati e piombati. Ci guardammo intorno, c' era solo un po' di paglia per terra e un secchio per gli escrementi, che ben presto si riempì debordando. All'inizio si sentiva piangere, gridare, alcuni chiedevano aiuto, i più fortunati pregavano. Nei giorni seguenti, invece, ci fu un silenzio solenne, si sentiva soltanto il rumore del treno, che implacabile ci avvicinava all' inferno a cui eravamo destinati e che ci allontanava sempre di più dalle nostre vite. Io e mio padre trovammo un angolino di parete a cui appoggiarci e, stretti una all'altro, non avevamo più bisogno di parlare: fu silenzio per sei giorni, gli ultimi della nostra vita insieme.
La mattina del 6 febbraio, il treno si fermò definitivamente alla rampa di arrivo di Auschwitz”.
Consegnata a Dante e a noi da Ugolino stesso, la "straordinaria umanità ed inumanità della storia di Ugolino", (Attilio Momigliano), non ha perso di intensità. Anzi, dopo sette secoli, riverbera un nuovo stigma euristico paradigmatico.
Entrambi i testi scandiscono le tappe di un viaggio nell’aldilà nella dimensione di una discesa agli inferi. Sia nella narrazione dantesca, sia in quella di Segre, si possono riconoscere quattro fasi: 1) l’atto della reclusione definitiva, 2) lo sguardo della fine, 3) il pianto, 4) il silenzio:
1) l'atto di una separazione ermetica e reclusione definitiva dal consorzio umano civile. In Segre: "i vagoni vennero sprangati e piombati".
In Ugolino: "e io senti' chiavar l'uscio di sotto/ a l'orribile torre".
2) L'atto di un guardare-guardarsi che identifica l’irreparabile.
In Segre: "Ci guardammo intorno".
In Ugolino: "ond' io guardai/ nel viso a' mie' figliuoi sanza far motto".
3) il pianto della disperazione, l'invocazione dell'aiuto:
In Segre: "All'inizio si sentiva piangere, gridare, alcuni chiedevano aiuto, i più fortunati pregavano."
In Ugolino: "Io non piangea, sì dentro impetrai:/ piangevan elli”.
4) il silenzio. In Segre: "Nei giorni seguenti, invece, ci fu un silenzio solenne, si sentiva soltanto il rumore del treno, che implacabile ci avvicinava all'inferno a cui eravamo destinati e che ci allontanava sempre di più dalle nostre vite."
In Ugolino: "Queta'mi allor per non farli più tristi;/ lo dì e l'altro stemmo tutti muti;/ Ahi dura terra, perché non t'apristi?"
Silenzio sillabato dal rintocco meccanico delle rotaie nel carcere mobile del vagone piombato. Scandito, nella torre della muda, dall'alternarsi impassibile del giorno e della notte. Non è soltanto un silenzio provocato dall'esaurimento delle forze, c’è un silenzio più profondo. Un silenzio abissale che avvolge tutto e tutti. Un silenzio che toglie l'ultima parola rimasta in gola. Il silenzio dell'implacabile. Dante, con la bocca di Ugolino, dice: stemmo tutti muti. Nel mutismo c'è il sigillo di una chiusura senza scampo. Nella testimonianza della Segre il silenzio assume un senso ulteriore, che apre un'altra possibilità: “Io e mio padre trovammo un angolino di parete a cui appoggiarci e, stretti una all'altro, non avevamo più bisogno di parlare: fu silenzio per sei giorni, gli ultimi della nostra vita insieme”. Un silenzio ambivalente. Quando tutto diventa segno di morte e annuncia morte, ogni grido o parola consumati, non resta che la rinuncia a ogni segnale, il ritrarsi in un guscio interiore, in un ultimo, concavo, ricettacolo di sopravvivenza: il silenzio di un risparmio vitale, avvolto da un tutto fatto di morte, ultimo barlume di speranza. Silenzio della soglia tra vita e morte. Sigillo dell'assoluto, da salvaguardare nello scrigno più remoto e profondo di sé. Silenzio solenne, lo definisce la Segre. Silenzio auto-difensivo e sacro-rituale, rito di passaggio da un mondo a un altro mondo, con altre regole, altre segnaletiche, altri significati. Ne parla anche De Benedetti: "Il treno si mosse alle 14. Una giovane che veniva da Milano per raggiungere i suoi parenti a Roma, racconta che a Fara Sabina (ma più probabilmente a Orte) incrociò il «treno piombato», da cui uscivano voci di purgatorio. Di là dalla grata di uno dei carri, le parve di riconoscere il viso di una bambina sua parente. Tentò di chiamarla, ma un altro viso si avvicinò alla grata, e le accennò di tacere. Questo invito al silenzio, a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano, è l'ultima parola, l'ultimo segno di vita che ci sia giunto da loro." (Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943, Sellerio, Pa. 1993, p.63).
Di silenzio ci parlano altri capitoli della testimonianza di Liliana Segre sia in La memoria rende liberi, sia in Fino a quando la mia stella brillerà. C’è il silenzio dell’indifferenza degli spettatori, di chi si volta dall’altra parte, c’è il silenzio dell’angoscia senza scampo degli internati nei lager. È il silenzio nullificante degli uomini fantasma di cui si parla nel film Shoah di Claude Lanzmann e di cui parla Levi, all’arrivo ad Auschwitz: “Tutto era silenzioso come in un acquario e come in certe scene di sogni. “ (Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, To. 1958, p.26).
C’è il silenzio, dopo la fine della guerra, di chi non vuole più sentir parlare di atrocità.
C’è il silenzio dell’ebreo errante come un tacere, di cui Celan in Conversazione nella montagna dice: “nessuna parola è stata soppressa e nessuna frase, è semplicemente una pausa, è una lacuna di parole, è un vuoto, tu vedi tutte le sillabe sparse intorno” (Paul Celan, La verità della poesia, Einaudi, To. 1993, p.43).
C’è il silenzio di Ungaretti.
Poesia: "[...] Quando io trovo/ in questo mio silenzio/ una parola/ scavata è nella mia vita/ come un abisso". Veglia: "Un'intera nottata/ buttato vicino/ a un compagno/ massacrato/ con la sua bocca/ digrignata/ volta al plenilunio/ con la congestione/ delle sue mani/ penetrata/ nel mio silenzio/ ho scritto/ lettere piene d' amore// Non sono mai stato/ tanto/ attaccato alla vita": è nel silenzio interiore che la parola poetica attinge nuova linfa di amore e vita.
Ugolino è un personaggio della Commedia, collocato da Dante-autore nel lago di Cocito dei traditori a divorare per l’eternità il cranio del suo carnefice, l'arcivescovo Ruggieri. Davanti al Dante-attore del viaggio nell' oltretomba, Ugolino racconta, mosso da pietà e da vendetta, la sua storia che termina con l’ambiguo endecasillabo: "poscia, più che 'l dolor, potè 'l digiuno”. La vivida testimonianza di Liliana Segre, invece, risarcisce anni e anni di silenzio, con carità, senza spirito di vendetta.
Rinaldo Caddeo ha pubblicato quattro raccolte di poesie (Le fionde del gioco e del vuoto, Narciso, Calendario di sabbia, Dialogo con l’ombra), una raccolta di racconti (La lingua del camaleonte) e una di aforismi (Etimologie del caos). Ha inoltre pubblicato Siren’s Song, selected poetry and prose 1989-2009, una raccolta antologica di testi in italiano con testo a fronte in inglese.
I suoi aforismi sono apparsi sulle antologie: Nuove declinazioni (2005) e, tradotti in inglese con testo a fronte, The new italian aphorists (2013).
Ha pubblicato saggi critici, recensioni, racconti, aforismi, traduzioni e poesie su diverse riviste.
I suoi due saggi più lunghi sono stati Ombre e impronte intertestuali in Buzzati e Gli animali e il mimetismo in Giampiero Neri, apparsi in due volumi di critica: L’attesa e l’ignoto su Buzzati, e Memoria, mimetismo e informazione su Neri.
Maria Grazia Calandrone, da “Il bene morale”, Crocetti, 2017, nota di Rosa Pierno
Un ago che serra i bordi di cose distanti come il “cuore molto bianco che in realtà rimanda alla nostra mente” lavora alacremente nei testi poetici di Maria Grazia Calandrone per ricondurre ciò che è sparso disordinatamente in un medesimo insieme. L’unione è nel cuore delle cose, ecco dunque che bisogna cercare l’essenza di ogni oggetto naturale per trapassare, tramite analogia, al corpo umano e in tal modo inserirlo - non più dunque visto come corpo estraneo alla natura - nel ritmo pulsante di un onnicomprensivo elemento. La ruggine diviene “scia emorragica”, “l’arancione” diviene sole, alla ricerca dell’unità perduta. Per tale via il corpo stesso diviene altro, si fa ombra, “un minerale bianco” o, ancora, “superficie”. La Calandrone cerca dovunque l’unità, anche nei forni crematori, a Fukushima, a L’Aquila: cerca ovunque vi sia dolore, poiché l’unità non ne viene distrutta, ma anzi insegna a reclamare ancora più fortemente il bene.
Le metafore dell’amor perduto
Io avevo solo detto: tagliami i rovi e quello mi ha buttato davanti alla casa tutti quei tronchi decapitati, una scena di muscoli combusti, l’ossario nero e contorto dell’abbandono. Ma ogni volta tutto il mondo va a capo dopo la morte, è cosí che succede.
1. Frutti dell’abbandono
Questo è il mio corpo
un minerale bianco
illuminato – vera
misericordia della materia
accesa come un cero
che ricorda soltanto la tua bocca.
Questa è la luce cieca del frutto
una esalazione di particelle
indispensabili alle sequenze di sole
su ovari bianchi.
La materia celeste della scomparsa
tra i fiori del giardino.
Qui tutto è colmo di benevolenza e le turbine
ronzano a mezzacosta.
Questa è la vigna delle mie ossa
la colonna che torna
alla calma iniziale,
ma uno sguardo
non ha ancora la pace della maceria,
nell’oggetto qualcosa si apre: un filo
di silenzio, una passione, l’ultima
esitazione.
L’idiozia o lo splendore della bellezza
Adesso credo necessario un ottuso atto di fiducia nella bellezza. Agire come non fossimo mai stati. Come non fossimo mai stati traditi. Come se non avessimo visto i nostri cari morire. Agire come se fosse la prima volta. Con la stessa innocenza di Cristo. Con la medesima mortalità elettiva. Abbandoniamo tutta la speranza e tutta la sapienza come il Cristo di Hans Holbein – radice appunto immaginaria de L’idiota dostoevskiano – che nemmeno ha interesse a risorgere, che non ha piú interesse a essere divino. Che non ha piú interesse. Ma che, compiuto il dovere di riaprire una strada a suo modo esemplare tra i rovi del mondo, abbandona se stesso – non il suo corpo: se stesso – alla manomissione che una morte completamente umana farà della sua carne. Diventiamo la bellezza perfetta del dio morto, perché solo la fine è infinita e su di essa sola la bellezza si accampa. Assumiamo la bellezza campale del dio morto. Ovvero del perfetto idiota dostoevskiano, che non ha piú la ferita e la nostalgia del risorto di Rilke per l’esperienza regale della finitudine che, nonostante tutto, costruisce imperi di parole. L’idiota agisce come agirà il Cavaliere di Hughes. Egli è il suo stendardo e di quello stracci. Essere stracci della propria gloria. Essere coscienziosamente carne. Carne mortale. Niente. Dante che sviene continuamente. Mostrare la bellezza di una fine che non scavalca e non trascende se stessa. Carne fatta serena come pietra. Carne completa. L’idiozia della pietra e dell’osso, l’idiozia della cosa, ovvero la piú acuta tra le intelligenze, la piú radicale bellezza e la bontà piú radiante, la bontà idiota che Dostoevskij definiva appunto attraverso la parola prekrasnyj, a dire “lo splendore della bellezza”.
luglio 2011
Maria Grazia Calandrone (Milano, 1964) vive a Roma. Poe- tessa, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice per RaiRadio3, scrive per “Corriere della Sera” e cura una rubrica di inediti per il mensile internazionale “Poesia”. Tiene labora- tori di poesia in scuole, carceri, DSM, con i migranti e presta servizio volontario nella scuola di lettura per ragazzi “Piccoli Maestri”. Libri: La scimmia randagia (Crocetti 2003, premio Pasolini Opera Prima), Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier 2005), La macchina responsabile (Crocetti 2007), Sul- la bocca di tutti (Crocetti 2010, premio Napoli), Atto di vita nascente (LietoColle 2010), L’infinito mélo, pseudoromanzo con Vivavox, cd di sue letture (sossella 2011), La vita chiara (transeuropa 2011), Serie fossile (Crocetti 2015, premi Marazza e Tassoni, rosa Viareggio), Per voce sola (ChiPiúNeArt 2016), raccolta di monologhi teatrali, disegni e fotografie, con cd allegato di Sonia Bergamasco e Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (pordenonelegge 2016, premio Dessì); è in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi 2012). Dal 2009 porta in scena in Europa il videoconcerto Senza bagaglio. Nel 2012 vince il premio “Haiku in Italia” dell’Istituto Giapponese di Cultura e nel 2017 è nel docufilm di Donatella Baglivo “Il futuro in una poesia” e nel progetto “Poems With a View” del regista israeliano Omri Lior. Ha collaborato con Rai Letteratura e Cult Book. Sue sillogi compaiono in antologie e riviste di nu- merosi Paesi. Il suo sito è www.mariagraziacalandrone.it.
Riccardo Deiana, dalla raccolta inedita “La bellissima fanciulla”, nota di Laura Caccia
A distanza d’amore
Si muovono tra la leggerezza e il dolore i versi della raccolta La bellissima fanciulla e altre poesie di Riccardo Deiana. Tra armonia e ustione, incanto e strazio, bellezza e pena.
Sono versi interlocutori, la maggior parte rivolti alla persona cara, menomata dall’infermità, racchiusi tra i due testi riflessivi di apertura e di chiusura, in cui la parola si fa interrogante sul senso del vivere e del dire, come a contenere, nella distanza emotiva, tutta la sofferenza che viene invece, all’interno della raccolta, sempre più ravvicinata, in una lenta e inesorabile messa a fuoco sulla malattia “osservata per non morire, / e per la forza che da sola è venuta”.
Una leggerezza inattesa muove ogni verso: nel trattare una materia dolorosa, l’autore si pone, da un lato, a distanza, come a osservare dall’alto e a spostarsi lontano nel tempo, dall’altro, invece, vicinissimo alla sofferenza, alla rabbia e alla fatica quotidiana, in entrambi i casi proteso a far sbocciare motivi di tenerezza e di incanto.
E in tale lievità emergono figure potenti, che non riusciamo a considerare solo metafore: la madre che del frutto ha “la grandezza / la misura / per stare nel palmo aperto di un figlio”, il pupazzo di neve dal sorriso storto, simile a quello deturpato dalla malattia, da raddrizzare poiché “ridere allinea la bocca, / fa vivere di più la felicità”.
Una lievità che riguarda anche il buio, accolto nel suo respiro universale, nel battito che affratella: “Non è il buio il colore del dubbio / perché di notte è uno il respiro di tutti / più del giorno… / Il colore del dubbio è il colore del mondo”. E, se il mondo riserva crudeltà e amarezze, vi è altro in cui cercare note di pacificazione e di vero: “Sei: in attesa che volgano le stelle a inverare / tutto, come solo si può: / a puntini / dal buio”.
E in tutto questo la parola? Come può riuscire a sorvolare il dolore per avere uno sguardo più ampio e, nello stesso tempo, a immergersi profondamente in esso, toccarne il respiro?
La distanza, evocata più volte dall’autore, appare come il desiderio personale di trovare, attraverso una visione più ampia, i contatti con le cose e con le vicende terrene, attraverso una parola in grado di mostrare ciò che non si palesa facilmente.
Una visione utile soprattutto a creare vicinanza e cura, per la terra e per le sue creature, per la persona cara e per l’umanità, e che, da un punto di vista sociale, si pone come esigenza di osservare con più lucidità il mondo e la vita e di farne oggetto di condivisione: “perché laggiù distanti, così distanti dalla riva / (sono molte miglia in / miglia, ma neppure un anno luce in anni / luce) / sussurreremo agli amici che si vede il mondo, / la nostra natura dissolta”, come scrive Riccardo Deiana. Che, come poeta, si sente emarginato da chi non tiene conto del valore dei versi, ma eticamente chiamato, insieme alla comunità dei poeti, a invitare tutti, anche chi inganna, anche chi commette atrocità, a confrontarsi sul senso e sull’enigma del vivere.
- L'armonia -
... Certo, lo capisco il discorso
dell'equilibrio eterno dei classici,
ma solo al modo in cui sette stelle appaiono
all'occhio seminudo uno scorpione;
ho un dubbio di precedenze, un cruccio
di forma, e zodiacale: è frutto
l'animale del tuo mitico indicare che illumina
in questa notte spudorata la figura,
o è da prima nella mente ma timido a brillare?
(L'armonia ce la inculcano a scuola
e mai un delatore che ne spifferi l'anima storica:
non è innocuo, abbiamo le ustioni
dei loro freddi alari,
abbiamo storpiato i ventanni a furia di imitare,
senza inventare mai formine
per la nostra dismisura).
Come si può dimenticare l'uncino velenoso
che limita la costellazione e
sbucando furtivo becca intimorisce uccide?
Se puoi, non girare le pagine con l'indice ma
lascia che il vento le sbrighi,
e quando non ti verranno la voglia le parole
santifica il giorno come la pasqua o il natale,
e dopo
soltanto dopo torna a allineare le stelle.
Ci assomiglieremo
soltanto nel giorno in cui ci vedremo diversi,
finalmente, tutti,
ghignando in un pieno di pietà.
XI.
Guardatemi tutta, pensavi
ché tutta sono
anche se una spalla mi pende come avessi uno zaino,
anche se il mio saluto è sempre a metà
se striscio le scarpe.
Tutta, vi dico, guardatela
come di notte dall’alto l’autostrada di Orte:
dove le macchine sono
un unico fluido che luccica bianco
luccica forte.
Riccardo Deiana, etrusco del 1988, si è laureato a pieni voti e con diritto di pubblicazione all’Università di Torino nel novembre del 2016 con una tesi di ricerca sulla storia delle pubblicazioni di poesia dell’Einaudi dal 1938 al 1964. I suoi interessi sono rivolti principalmente alla poesia italiana contemporanea e alla storia dell’editoria. Si è occupato di Vincenzo Cardarelli e di Amelia Rosselli. Nel 2017 ha partecipato in qualità di relatore ai convegni «Franco Fortini: leggere e scrivere poesia (1917-2017)» tenuto all’Università degli Studi di Torino e «Sandro Penna (1977-2017): quarant’anni dopo» tenuto all’Università degli Studi di Perugia (presto il suo intervento verrà pubblicato da San Marco dei Giustiniani). Suoi articoli sono usciti sulla rivista viterbese «Biblioteca & Società» e sull’ «Indice dei Libri». Contemporaneamente all’attività letteraria, ha lavorato con i disabili, come corriere in bicicletta e come operatore notturno presso un dormitorio per senza tetto. Si diletta come cantautore.
Sono in preparazione dei suoi studi sull’attività di Franco Fortini e di Angelo Maria Ripellino come consulenti dell’Einaudi.
Lella De Marchi, dalla raccolta inedita “Bianca”, nota di Giorgio Bonacini
Se il bianco è il colore che li contiene tutti, allora il nome eponimo che agisce in queste pagine, non può non contenere in sé tutte le moltitudini di senso che la poesia riverbera in una voce. Infatti, nella dichiarazione di poetica che apre il poemetto, Lella De Marchi ci informa su tutto ciò che Bianca è e non è, riassumendo ogni metamorfosi nel progetto e nel desiderio di un’opera che “parla come parla un’intenzione, al fondo di tutto le cose, prima di tutte le cose”. Ecco, una lingua che dà corpo al suo significato, non con un movimento o una direzione stabiliti da un principio, ma costruendo con la sua vocalità una struttura mossa, dalle fondamenta foniche, sempre imprevedibili. Perché la parola dell’autrice svolge i suoi tratti distintivi nel mare di una sonorità concreta che fa della poesia una materia fluente, che scava se stessa con lacerazione o accarezza il sentimento del reale e del vero. Lì dove non basta trasgredire norme consumate, ordinarietà comunicative svuotate di significanza “se poi il mondo/ non lo inventi”, scrive con un cenno di giusto ammonimento. Bianca smonta le consuetudini con una scrittura che dice come sia inafferrabile e molteplice la natura della poesia: che è natura umana intonata in una melodia. Anche nell’errore, anche nel dolore il centro propulsivo deve sviare dal conforme, fino all’estremo della dissomiglianza verso ciò da cui prende o dà vita: “il mio cuore è/l’unica cosa che non mi assomiglia”. Così parla Bianca: dal fondo della sua presenza di corpo in essere, quale libertà e unicità di poesia con poesia. Perché questo è il passo, distorto ma necessario e incomparabile, del poema che oltrepassando se stesso e la pagina bianca si avvia prima dell’inizio per terminare dopo la fine.
Incipit
Bianca è la pagina bianca, che fa paura e che seduce chi sa che deve o che può provare a riempirla, chi si trova a giocare o lottare col vuoto, senza bucarlo o ferirlo.
Bianca è la somma di tutti i colori, il colore che non esiste che non vedi ma c’è, prima di ogni colore. Bianca è un’aspirazione al contrario, il sentimento in ogni contrario.
Bianca non ha una forma predefinita, è un po’ dappertutto è in tutte le cose, Bianca ha la forma che nel mondo hanno le cose, prima di tutte le forme prima di tutte le pose.
Bianca non è una donna perché il suo nome finisce per a.
Bianca, se la trovi, la trovi soltanto ad Ibiza, in questa terra c’è solo una terra che possiamo che dobbiamo abitare, che sia solo la nostra, che ci concede il diritto di cittadinanza, nel breve spazio tra l’inizio e la fine.
Bianca non è una poesia, non è un romanzo, non è una canzone, Bianca è un’intenzione, e parla come parla un’intenzione, al fondo di tutte le cose, prima di tutte le cose.
Bianca non sono io.
Bianca non è un santo, non lo è stato
Bianca non è un santo non lo è stato,
Bianca fa l’amore o forse sesso un po’
con tutti, Bianca è tipo-indipendente,
un po’ ricordi di classe operaia un po’
aperitivo trendy post-lavoro, un po’
nullafacente un po’ sé stessa-facente,
Bianca non è un santo non lo è
stato, Bianca fa l’amore o forse sesso
un po’ con tutti e pensa, Bianca
pensa che un cuore solo non ha occhi per
vedere e gli occhi non hanno un
cuore solo per vedere la nostalgia
Bianca volentieri cederebbe alla tentazione di parlare senza dire niente
Bianca pensa che in ogni tempo volentieri
cederebbe alla tentazione di ritrovarsi
immutata superando l’effetto serra e
il tempo più ostinato, Bianca
pensa che in ogni tempo volentieri
cederebbe alla tentazione di riuscire a
non pensare per poter parlare senza
dire niente, senza aggiungere
al rumore altro rumore, senza
diventare una spiegazione, senza
diventare necessaria, necessaria
come una spiegazione
Lella De Marchi è poeta, scrittrice, performer.
E' laureata in Lettere Moderne indirizzo storia dell'arte contemporanea all'Università di Bologna. Ha seguito laboratori di scrittura creativa e sceneggiatura cinematografica con Andrea Camilleri, Ugo Pirro, Tonino Guerra, corsi di lettura ad alta voce e teatro. E' diplomata al CET, la scuola di Mogol, come autrice di testi.
Ha pubblicato tre libri di poesia: "La spugna" (Raffaelli, 2010, prefazione di Renato Martinoni, "Stati d'Amnesia" (LietoColle, 2013) con un saggio di Enzo Campi, "Paesaggio con ossa" (Arcipelago Itaca, 2017) postfazione di Caterina Davinio e finalista al Premio Pagliarani 2016 ed un libro di racconti "Tutte le cose sono uno" (Prospettiva Editrice, 2015), vincitore del Premio Braingnu 2013.
Ha ottenuto molteplici riconoscimenti, nazionali ed internazionali, sia con l'edito che con l'inedito. Suoi testi compaiono in antologie di poesia contemporanea, riviste e blog su internet.
Unisce alla scrittura un'intensa attività performativa, partecipando con suoi testi e come attrice a festival, reading, poetry slam, eventi teatrali, in collaborazione con poeti, artisti, musicisti.
Collabora come recensionista di libri di poesia contemporanea con la rivista "Versante Ripido".
Raffaele Floris, dalla raccolta inedita “Senza margini d’azzurro”, nota di Laura Caccia
Il profumo dell’ombra
Se potessimo sospendere il tempo, di fronte alle perdite di stagioni e di affetti, quando mancano le leggerezze che in passato spalancavano la vita in una profusione di profumi e colori, potremmo tentare di fare delle parole il cielo che manca, seguendo Raffaele Floris in Senza margini d’azzurro.
Sia nei temi che nell’attenzione formale, lungo i versi che si distendono nei loro endecasillabi, la raccolta appare mossa dall’esigenza di ritrovare quei margini spaziali e temporali, confinati ora nella lontananza, che hanno segnato il vissuto dell’autore.
Sono margini di cielo, legati all’infanzia e alla presenza degli affetti familiari, che mancano. E sono margini di un tempo che resta come sospeso, trattenuto nel tentativo di far permanere e rivivere quanto è stato emotivamente significativo ed ha cessato di esistere.
Nel chiedersi “Che ne sarà di noi, del nostro cielo? / Non ci è rimasto niente fra le dita”, nell’ombra che pervade ogni cosa e nel buio dell’assenza della persona cara, l’autore è consapevole che non si tratti tanto di ritornare indietro nel tempo, seguendo le tracce della memoria, quanto di percorrere dolorosamente la strada della mancanza che si è spalancata; così, scrive, ripensare “non è sfogliare il libro dei ricordi / ma spingere anche il cuore in fondo al nulla”.
Così in fondo che il dolore ne viene quasi deterso, purificato: simile ad un bucato fatto con la cenere, anche la scrittura ne esce come mondata, dopo il contatto con il fuoco della sofferenza e con i residui di ciò che prima ardeva. Riuscendo, in questo modo, a mantenerne intatta una parte, a trattenere qualcosa, a profumare l’ombra rimasta: “Il paradiso / dei lini ripiegati nei cassetti / racconta di un giardino che non muore”.
Restano così memorie sensoriali, soprattutto olfattive, legate dell’assenza: profumi di bucato e di teli negli armadi, di fiori e di giardini, di mirto e di rugiada: “Lenzuola che profumano i cortili / gonfie di primavera. A mani piene / lavanda per il lino dei bauli, / e la cenere spenta è come neve”.
E come tra il bucato appeso ai fili l’autore fa comparire la persona cara scomparsa a cui si rivolge, “Vorrei vederti, quel giorno, tra i panni / stesi in cortile”, così ci rammentano visivamente i panni stesi anche le due serie di haiku, ispirati ad opere artistiche, che separano e chiudono le parti della raccolta e che sembrano costituire, nei loro lampi di ombra e di luce, un modo per trattenere e lasciare vagare in essi l’assenza. I teli come le pagine sono impregnati di ciò che manca: come in quel “Conserva un foglio bianco: / ti lascio l’ombra delle mie parole”, con cui Raffaele Floris ci ricorda che anche le parole possono vivere d’ombra. E che l’assenza è il cuore pulsante della poesia.
La porta
“Signore: è tempo. Grande era l’arsura.
deponi l’ombra sulle meridiane,
libera il vento sopra la pianura”.
(Rainer Maria Rilke, Giorno d’autunno)
Le tenebre mai più, non più l’abisso
dell’ora nona e il cielo che si oscura:
la porta è spalancata e sulla soglia
la luce irrompe ai margini del tempo.
Marchio potente, vita che ha bruciato
il sudario, spezzando le catene
della notte. La porta è spalancata:
libera il vento che ravviva il fuoco.
XXII maggio
Nel solaio dei giorni ho rovistato
a lungo: oggi cercavo una rosa.
Era nei Malavoglia! Tra le pagine
gonfie di spine e l’ombra del silenzio,
polvere amara che ha graffiato il tempo.
L’incenso di una sera. Poi l’estate
nel bicchiere, e la fragranza svaniva
tra le pagine e i roghi di novembre.
Haiku ispirati alle opere artistiche di Mario Fallini (1947, Alessandria)
(Sempre)
mesi e stagioni
nel vortice del tempo:
sempre è per sempre.
(La quinta stagione)
stagione amara
scoria di un tempo ostile,
vita non-vita.
(Corda d’arco e di lira)
tenebre e luce
nell’arco che dispensa
l’arte e la guerra.
Raffaele Floris. Pubblicazioni: Il tempo è slavina, ed. Lo Faro (Roma) 1991 – silloge poetica; L’ultima chiusa, ed. Joker (Novi Ligure) 2007 – silloge poetica; La croce di Malta, puntoacapo ed. (Novi Ligure) 2013 – romanzo breve; L’òm, l’aşi e ‘r pulóu, PiM ediz. 2016 – detti, proverbi e filastrocche in dialetto pontecuronese; Mattoni a vista, puntoacapo ed. (Novi Ligure) 2017 – silloge poetica
Adelio Fusé, una prosa inedita “La parola è l’immagine che si stacca dalle cose”, nota di Mara Cini
La parola è l’immagine che si stacca dalle cose vere.
La parola è essa stessa una cosa, naturalmente. Il segno alfabetico, con la sua pelle di grafite, d’inchiostro, di pixel, ha una sua storia in ambito estetico. Tutte quelle modalità di lavoro sulla parola che si riappropriano del circuito mano-pensiero (o voce-pensiero) trovano le loro motivazioni nella consapevolezza che la parola è luogo privilegiato della produzione ideologica e simbolica ma consiste anche di autonomi valori visuali o fonetici.
Fusé si sofferma sull’ambiguità dei significati: la parola designa, la parola allude, la parola “osserva”. E quando nella sosta osserva e indugia lo scarto cresce.
Fusé dice che si può scrivere (di qualcosa) dopo molto, quando le cose sono ombre.
O molto prima, quando ancora fa buio. Come Emily Dickinson possiamo scrivere Buongiorno – Mezzanotte.
La parola è l'immagine che si stacca dalle cose
(dai Taccuini di Aldous Canti)
Talvolta penso di sopprimerla. Lei sa quello che mi passa per la testa. è la prima a saperlo. Rinuncia allora a inseguirsi. Si arresta e contempla le poche parole, sue consanguinee, sparse fra buffi segni che non coprono mai abbastanza. Il misfatto non si cancella.
Lei – la parola – simula la vittima che nel gioco implora il carnefice. Ne ha uno tutto personale. E lo sfida in una terra esposta ai venti, dal clima mutevole. Cerca una via di fuga e si camuffa, forse meschina, forse scaltra. Tutto questo per salvarsi la pelle. “Ma quanto vale la tua pelle?” le chiedo. “E la tua?” mi fa lei, pronta. L'autore è in sua balia.
Desiderare le prove peggiori pur di avere materia prima per la mano che sgrezza e tritura. Sei cinica, o parola. Insensibile alle ragioni. Perché raccontare questi avvenimenti e non altri? Qui o là, io o un altro. Non ti curi delle differenze. Qualità alta o melmosa, personaggi virtuosi o assassini, autore zelante o inaffidabile. Il tuo stomaco ospita qualunque cosa e chiunque e il suo contrario. Lì dentro ha casa la coincidenza degli opposti. Affamata come sei, reclami nutrimento. Il resto è chiacchiera, neppure da servire come stuzzichino.
La parola che si fa scrittura è porto franco o discarica?
Ma con quali parole sfamare – sfamarmi? La mia dispensa è senza provviste. Sì, c’è scatolame, poca roba, quasi niente. Cristo, siamo oltre la soglia del consumo. Cibo alla partenza già deprezzato, ora avariato.
Sempre la domanda, oziosa: “Che ne è delle cose?” Le cose sono laggiù, lontane. Fingo di non sapere e proseguo. La regola del gioco è questa e io la rispetto. Ma la scrittura, lei, viaggia separata dalle cose. E quando nella sosta osserva e indugia lo scarto cresce.
La parola è l'immagine che si stacca dalle cose vere.
Dovrei raccontare. Il racconto come dovere n. 16.790 (non ridete: ho conteggiato con scrupolo). Le parole, narcise onaniste, aprono la bocca e si divorano. Sanno come mangiarsi. In mancanza di cibo la bocca si fa cibo.
Fare presto. Le cose si scrivono hic et nunc o partono con il loro saluto (bye-bye: vedi – proprio tu, che sei l'autore –, come agitano delicate manine e candidi fazzoletti?). Anzi, neppure ti inviano un segnale. Non ne hanno il tempo. E tu alzi le spalle. Che sia pure così. Sai che puoi poco. Si perdono comunque, le cose. Forse che ritornano? Andiamo, signore e signori, siamo gente di mondo. Il nostro uovo si è schiuso parecchio tempo fa, e parecchio tempo fa la nostra testolina, chiedendo al collo lo sforzo massimo, ha fatto la sua capatina fuori. Come recuperare la prima occasione? Non recuperandola. Non ci sono macchine del tempo. Le occasioni svanite hanno il sesso degli angeli. E le parole, soverchiate dal mistero, annaspano spente.
Puoi odiare l’orologio, caro autore. Non curartene. Non possederne uno. Metterlo fuori uso. Spedirlo alla gogna. Quello ha modelli simili: fratelli, cugini, un largo parentado. Puoi fare incetta di ogni modello in commercio, distruggere tutti i depositi, tutte le fabbriche. Avrai pur sempre l’orologio che è il tuo corpo. In forma di segnatempo interiore o bene in vista sulla tua pelle. (Anche noi abbiamo i nostri anelli, come gli alberi.) O In forma di mano che scrive, certo. C’è sempre una lancetta che scatta in avanti, anche se il tuo orologio susperstite non la prevede. In ogni caso il tempo balza in là. E a ogni suo balzo, visibile oppure occulto, tu rimani al palo. Scrivi, presto, se non vuoi regredire all’alba del mondo, mentre il mondo va oltre. Oh, si può scrivere dopo molto, quando le cose sono ombre. Ma come restituire spessore, sapore? La polvere compromette la visione e ti fa tossire. Croste sommate a croste e il tuo raschiare che non si arrende. Quando ti spiani la strada, risaltano le cicatrici. E le residue parti ancora intatte sono spaiate: i compagni di vita sono ormai di morte. Nessuna sostanza per il gusto, solo i danni del rimpianto.
Adelio Fusé (1958) vive a Milano e lavora nell’editoria. Ha pubblicato saggi su Sade, Kafka, Sartre, Handke, Eno (Materiali Sonori-Auditorium, 1999), i romanzi North Rocks (Campanotto, 2001) e L'astrazione non è la mia passione principale (Manni, 2018), i libri di poesia Il boomerang non torna, Orizzonti della clessidra distesa, Canti dello specchio bifronte, L’obliqua scacchiera (Book Editore, 2003, 2005, 2009, 2012, segnalati al Premio “Lorenzo Montano”), La veglia del sonnambulo(Book Editore, 2016; candidato al Premio “Camaiore” e finalista al Premio “Lorenzo Montano”, 2016). Scritti critici, testi in prosa e in versi sono apparsi su riviste (“alfabeta”, “auditorium”, “Atelier”, “Il Segnale”, “La Ginestra”, “Legenda”, “Lengua”, “Sonus”, “Tratti”) e online in siti letterari (“Carte nel Vento/Anterem”, “Poetarum Silva”, “Vico Acitillo 124-Poetry Wave”). Ha fatto parte della direzione di “Legenda” (Tranchida, 1988-1995). Collabora con artisti e musicisti. Ha ottenuto un riconoscimento al Premio “Riccione per il teatro” (1981). Cura una rubrica di musica e poesia sul sito altremusiche.it.
Carmen Gallo, da “Appartamenti o stanze”, Edizioni D’if, 2016, nota di Rosa Pierno
Apparentemente una narrazione oggettiva, asettica, se non fosse per alcuni segnali che aprono squarci nella carena poetica. Azioni spesso compiute da personaggi silenziosi, che hanno il raggiungimento della staticità come scopo: i personaggi sono non in attesa, ma volontariamente isolati, ritagliano in realtà uno spazio impenetrabile intorno a loro. A volte, le azioni risultano paradossali: "donne si infilano lettere" una a una "nella bocca", sollevano il soffitto. Ma sempre c'è la misurazione della distanza tra i rispettivi vuoti. Irrompono però i ricordi a rompere la continuità spaziale con salti temporali. Nello spazio, il tempo va avanti e indietro, ma il soggetto è capace anche di diventare "incrostazioni sull'intonaco". A dimostrazione che nulla può essere mai veramente oggettivo.
***
La donna bianca annuisce o trema.
Vista di profilo annuncia
tempesta, giudizio, concordanza
difficile della parola al senso.
Le donne si alzano e la guardano.
Si appannano vetri dietro respiri.
Noi spegniamo la luce perché ora è notte.
***
L'uomo si sveglia sul balcone
e preferisce non guardare
dietro i vetri che gli fanno da schienale.
Il buio intorno è alto. L'uomo si tiene le ginocchia
misura con gli occhi la resistenza all'urto
in base alla distanza.
La donna nella parete di fronte dorme.
Solo le labbra continuano a guardarci e a domandare.
***
L'uomo in tangenziale fissa il vuoto
e l'auto rovesciata. La gente intorno
è agitata. Le donne sono arrivate
a raccogliere le sue cose.
Ogni tanto qualcuna è stanca
si ferma e fuma, seduta sul guardrail.
***
L'uomo in tangenziale si guarda intorno
e comincia a camminare. Fa pochi passi
barcolla, si stende sull'asfalto.
Le donne intorno all'auto adesso
dimenano le braccia, fanno cenni
ai fanali inchiodati. Noi ci mettiamo in fila
con gli occhi degli altri a guardare.
***
Da quando siamo finiti nella stanza più lontana abbiamo
cominciato a sparire, uno a uno. Se non possiamo guardarla
non siamo più sicuri di esistere. Alcuni non ce la fanno, hanno
paura, scompaiono. L'uomo che vive con lei ogni tanto apre la
porta e prova a farci uscire. Ci chiede di nascosto di tornare, ma
noi siamo soltanto incrostazioni nell'intonaco e non sappiamo
come fare. Se lei non viene qui scompariremo. Ad aspettarla
siamo rimasti solo in due. Non so se ci siamo scelti, so soltanto
che mi somiglia. L'altro sente quello che sento io, vede quello
che vedo io. Presto diventeremo una cosa sola e spariremo.
Carmen Gallo vive a Napoli dove insegna Letteratura inglese. Nel 2014 ha pubblicato Paura degli occhi, per L'Arcolaio, Forlì, tradotto in parte in francese da Clement Lévy per Remue.net, già finalista Premio Montano 2015. Nel 2016 è uscito Appartamenti o stanze (Edizioni D'If), una parte del quale sarà tradotto in Germania nell'ambito del progetto "Poesie der Nachbarn. Poets translated by poets" diretto da Hans Thill. Alcuni testi e sue traduzioni sono stati pubblicati su blog (tra gli altri Poetarum Silva, Formavera, Nazione Indiana, Nuovi Argomenti, Leparoleelecose ), in antologie e su rivista (Argo, Smerilliana, L'Ulisse).
Dal 2015 cura, con altri colleghi, il Seminario di poesia comparata presso l'Università di Napoli "Federico II", e nel 2016 ha partecipato al Laboratorio di poesia in carcere promosso dalla Fondazione Premio Napoli. Ha curato la nuova edizione e traduzione di Tutto è vero, o Enrico Vili di Shakespeare e Fletcher (Bompiani 2017) e ha da poco pubblicato un saggio dedicato ai poeti metafisici inglesi, L'altra natura. Eucarestia e poesia nel primo seicento inglese (ETS 2018).
Vincenzo Mascolo, da “Q. e l’allodola”, Mursia, 2018, nota di Rosa Pierno
È la poesia, il soggetto dell’ultimo libro di Vincenzo Mascolo Q. e l’allodola, Mursia, 2018. Mascolo, tra versi e prosa poetica, delinea il campo assordante delle pretese e delle aspettative che rendono la contemporaneità una sorta di Moloch a cui sacrificare il proprio impulso o le proprie scelte poetiche. Il problema resta non il modo di versificare, ma il manifestarsi stesso della poesia. Vi è, dunque, la necessità di liberarsi da quelle pastoie che finiscono con il depositare un velo, per cogliere alfine nuovamente, quasi fosse una nuova prospettiva, il dono della poesia. Dono che non può ottenersi senza l’esercizio dello stile e della tradizione.
Tuttavia, non solo stile, non solo dato esistenziale, non solo bellezza, la poesia per Mascolo attinge a fonti di ben altra natura, di metafisica portanza. La poesia deve travolgere il sé profondo, deve essere esperienza di vita che avvicini all’uno, al creato, che sia cioè quell’unico sentire in grado di forgiare e di trasformare, rendendo inique tutte le mere questioni che non abbiano a che vedere con questa verità, deve essere poesia-salvezza, l’unica che abbia un senso. Persino la ricerca della bellezza diventa una chimera, infatti, se non ci si approssima alla verità del proprio cuore, a quel canto che è la purezza sorgiva dell’origine.
***
Oh, Queneau
non basta più esercitarsi nello stile
come tu sapevi fare inanellando
notations, hellenismes, le contre-pettéries
e tutte le altre tue diavolerie
che aprivi come nuove fioriture
nelle terre inaridite che solcavo
con strumenti quasi umani zolla a zolla
per offrire a Cerere il raccolto
generato in primavera dai miei semi.
***
Oh, Queneau
Queneau
parlavo seriamente della bile
perché stanno esaurendosi le scorte
delle anime ridotte al lumicino
e per nutrire ancora una speranza
che adesso si fa sempre più sottile
ai poeti non resta che affilare
parole sulla pietra per raschiare
il fondo limaccioso del barile.
***
Oh, lo so
Queneau, lo so
potresti allora dirmi che il reale
per i poeti è cosa ben diversa
da questo affaccendarsi quotidiano
che loro riconoscono i confini
dell’anima costretta nella forma
che muta, evolve, vira
si trasforma
cambiando il punto dell’osservazione.
Vincenzo Mascolo è nato a Salerno e risiede a Roma. Ha pubblicato Il pensiero originale che ho commesso (Edizioni Angolo Manzoni, 2004), Scovando l’uovo (appunti di bioetica) (LietoColle, 2009), Q e l’allodola (Mursia, 2018). Per la casa editrice LietoColle ha curato le antologie: Stagioni (con Stefania Crema e Anna Toscano), La poesia è un bambino, Quadernario – Venticinque poeti d’oggi (con Giampiero Neri). Dal 2006 è il direttore artistico di Ritratti di poesia, manifestazione promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo.
Francesca Monnetti, una poesia inedita “(s)onde”, nota di Ranieri Teti
C’è una realtà che si disfa a poco a poco, verso dopo verso, senza riparo, nel poemetto di Francesca Monnetti.
Già il titolo anima una dissoluzione, in “sonde” si attenua la S, posta tra parentesi, lasciando le onde fluttuare nel vuoto. Come foglie che danzano “nel lessico del vento”. Come un corpo che diventa “carne in fuga”. Fino alla fine si perdono tracce, tutto si dissolve e allo stesso tempo si radica nel linguaggio che ben rappresenta la compostezza formale dell’autrice.
Il testo si incide nelle rime interne, nelle consonanze di uno “(s)finito gridare”, in una limpida e strenua esattezza.
Precipitati
la caduta dei gravi
polvere e roccia glabra il mondo
grama la linea di sola terra
per i messi a nudo
i raminghi corposi
in piena luce
senza un riparo
assorbita dal peso dei passi
all’ombra della forma
del peccato… della sostanza
s’è persa la traccia
vuoto di consistenza
… il corpo s’è fatto
carne in fuga
che esonda, che suda
del tutto adatto
al proprio carnale calvario
premeditazione
innocenza presunta
gesto inconsulto
ravvedimento
menzogna
espiazione
vergogna
fittizio… reale
senso doloso
rimosso… senso di colpa
fa fatica
(s)fugge in fretta
si confonde
l’impronta
vagare è grave
fuori dall’eden
tra candore
tentazione
e caduta
sul suolo brullo
senza una fronda
il segno resta
del danno… del reato
dell’onta
a distanza d’azzurro
in assenza di foglia
la coscienza s’annebbia
muta s’adonta
si fa… monda
impresso
un malcelato sudario
orbite livide
incise sul volto
…madida e calva
la testa… si piega
all’indietro
ex virgo
venus impudica
con la mano
il sesso comprime
il sesso nasconde
a lato
il primo uomo
con le dita
s’occulta il volto
curvo… s’inarca il busto
in lui
il sesso si fa forte
il sesso si scopre
cava e pesta
sgomenta
resta aperta
la bocca
afono e devastato
il suo (s)finito gridare.
Da sempre io, Francesca Monnetti, vivo a Sant'Ellero, una frazione in provincia di Firenze, città dove sono nata e dove ho studiato Filosofia. Da venti anni insegno nella scuola primaria e da altrettanti, più o meno, scrivo poesie. Al 2009 risale la pubblicazione del mio primo volume di poesie, In-solite movenze (Cierre Grafica, Verona, collana "Opera Prima", diretta da Flavio Ermini); tale raccolta è risultata opera finalista nell'edizione 2008 del "Premio di Poesia e Prosa Lorenzo Montano", sezione "Raccolta inedita". Nel 2017 è stata pubblicata la mia seconda raccolta di poesie, Pen-insul-aria (Edizioni Helicon, Arezzo), che, in una versione ridotta, era giunta finalista in occasione della I edizione del Concorso di Poesia e Narrativa "L'Erudita", i cui membri di giuria erano Cristiano Armati, Paolo Febbraro, Giorgio Manacorda, Walter Mauro, Matteo Lefèvre, Giorgio Nisini, Cinzia Tani. Nel 2010 una mia silloge ha vinto la IV edizione del "Premio Letterario Sergio De Risio" dedicato al pensiero poetante, la cui giuria era composta da Renato Minore (presidente), Flavio Ermini, Filippo Maria Ferro, Giuseppe Langella, Cesare Milanese, Giancarlo Quiriconi, Maria Cristina Ricciardi, Jacquelin Risset, Marco Tornar e Raffaele Saraceni. Una mia poesia singola inedita (contenuta in Pen-insul-aria) è stata premiata come vincitrice nella sezione omonima della I edizione del Concorso di Poesia e Narrativa "L'Erudita" ed appare nel volume antologico dedicato al Premio (Giulio Perrone Editore, Roma, marzo 2012). Nel 2018 una mia silloge inedita, Secondo-genitura, ha conseguito il primo premio nell'ambito della XVIII edizione del Premio Letterario Castelfiorentino, sezione inediti. Nel 2016 una mia raccolta inedita, (S)oggetti a (s)comparsa, è stata inclusa nella rosa dei dieci finalisti della seconda edizione del Premio nazionale editoriale di poesia "Arcipelago itaca". Quattro poemetti inediti sono giunti in finale in edizioni diverse del "Premio di Poesia e Prosa Lorenzo Montano" (2012, 2015, 2016 e 2017). Miei testi poetici, finalisti e segnalati in edizioni precedenti e recenti del Premio Montano e in occasione della seconda edizione del Premio editoriale di poesia "Arcipelago itaca", compaiono on-line sul sito della rivista di ricerca letteraria "Anterem", su "Blanc de ta nuque" di Stefano Guglielmin e sul blo-mag "Arcipelago itaca" di Danilo Mandolini. In seguito a segnalazioni, con altre poesie sono presente in volumi antologici e siti legati a concorsi organizzati in Toscana: Premio Firenze, Premio Internazionale di Poesia San Domenichino, Premio Arno Fiume di Pensiero, Premio Letterario Castelfiorentino - edizioni 2011, 2014 e 2018 -, Premio Alpi Apuane 2014, Premio Casentino 2015 (doppia segnalazione), 2016 e 2018 (segnalazione con menzione d'onore), Premio Nazionale di Poesia Borgognoni 2016. Sulla mia poesia hanno scritto Mauro Barbetti, Giorgio Bonacini, Lia Bronzi, Silvia Ferrari, Marco Furia, Giancarlo Quiriconi, le giurie del premio "L'Erudita", del "Premio Letterario Castelfiorentino" e del "Premio Casentino", presiedute rispettivamente dal compianto Walter Mauro, da Marco Marchi e da Silvio Ramat.
Daniela Pericone, da “Distratte le mani”, Coupd’idée, 2017, nota di Rosa Pierno
Strategie di avvicinamento sostenute da un’attrezzatura razionale, a tratti geometrica, non prive di lusinghieri inviti a una realtà che già si sa essere menzognera, vengono a tessere la trama poetica di Daniela Pericone. Ogni cosa viene localizzata, misurata, se ne coglie la distanza rispetto al sé, mentre ci si ripete la lista di precauzioni a cui attenersi per evitare spiacevoli conseguenze: “Non cedere a lusinghe / di paesaggi, / sciogliere nodi / è mestiere da penelopi / la tentazione è nelle forbici”. Una giusta distanza fa valutare ciò che è nel campo visivo e dà il tempo di elaborare l’azione necessaria. Ma è anche testimonianza di un’attitudine allo sguardo non priva di passione che inevitabilmente brucia le distanze, rendendo sonanti le parole e fusi il soggetto percipiente e il referente. Ma di questo ci aveva dato già certo indizio l’uso di un’aggettivazione sensuale e mobilissima.
Dalla sezione “Lucori”
2.
Davanti a voi sospesi
d’inerzia e dolenti
traveggo un guado alle cime
d’assalto cavalco un volo
un calco di volto
in assolo.
11.
Scrivere accresce lontananza
da mani disutili e nomi inceneriti
- inesperta di vanità che distoglie.
Nostro soltanto è conoscere
e non dirne vanto o privilegio.
Non turbare la luce che covi,
forgia un accordo di fuochi.
Verrà il torchio dei dolori
del corpo e in quelli adoprarsi
per non dare la resa o invelenire.
Se c’è un rivolo, un cielo uguale
ai deserti, accogline l’empito
la vampa improvvisa
nel cavo del gelo.
Dalla sezione “Disertori”
4.
È ora che suono
si plachi a scuotere via
ogni eccesso un gesto
in levare un lavare le scorie
osso d’un tempo a scucire
vertigine di varianti.
14.
Da temperamento
ed esperienza nasce dirittura
di viaggio, incisa fisionomia.
Non stupire se insorge deviazione,
la mente duttile non teme incoerenze
respira affetti, riconosce occhiali e mani
sul cuore, avanza d’alta ebbrezza
l’agire, l’eresia.
Daniela Pericone è nata nel 1961 a Reggio Calabria, dove vive. Ha pubblicato i libri di poesia Passo di giaguaro (Edizioni Il Gabbiano, 2000, con una nota di Adele Cambria), Aria di ventura (Book Editore, 2005, prefazione di Giusi Verbaro), Il caso e la ragione (Book Editore, 2010), L’inciampo (L’arcolaio, 2015, prefazione di Gianluca D’Andrea e nota di Elio Grasso). Cura, con enti e associazioni, eventi e incontri culturali.
Alfredo Rienzi, una poesia inedita “Qui i verbi rinunciano, i presagi non dicono”, nota di Ranieri Teti
Cosa resta, quando anche i verbi rinunciano e i presagi non dicono?
Per fortuna rimane una figura, vigile anche se colta in un passo simile a uno smarrimento, in un passo che affonda.
L’atto di resistenza poetica è memoria del sottosuolo, terra estrema, fertile per un seme o per un rizoma che si diffonderà.
Il valore della parola vive nella poesia, che registra, oltre le apparenze, il vero.
Alfredo Rienzi infatti resiste con alcuni verbi fossili, criticamente e con lucidità resiste senza cedere all’idea di catastrofe. Nel silenzio, nell’anfratto dove la storia ha deportato le idee, in questa notte nera, le parole necessarie per ridefinire il mondo saranno portate da chi può nominarle.
Qui i verbi rinunciano, i presagi non dicono
Dicono questi versi
di nulla che succede,
non descrivono fatti.
Resiste qualche raro verbo fossile:
sta, aspetta, disperde.
Questo vuole l’ebbra superficie:
al troppo dire, al morso dei ragni
opporre silenzî di arenili
boccheggii di meduse.
Sotto, dentro, diffidiamo delle albe:
ci serve notte, ancora
di radice e di seme
ci serve buio, dentro,
la sua morente schiera.
Qui, in superficie, i verbi rinunciano
i presagi non dicono.
Alfredo Rienzi, nato a Venosa nel 1959, risiede dal 1963 a Torino, dove esercita la professione di Medico.
Poeta e saggista. Nel 1993 ha pubblicato Contemplando segni, silloge poetica vincitrice del X Premio “Montale”, in Sette poeti del Premio Montale, (Scheiwiller, 1993); i successivi volumi sono Oltrelinee (Dell’Orso, 1994) e Simmetrie, Pref. di F. Pappalardo La Rosa, (Joker, 2000), entrambi segnalati al Premio Montale sez. Editi, eCustodi ed invasori(Mimesis-Hebenon, 2005). I volumi citati sono in parte confluiti ne La parola postuma. Antologia e inediti, pubblicata da Puntoacapo Ed., Novi L., 2011, in quanto opera vincitrice del Premio Fiera dell’Editoria di Poesia (con pref. di G. Linguaglossa e postfazione di M. Marchisio).L’ultimo volume in versi è Notizie dal 72° parallelo (Joker Ed., 2015, con pref. di D. Gigli e postfazione di S. Montalto), Premio Civitella-Pelagatti, tradotto in alfabeto Braille, e Premio Metropoli di Torino.
Ha all’attivo collaborazioni e/o contributi creativi e critici con numerose riviste e siti di poesia e letteratura nazionali ed è inserito in varie Antologie critiche sulla poesia contemporanea (tra cui: G. Linguaglossa, La poesia italiana del tardo Novecento tra conformismi e nuove proposte, 2002, e La nuova poesia modernista italiana, EdiLet, Roma, 2010; S. Montalto, Tradizione e ricerca nella poesia contemporanea, 2008; L. Benassi, Rivi strozzati – Poeti italiani negli Anni Duemila, 2010; G. Lucini, Poeti e poetiche-I, 2012; G. Linguaglossa, Critica della Ragione Sufficiente, 2018).
Ha partecipato alla traduzione di OEvrepoétiquedi L. S. Senghor, in Nuit d’Afrique ma nuitnoire – Notte d’Africa mia notte nera, Harmattan Italia, Torino-Paris, 2004, a cura di A. Emina. Suoi testi sono tradotti in rumeno ed in inglese.
Come saggista ha pubblicato Del qui e dell’altrove nella poesia italiana moderna e contemporanea, Dell’Orso, 2011, Finalista al Premio Soldati-Pannunzio 2016 e Premio per la saggistica Metropoli di Torino 2016.
Attualmente collabora con i comitati di redazione delle collane di poesia di Joker Editore. È tra i collaboratori e sostenitori di Amado mio, foglio letterario torinese fondato nel 2014 da Marcello Croce e Luca Borrione.
Francesco Vasarri, dalla raccolta inedita “Rerum Creatarum Pavanae”, nota di Giorgio Bonacini
Leggendo queste pagine la prima osservazione è quanto, in queste poesie, lingua e suono siano soggetto e oggetto, selezione e combinazione, paradigma e sintagma intrecciati in un unico significante che include la natura in un ritmo e il ritmo in natura. La parola poetica si carica di materia organica in osservazione concreta, quasi primordiale. Cantare larve bastevoli disfatte e arse può sembrare un azzardo sperimentale, ma è invece una necessità sostanziale che nasce dalle cose che ci sono e che nel loro movimento devono essere dette. Vasarri, in questo modo, porta la scrittura fin dentro il corpo della nominazione, dove la carne spoglia respira e ne sente l’odore. Perché solo una lingua poetica che si sviluppa e si insinua in un reale pastoso e contorto, è capace di tanto. Il senso che ne emerge è un rivolgimento continuo, alla ricerca del vero che sta nel poco: nella incommensurabile e fondante povertà della voce iniziale: ouverture creaturale al di qua e al di là del principio. Il fare di questi testi sembra così scaturire da un conglomerato di segni che vanno sciogliendosi in musica: un canto vocalico che rimescola la distinzione tra fonia e grafia, andando a prendere ciò che sconcerta; non per stupire il lettore, ma per dare nuova riconoscibilità alla “crosta muta”, al suo generarsi in un dire quasi fosse “un ultimo soffio di fiato”. E questa è la conseguenza estrema in cui la poesia può riprendersi ciò che le spetta: fossero anche solo “poche sillabe”, o una larva di senso in proteiforme materia, in tensione oltre se stessa affinché “avanzi la vita”.
Falso esergo del lupo
Non c’è.
Non l’abbiamo
mai visto.
Confitto
nella lisca del male.
Per generosa confisca.
[E anche se ce l’avessimo…
o se lo fossimo noi…
correi, rodendone l’osso…
Domesticarlo. Mai.]
Da “Fioretti e variazioni”
Tutto quel gergo di anime.
Almeno servisse a qualcosa.
Almeno potesse decidersi
che dopo le spine,
la rosa.
Da “Diminuendo”
***
Consèrvati dovunque
levigato in miriade,
scheggia, spina e prepuzio.
Per tornare a chiudere il cerchio,
a riattizzare l’inizio.
[Ma quanto perdi, mantice fioco, fiato.
Come non s’è infuocato, non prende fiamma
nella sua solitudine il rovo.]
***
Io c’ero. In culto. In fissità d’immagine.
Lacrima d’io, voce travolta, fronda
contro la quale battere in rivolta.
E con che diligenza vi battevo.
Decisamente io vi andavo a sbattere,
vi ci sbattevo, sì, io lì sbattevami.
Che dio manchi in vertigine.
E faccia fuoco vergine.
Francesco Vasarri è nato a Bagno a Ripoli (FI) nel 1987. Vive a Firenze, in Oltrarno. Dottorando in italianistica presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi dedicata all’entomologia nella letteratura italiana contemporanea, ha pubblicato, su rivista, in atti di convegno e per volumi collettanei, diversi saggi sulla poesia del secondo Novecento (Caproni, Cavalli, Lamarque, Merini, Parronchi, Valduga, Zanzotto). Ha tenuto, nell’ambito dei corsi universitari di Anna Dolfi ed Ernestina Pellegrini, lezioni di didattica integrativa sulle poetesse del secondo Novecento, su Caproni, Sereni, Gadda e Landolfi.
Ha partecipato, con suoi testi o letture commentate, a manifestazioni pubbliche (Giornata della Poesia, Fiorano Modenese – MO, 2008 e 2014; Perché poeti in tempo di povertà, Firenze, 2016 e 2017). Dal 2017 collabora al Festival internazionale di poesia Voci lontane, voci sorelle, Firenze.
Nel 2008 si è classificato secondo al concorso Ottottave; nel 2014 primo per la sezione Inediti (ex aequo con Antonella Ortolani) al XX Premio nazionale di poesia Alessandro Contini Bonacossi.
Ha esordito nel 2016, per la collana «Opera Prima» di Anterem, con il libro di versi Don Giovanni all’ossario.
Giorgio G. Adami, nota biografica e altre opere
Giorgio G.Adami è nato a Verona il 7.8.1935.
Autodidatta , dipinge dal 1950. Ha seguito stages tenuti da qualificati maestri: A.Tavella, G. Celada, R Licata, R. Da Lozzo, N. Sene, per verificare e perfezionare le tecniche personali già acquisite.
Dopo l'esordio consueto m mostre provinciali, partecipa a varie rassegne nazJonah e mternazionati:
Roma, Venezia, Milano.Trento, Bolzano, Salisburgo, lnnsbruck, Rosario-Argenuna, Mexico, Parigi, Osaka, Monaco m Baviera, Sao Paulo(Brasllc), WashingtOn (USA).
Mostre personali in ltaha e all'estero.
Nel 1992 è invitato alla 3" edJZ1one di " Pittura a Verona" ( 1975-1991 ), curata da A.Mozzamban1 e L. Meneghelli, a Sona (Vr)
Il Comune di Verona,Assess.alla Cultura gli dedica nel 2006 una vasta antologica presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona, a cura di Luigi Mencghclli . E' il riconoscimento di una attività durata oltre 50 anni, segnata dalla continua ricerca di purificazione dei mezzi e delle intenzioni.
Parallelamente alla pittura ha compiuto lo studio del canto, perfezionandosi nel repertorio classico antico, che lo ba portato a collaborare con diversi art1st1 e istituzioni mus1cal1
Segue Biografia di Giorgio G.Adami:
Sue opere in collezioni pubbliche:
Galleria d’Arte Moderna A.Forti,Verona - Young Museum, Revere (MN)

P

Sue grafiche sono state inserite nelle seguenti pubblicazioni:
ANTEREM – Rivista di ricerca letteraria n.42-1991 – Verona
ELDORADO – Romanzo di Nereo E.Condini, ed.Anterem, 1991
LETRAS ABIERTAS, Rivista de Comunicacion Creativa, Madrid, n.2 e n.3 – 1992
BOUQUET – 110 frammenti in prosa di Marco Furia, ed.Anterem, 1992
CODICI - Poesie di Aldo Ferraris, ed.Anterem, 1993
IMPROVVISO E DOPO – Poesie di Giuliano Mesa, ed.Anterem, 1997
GRAMMI – 40 disegni di G.G.Adami, ed.Anterem-Verona 1997
MM’S Revolution, a Menippean Satire - di Madison Morrison. Ed.East & West,1998
VENTAGLIO, Poesie di Cinzia Ferro, ed.Cierregrafica, Verona, 1999
SCENES FROM THE PLANET, Prose di Madison Morrison, ed.Sterling Publisher ltd -New Delhi, 2001
CONTRASTI D’AMORE – poesie di Gilberto Antonioli – 2012
METROPOLIS –303 incisioni di 303 artisti, in un libro rilegato a leporello – ed.Centro Internaz.della Grafica, Venezia,2014. Il volume è stato esposto in musei e biblioteche pubbliche in Italia,Germania, USA, Brasile.
VARIE – Opera Prima, poesie di Massimo Stirneri - Ed.Cierre Grafica/Anterem, Verona
Dall'alto in basso, le opere sono "Piccolo racconto", "Due paesaggi", "Racconto d'autunno". La tecnica dei dipinti è olio e smalti su carta, solo "Due paesaggi" è un olio su tela, cm 70x50.
Ultima pagina: Autori presenti in “Carte nel vento”
Sebastiano Aglieco, Nadia Agustoni, Alessio Alessandrini, Pietro Altieri, Viola Amarelli, Angelo Andreotti, Marcello Angioni, Cristina Annino, Gian Maria Annovi, Lucianna Argentino, Davide Argnani, Giuseppe Armani, Alessandro Assiri, Daniela Attanasio, Dino Azzalin
Luigi Ballerini, Paola Ballerini, Daniele Barbieri, Bianca Battilocchi, Maria Angela Bedini, Daniele Bellomi, Primerio Bellomo, Mario Benedetto, Dario Benzi, Riccardo Benzina, Pietro Antonio Bernabei, Armando Bertollo, Giorgio Bona, Leonardo Bonetti, Doris Emilia Bragagnini, Silvia Bre, Fabrizio Bregoli, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani, Simone Burratti, Giusi Busceti, Antonio Bux
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Maria Grazia Calandrone, Giovanni Campana, Mario Campanino, Enzo Campi, Giovanni Campi, Martina Campi, Emanuele Canzaniello, Maddalena Capalbi, Michele Cappetta, Allì Caracciolo, Alessandra Carnaroli, Lorenzo Carlucci, Anna Maria Carpi, Peter Carravetta, Alberto Casadei, Mauro Caselli, Guido Caserza, Paola Casulli, Alessandro Catà, Alessandra Cava, Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Alessandro Ceni, Rossella Cerniglia, Marilina Ciaco, Viviane Ciampi, Gaetano Ciao, Laura Cingolani, Gabriella Cinti, Domenico Cipriano, Roberto Cogo, Osvaldo Coluccino, Tiziana Colusso, Silvia Comoglio, Federico Condello, Nicola Contegreco, Antonino Contiliano, Morena Coppola, Giorgiomaria Cornelio, Marina Corona, Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto, Lia Cucconi, Miguel Angel Cuevas, Vittorino Curci
Mauro Dal Fior, Anna Maria Dall’Olio, Chetro De Carolis, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Lella De Marchi, Evelina De Signoribus, Riccardo Deiana, Silvia Del Vecchio, Fernando Della Posta, Pasquale Della Ragione, Stefano Della Tommasina, Aurelia Delfino, Tino Di Cicco, Danilo Di Matteo, Vincenzo Di Oronzo, Stelvio Di Spigno, Letizia Dimartino, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria, Patrizia Dughero, Giovanni Duminuco
Marco Ercolani, Franco Falasca, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina, Silvia Favaretto, Francesco Fedele, Federico Federici, Annamaria Ferramosca, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Luca Ferro, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory, Zara Finzi, Raffaele Floris, Rita Florit, Ettore Fobo, Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Valentino Fossati, Biancamaria Frabotta, Kiki Franceschi, Tiziano Fratus, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Gabriele Gabbia, Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Marinella Galletti, Carmen Gallo, Gabriella Galzio, Guido Garufi, Paolo Gentiluomo, Mauro Germani, Fabia Ghenzovich, Alessandro Ghignoli, Gianluca Giachery, Anna Maria Giancarli, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Patrizia Gioia, Carolina Giorgi, Marco Giovenale, Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Llanos Gomez Menéndez, Giuseppe Gorlani, Alessandra Greco, Angela Greco, Cesare Greppi, Lino Grimaldi, Maria Grimaldi Gallinari, Giovanni Guanti, Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini, Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin, Andrea Guiducci
Giovanni Infelìse, Maria Grazia Insinga, Carlo Invernizzi, Stefano Iori, Francesca Ippoliti, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Michele Lamon, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Alfonso Lentini, Laura Liberale, Tommaso Lisa, Oronzo Liuzzi, Andrea Lorenzoni, Francesco Lorusso, Ghérasim Luca
Loredana Magazzeni, Marianna Marino, Emanuela Mariotto, Attilio Marocchi, Raffaele Marone, Francesco Marotta, Giulia Martini, Giulio Marzaioli, Vincenzo Mascolo, Stefano Massari, Mara Mattoscio, Alessandro Mazzi, Luciano Mazziotta, Daniele Mencarelli, Manuel Micaletto, Emiliano Michelini, Marco Mioli, Francesca Monnetti, Daniela Monreale, Gabriella Montanari, Emidio Montini, Romano Morelli, Sandra Morero, Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Gregorio Muzzì
Luigi Nacci, Paola Nasti, Giuseppe Nava, Stefania Negro, Davide Nota, Marco Nuzzo, Francesco Onìrige, Cosimo Ortesta
Luca Paci, Marco Pacioni, Alessandra Paganardi, Carla Paolini, Alice Pareyson, Paola Parolin, Angela Passarello, Giuseppe Pellegrino, Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Daniela Pericone, Roberto Perotti, Luisa Pianzola, Antonio Pibiri, Renzo Piccoli, Antonio Pietropaoli, Pietro Pisano, Stefano Piva, Daniele Poletti, Gilda Policastro, Chiara Poltronieri, Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Stefania Portaccio, Claudia Pozzana, Chiara Prete, Loredana Prete, Maria Pia Quintavalla
Jacopo Ramonda, Giuseppina Rando, Andrea Raos, Beppe Ratti, Luigi Reitani, Vittorio Ricci, Jacopo Ricciardi, Alfredo Rienzi, Giuliano Rinaldini, Alfredo Riponi, Massimo Rizza, Gianni Robusti, Marta Rodini, Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa, Sofia Demetrula Rosati, Lia Rossi, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti, Greta Rosso, Enea Roversi, Paolo Ruffilli, Gianni Ruscio
Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Rosa Salvia, Lisa Sammarco, Massimo Sannelli, Marco Saya, Viviana Scarinci, Antonio Scaturro, Evelina Schatz, Giuseppe Schembari, Fabio Scotto, Massimo Scrignòli, Loredana Semantica, Luigi Severi, Sergio Sichenze, Ambra Simeone, Stefania Simeoni, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Marco Sonzogni, Pietro Spataro, Fausta Squatriti, Giancarlo Stoccoro, Maria Paola Svampa
Antonella Taravella, Gregorio Tenti, Italo Testa, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato, Silvia Tripodi, Luigi Trucillo, Guido Turco, Giovanni Turra Zan
Liliana Ugolini, Tonino Vaan, Roberto Valentini, Camillo Valle, Sandro Varagnolo, Francesco Vasarri, Matteo Vercesi, Maria Luisa Vezzali, Ciro Vitiello, Annarita Zacchi, Simone Zafferani, Paola Zallio, Claudia Zironi
Febbraio 2019, anno XVI, numero 42

Il nuovo numero di “Carte nel vento” esce un mese prima degli eventi finali del Forum Anterem legato al 32° Premio Lorenzo Montano (edizione del 2018); il prossimo sabato 16 marzo al mattino verrà inaugurata la mostra dei ragazzi del Liceo Artistico di Verona, mentre al pomeriggio si terrà “Editoria e poesia”: venti poeti segnalati e finalisti all’ultimo “Montano” che leggeranno alcuni testi, introdotti da Flavio Ermini e Rosa Pierno, e dieci editori di poesia che racconteranno la loro attività e le loro esperienze.
Abbiamo il piacere di presentare qui i progetti preliminari dei ragazzi dell’Artistico, attraverso le anticipazioni che hanno espresso il 20 ottobre scorso: la loro passione, guidata dalla competenza dei docenti di riferimento, preannuncia anche per quest’anno una mostra ricca e importante sul tema del Forum, “Oltre le apparenze”. Prova ne sono i bozzetti che corredano gli interventi.
Il corpo di questo numero è rappresentato dalle prose e dalle poesie di alcuni degli autori che hanno animato a ottobre scorso la prima giornata del Forum Anterem: Doris Emilia Bragagnini, Giusi Busceti, Martina Campi, Paola Casulli, Enrico De Lea, Fernando Della Posta, Ettore Fobo, Fabia Ghenzovich, Vincenzo Lauria, Giulia Martini, Alessandro Mazzi, Stefania Portaccio, Enea Roversi e Sergio Sichenze, presentati dalla redazione di “Anterem”. L'apertura è dedicata a Franco Ferrara, grazie al contributo di Giorgiomaria Cornelio.
La nuova edizione del “Montano” ha preso il via: scarica il bando della 33^ edizione
In copertina: immagini di Emma Teti dal Forum Anterem, sabato 27 ottobre 2018
Giorgiomaria Cornelio, “Come il primo giorno del mondo. Un ritratto di Franco Ferrara”

Casa di Franco Ferrara e di sua moglie Raffaella, Settembre 2017
Sebbene ogni presenza oscilli nel vento breve di una foglia
E ogni parola disperda la propria luce
Nel letto deserto di un’assenza
E nel gelo di chi ha donato a tal punto
Da credere di non aver mai donato
Franco Ferrara, Questo intendevo dire
Incominciare, perciò, nell’osservanza della parola, facendo l’inventario delle carte in esilio. Insistere a far nascere la ferita del senso. Accertare, in anticipo, l’equivoco, l’inadeguatezza di ogni resoconto, e il filo d’oro del legare insieme i postumi del transito: “questa mia mano, che è della stessa terra della memoria*”. Franco Ferrara (16 marzo 1935 – 23 gennaio 2014) è stato poeta di versi “senza mendicherie di plauso o pitoccando governi, potentati, costanzesche adunanze d’osti, mimi, parolai, orchesse leste al calappio di con buche genitali, o lisciando elisiri di letterari menestrelli o cori di castrati”, e tanto basta a riparare la debile definizione di poesia come pura regione di circostanze: semmai l’enigma all’opera, il fuoco sopra ogni segno.
In una lettera all’editore a proposito della seconda edizione dello PseudoBaudelaire, Corrado Costa scrisse che per “il poeta non c’è nessuna biografia – a tutela della sua immagine.” Per Ferrara parliamo allora d’immemoriale, come se la definizione continuasse a ritrarsi, ad opporsi al certificato d’esistenza che lo volle, allo stesso tempo, docente, critico letterario, esploratore, fondatore di riviste letterarie ed autore televisivo. Prendendo poi a sbrecciare un poco la compagine dei resti, i “cinque continenti strappati al midollo dell’anima”, i quasi 40.000 volumi appigliati ovunque nella sua casa così irrecintata (avendo allora concentrato il nubifragio in unico auto-de-fé: esoterismo, alchimia, letteratura, religioni orientali…), il greto del testo reclama lo studio combinatorio, la vigilanza, il volgersi e il rivolgersi nell’altrove del viaggio e del deserto: non solo quello dell’Africa Sahariana, dove pure Franco Ferrara è stato nel corso delle sue spedizioni seguendo le piste carovaniere utilizzate dai Romani, ma anche quello scavato e innervato
nel corpo delle adunanze, delle reminiscenze fossili, del silenzio che trattiene “l’alba di due eternità”, e custodisce il canto d’amore d’un violino (Imzad, Edizioni Ripostes, poemetto legato alla lingua parlata dai Tuareg dell’Haggar e Premio Gozzano nel 1989).
Ferrara fa del deserto la capitale della moltiplicazione dei due tempi, e del tempo una stagione del sangue: poesia è “allevare l’uragano sulla fronte della siccità”. Qui l’accadimento e la storia sono cause pendenti, e la destinazione del detto è la carie. Sicché da un capo all’altro dello scisma si edifica la galassia nel corpo dell’altro, e l’amore diventa minuta ricreazione del mondo: “Vorrei bruciare incensi di comete per la tua anima (…) e rapire la prima parola di Dio per fartene un nido” (Lettere a Natasha, edizioni Ripostes, 1986, lungo poema in forma di corrispondenza iniziata altrove, come originato senza origine). Qui, infine, la poesia fa luce prima dell’alba, e bisognerebbe ascoltare senza inginocchiare le parole soltanto al sigillo dell’oracolo, ma riconoscere un’altezza che è precedente ad ogni altezza, cioè una formula per rifare il mondo (diciamo, noi ultimogeniti: per uscire dal “postmoderno”):
Mentre anche la natura si ripete, essendo ogni nuova primavera la stessa eterna
primavera (cioè la ripetizione della creazione), la « purezza » dell’uomo arcaico, dopo
l’abolizione periodica del tempo e il ricupero delle sue virtualità intatte, gli permette, alla
soglia di ogni « vita nuova », un’esistenza continua nell’eternità e quindi l’abolizione
definitiva, hic et nunc, del tempo profano. Le « possibilità » intatte della natura a ogni
primavera e le « possibilità » dell’uomo arcaico all’inizio di ogni nuovo anno non sono
quindi omologabili. La natura ritrova soltanto se stessa, mentre l’uomo arcaico ritrova la
possibilità di trascendere definitivamente il tempo e di vivere nell’eternità. Nella misura
in cui fallisce nel farlo, nella misura in-cui egli « pecca », cioè cade nell’esistenza «
storica », nel tempo, sciupa ogni anno questa possibilità. Però conserva la libertà di
abolire queste colpe, di cancellare il ricordo della sua « caduta nella storia » e di
tentare nuovamente una definitiva uscita dal tempo.
(Mircea Eliade, Il mito dell’eterno ritorno)
La prima pubblicazione di Ferrara, I pascoli della nostra mano, viene fatta risalire al 1960, e a questa fecero seguito, tra gli altri volumi, la “Storia della sorgente del tronco bianco”, traduzione da Tymoteusz Karpowicz come rivolgimento e divagazione, rinvio del senso ed invito a pensare il “testo” come estremità mutevole, da cui sempre si passa, e “Nella polvere d’oro d’una antica stanchezza: manomissioni e licenze” sempre su testi di Timoteusz Karpowicz e di Ursula Koziol.
A metà degli anni 90 Ferrara aveva iniziato a comporre un romanzo rimasto incompiuto, sua “dilettosa narranza”, dal titolo Ritorno all’Indie meridiane
ovvero
sulle vicende realissime e postreme
di Aliotto da Guienna
Lupo Goliante, Ghiandino Colapicco, Livriero di Vega
e Albarello Cometa
che le su dette
narrò.
Sempre continuando ad impietrire la parola, a farne una cera, un nido paretimologico che trattiene la densità dell’andare, cercando così non il governo di un’origine certa, ma lo spazio, la terra eletta del tappeto dove “le figure rovesciate si ricomporranno nel tessuto splendente, nell’atlante perfetto dei significati” (Cristina Campo), Ferrara ha rivolto la sua poesia oltre il letargo delle categorie interiori e del tempo presente: perché “mitologia è ontologia”, mattino di un altro giorno, conferenza sulla caligine, viaggio che non ha fine, canto:
“(…) E aver raccolto il deserto nel cavo della gola
Aver nutrito col sangue l’indifferenza delle pietre
Aver assunto la leggerezza della nebbia
Per confondere ciò che l’assenza ha lasciato
nei miei occhi
Aver piegato parole come ginocchia
Per colmare lo scarto esiguo tra due onde
Aver fissato parole di una solitudine nuda
Come un cuscino sgualcito dall’assenza
Aver scavato parole per alimentare le vene
e disciolto ogni vena per ricomporla in parola
e da labbra umane essere dissolto in suono.
Questo intendevo dire.”
*Tutte le citazioni sono versi di Franco Ferrara, laddove non indicato altrimenti
Giorgiomaria Cornelio (14 Gennaio 1997) ha fondato insieme a Lucamatteo Rossi l’atlante Navegasión, inaugurato nel 2016 con “Ogni roveto un dio che arde”. Il film è stato presentato alla 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ed è stato incluso nella selezione dei Rencontres Internationales Paris/Berlin 2018.
In corrispondenza con il loro secondo lavoro, “Nell’’insonnia di avere in sorte la luce”, i due hanno curato l’esibizione “Come tomba di un sasso, come culla di una stella”, ospitata in Italia alla galleria Philosofarte, al Pesaro Film Festival, al Marienbad Film Festival e al Trinity College di Dublino, dove entrambi studiano.
Tra le altre collaborazioni si segnalano la performance “Playtime” e la mostra “Young at heart, old on the skin”, entrambe realizzate da Franko B.
Giorgiomaria Cornelio è il co-curatore del progetto di ricerca cinematografica “La camera ardente”, ed è anche scrittore: i suoi interventi sono stati ospitati in riviste e blog come “Artnoise”, “Le parole e le cose”, “Il Manifesto”, “Anterem", “Il Tascabile”, “Doppiozero” e “Nazione Indiana”, di cui è anche redattore.
Progetti per una mostra dei ragazzi del Liceo Artistico “Nani-Boccioni” di Verona
Liceo Artistico statale di Verona “Nani-Boccioni”
PROGETTO “OLTRE LE APPARENZE”
Immagini di una presentazione: i ragazzi del Liceo Artistico fotografati da Massimo Girelli
I ragazzi del Liceo Artistico fotografati da Massimo Girelli
Doris Emilia Bragagnini, poesia inedita “determinismo verticale”, premessa di Ranieri Teti
In sette versi Doris Emilia Bragagnini ci dimostra che la poesia, tra le sue varie rappresentazioni, può essere l’istante del pensiero, quel momento colto apparentemente a bruciapelo e che vive per sempre. L’autrice è nella scena, ma in secondo piano: “io” non domina, diventa un “me” quasi accennato. Come ricordare un sogno. Nella brevità del testo, la fase onirica iniziale, tra falco e ballerina, svettare e passo, becco e labbro, introduce l’abisso cui può spingersi la poesia: verso l’insaputo, attraverso “un fiore reclinato sull’eterno”. Come ha scritto Karl Kraus, la poesia è la via più breve per andare da un rigagnolo alla Via Lattea.
determinismo verticale
del falco che t’incideva il passo, lo svettare sulle circostanze
fermo sulle - punte - con la grazia di una ballerina di Doisneau
non ho più sentito il grido lo strappo di becco il varco
che mi sapevi togliere dal labbro
come un fiore reclinato sull’eterno, versato
goccia a goccia disanimata glossia all’orecchio del mondo
il tuo dentro insaputo, il baleno di un cielo inciampato
Doris Emilia Bragagnini: ”nata nel nordest vive da sempre a due passi da sé, qualche volta v’inciampa e ne scrive”. Compare con suoi testi in varie antologie (tra cui Il Giardino dei Poeti ed. Historica e Fragmenta premio Ulteriora Mirari ed. Smasher), in blog e siti letterari come Neobar (cui collabora come redattrice), Il Giardino Dei Poeti (vi ha collaborato), Filosofi Per Caso, Torno Giovedì, Linea Carsica, Carte Sensibili, Words Social Forum, Via Delle Belle Donne, La Poesia e lo Spirito, La Dimora del Tempo Sospeso, Poetarum Silva. Ha partecipato ai poemetti collettivi “La Versione di Giuseppe. Poeti per don Tonino Bello” e “Un sandalo per Rut” (ed. Accademia di Terra d’Otranto, Neobar 2011). Menzione speciale per il testo “Claustrofonia” sezione “Una poesia inedita” premio Lorenzo Montano 2013 e per il testo “di fuga Soluta” nel 2016. Premiata con segnalazione la silloge inedita “Claustrofonia” al Premio Lorenzo Montano 2017. Il primo libro edito: OLTREVERSO il latte sulla porta ed. Zona 2012. Presente in alcuni periodici on line e cartacei tra cui Carte nel Vento a cura di Ranieri Teti, EspressoSud a cura di Augusto Benemeglio. Recentissima la pubblicazione di “Claustrofonia” per Ladolfi Editore (dicembre 2018) con prefazione di Plinio Perilli e postfazione di Laura Caccia.
Giusi Busceti, poesia inedita “Vetrine”, premessa di Ranieri Teti
Il dio della metropoli non si cura delle apparenze, come il poeta che racconta la profonda vita di una reale città trasfigurandone gli abituali connotati.
Le vetrine, alle ore ventidue, sono poesia dell’abbandono, “maglie disabitate”. Con tutto quello che nel giorno è passato, tutto quello che “sembra”, come ciglia finte, o foglie che cadono. Il dio della metropoli, di notte, è sul marciapiede di una città che dopo essersi inchinata al crepuscolo riesce a essere accogliente. Perché “in noi è chi respira”. Non è vero che siamo tutti stati vinti, ci dice Giusi Busceti, dal "sempregiorno".
Vetrine
A vetrine serrate amo i ricami
maglie disabitate scialli spille
richiami strass su sagome, scintille,
micromosse di vacue finte ciglia
vanno sospese alle ventidue
col vento, ora imprevisto il corso taglia
sciame di foglie scontrini sollevati
fogli sperduti al mondo noi in quest’ora
sostiamo, è l’inazione: e l’invenzione
degli occhi trova fine, svela volto
del nulla una corrente che afa oscura
argina ai visi erosi della nausea,
dei condizionatori, mentre avanza
un minuto ogni giorno la stagione
il crepuscolo invade e la città
s’inchina, stoppia secca che si estingue
Europa sotto il velo che non sa
di corpi nuovi d’altro mondo avvolti
ma sorgi, sera di nessuno scopo
munificente frutto ora discendi
arancio verde azzurro gelatina
rosa dai cieli a grappoli nel bianco
firmamento che in noi è chi respira
qui ora dove ha centro il sempregiorno
e la città che scende s’inginocchia
sotto la gemma immobile che veglia
ogni vetrina tacco ritmo tace
e polvere ritorna, torna amore.
Giusi Busceti è nata a Milano, dove risiede. Ha pubblicato Sèstile (Corpo 10, Milano 1991), le plaquette L’innaffiatoio (Signum Edizioni d’Arte, Bollate 2001) e Due Scatti (Madam Web, Milano 2005) e la raccolta A nucleo perso (LietoColle, Faloppio 2007). Suoi testi sono apparsi su riviste italiane e straniere, tra cui: Alfabeta, Anterem, Manocomete, Hebenon, Gradiva, BlocNotes, Chelsea, Il Segnale, Qui, Il Monte Analogo, La Mosca di Milano. E’ presente nell’Antologia “Italian Poetry 1950-1990”, Dante University Press, Boston, 1996; “Nottetempo”, Ed. Di Latta, Milano 2007; finalista al Premio di Poesia “Lorenzo Montano” 2005, ha collaborato all’Antologia Poesia Contro Guerra, a cura di Antonella Doria, Ed. Punto Rosso, Milano 2000-2007; è tra gli autori dell’opera critica Vertigine e Misura, appunti sulla poesia contemporanea, a cura di Marco Ercolani, La Vita Felice 2008 e dell'Antologia Chi ha paura della Bellezza, a cura di Tomaso Kemeny, Arcipelago Edizioni 2010. Nell'Antologia "La poesia del lavoro" compare tra i vincitori del Primo Premio di Poesia bandito nel 2014 dal Sindacato CISL. Del 2017 sono l'antologia Perturbamento, per le Ed. Joker a cura di Marco Ercolani, che include una scelta di suoi testi per la sezione dedicata ai poeti contemporanei, e la plaquette Buio Selvatico, in coppia con un’opera dell’artista Andrea Capucci, per le edizioni Pulcino Elefante di Alberto Casiraghi. E’ in uscita per la collana de Il Verri la sua ultima raccolta, Ufficio del sole, con prefazione di Angelo Lumelli.
Nella redazione della collana di poesia Niebo, diretta da Milo de Angelis, dal 1999 al 2002, è Presidente dell’Associazione Casa della Poesia al Trotter di Milano, che opera dal marzo 2004 per la diffusione della poesia nei suoi più diversi registri, anche nelle periferie multiculturali e nella scuola; da ottobre 2017 è Art director dello Spazio 57events nel quartiere NoLo (North Loreto), Milano.
Martina Campi, dalla raccolta inedita “Partitura su riga bianca”, nota di Laura Caccia
Spartito liquido
Se cercassimo le parole per dare suono al silenzio, farne parti in musica, orchestrarne i battiti, potremmo seguire la voce di Martina Campi che in Partitura su riga bianca porta l’oralità a confrontarsi con l’assenza sonora. Nell’insieme di parti e di riga, di silenzio e di suono, in un contrappunto poetico dove la sonorità viene intensificata dalle citazioni del cantautorato, soprattutto di lingua inglese, e l’interruzione acustica da pagine bianche e parentesi mute. Anche se, di fatto, musicare il silenzio pare impresa ardua.
Già J.Cage, nella sua famosa composizione 4′33″, aveva evidenziato come la stessa opera non potesse costituirsi come silenzio assoluto, poiché, durante l’assenza di esecuzione strumentale, altri suoni venivano evidenziati, fossero il battito del cuore degli ascoltatori, il loro respiro o i rumori esterni.
C’è un suono nel canto, ma anche nell’assenza di suono, pare dirci l’autrice, “una / modulazione” oppure anche “solo un grido / se mai in cuffia / spacca silenzio / in pezzi / abitati”. E c’è un’inquietudine che chiede sia il nutrimento della voce, per “questo malessere / (dì le) lame nell’essere // una madressere poi, / non accudire… / nutrire”, sia il respiro del silenzio, tra i “nomi che vanno al rumore / del discorrere, a me il silenzio / del dispiacere”.
La sensazione complessiva è che si sia in presenza di una poesia liquida, fortemente sonora e altrettanto intensamente inquieta e sofferente, tale per cui “qui / c’è / l’affogare (/affiorare)”. Dove la frammentazione, la reiterazione e l’uso sospensivo delle parentesi conducono il linguaggio e il pensiero in uno stato di immersione, che assume andamenti oscillanti e onirici, in cui sonorità e sensi si stemperano nello stesso stato fluido in cui si dissolvono assenze sonore e vuoti di senso.
Quasi che l’alternanza suono-silenzio diventi anche corrispettiva di quella tra lo stato di veglia e il sonno-sogno: “ascolto il mondo / svegliarsi / così non disturbo / le scale dei sonni”, così che anche i sonni e i sogni si possano distribuire lungo scale musicali, nelle loro partiture scritte su righe invisibili.
Come il linguaggio poetico, che ha i suoi spartiti inconsci, le sue righe bianche, le sue parole mute. E che riesce per questo, quando emerge nelle parti sonore e nel frammentarsi del dire, a dare risonanza al sommerso. Martina Campi ne ha piena consapevolezza quando esprime “la gratitudine come / attore linguistico / accenno a scelte / non espresse, / attraverso / il frammento riscosso / per linguaggio”.
Una scrittura per frammenti la sua, intensamente sonora anche quando è spezzettata, anche quando è silenziosa. Dove il nome trova spazio nel canto come nell’assenza di nome. Poiché ciò che più conta, in poesia, è “Tenere il nome / nel luogo più caro”.
Dalla sezione “Riga – Suono”
***
nei giorni del vento
ai cambi di stagione
della brezza
che apre la porta
viene a fermarsi
viene a guardare
quel lontano
(piccolo) vibrare
che poi sono i resti
delle foglie smesse
o forse sono s(p)ecchi
per congiunzione addestrati
picchi all’attraversamento
I've been to a minor place*
* Will Oldham
Dalla sezione “Riga – Suono III”
***
s’è tentato con le spezie
a fare come si deve
e una cartolina è sopravvissuta
dallo Sri Lanka
qui, mentre pioveva forte
nel lasciarsi c’era tutta
la neve di gennaio
la musica in macchina
solo anziani che scivolavano
per la via, niente da mangiare
say something once, why say it again?*
*Talking Heads
Dalla sezione “Parti – Silenzio IV”
***
un buio pianura e notte allarga
grovigli di macerie gialle rifiuti e lenzuola
ascolto il mondo
svegliarsi
così non disturbo
le scale dei sonni
Martina Campi autrice e performer, ha pubblicato: La saggezza dei corpi (L’arcolaio, 2016), Cotone (Buonesiepi Libri 2014), Estensioni del tempo (Le Voci della Luna Poesia, 2012 – Vincitore Premio Giorgi), e la plaquette È così l’addio di ogni giorno (Corraino Edizioni 2015), con il poeta V. Masciullo e opere grafiche di C. Pozzati.
Curatrice, con A. Brusa e V. Grutt, di Centrale di Transito (Perrone Editore 2016).
È stata giurata per alcuni concorsi e membro di redazione della rivista Le Voci della Luna, fa parte del Comitato Bologna in Lettere B.I.L dalla prima edizione.
Da giugno 2017 partecipo a Il banchetto di Rosaspina – Di virtù e maledizioni, Spettacolo di Teatro, Poesia e Favola, di e con Alessandra Gabriela Baldoni; con Giancarlo Sissa, Luna Marie, Mario Sborina.
Co-fondatrice, con il compositore e musicista Mario Sboarina, del progetto Memorie dal SottoSuono – The poetry music experience, nel quale si fondono reading poetico, elettronica, jazz/ambient, contaminazioni afro e accenni di musica popolare; di Marzo 2016 l’omonimo album. Del 2010 il cd Mani e qualcos’altro. Il progetto Memorie dal SottoSuono è oggi un vero e proprio collettivo di artisti di diversa formazione.
È nata a Verona nel 1978. Vive a Bologna, dove ha studiato e si è laureata in Scienze della Comunicazione. Vincitrice del Premio Renato Giorgi 2012 con Estensioni del tempo (Edizioni Le Voci della Luna Poesia, 2012). Tra gli autori finalisti al Premio Lorenzo Montano 2014, con la raccolta inedita Manuale d’estinzione, tra segnalati nel 2012 con La saggezza dei corpi (L’arcolaio, 2016) al medesimo premio e menzione d’onore, l’anno successivo, con la raccolta Le metamorfosi della gioia, ora divenuta Cotone (Buonesiepi Libri 2014) e nel 2015 con la silloge inedita Quasi radiante.
Paola Casulli, prosa inedita “Akedia” (Through darkness to light), premessa di Davide Campi
Paola Casulli si produce in una prosa apertissima, ricca di parole ora evocative ora forti, priva di punteggiatura, a parte gli indizi depistanti di alcune lettere maiuscole. Una prosa priva di ritmi prefissati o di altri ancoraggi che ne facilitino la lettura e la fruizione. Il risultato è un continuo senso di equilibrio e spaesamento, che accompagna la lettura come un viaggio in mare tempestoso.
In questo viaggio nell’accidia l’autrice si muove attraverso l’oscurità verso una luce.
Per compierlo mediante un’imbarcazione di parole, Paola Casulli opera costantemente pressione su di esse, come per addensarle, ispessirle e renderle ancora più risonanti nella caduta sulla pagina.
Akedia
Nessuno resta inerti come siamo nella bufera Nessuno ha parole in mezzo ai campi inseguiti come siamo dai lupi dai loro artigli rossi una zampa davanti all’altra raggiunti oltre il legno e il ruscello odori teneri noi E subito dopo caprioli di sangue ché il lampo a ferirci è senza pietà che muove i perdonati Nessun suono o rumore separa le ombre restiamo sulle zolle distesi relegati nella storia di esseri invisibili in mezzo a tanta dissacrazione siamo le foglie sopra l’erba La metamorfosi concessa ai fiori che imputridiscono nutriti dal vento torturati dal fango nell’istante dell’ubbidienza restiamo sulle pianure fissi e immobili a conoscere un solo Creato senza spirito che di carne ne abbia il riflesso senza corpo che abbia un residuo flebile tra le mascelle sulle pianure restiamo infiniti nel pianto È la mia calma che ha man- dato via tutti O il mio odio lento di altre piogge Come goccia sull’orlo di una tazza l’ho vi- sta scivolare via Non c’è spiegazione della sua gravità della goccia Essa scivola e basta E così fanno tutti solcando la piaga che non assolve Questa è la carezza del nulla La materia in cui l’attimo freme e si concede all’occhio del meridiano spaventoso quella che (volendo trionfare) si arrampica sulla parete impervia di ogni anticipo e cade nel supplizio di ciò che tutto scorre Noi abbiamo lo stesso supplizio La stessa preghiera ripida linea sonora caduta pesantemente al suolo Qui si spengono tutte le pareti le elegie i mormorii e poi le urla La triplice specie che si chiama - Padre - e dice << prega >> tacendo i salici nel petto più di- stante il Figlio che dice << sii cauto>> flagellandosi nella gloria del ritorno e infine il legge- ro turchino Spirito a sussurrare <<voi siete me>> o forse più esattamente con stizza a chie- dere nella molle grazia di qualche scirocco << voi siete me?>> Ebbene questa piratesca forma di ogni cosa ha molte stanze e tra poco farà buio si sentono sbattere porte cigolii ra- gnatele che pronunciano esili Tu fasciato nella benedizione dell’ametista hai tutto questo nella testa vero? Anche tu incline al gioco dei cenobiti prima del punto bendato sei nel petto della Vergine lo stupore delle pupille riverse ecco siamo simili a Lei la ruga del lungo asse- dio vittime di lunghi balzi nel mondo a rovescio a frantumare le uova molli del demonio Nessuno resta nell’intervallo di attese senza muri a scambiarsi una morte con un’altra bardo sfuggiti di mano A questa prima morte senza peso ho dato pietre per la chiocciola del dive- nire Alla seconda morte senza forma soltanto strazio che è meno di niente Alla terza morte senza storia ho dato scaglie grigie di una devozione di rami Alla quarta morte che dicesse appartenenza o invocasse il frastuono dell’onda che aggredisce la roccia che raggela la rena che si ammassa sugli scogli e li rende lividi di afflizione ho dato ginocchia allentate dalle redini a misurare il sonno e le rose e le ortensie e i gelsomini svanenti Io assolto dalle consonanti di un abbandono Io battezzato nell’incandescenza delle tue costole costretto a sentire la tua voce a dirmi c’è ancora un Est sopra le cascate Ma la bellezza che nessuno comprende una specie di intimità è andarsene all’improvviso come fuco o lombrico e porge- re il buio alla chioma delle candele Creare quel bianco uguale alla mia chiarezza il peso istintivo del Perfetto Nessuno resta in questa aurora obliqua Nessuno ha parole nei solchi della terra dove pure le formiche ci somigliano con i neri dorsi sui crinali e insetti fosforescenti rilucono sui fondali al di là delle foreste Tenere d’occhio la strada ecco questo è l’importante Quel desiderio e l’intelligenza nella spietata nudità di deserto ciò in cui io posso scivolarci dentro e Tu patire il mio sguardo Io torturato gelido fisso nel perdere ogni cosa una preistoria di cancelli aperti sul tuo giardino di liquirizie così oscuro perverso e perduto Esattamente cos’è che voglio vedere? In questo luogo perfetto emisfero? Ha smesso di pio- vere Tu sei geniale quando dici vado a vedere fuori non corri il minimo rischio in tal senso tremi così tanto tu che sembri così veramente vero Nessuno resta in questo paradiso che aggrega la pelle alla velocità trattenuta del tempo e della terra all’affondo di una spada e Io la vedo fuoriuscire dalle maniche troppo larghe a tradirmi a colpirmi polvere fine di gesso Non temere sopravvivi alle poche cose alle storie e agli addii ai polpacci di tessuto alla carnagione di acero a renderti lieve al vento e al declino E così ora conto fino a dieci prima di entrare nella penombra nel crepuscolo color fumo dei miei gomiti dei miei fianchi delle mie mani in quel vento australe arrendevole quasi in quel fioco esserci in quella colomba da poterla tenere nel palmo di una mano sola l'unica che mi è rimasta L'altra è sulla corteccia di un albero a scolpire il grido degli agnelli Nessuno resta È questo sedersi come nuvola spazio che coincide sulle nostre schiene impure le ali sui cardini sospese Questo è ciò che affama in quell’aria scolorita dal sole un orlo scucito in una vicinanza apparente E non lo sai mai con certezza se saltare lo steccato o andare a salti giù per il ripido sentiero semplicemente con la testa piena di stupore restare avvinghiato al fruscio delle foglie sentire sotto i piedi l’erba che circonda le caviglie che risale placida sul tuo ventre mentre tutto ciò a cui tieni siede nel vecchio inverno spento delle litanie di una voce che imita la pioggia con quel cadere giù confusa prima del risveglio sono i sogni che annegano con le narici piene di muschio azzurrate in grigio-verdi una notte dopo l’altra in avvelenamento progressivo assumiamo ridicole ali da cornacchia indossiamo maldestri sguardi da combattere e dirci catene ho visto quel filo grigio appeso al collo una sfilza di croci tra le mani a chiederti Con la bocca chiusa perlopiù Senza mai smettere di pensare certe cose non sembrano vita mentre le fai.
Paola Casulli nasce a Ischia ma vive da poco più di un anno tra le colline del Monferrato. Poetessa, fotografa, giornalista, pubblica 4 raccolte di poesie, “Mundus Novus” ed. Del leone, “Pithekoussai, racconti di un’isola”, ed. Kairos, “Di là dagli alberi e per stagioni om- brose”, ed.Kolibris, “Sartie, lune e altri bastimenti” ed. La Vita Felice. Pubblica anche 2 poemetti brevi, “Lontano da Itaca” e “MitoGrafie”. Il poemetto "Lontano da Itaca", è stato portato a teatro con successo a Verona, con coreografia della stessa Casulli.
Una raccolta di racconti, “7 racconti del vento immobile”, è in editing.
Si avvicina alla fotografia tanti anni fa con una Nikon reflex analogica e poi con una D3100 e solo un paio di obiettivi. Con questo piccolo bagaglio comincia la sua avventura artistica e spirituale. Inizia infatti a viaggiare in tutto il mondo cercando di catturare volti, colori e impressioni di quei luoghi lontani. I ritratti e il colore sono la sua ricerca artistica. Nei gesti, negli sguardi di persone lontane migliaia di km dal suo vissuto quotidiano, Paola ritrova un’umanità fatta di grazia e di bellezza. Ora le fotocamere e gli obiettivi sono ben altri, ma rimane intatta la sua voglia di scoprire e viaggiare. Organizza eventi culturali che uniscano la poesia con la fotografia e scrive reportage di viaggio su riviste culturali.
Il suo blog, "Incanto Errante”, é il suo blog di poesia e fotografia, reportage e racconti di viaggio.
www.incantoerrante.com
Enrico De Lea, dalla raccolta inedita “Anacoretico cartiglio”, nota di Laura Caccia
Rosario laico
Si snoda per tappe di memoria e di pensiero, nel suo percorso dedicato a persone e luoghi cari, la raccolta Anacoretico cartiglio di Enrico De Lea. Un percorso intriso di meditazioni e di cammino, attento all’alterità e alla pluralità del sentire, poiché “Ci sono versi, / Ed anche versi della bocca, / Che vogliono il sentiero / La pietra che si tocca e il passo / Ed un "noi" sempre, / Almeno sottinteso”. Dove la parola cerca, nello sgranarsi del pensiero, di riprendere la rotta di un dire in movimento verso il proprio senso.
Quasi un rosario laico, in cui brevi testi datati scandiscono ricordi familiari, paesaggi, figure poetiche e letterarie incontrate realmente o vissute attraverso intense letture, nello scorrere della ghirlanda dei nomi di Raboni, Sciascia, Cattafi, Sereni, Carducci e nel susseguirsi di passi e ancora passi, come grani, orazioni.
Che si tratti di sgranare il movimento in piccole parti, quasi una necessità di concentrazione chiaramente espressa dalla brevità dei testi, come viene esplicitato anche da un titolo interno ripetuto “tre passi sgranati di un rosario”, o che si tratti di un atteggiamento di devozione e contemplazione che accompagna la memoria di paesaggi e di affetti, come indica l’autore: “mi recito e dico, invano / forse, per le mie mute, inesauribili orazioni”, la raccolta ci mostra le due azioni complementari, di cui necessita il pensiero: l’erranza e la meditazione, il moto e la riflessione.
Il verso è già, in sé, movimento, vertigine di suono e di senso. E questi versi in rima, spesso endecasillabi, mettono a fuoco, nell’illuminare ogni tappa del cammino, il loro moto inesausto in cerca di senso. Forse un senso che è stato sottratto, celato. Forse il mistero che si cela nell’esistere. Che richiede un percorso di riflessione su come possa la parola, quella poetica soprattutto, essere in grado di avvicinarne l’enigma, di arrivare all’essenza del tutto.
Da un lato, per l’autore, la parola resta all’estremità, sul ciglio della sua solitudine: “A margine freddamente si tratteggia / La parola che c'è, il finto foglio, / La rinuncia schizzata, in una scheggia / Di estremo anacoretico cartiglio”. Dall’altro, è forse nell’astenersi dal pronunciare i nomi dell’apparenza, nel rinunciare a nominare la molteplicità che le è possibile giungere all’essenza delle cose: “Così, senza nominare, senza evocare, scendere / alla dimensione dei muri a secco, con le mani”.
Dove si trovino allora i nomi del vero, possiamo chiederci con l’autore, che, insieme alla ricerca del senso esistenziale, non cessa di farne inesausta domanda. E in quale luogo straniero o sommerso, in quale significato maiuscolo o minuscolo si nasconda il loro segreto. Forse possiamo dire che il mistero che racchiude il rosario laico di Enrico De Lea consista proprio nell’ignoto che li cela, come emerge dalla potente interrogazione: “e se tutto in minuscolo il mondo / tutti celasse i Nomi, in fondo in fondo?”
(amabili mezze)
dire a metà l'intero
della vita, a misura del vero
fino a metà saperla definire,
la mezza birra o la mezza
con panna, per la granita,
arrivo di magi, ma senza
oro incenso mirra
(26 Dicembre 2015)
(prova per silenzio)
il silenzio di mio padre nascondeva la diserzione –
dal mondo, dalla vita quotidiana, financo
dalla storia, con una battuta al solito banco
del caffè – una sorta di vittoria per omissione,
una passeggiata per lenta sottrazione
(6 Luglio 2016)
(palinsesti filiali)
giorni che resteranno palinsesti da raschiare
ove scoprire riscrivere i padri andati
i loro nomi le loro parole nel camminare
da un versante all’altro delle contrade;
sarà sempre un’opera filiale, si voglia o no,
una parola sfuggita, un detto sfuggito all’oblìo,
ovunque ci sia tempo e lentezza dell’occhio,
sulla terra dei loro passi, nel resto che non è addìo
(28 Marzo 2017)
(a margine)
A margine freddamente si tratteggia
La parola che c'è, il finto foglio,
La rinuncia schizzata, in una scheggia
Di estremo anacoretico cartiglio.
(07 novembre 2017)
Enrico De Lea (Messina, 1958), originario del territorio tra Casalvecchio Siculo, nella Valle d’Agrò, la riviera jonica, Messina e lo Stretto, vive e lavora in Lombardia.
Ha pubblicato le raccolte di poesia Pause (1992, Edizioni del Leone), Ruderi del Tauro (2009, L'arcolaio ed.), Dall'intramata tessitura (2011, Ed. Smasher), la sequenza- poemetto Da un'urgenza della terra-luce (2012, Ass. La Luna, nella collana diretta da Eugenio De Signoribus) e la raccolta La furia refurtiva (2016, Vydia editore).
Suoi testi sono apparsi sulle riviste Wimbledon, Specchio (de La Stampa), Sud, Atelier, Tuttolibri, Registro di Poesia (Editore D'If), Caffé Michelangiolo.
E’ presente nell’antologia “Poesia di strada 2010- Licenze Poetiche” – Vydia editore, 2011, Macerata, e nel volume collettaneo Parabol(ich)e dell’ultimo giorno – per Emilio Villa – a cura di Enzo Campi – DotCom Press edizioni, 2013.
E' stato finalista o segnalato al Premio Licenze Poetiche- Poesia di strada – Città di Macerata (vinto nel 2010), al Premio Miosotis-D'If editore (Napoli), al Premio Lorenzo Montano (Verona), al Premio Tirinnanzi (Legnano), al Premio Interferenze – Bologna in Lettere.
Ha pubblicato in rete in vari siti e blog, tra cui Rebstein, Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, Compitu re vivi, Poetarum silva, Carteggi Letterari, Arcipelago Itaca, Atelier, Carte nel vento- Anterem, pubblicando anche su un proprio blog, da presso e nei dintorni.
Fernando Della Posta, dalla raccolta inedita “Gli anelli di Saturno”, nota di Laura Caccia
Alchimie d’inciampo
Quasi seguendo le orme del dio della rigenerazione, nella raccolta Gli anelli di Saturno Fernando Della Posta pare mosso dall’esigenza di uscire da asfissie e indifferenze, di trovare altri spazi oltre le apparenze, come dichiara nel testo di apertura, fino ad “ascoltare lo scroscio di cascate che non si vedono … / erodere il contrafforte / con la discesa al baratro… / Incontrare i folli / di queste vastità… / dimenticare i sunti dei sentieri più battuti”.
Una rigenerazione che prevede il superamento dei confini e delle limitazioni e che richiede l’assunzione della sofferenza quale modo di possibile rinascita. E che necessita, all’interno di una raccolta molto concentrata sulle vicende terrene, di fare i conti con il senso del dire, chiedendosi cosa sia poetico e cosa sottenda confrontarsi con la ricerca estetica, rispetto alle connesse connotazioni etiche.
Per cui se, da un lato, “si deve fare / dell’impoetico il poeticissimo, / estrarre la bellezza da tutte le cose”, dall’altro è forte la tensione tra il senso del bello e lo stato di pena: “quella bellezza / che a notarla ci vuole una certa noncuranza / per la sofferenza / che pochi dimostrano di avere / e che spesso può sapere / d'impietoso guardare”.
Allora, come si colloca la parola poetica? Fino a che punto può portarci a seguire le meraviglie del cosmo e della natura e fino a che punto costringerci a fare i conti con le esperienze terrene dell’umano?
Scrive l’autore: “Il gioco del poeta è saltellare / da una nuvola all'altra del cielo / cercando l’inciampo dell’ingiuria / che riporta a terra”, dove, nell’insieme di stati onirici e di dura realtà, può trovare “quella voce / come unica, incandescente luna di salvezza”.
Vi è come un girare intorno al reale rimanendo in sospensione, quasi a ricordarci gli anelli di Saturno, quando leggiamo come per l’autore vi siano “imprevedibili alchimie / che tengono salde le cose” e come gli sia necessario porsi “nei luoghi dei passaggi di stato / non appartenere né all’uno né all’altro / per fare di tutte le fioriture / un’epifania”.
Vi sono, però, anche l’urto, l’inciampo, l’esigenza di rovesciare le certezze, di capovolgere le apparenze. Siano esse legate alla realtà o agli assiomi del pensiero. Siano esse legate alla percezione di sé o all’idea dell’altro in una rifrazione continua che mette in evidenza gli opposti, poiché “spesso noi non siamo altro / che l’altro di noi stessi”.
“Scrivere è ritrovarsi in una casa altra” allora, possiamo affermare con l’autore, soprattutto uscire da noi stessi, urtare negli ostacoli e negli impedimenti che possono rendere autentica ogni parola poetica: “Poesia non fa sconti.”, come ci indica Fernando Della Posta, “Il noi che resta imprigionato / dentro poche pennellate / si avvale soprattutto / del diritto d’inciampare”.
Dalla sezione “Spazio profondo”
***
Stare nei luoghi dei passaggi di stato
non appartenere né all’uno né all’altro
per fare di tutte le fioriture
un’epifania. Un gioco pericoloso:
le corsie preferenziali possono tradire
e i trivi possono fare da falsa prigione,
ma si può scoprire
che non esiste un tradimento più dolce.
Dalla sezione “Gli anelli di Saturno”
***
Essenza del punk (trick or treat?)
Il punk non è poesia
ma la poesia contiene il punk.
Il punk vero non è punk. Solo quando è vero, è poesia.
La sua motivazione è un grande inganno
ma un inganno assestato col cuore.
***
marcoPolo con scrittura cammellare
cercò di attraversare
il fiume alla chetichella
ma vi cadde con un tonfo sonoro.
Tu, come tuo solito
non ti voltasti in tempo.
Poesia non fa sconti.
Il noi che resta imprigionato
dentro poche pennellate
si avvale soprattutto
del diritto d’inciampare.
Fernando Della Posta è nato nel 1984 a Pontecorvo in provincia di Frosinone, è laureato in Scienze Statistiche, vive a Roma e lavora nel settore informatico. Si interessa di poesia e fotografia. La poesia per lui è il manifestarsi di un pensiero vitale comune che, immancabilmente, si fa spazio nelle destrezze quotidiane degli uomini, in ogni luogo e in ogni epoca. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti nel 2011 è arrivato tra i finalisti al concorso di poesia “Ulteriora Mirari” nella sezione silloge poetica inedita; nel 2014 ha ricevuto una menzione d’onore al premio di poesia e teatro “Città di Valenzano” e si è classificato secondo al premio nazionale di poesia “L’incontro – Salice d’oro”; nel 2015 è stata selezionato per la pubblicazione al concorso “Pubblica con noi 2015” di Fara Editore ed è risultato tra i finalisti del concorso letterario "Sistemi d'Attrazione", legato al festival "Bologna in lettere 2015", nella sezione dedicata a Pier Paolo Pasolini; nel 2016 si classifica tra i segnalati al premio letterario “Ponte Vecchio” nella sezione “Saggistica”, vince il concorso “Stratificazioni: Arte-fatti Contemporanei” legato al festival letterario di Bologna in Lettere 2016 nella sezione B poesia inedita a tema libero, ottiene una menzione al XXX premio Montano per la silloge inedita e ottiene il secondo posto nella poesia inedita al premio letterario “L’albero di Rose” di Accettura in provincia di Matera. Nel 2017 si è classificato secondo nella sezione poesia a tema sulla città di Roma e ha ottenuto la menzione d’onore nella sezione poesia a tema libero al premio “Divagazioni D’Arte”, ha ottenuto una menzione speciale al XXXI premio Lorenzo Montano nella silloge inedita e ha vinto il Premio Nazionale Poetika nella sezione silloge inedita. Numerose solo le sue recensioni e le sue sillogi reperibili su diversi blog letterari come Neobar, di cui è redattore, Words Social Forum, Viadellebelledonne, Poetarum Silva e Il Giardino dei Poeti. Nel 2011 ha pubblicato la raccolta di poesie “L’anno, la notte, il viaggio” per Edizioni Progetto Cultura e, sempre in poesia, nel 2015 "Gli aloni del vapore d'Inverno" per Divinafollia Edizioni e nel 2017 “Cronache dall’Armistizio” per Onirica Edizioni.
“Gli anelli di Saturno” è diventato libro nel 2018, presso Ensemble Edizioni.
Ettore Fobo, prosa inedita “La sapienza degli erranti”, premessa di Davide Campi
Questa scrittura si sviluppa come una continua corrente di parole che mirabilmente dispiega la coscienza del nostro comune destino: il vuoto, la dissoluzione, la fine, mediante tutti i simboli che ne caratterizzano la percezione e il pensiero. La prosa poetica di Ettore Fobo ha il dono di unire la precisione della scrittura in versi con le possibilità narrative della prosa, in un ritmo incalzante che rende ancora più intenso il senso di tutta l'operazione. Per mezzo "di una parola che illumina, moltiplica, ama il silenzio", dice l'autore. Tra distanze percorse e vicinanze del sentire, possiamo camminare al fianco di sogni e segni, tra citazioni chiare e crittate, tra conoscenza e idealità. In una scrittura che si rinnova a ogni passo del vagare nomade su questa terra.
La sapienza degli erranti
I
Per ora siamo coloro che abbinano il deserto alla sua eco ma quando saremo polvere, chi agiterà i nostri nomi, come gli stracci di un’antica gloria, troppo nascosta per suscitare invidia, ma fiabesca e cara agli dei, che nessuna lingua più nomina? Quando il nostro passo avrà esaurito il suo viaggio e la nostra voce sfiorato la danza fino a dissolversi in essa, chi saprà evocare un sogno dai nostri zeri e vedrà cifrato l’urlo che un verso paziente ha tessuto? Vittoria dionisiaca o squarcio di Munch, riecheggiante vastità; ora chi disseppellisce il canto, vanto del vuoto? Da quale anima sarò sfiorato quando la mia voce di polvere avrà detto il suo ultimo, e dunque più intimo, deserto? Quale sguardo congelerà le mie ossessioni in materia incandescente da spartire con le notti più enigmatiche?
Non potrò mai sapere quanta luce avrò sparso dentro il buio secolare, dove una magia maledetta dispone il suo caos, nel cuore disumano dell’ordine, io sveglio eternità dissolte nel tempo e celebro il vento che onora la pelle arsa dal sole e la sapienza dei vagabondi. La loro meta è la sfida della libertà, talvolta l’incantesimo di una parola che illumina, moltiplica, ama il silenzio, venera la notte che ti nomina poeta, il signore del labirinto, che sogna le lacrime di un dio che cadono nel mare di tutti gli attimi. Perché poesia è il nostro modo di sentici eterni, perché poesia è il nostro modo di sentirci, perché poesia è il nostro modo.
Vagare sì in cerca dell’attimo, in cerca del sogno o del segno; sotto un sole infernale che ci benedice, nell’atmosfera che riecheggia il fiume che stupì Eraclito.
II
Così se tutto scorre e non ritorna, il mare saprà accogliere anche la sorgente del nostro primo grido nella fase rem di questa esplosione, quando feti si galleggiava nell’enorme, apeiron di galassie vegetali, minerali, nimbo di un fulmine inespresso, sobillando attimi senza aggettivi, esplorando vertigini, monopolio del Tempo, si scavava in cerca del fiume carsico di tutta l’ebrezza, lontanando spazi, evacuando memorie quantiche di impressioni e misteriosa filogenesi di anfibi, illuminati da dentro da una forza cosmica abissale, formulando frattaliche epopee e chissà cosa; si navigava oltre le colonne d’Ercole dell’ Io sono io.
Molto prima che il pensiero imprimesse le sue orbite e la parola immaginasse il mondo ma non prima del tempo, del divenire e di tutta la cenciosa apparenza, la Maya dei tumulti e la paura. Prima che Dio unificasse il corpo e il pensiero ci esiliasse nella Dualità e la paranoia scrivesse il suo elogio funebre alla vitalità e alla gioia, prima che il carnefice umiliasse la nostra infanzia e la Grande Macchina imponesse il suo Tempo senza speranza. Prima che la parola dettasse la Legge dell’Automa e configurasse il labirinto di Babele e prima che il Programma Uomo fosse installato.
Cosa si era? Se non la grandiosa frase non scritta nel libro del destino, il maestoso silenzio che nella cattedrale sfida i ghiacci, il monologo senza pensiero di un viandante che segue solo il movimento di una musica terrestre, il vulcano segreto del sangue e dei nervi, il basalto inviolabile di un’ombra senza codici, un niente, soprattutto, impossibile da raccontare. Così, sarà stato come udire una musica e il frastuono d’acciaio dell’epoca.
Dentro la carezza senza mano il tuono che fortifica. Dentro l’incomprensibile tutte le risposte.
III
Ora che la fugacità insegna a tramontare, tramontiamo con un’ebrezza in fondo nuova.
Noi, che abbiamo ereditato la luna, non sappiamo più ritrovare là la nostra follia.
Lo specchio dove ci inoltriamo è una terra deserta. Il deserto è uno specchio che raddoppia il vuoto. La nostra maschera tradisce un volto assente. Dove non c’è più volto, il deserto regna. È il momento di disfarsi di maschere che troppo hanno atteso. È ora che il grido che gettammo alla nascita trafigga il cielo. È ora che il cielo si accorga di noi che siamo il suo specchio. La solitudine riconquistata è la prova che non hai sognato.
Sia fatta la volontà degli specchi!
IV
Soffio via i marosi del sentimento, mentre sbuffa il vento della redenzione, secco come terra arsa, lucido come la mezzanotte in cui l’altro ci appare in tutta la sua estraneità di sfinge. Poi scavo, forme esatte, le parole, per un teorema da scagliare nel tempo. Divengo la pietra e miagolo di notti mal spese, di rotte inclini al naufragio esistenziale, di attimi di sangue sparsi nel fango, di suole arroventate dall’asfalto.
In questa periferia in cui il mondo si decanta, per un momento sembra che ai margini della visione l’occhio mappi una strada non tortuosa, che le sillabe rincorrano aquiloni, proprio in questo cielo di seconda mano, intravisto danzare tuttavia al metro giambico, al sussulto dell’endecasillabo. Nella sfarzosa metropoli, la vita continua ad accadere, incerta; ora fragile, ora brutale, sempre contradditoria, mentre la spazzatura della Storia si riempie di idoli di plastica, farmaci scaduti, cieli vuoti, dei dal profilo di fuoco, ombre di vaghi e sognanti crepuscoli. La mezzanotte è irta di nascite, è il momento in cui la solitudine diventa sacra e il silenzio apre la mente per accogliere la musica esaltante dell’universo in espansione.
Siamo tra sogni e tra segni in quel luogo dove lo specchio ha mille occhi. Attendo la rivelazione che muove il mondo e so che ogni stella è una ferita di luce e che ogni ombra è un inno in cui il lamento degli esseri viventi è dissolto come l’essenza di un profumo.
Così ho abbandonato la mia faccia e sono maschera. Me stesso rimane sullo sfondo a interpretare sul palco la parte assegnata dell’assente.
Lo specchio sa che mi rifletto in lui per conoscere il mondo delle ombre. E con questo? Non sarò mai ombra abbastanza per partorire un dio, un labirinto, o una stella danzante. Torniamo allora all’oggettività della musica, alla sua ritmata odissea in cerca dell’origine riconquistata a ciò che smisurato ci eccede.
Ettore Fobo è nato a Milano nel 1976. Ha pubblicato tre libri di poesia con Kipple Officina Libraria: “La Maya dei notturni “ (2006), “Sotto una luna in polvere” (2010), “Diario di Casoli” (2015). Alcune sue poesie sono apparse in diverse antologie, fra le quali la raccolta connettivista “SuperNeXT”(Kipple Officina Libraria, 2011). Dal 2008 gestisce un blog di letteratura “Strani giorni” (www.ettorefobo.it). Collabora con la rivista multilingue “Orizont literar contemporan” e con il portale di critica letteraria e dello spettacolo “Lankenauta”. Una sua silloge, “Musiche per l’oblio”, è stata tradotta in romeno, in francese e in inglese.
Fabia Ghenzovich, poesia inedita “Nudità”, premessa di Ranieri Teti
Leggere, e soprattutto rileggere questa poesia di Fabia Ghenzovich tocca in profondità. Tocca le corde più sensibili dell’agire in versi: infatti Nudità non è solo una poesia ma anche una dichiarazione di poetica. Nudi, come veniamo al mondo, scriviamo; anche se la nostra voce aurorale nasce sotto “strati e strati” di deteriorate parole rese vane e vassalle da un uso sempre più strumentale e utilitaristico. La poesia, quando è tale, è voce dal fondo che per contrasto illumina le tenebre.
Nudità
Dico - la nudità -
qualcosa di integro insomma
come alba o natale ma corporale
dico ecco la voce pulita sotto strati e strati
la voce dal fondo che spiazza
ogni parola vassalla che non suona
che non filtra più la luce.
Fabia Ghenzovich è nata a Venezia dove vive. Ha pubblicato “Giro di boa” (Joker edizioni 2007), “Il cielo aperto del corpo” (Kolibris 2011- menzione speciale al premio Astrolabio 2013), riproposto in ebook su La Recherche, “Totem”( Puntoacapo Editrice 2015 – II° premio nazionale Anna Osti 2016, finalista al premio internazionale “Sulle orme di Leopold Sèdar Senghor” 2015, finalista al premio nazionale “Tra Secchia e Panaro” 2016, menzione speciale al premio Lorenzo Montano 2016 ). Ha avuto premi a concorsi di poesia: secondo premio per la silloge inedita al concorso Guido Gozzano 2009, terzo premio al concorso nazionale poesia scientifica Charles Darwin 2014. È inserita in numerose antologie tra le quali: “Blanc de ta Nuque” – uno sguardo dalla rete sulla poesia italiana contemporanea – a cura di Stefano Guglielmin (edizioni Le Voci della luna 2016) e nel Tomo II° “Il Fiore della poesia contemporanea” (Puntoacapo editrice 2016). Ha partecipato a numerosi festival tra i quali: Festival Internacional Palabra en el Mundo (Venezia 2013 e 2016). E diverse sono state, nel corso degli anni, le adesioni e partecipazioni a eventi di Milanocosa, tra le quali Menti e Mondi della Giornata Mondiale della Poesia del 2005, e Quintocortile del 2007.
Vincenzo Lauria, dalla raccolta inedita “Dalìrium” (In Dalì’s rooms), nota di Laura Caccia
Visioni d’altrove
Si nutre delle suggestioni delle opere di Salvador Dalì, in dialogo poetico con le stesse, la raccolta Dalìrium (In Dalì’s rooms) di Vincenzo Lauria. Propriamente in comunicazione diretta con l’artista, considerato dall’autore, in uno dei tanti giochi linguistici sparsi tra i testi, “mia Salvazione”, nel sentirsi parte delle visioni, o meglio delle ultra-visioni, che i suoi lavori spalancano sull’altro e sull’oltre, come leggiamo nei quattro testi bilingue che aprono la raccolta, a lui dedicati, nel colloquio con i suoi mondi e con le sue parole: “Attraverso la porta delle tue Visioni / la mente amplifica mondi…./ proiezioni multiple attendono / il non dove…/ immagini di altri Noi”. Così le immagini, multiple e in continua rifrazione, costellano i testi, nel loro intensificarsi, senza schemi razionali, in una erranza fluttuante: “Perché ti cerchi / se non c’è approdo? / E’ nel perdersi / - magico - un delirio”.
E se delirare è propriamente, dal suo significato etimologico, uscire dal solco, non è altro che a questo che veniamo condotti: nei fuori-immagine, nei fuori-cornice, nei fuori-confine, oltre l’apparenza, in quello che, per l’autore, è “il viver mio in un altrove”. Questo andare oltre appare caratterizzare la poetica di tutta la raccolta, in tensione continua verso una diversa realtà: “Accolti nell’inverosimile / sappiamo di un’altra dimensione / evocazione di un essere oltre misura”.
Ed è la dismisura a connotare la molteplicità delle proiezioni a cui assistiamo, in una tensione inarrestabile verso “l’estremo oltre”, protesa, nelle sue immagini vertiginose, ad un altrove collocato al di fuori della realtà e insieme nell’interiorità più profonda.
“Il surreale sta dentro / nel forse capovolto / che sa di certezze altre”, dichiara l’autore, alla ricerca di ciò che appare inconoscibile e oscuro, per il quale occorre uscire dal controllo della ragione e tendere a livelli di pensiero e linguaggio più profondi e più veri: “Eppure basterebbe perdersi nell’imperdibile / e carpire l’incompreso / del non senso / andando a senso. / Lì in quel punto dell’impossibile / sta l’abbandono / il precipizio buono”. E proprio in questo la parola poetica, come l’arte, può riuscire ad esprimere la sua massima tensione: nella ricerca del vero oltre la realtà visibile.
“In mano d’arte / sta la Poesia”, ci indica l’autore, nel cogliere quanto le due modalità tendano allo stesso fine: fare delle immagini e delle parole l’atto creativo che consenta di accedere all’impensabile, di avvicinarsi al senso delle cose, per quella, come scrive, “verità che è il ritrovarsi in arte”.
Una verità che Vincenzo Lauria ricerca, attraverso i suoi versi, nel delirio che conduce oltre, nella fluttuazione che non conosce confine, come dichiara: “Non poter immaginarsi diversamente / perché è in questo non confine / che giace / la meraviglia tutta / dell’essenza / essenza”.
Cieli
Esterrefatto all’abbandono
non batter ciglio
la fissità dello sguardo
rammenta
il viver mio in un altrove.
Tremante
ravvicinarsi
per un incontro nuovo
un toccarsi
per dita in punte,
un dir di parole mute
m’avvolge in quadro
e sono raffigurazione esterna
per quel che di me
è dato di( )svelarmi
sussurro a porte chiuse
intorno al cielo.
Gusci
In guscio
l’incubazione di un nuovo dove
traspare,
liquida costellazione
a farsi fissità stellare
un mangiarsi le carni
in autoriproduzione.
E’ nell’anelito la salvazione
un varcar la soglia
per non sapere dove.
Bruciano i tempi dell’infinito
e nel non bastarsi
si crepano le protezioni
viver d’altro di sé
in proiezioni.
Poesia
In coda al destino
è un’unica parola
a dir della magnificenza
del gioco.
Né mai vidi a sufficienza
per dir di tua grandezza
ché pure il tempo
si scioglie in alcunché
per passar dell'oltre.
In mano d’arte
sta la Poesia
e sedendo in te
l’ascolto
di pura voce
seduce.
Vincenzo Lauria, nato nel 1970, inizia la condivisione del suo percorso nel 2001 all’interno di “Stanzevolute” gruppo di 11 poeti selezionati da Domenico De Martino (collaboratore storico dell'Accademia della Crusca e docente universitario di Filologia Dantesca a Udine).
Dal 2010 collabora con Liliana Ugolini ai progetti multimediali Oltre Infinito, Oltre Infinito 2.0, OL3 Infinito, Oltre Infinito 4 (Le stanze della mente). Dal 2012 Collabora con l’Associazione Multimedia91- Archivio Voce dei Poeti.
Ha partecipato a più di 40 reading e stampato in proprio 4 sillogi.
“Teatr/azioni” è stata pubblicata, con prefazione di Laura Caccia, da Puntoacapo nel 2018.
Riconoscimenti:
Mar 18: Premio “I Murazzi” 7° edizione è tra i 26 selezionati con la raccolta inedita “L’In/cubo di Rubik”
Lug 17: Premio Lorenzo Montano 31° edizione è tra i 5 finalisti con la raccolta inedita “Teatr/azioni”
Giu 17: Premio Letterario Casentino 42° edizione è tra i finalisti e riceve il Premio Speciale della Giuria con la raccolta inedita “Alberi Improbabili”
Set 16: Premio Casa Museo Alda Merini I edizione è tra i 20 finalisti con la raccolta inedita "INF – INFernità IN Fieri”
Lug 16: Premio Lorenzo Montano 30° edizione segnalazione per la raccolta inedita "Oltre Infinito” scritta con Liliana Ugolini
Giu 16: Premio Nazionale Elio Pagliarani II Edizione - la silloge inedita “Teatr/azioni” è tra le 9 semifinaliste.
Giu 16: Premio Internazionale Città di Como – III Edizione: la videopoesia “FEDRA” (in 3 minuti) è tra le 3 selezionate (video: Vincenzo Lauria, musiche: Tommaso Pedani, testi: Liliana Ugolini, voce: Gaia Nanni)
Mag 16: Festival Visioni Shakespeariane 2016 selezione e proiezione del video blob “OFELIA – (Rilettura)”, testi poetici di Liliana Ugolini, Montaggio video: Vincenzo Lauria.
Nov 15: Premio Lorenzo Montano 29° edizione segnalazione ricevuta per la raccolta inedita "Le stanze della mente” scritta con Liliana Ugolini
Giulia Martini, prosa inedita “La gora e l’abbandono”, premessa di Davide Campi
In questa prova saggistica lo sguardo acuto di Giulia Martini coglie la presenza del termine “gora“ in quattro grandi testi poetici e da qui costruisce un saggio sull‘abbandono, sul senso di estraneità, in cui convergono Dante, Pascoli, Montale e Luzi. Le connessioni trovate da Giulia Martini sono straordinarie e arrivano a superare l’assunto iniziale; da uno stato d’animo di abbandono, di solitudine, di perdita, si cambia piano: “I quattro testi sembrano ritrovarsi su un altro livello ancora, afferente non più a uno stato (d’animo, a un ritrovarsi lì come una cosa), ma a un verbo, e il verbo è guardare”. Il passaggio avviene attraverso l’uso rigoroso e puntuale delle citazioni, ma soprattutto grazie al sentire poetico dell’autrice. Grazie a questo sentire poetico Giulia Martini ci conduce a un terzo, ulteriore livello, come in un’ascesa dantesca. La poesia, alla fine, è proprio questo guardare la rivelazione improvvisa delle cose.
La gora e l'abbandono
Mi trovo qui a questa età che sai, né giovane né vecchio, attendo, guardo questa vicissitudine sospesa; non so più quel che volli o mi fu imposto, entri nei miei pensieri e n’esci illesa. (Mario Luzi, da Notizie a Giuseppina dopo tanti anni).1
La parola «gora» ricorre in quattro testi indimenticabili della nostra letteratura: l’ottavo canto dell’Inferno di Dante, Lavandare di Pascoli,2 Notizie dall’Amiata di Montale3 e Presso il Bisenzio di Mario Luzi.4 Ma se tale occorrenza è il primo punto di contatto, questi quattro testi si riuniscono più profondamente, nel grande tema dell’abbandono.
L’ottavo dell’Inferno è il canto in cui Dante si appressa alla città rossa di Dite, in uno scenario non molto diverso da quello di Notizie dall’Amiata: «Ma il passo che risuona a lungo nell’oscuro / è di chi va solitario e altro non vede / che questo cadere di archi, di ombre e di pieghe»; e ancora le «architetture / annerite», le «vampate di magnesio», «il lungo colloquio coi poveri morti», «la morte che vive».
Qui Dante viene apostrofato dallo spirito di Filippo Argenti, che gli si fa incontro e gli domanda chi è:
Mentre noi corravam la morta gora,
dinanzi mi si fece un pien di fango,
e disse: «Chi se’ tu che vieni anzi ora?»
Domanda che prelude alla vera e propria accusa di estraneità, di cui Dante verrà tacciato in capo a neanche cinquanta versi:
Io vidi più di mille in su le porte
da ciel piovuti, che stizzosamente
dicean: «Chi è costui che sanza morte
va per lo regno de la morta gente?»
1 Primizie del deserto, 1952.
2 Myricae, 1891.
3 Le occasioni, 1951.
4 Nel magma, 1963.
Ed è lo stesso tipo d’incontro e la stessa accusa di estraneità con cui si apre Presso il Bisenzio di Mario Luzi:
La nebbia ghiacciata affumica la gora della concia
e il viottolo che segue la proda. Ne escono quattro
non so se visti o non mai visti prima,
pigri nell’andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte.
Uno, il più lavorato da smanie e il più indolente,
mi si fa incontro, mi dice: «Tu? Non sei dei nostri.
Non ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta
quando divampava e ardevano nel rogo bene e male».
Ma l’ottavo dell’Inferno è anche il canto in cui Dante rimane senza guida, quando Virgilio si allontana per trattare coi diavoli, con quel verso memorabile, «Così sen va, e quivi m’abbandona».
E non può che trattarsi di una solitudine cosmica, come cosmica sembra la solitudine di quel «tavolo / remoto» in una «sfera lanciata nello spazio» di Montale; analogamente anche l’«aratro senza buoi» di Pascoli, oggetto di uso quotidiano, viene subito caricato di una valenza universale e diventa emblema di una solitudine assoluta – che difatti si trasferisce subito alla donna che intona cantilena in chiusura, abbandonata «come l’aratro in mezzo alla maggese». Inoltre, proprio l’attività a cui il testo fa riferimento, lavare i panni, è una mise en abyme dell’oblio, del rapporto fra passato e presente: lavare una macchia è anche cancellare un trascorso, riazzerare il vissuto.
Senza contare che i due testi condividono lo stesso tipo di enjambement: «tavolo / remoto», «pare / dimenticato»: un enjambement aggettivale, che pone l’accento sulla solitudine dell’oggetto, il tavolo, l’aratro.
Quindi la gora, l’estraneità, l’abbandono – eppure la storia non finisce qui. I quattro testi sembrano ritrovarsi su un altro livello ancora, afferente non più a uno stato (d’animo, a un ritrovarsi lì come una cosa), ma a un verbo, e il verbo è guardare. Chi scrive infatti si fa spettatore di un quadro naturale, che inizia a descrivere e continua finché una nebbia non gli obnubila la vista.
L’ottavo dell’Inferno si svolge in una palude nebbiosa, e quando Dante domanda a Virgilio l’entità del segnale che scorge da lontano, Virgilio risponde che lo vedrà da solo, purché le esalazioni che salgono dal terreno non glielo impediscano («se ‘l fummo del pantan nol ti nasconde», VIII, 12).
In Pascoli, questo fumo diventa «vapor leggero»: «Nel campo mezzo grigio e mezzo nero / resta un aratro senza buoi che pare / dimenticato nel vapor leggero».
In Montale, questo vapore leggero diventa «fumate morbide»: «Le fumate / morbide che risalgono una valle / d’elfi e di funghi fino al collo diafano / della cima m’intorbidano i vetri».
In Luzi infine, sarà «nebbia ghiacciata»: «La nebbia ghiacciata affumica la gora della concia / e il viottolo che segue la proda».
Questo impedimento visivo sembra un pretesto per far scattare l’udito, che finirà con l’essere il senso privilegiato per continuare la descrizione di partenza.
Così Inf. IX, 4-6:
Attento si fermò com’uom ch’ascolta;
ché l’occhio nol potea menare a lunga
per l’aere nero e per la nebbia folta.
La scarsa visibilità di «fuori» sarà per Montale l’occasione di descrivere il suo interno:
Le fumate
morbide che risalgono una valle
d’elfi e di funghi fino al collo diafano
della cima m’intorbidano i vetri,
e ti scrivo da qui, da questo tavolo
remoto, dalla cellula di miele
di una sfera lanciata nello spazio
Stesso discorso per Luzi, dalla cui «nebbia ghiacciata» «escono quattro» e gli rivolgono la parola.
Il caso più evidente di questo passaggio rimane però Lavandare, madrigale diviso in due terzine e in una quartina, la prima terzina intermante dedicata alla vista, la seconda all’udito:
E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene.
Ma proprio Lavandare permette una considerazione ulteriore: che c’è anche un terzo tempo, o meglio, una terza modalità percettiva, che viene dopo la vista, che viene dopo l’udito – un altro tipo di sentire, quasi “miracoloso”: e il miracolo è proprio la lunga cantilena, vale a dire, la poesia stessa.
Questo terzo sentire sarà adoperato nei quattro testi (ennesima e più profonda comunanza) in un contesto d’attesa, per rimarcare la speranza che arrivi qualcuno che sta tardando.
Dante:
Attento si fermò com’uom ch’ascolta;
ché l’occhio nol potea menare a lunga
per l’aere nero e per la nebbia folta.
«Pur a noi converrà vincer la punga»,
cominciò el, «se non... Tal ne s’offerse.
Oh quanto tarda a me ch’altri qui giunga!».
Pascoli:
lunghe cantilene:
Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
Quando partisti, come son rimasta!
Montale:
Le fumate
morbide che risalgono una valle
d’elfi e di funghi fino al collo diafano
della cima m’intorbidano i vetri,
e ti scrivo da qui, da questo tavolo
remoto, dalla cellula di miele
di una sfera lanciata nello spazio –
e le gabbie coperte, il focolare
dove i marroni esplodono, le vene
di salnitro e di muffa sono il quadro
dove tra poco romperai. La vita
che t’affabula è ancora troppo breve
se ti contiene! Schiude la tua icona
il fondo luminoso. Fuori piove.
Luzi:
Ma uno d’essi, il più giovane, mi pare, e il più malcerto,
si fa da un lato, s’attarda sul ciglio erboso ad aspettarmi
mentre seguo lento loro inghiottiti dalla nebbia. A un passo
ormai, ma senza ch’io mi fermi, ci guardiamo,
poi abbassando gli occhi lui ha un sorriso da infermo.
«O Mario» dice e mi si mette accanto.
Sempre in Luzi, poco più avanti, «il più giovane» dice questa cosa, che sembra d’importanza capitale:
poni mente a che cosa questo tempo ti richiede,
non la profondità, né l’ardimento,
ma la ripetizione di parole,
la mimesi senza perché né come
dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine
morsa dalla tarantola della vita, e basta.
Cosa richiede questo tempo? La ripetizione di parole, la mimesi dei gesti – vale a dire, «tonfi spessi e lunghe cantilene». Tout se tient.
In altre parole. Il primo obiettivo sembra il mondo: la realtà, l’onore del vero; ma il significato è fumoso, non si vede tanto bene – di qui la necessità di affidarsi al significante (l’ipotesi della relatività linguistica di Sapir-Whorf: il mondo si presenta come un flusso caleidoscopico di impressioni che il sistema linguistico tenta di carpire). Capire è il miracolo della poesia, la rivelazione improvvisa delle cose, l’apparizione attesa del senso.
Quello che sembra è che questi testi non siano mai, più o meno consciamente, esonerati dalla loro stessa poetica, da una riflessione che ricada sui meccanismi che li hanno generati.
E la poesia sembra essere proprio questo, l’attesa di un miracolo per cui uno è stato a lungo all’erta: che qualcuno esca dalla nebbia e parli, che un suono ne preceda l’apparizione.
Infine, in Un brindisi5 Luzi fa una rilettura pazzesca della rossa città di Dite, e parla degli «occhi troppo grevi», del «cuore umano gonfio ed assordito» ma anche di «calme primavere inattuate».
Ora, una primavera è inattuata quando non dà frutti, e non dà frutti un campo “a maggese”: il maggese infatti è un anno di riposo, in cui il terreno viene arato e mosso, per restituirgli la fertilità.
Il maggese è una «vicissitudine sospesa».
5 1946.
Giulia Martini è nata a Pistoia nel 1993 e vive a Firenze. Dopo una prima laurea in Lettere moderne, con una tesi su La figlia di Babilonia di Piero Bigongiari (Firenze, Parenti 1942), sta conseguendo una laurea magistrale in Filologia con un commento a Pigre divinità e pigra sorte di Patrizia Cavalli (Torino, Einaudi 2006). Ha partecipato al XXI Congresso dell’Associazione degli Italianisti con uno studio su Donna di dolori di Patrizia Valduga (Milano, Mondadori 1991). A gennaio 2015 ha raccolto 38 componimenti sotto il titolo Manuale d’Istruzioni (Roma, Gruppo Albatros Il Filo); a gennaio 2016 sono uscite Ventitré poesie sul mensile «Poesia»; altre, sulle riviste «Gradiva» e «Pelagos» e sulle antologie Secolo donna 2017: Almanacco di poesia italiana al femminile (Francavilla Marittima, Macabor 2017) e Un verde più nuovo dell’erba. Poetesse Millennial degli anni 90 (Milano, LietoColle 2018). Ha partecipato con successo a numerosi concorsi letterari e sta dedicandosi a una seconda raccolta poetica, che prenderà nome Coppie minime.
Alessandro Mazzi, prosa inedita “Il mito del nostro tempo”, premessa di Davide Campi
Alessandro Mazzi costruisce questo testo come si costruisce un atlante del pensiero. C’è tutto: filosofia, poesia, pittura, psicanalisi. È in realtà una sorta di flusso ininterrotto di conoscenza, fatto di citazioni, rimandi, brevi sintesi teoriche, a volte organizzato con momenti di pura letteratura, spesso con il tono dell’esortazione, pensato in crescendo.
Abbiamo di fronte un testo prosastico scritto con l’esattezza linguistica del poeta, che si configura come un vastissimo orizzonte di senso ricco di reperti: un’area monumentale.
Il mito del nostro Tempo
Logos e mythos sono i due movimenti che Platone ha scisso all’alba della filosofia occidentale, condannando il discorso e il poetico a impegnarsi nella riconciliazione. Se la filosofia è «un farsi più divino da parte dell’uomo, una tensione oltre di sé», va riunita al mitico in una filosofia della sensibilità, così sente Susanna Mati.
Portare fuori le immagini poetiche, le nostre immagini, che nel profeta sono anche immagini del Tempo, senza bruciarle al Sole, è possibile? Certo, se ci facciamo ombra con le palme raccolte all’oasi vicina, perché se anche Nietzsche ammoniva nel suo Zarathustra «Il deserto cresce: guai a colui che cela deserti dentro di sé!», non è detto che invece proprio nella massima aridità non possa sgorgare il petalo più sacro.
Il pensiero e la poesia si incontrano, due fiumi che come il Tigri e l’Eufrate nutrono la Mezzaluna fertile dell’umanità, generano la nostra comprensione in una ierogamia filomitica. Così nasce un uomo nuovo, più consapevole, più vasto, e con lui nasce una nuova civiltà. Viviamo il mythos così come vuole essere vissuto. Ricorda Cvetaeva che il poeta non crea, ma dà ascolto a qualcosa che in lui indica e ordina.
Come specie simbolica, Animal Symbolicum ci definì Cassirer, è passata fin troppa acqua sotto i ponti per ignorare la capacità psicopoietica del mythos di essere Storia. La nostra epoca vuole consapevolezza. Chiediamoci allora, qual è il mito del nostro Tempo?
Veniamo incontro alla sophia, ricorda Mati, il femminino universale che ci bagna. Porgiamole l’orecchio bisognoso, come Odino che si reca dalla veggente per conoscere gli eventi che verranno, per esserne educati, da educěre, trarre fuori e allevare le immagini dalla tenebra inconscia, a noi affidate come novelli Mosé. Raffiniamo con arte di maniscalco il materiale sorto, dando voce al pensiero poetante.
Dirigendosi verso il ‘900, questo secolo bifronte, Aivazovsky dipinge i suoi mari tempestosi. Sono quadri abissali nel senso più puro del termine, perché attingono allo spirito orizzontale del Moderno, pongono l’uomo di fronte all’imminente cataclisma di fine secolo. In La nona onda del 1850, sei naufraghi chiedono asilo alle onde pur sapendo che ne verranno travolti, mentre il Sole è sospeso in un tramonto albeggiante.
Nel Nietzsche della Gaia Scienza abbiamo bisogno di farci Noè improvvisati e costruire navi che permettano di imbarcarci ed esser-ci (gegangen) in un mondo in diluvio, mentre salpiamo per nuove terre (Land) all’inabissarsi di Dio. Come nella visione della barca nel Libro Rosso di Jung, il Dio deve iniziare il suo viaggio nell’aldilà per rinascere rinnovato nel nuovo eone, e noi con Lui.
Scrive Rilke nella prima elegia duinese del 1912 che «L’eterna corrente/ trascina attraverso entrambi i regni ogni età,/ sempre con sé, ed entrambi sovrasta con il suo suono». Possiamo solo approntarci e sperare che la nostra arca regga.
Il poeta Yeats nel 1919 compone La seconda venuta, un poema spartiacque tra le due guerre. Siamo alla fine dei tempi e gli elementi si fanno mostri biblici, «E quale bestia orrenda [...] striscia verso Betlemme per venire al mondo?». Al leontocefalo non si comanda,
e nessuna lancia potrà ucciderlo. Schmitt pure deve ritrovare lo spazio in Terra e Mare, dove irrompono il Leviatano e il Behemoth.
Heidegger cerca la risposta alla mancanza di fondamento (Grund) nei fiumi di Hölderlin, così come il Siddhartha di Hesse impara dal fiume. L’acqua che scorre, la transitorietà (Wanderschaft) che ha nella sua radice il migrare (Wanderung). Nei tempi si entra navigando, come rifugiati che attraversano il Mediterraneo.
In Aion Jung parla dell’uomo con la brocca menzionato nel Vangelo di Luca, l’Acquario. Può essere che in questi interregni per cui si passa da un mese platonico all’altro, ci sia sempre un barlume della prossima era, che riaffiora in questo tempo presente portando con sé una scintilla di ciò che verrà?
Jung esprimeva le sue curiosità sull’Età del Capricorno, che sarebbe succeduta all’Età dell’Acquario. Ma se l’Acquario è un simbolo del Sé che ci chiede la soluzione degli opposti dell’Età dei Pesci, se è lui a rovesciare con le sue brocche d’oro la corrente iperborea che ci sovrasta, che cosa ci chiederà il Capricorno? Interroghiamo la Pizia.
Nel secondo libro della Mitologia Astrale di Igino, troviamo il mito di Tifone, sposo di Echidna, che scatena il panico fra gli dèi; ognuno fuggendo muta in un proprio animale. Questa dispersione degli dèi, il loro assumere una forma diversa di fronte al cataclisma, non è la condizione postmoderna in cui ci troviamo oggi? Non abbiamo vissuto finora l’incapacità della Storia di poter attingere a una grande narrazione, perché impegnati a scappare dal vortice del nichilismo, l’ombra di Dio che genera disastri?
Hillmann considerava Pan l’origine del panico. Cumont nel suo Zodiaco dice che nella fuga da Tifone i Greci trasformarono il dio Pan nel segno del Capricorno, creatura duplice e una. Forse le correnti transumaniste, l’euforia di creare esseri cibernetici, il rapporto uomo-robot-intelligenza artificiale, la necessità di nuove ontologie sfumate, non sono sprazzi del Capricorno?
Difficile dirlo. Nessun oracolo pre-cristiano avrebbe potuto predire che l’Età dei Pesci avrebbe generato la Chiesa cattolica, o che l’Apocalisse si sarebbe consumata nei campi di concentramento. De Santillana, nel Mulino di Amleto, ricorda la veggenza del poeta antico. Ma andare troppo a fondo ha un costo, come Odino che sacrifica un occhio alla fonte di Mímir. La virtù del poeta è saper riconoscere i limiti della propria visione.
Seguiamo la ninfa, ma attenzione! Il confine dell’uomo è un’arcata di pietra, oltre la quale si staglia l’indefinito. Metaxis, intimava Diotima nel Simposio di Platone, che significa avere il coraggio di stare nel mezzo! Hölderlin e Nietzsche hanno pagato caro il prezzo degli intuitivi introversi. Il divino pugnala le teste d’oro e smuove le viscere in forti spasmi.
Possiamo solo dire che il monte capricornino ci chiama, e che dobbiamo scalarlo. È il tempo dell’approdo.
Alessandro Mazzi nasce a Pompei il 17 Aprile 1990. Si laurea in Estetica all’Università “L’Orientale” di Napoli con una tesi originale su Hölderlin e il Taoismo, sotto la supervisione del prof. Giampiero Moretti. Dopo un periodo in Islanda, continua lo studio della filosofia e delle scienze pure all’Università di Urbino, dove è attualmente laureando. Collabora con diverse testate online, tra cui La Tigre di Carta e L’Indiscreto, e tiene seminari filosofici all’università.
Stefania Portaccio, dalla raccolta inedita “Waterloo”, nota di Laura Caccia
Tra misura e dismisura
C’è un momento ben preciso, una cesura o una percezione del limite, che separa la piena espansione di sé, del sentire, del dire e la consapevolezza dello stato di esilio della condizione umana e della lingua che la esprime: il limite evidenziato dallo scacco e dalla sconfitta che attende al varco gli atti umani, sia esistenziali che poetici, e che Stefania Portaccio porta alla luce nella raccolta dal titolo emblematico Waterloo.
L’autrice ci parla “dall’orlo”, come evidenzia, fin dall’inizio, il titolo della prima sezione. Da un bordo che segna la misura precaria della condizione umana e, insieme, l’essenza più chiara del luogo poetico per eccellenza, tra lo slancio e l’erranza, l’impeto e l’abbandono, il desiderio e la stortura, la misura e la dismisura. Da un lato la passione, l’aspirazione a tendere a grandi cose, soprattutto lo spingersi a oltranza, come ben evidenzia l’autrice nella poesia dedicata a Marina Cvetaeva, nella cui libertà infuocata si riconosce: “una vita che so la dismisura”. Dall’altro lo sguardo sulla quotidianità, proprio su quelle piccole cose che sostengono in qualche modo le difficoltà di un vivere e di un dire esiliati: “tutto serve in mancanza / di un’estasi in cui sciogliersi / di un segno che ci scriva”.
Ed è soprattutto la riflessione sul dire poetico, o meglio sul mestiere di fare poesia, che pervade la raccolta: in particolare nella prima parte, l’autrice ci permette di condividere la sofferenza e lo sconforto, comuni a chi scrive, nel non poter esprimere appieno l’intensità del sentire, nel non riuscire a dare quella risonanza alla passione e alla ricerca espressiva così profondamente voluta, chiedendosi, da un lato, “come daremo conto della gioia / respiro luce pelle albero mano” e, dall’altro riconoscendone l’impossibilità: “solo non ho l’arte / di cantare gli incanti e dare nome / all’inclusione”.
Una difficoltà che, nelle altre parti della raccolta, coinvolge fortemente il rapporto amoroso, contrassegnando la vita in tutte le sue sfaccettature, dalla condizione esistenziale a quella poetica: “esserti limite esserti centro // epicentro del sisma farmi e smania / di confine // colmare con mia terra la forra / tra le lingue // volevo e sono caduta nel fossato - Waterloo”.
Una sconfitta, sia amorosa che poetica, che ci consegna all’erranza e all’esilio, nella ricerca di un senso che non si lascia approcciare, se non attraverso la scelta dell’inciampo e della stortura: “M’importa la faccenda storta”, dichiara l’autrice, “Scelgo lo sbaglio”.
Una sconfitta scelta più che subita, che caratterizza la condizione umana, come quella del fare poesia. Soprattutto del fare poesia, che costringe, per dirsi tale, a contemplare lo scacco come suo elemento di forza, intrinseco ed ineliminabile.
Stefania Portaccio ci ricorda infatti come ogni sforzo, sia esistenziale che poetico, per essere autentico debba far vivere, nelle piccole come nelle grandi cose, nella misura come nella dismisura, la sua passione e la sua impossibilità, la sua grandezza e la sua Waterloo.
Dalla sezione “Dall’orlo”
Per dare conto della reminiscenza
per preservare quello
che per dimenticanza andrebbe perso
che morirebbe senza
quello che a testa china vai
e senti alla bocca della mente
un sapore salino adolescente
oppure guidi e a vanvera sorridi
***
tutto serve pure i panni stesi
le sfumature lilla il segno nero
storto dei pini contro il cielo
tutto serve in mancanza
di un’estasi in cui sciogliersi
di un segno che ci scriva
Poi c’è la pace
a strappi, a tratti, breccia
tregua a scomparsa come
la linea di carico di un cargo
come la stella cadente e tu il cielo
la bianca bandiera e tu un campo
di contrasti sanguinanti rossi
(da O lost, di Thomas Wolfe)
Nota per il lettore:
Alcune poesie hanno in calce l’indicazione di un romanzo, perché è da quella prosa che è nata
Stefania Portaccio è nata a Lecce e vive a Roma. Nel 1986 sue poesie appaiono nel volume collettivo 7 poeti del premio Montale (All’insegna del pesce d’oro); nel 1987 un’altra silloge nel volume collettivo Testarda Tregua (Sciascia) e nel 1993 venti testi sulla rivista Poesia (Crocetti), presentati da Milo De Angelis.
Nel 1996 pubblica Contraria Pentecoste (I Quaderni del Battello Ebbro). E’ del 2007 la seconda raccolta di poesie, Continenti (Empiria). Nel 2011 pubblica un nuovo libro di poesie, La mattina dopo (Passigli).
Nel 2016 pubblica, con Manni, Il padre di Cenerentola e altre storie, riscrittura di dodici fiabe dei Grimm, in forma di prosa e ballate, corredate da 12 disegni di Stefano Levi Della Torre.
Nel 2017 pubblica con Mimesis Pane per i denti, racconti di letture, raccolta di saggi narrativi intorno all’esperienza del leggere.
Sempre nel 2017 un suo racconto, Dortmund, riceve il premio InediTO - Colline di Torino, bandito dall’associazione culturale Il Camaleonte.
Enea Roversi, dalla raccolta inedita “Coleoptera”, nota di Laura Caccia
Le mutazioni
Si snoda come una sequenza di inquadrature, insieme statiche e mosse da trasformazioni, la raccolta Coleoptera di Enea Roversi, in tensione tra stagnazione e cambiamento, immobilismo e mutazione.
Ci si trova su uno sfondo che contempla la compresenza degli stati opposti sia della figurazione che del vivere, come ci evidenzia quella “immagine immota e mutante” di cui scrive l’autore, così come, in un ambito più ampio, l’affermazione: “nulla è cambiato tutto / si è trasformato”. E, insieme, dentro piani di ripresa e di pensiero che mettono a fuoco, nel loro incrocio, immagini filmiche e riflessioni esistenziali.
Le inquadrature spalancano continue domande di senso sul vivere, o meglio sul sopravvivere, di fronte all’inquietudine e al disorientamento generati dalla stagnazione culturale e sociale attuale, oltre che dagli stati, impliciti nella condizione umana, del dolore e della morte. La domanda di senso più pregnante riguarda espressamente la condizione esistenziale, stretta e quasi soffocata dalle mutazioni determinate dalla natura e da quelle imposte dalle odierne insensatezze, portando l’autore ad affermare “tutto ha un prezzo anche l’essere / umano è questo il conto da pagare” e a chiedersi: “che cosa sarà / se diverremo noi stessi una catastrofe / che cosa di noi ma siamo ancora umani / ?”.
Di fronte a tale assillo, restano diverse possibilità, come possiamo intravedere, per trovare una qualche risposta, per uscire dal disorientamento e per anticipare o contrastare le mutazioni che ci riguardano e di cui non conosciamo gli sviluppi.
La più evidente, quella di tipo metamorfico che dà titolo alla raccolta, è la necessità di farsi altro, mutare anzitempo, come scrive l’autore: “forse la soluzione potrebbe stare nel / vivere come un coleottero qualunque / … sorvolare inquietudini e tormenti”, in una danza lontana dalle sofferenze del vivere. Una mutazione di forma liberatoria, una metamorfosi distante dai miti di Ovidio e dal senso angosciante di alienazione di Kafka.
Altra, umanamente, è quella di cercare di “ritrovare il bandolo” in un terreno precario “oltre le / nostre idee oltre i confini ripassati / oltre le mai arrivate risposte”, anche se viene dichiarato esplicitamente un parere pessimistico al riguardo, così come il disprezzo per un pensiero positivo sul futuro e sul destino del mondo e della specie umana.
E altra infine, poeticamente, è quella di portarsi nel cuore della mutazione per cogliere l’essenza delle cose. Anche se afferma che “han perso di significato le parole / tutte o quasi anche i pensieri anzi / il pensiero”, anche se invoca sconfortato “il senso perduto”, Enea Roversi pare mantenere piena fiducia nel dire poetico, che ci permette di guardare al fondo del mutare, nelle forme del vivere e del deperire, dell’essere e del non essere, come indica chiaramente: “solamente un fiore appassito un / rigurgito di natura da eliminare / probabilmente ma sta lì in quel / non essere sta lì l’essenza”.
Dalla sezione Presenze/Presente
fuori tempo massimo
rinviare ogni cosa a quando
ci sarà più tempo rimanere a
guardare dall’alto del ponte
verso il fiume che scorre e scava
osservare dal basso della strada
verso le finestre illuminate
dal novilunio i balconi le colonne
il marmo freddo al tatto gli sguardi
le incertezze ora rinvenute sempre
rinviare ogni decisione al giorno
in fondo al calendario in fondo al
pensiero minimo et morale al
centro delle scorie avanzate rinviare
non hai analizzato il contenuto
peccato sei già fuori tempo
massimo
blu intenso
il taglio della visuale ridefinisce
l’orizzonte ora verticale il suo
blu intenso di termosfera tascabile
muovono le figure (intorno) al
riparo dai venti dalla rosa eccole
abbracciate in un fiato elettrico
sono due parti di uno due parti
metà esatte che scavano
la pietra levigata del giorno
che percorrono curve tortuose
prima di giungere all’arrivo
hanno respiri nelle pieghe del cuore
intersecano ora innocenti
l’orizzonte il suo blu intenso
di antica riemersa profondità
Dalla sezione Il futuro del mondo
coleotteri
forse la soluzione potrebbe stare nel
vivere come un coleottero qualunque
tra miliardi di simili incompresi e vacui
con la disinvoltura del saprofago
che sceglie con cura ogni sostanza
sorvolare inquietudini e tormenti
disegnando nell’aria la naturale
linea di voli radenti e ben calibrati
un organismo anonimo e ronzante
sbeffeggiatore di teste umane
inopportuno trasvolatore in cerca
di
Enea Roversi vive a Bologna, dove è nato nel 1960.
Ha ottenuto riconoscimenti e segnalazioni in vari concorsi nazionali di poesia ed è stato pubblicato su riviste, antologie e siti web.
Tra le pubblicazioni: la raccolta Eclissi di luna (Poesie 1981-1986), uscita in versione e-book nella collana Nuovi Echi per la casa editrice La Scuola di Pitagora e la silloge Asfissia, pubblicata nel volume Contatti edito da Edizioni Smasher.
Più volte segnalato o menzionato al “Premio Nazionale di Poesia Lorenzo Montano” organizzato dalla rivista Anterem, ha partecipato ad alcune edizioni della Biennale di Poesia di Verona e ad altre rassegne letterarie.
Fa parte della redazione della rivista Versante Ripido e figura nello staff organizzativo del Festival Letterario Bologna in Lettere.
Cura il sito web www.enearoversi.it, interamente dedicato alla propria attività letteraria e pittorica e il blog Tragico Alverman – Scrittura e altro.
Sergio Sichenze, una poesia inedita “Et in Arcadia ego”, premessa di Ranieri Teti
Il primo capitolo, l'origine di un ipotetico atlante di gesta celesti e terrene, viene dispiegato in questa poesia di Sergio Sichenze. Siamo all’incipit, l’Arcadia. Sono gesta che solo il poeta può avvertire e mettere in atto: qui anche la forma è sostanza, come lo spostamento del verbo o del participio alla fine della strofa, slegato e lontano dal soggetto, per offrire un aumento di percezione; come l’uso dell’enjambement che consente, nello stesso verso, oltre l’oscillazione del senso, variazioni di genere che rendono nell’effetto spiazzante (“freddoloso la vegetale”) il piacere di leggere poesia. Sono gesta che pian piano si modificano in gesti, soprattutto naturali. Ma la grandezza del poeta, che non si limita a registrare, riesce a portarci un po’ più in là, dove pulsa il seppellito, il segregato, il disincanto.
Et in Arcadia ego
Caste
matasse di stradicciole
all'alba: implume
sole, inoperoso
fuoco, di luce
contrattile
svestito.
Crepitio
di pergole
sconnesse, da residuo
vento
percosse. Notturna
bufera l’attacco
sferrò da lancieri
fulminei
preceduta; l’afa
nel buio
s’estinse, cumulonembi
traversò. Alito
freddoloso la vegetale
seta della senna
buca. I lassi
racemi d’iracondo
giallo
sfioriscono.
Sgomberi
i nostri gesti di rissa
acuta, di squarci
e alterchi degli ansimanti
petti: l’adrenalina
cheta.
Il nostro
intrico sciolto, il garbuglio
secato delle braccia.
Burrasca
sedata: acceso
artiglio
seppellito.
Ancora la falena
segregata: nel disincanto
della fine l’uscita
cerca.
Sergio Sichenze è nato a Napoli.
Ha pubblicato il racconto “L’attesa” (KV ed., 2007); la raccolta di poesie “Nero Mediterraneo” (Campanotto ed., 2008); il racconto “BOBBIO Y MOSTAR”(Marcos y Marcos ed., 2011); cinque inediti nel n.8 dell’ottobre 2016 di Versante Ripido; la raccolta di poesie con Elisabetta Salvador “Nei chiaroscuri del tango” (Campanotto ed., 2017). Collabora con l’associazione Versante Ripido per la diffusione della poesia dal 2017.
Ultima pagina: Galleria fotografica di sabato 20 ottobre 2018, scatti di Francesco Paviglianiti
Gennaio 2019, anno XVI, numero 41
.jpg)
Con questo nuovo numero di "Carte nel vento" torniamo temporalmente all’edizione 2017 del Premio Lorenzo Montano, dando evidenza a opere che furono premiate con "Segnalazione".
Tutti gli autori presenti sono introdotti da alcuni poeti della redazione di "Anterem", che coincide con la giuria del Premio.
Il nostro incessante lavoro intorno alla poesia e alla prosa prosegue da molti anni ed è documentato nei precedenti numeri di questo periodico; viene svolto per tutte le sezioni in cui il "Montano" si articola ("Raccolta inedita", "Opera edita", "Una poesia inedita", "Una prosa inedita") e per tutte le opere segnalate e finaliste.
Siamo lieti di comunicare che il bando della 33^ edizione (2019) è disponibile scarica il bando.
In copertina: Nicoletta Bidoia, due Collage, serie ITAJ, 2013
Emanuela Mariotto, dalla raccolta inedita “Alzheimer”, nota di Laura Caccia
Sorella poesia
E se la poesia fosse proprio la “parola deformata” che Emanuela Mariotto sussurra dolorosamente nella raccolta “Alzheimer”, in cui la drammatica vicenda familiare si fa dire di un altro senso?
Un dire che ustiona: “È caduta”, scrive l’autrice, “come goccia di fuoco / la tua prima parola deformata / scottandomi la gola”, nella vertigine di un dolore e di un abisso che solo la poesia può osare toccare, accarezzare.
Come nella poesia, il linguaggio, che la malattia deforma, proviene da un altro mondo: “Mi racconti qualcosa? / Qualcosa / prima dei racconti? / Una storia prima del mondo?” , sono i versi d’esordio della silloge, dedicata alla sorella che “mostra la strada”, spalancando, nel dramma personale, gli abissi di un dire primigenio e l’apertura a nuove possibilità di senso e di parola.
Ed è analoga, alla poesia e al morbo degenerativo, la lingua che interrompe la comunicazione ordinaria e la logica della ragione, come riferisce sommessamente l’autrice: “Scompigliato l’alfabeto del mondo / le lettere diventano nemiche / e parole inventate entrano in gioco”, così come la perdita di senso: “Mi faccio tua memoria / a te che vai in giardini di gesso / e sfili la collana del senso / perdendone le perle”.
Anzi è propriamente una parola “a rovescio” che, in entrambi i casi, capovolge i sensi, “Allora anch’o entro nel gioco / per un po’ credo al tuo mondo / lo capovolgo con te”, come ancora dichiara l’autrice, in cerca di una nuova lingua: “Marionette spezzate le parole / se ne vanno di scena / e un nuovo glossario va inventato / per rimetterle in piedi”.
Soprattutto è un dire che affronta l’oscuro, l’ignoto, l’enigma, come leggiamo, “Arranchi tra parole-mistero / sorteggi un tuo vocabolario”, e che appartiene propriamente all’altrove, “Con te reinvento la grammatica / apro corridoi di senso / voglio raggiungerti / nel tuo altrove”.
Mettendosi dalla parte della lingua smarrita, Emanuela Mariotto ci parla contemporaneamente della parola capovolta della sorella e della parola poetica, come fossero entrambe sorelle: una colpita dolorosamente dalla patologia, l’altra che ne accarezza il percorso e insieme trova, nell’affezione della mente, un rispecchiamento nitido, prezioso.
***
Mi racconti qualcosa?
Qualcosa
prima dei racconti?
Una storia
prima del mondo?
***
Mi faccio tua memoria
a te che vai in giardini di gesso
e sfili la collana del senso
perdendone le perle.
Quasi tua madre
ti offro le parole
ripetendo per te l’alba
e il tramonto
la clessidra del tempo
i mille nomi delle cose.
Mi chiedi chi sei
tremando te lo dico
io stessa mi perdo
nel tuo buio.
Emanuela Mariotto, laureata in Lettere moderne a Padova, vive a Milano. Qui ha seguito i corsi di scrittura creativa di Raffaele Crovi e di poesia di Antonio Porta. Sue poesie sono sono apparse su riviste e quotidiani, in libri e antologie; alcune nel sito della Libreria delle donne di Milano. Nel 1987 ha ricevuto il Premio della Biblioteca Civica di Paullo in occasione dell’8 marzo. Più volte segnalata e finalista al “Montano”.
Stefano Della Tommasina, da “Global”, Oèdipus, 2017, nota di Flavio Ermini
Stefano Della Tommasina ha pubblicato la sua opera prima con Anterem. Global è il suo secondo libro, edito da Oèdipus nel 2017.
Questo lavoro si configura come un movimento verso l’ulteriorità. Un movimento che induce a sottrarci da qualcosa che sta in superficie per indagare l’interiorità.
Questo movimento manifesta due versanti del dire. Uno si prende cura della forma a tutti visibile delle cose; l’altro si rivolge all’informe proprio delle immagini illeggibili.
“Tra” questi due versanti, l’indecisione di Della Tommasina è evidente. La sua poesia interpella cose e persone che incontra, in modo da convocarle nello spazio delimitato della frase. In questa maniera la poesia crea avvicinamenti, incontri, contatti. È puntuale e vigile nell’affidarsi a quei segni che possono individuare ciò che le si presenta davanti.
La poesia va in cerca di un “tu” e il lavoro di Della Tommasina mostra i tratti di questa ricerca. Mette a nudo il passaggio in atto tra l’al di là e l’al di qua dell’occhio, interpretato come finestra e schermo rispetto al mondo.
Ogni poesia del libro mostra qualcuno che è partito o che è in procinto di partire; dice la mancanza, l’eccesso di sottrazione. Un lutto? No. Al contrario la celebrazione della diversità che è propria del fare poesia.
Nel Museo
La strada a mare è un nome e qualche numero
davanti: le case sono vuote o forse i gatti
dormono sul retro, ultima spiaggia. La sabbia
dentro la clessidra si rovescia: perde tempo.
E noi nel mezzo non sappiamo
se scavare buche, seppellire amori.
Ci osserveranno quei colori che dal cielo
scendono e trasformano le cose,
i resti di un tesoro antico:
a fianco, nel museo, saremo statue
senza braccia, gambe, tronco, busto, viso.
Stefano Della Tommasina si è laureato in lingue e letterature straniere nel 1986.
Maestro Nazionale FIT (Federazione Italiana Tennis).
Nel 2015 vince il Concorso Opera Prima, iniziativa promossa dal 2012 da Poesia2punto0 con la silloge intitolata Museo Bianco.
Sempre nel 2015 vince con "Global" il Lorenzo Montano per la poesia inedita.
Alcune sue poesie sono state pubblicate online su:
Critica Impura, La Presenza di Erato, Interno Poesia, Versante Ripido, Forma Vera, Limina Mundi. Words Social Forum.
Presente in alcune antologie edite da Lietocolle: Il Segreto delle Fragole, Verba Agrestia, L'Amore al tempo della Collera e i Poet, Lunario in versi, dodici poeti italiani, e nell'antologia Umana, troppo umana - Poesie per Marilyn Monroe edita da Nino Aragno Editore.
Mario Benedetto, una prosa inedita, “L’era in cui viviamo”, nota di Davide Campi
Tema centrale del testo di Mario Benedetto è la dimensione del tempo nella comunicazione umana, la sua valutazione culturale, la sua ottimizzazione.
Nella prima parte viene analizzato il trasferimento delle idee nel mondo della rete globale; il sistema di analisi è semplice: si parte citando dati quasi banali, ampiamente vulgati e si continua a scavare in questi, sino portarne alla luce gli esiti ultimi, le conseguenze meno evidenti e quelle più nascoste.
In questo modo Mario Benedetto giunge ad uno dei problemi fondamentali della comunicazione di questa era digitale, e cioè l’intrinseca pretesa di istantaneità che si traduce in una velocità nello scambio dei fatti e delle idee tale da far perdere agli stessi qualsiasi spessore e qualsiasi valore “umano”.
Tutto ciò viene contestato nella seconda parte, in cui alla superficialità di uno scambio spasmodico di immagini, parole e storie spesso prive di peso si contrappone il valore del tempo umano, giustamente dilatato, nella produzione dell’arte e degli oggetti culturali, nonché nella fruizione degli stessi.
Pure con una indiscutibile lucidità nell’analisi, arricchita di citazioni e dotti sottintesi, questa ultima parte si configura, quasi nei modi dei volantini politici d’altri tempi, come una vera e propria esortazione a tornare a ritmi più umani del dire.
L’ERA IN CUI VIVIAMO - Tra comunicazione tecnologica e comunicazione poetica
Viviamo nell’era della comunicazione ed è il primo comparto al mondo per investimenti, profitti e possibilità occupazionali, come recitano le tante scuole create ad hoc per gestire i nuovi scenari. Soltanto nel nostro paese ci sono più carte sim che esseri umani, i contratti telefonici mobili utilizzati sono 82,3 milioni, il 135% della popolazione residente, in dettaglio sette italiani su dieci hanno uno smartphone e le applicazioni più scaricate sono quelle che permettono di rimanere collegati al mondo. Oramai è molto difficile non restare impigliati nella “rete”. A questa particolare “visibilità” concessa dai social network alla massa di utenti, corrisponde un enorme accumulo di dati privati rivelati che ci rendono più vulnerabili. Si è diffusa come una febbre, da chiunque verificabile, e smania di dover raccontare, rendere pubblico, ogni aspetto privato come se fosse rivelatrice d’importanti significati e nulla più resta in ombra. Il non essere in rete equivale al non esistere proprio, è inconcepibile e insopportabile restare fuori dalla rappresentazione di questa realtà fatta di successioni di flash, frammenti superficiali che non permettono una visione complessiva delle cose che viviamo. Tutto dev’essere fast che è anche la caratteristica della nostra epoca. La velocità io la lascerei ad altro, per le relazioni umane e l’arte serve, soprattutto, un coinvolgimento fisico con la libera consapevolezza di tutti i sensi, un ritmo diverso e meno virtuale. L’arte e la poesia sono ben altro dalla necessaria e semplice comunicazione. Certo non si può negare, quanto le nuove tecnologie siano utili e quanto contribuiscano a stimolare e sensibilizzare la gente al mondo dell’arte, anche se nulla potrà mai sostituire la presenza fisica con la sua aura dell’opera d’arte, unica e irripetibile nel posto in cui si trova. Prima o poi si arriverà, anche in queste latitudini, al clicca e compra (click and buy), ma andiamoci piano, che necessità c’è di affrettarsi, precipitarsi a rotta di collo. Va bene stare al passo con i tempi, comunicare, pubblicizzare, promuovere, gestire, diffondere e valorizzare, ma non facciamo assurgere l’opera virtuale a paradigma arrogante di qualificazione estetica. Restiamo umani! Quando la realtà in uno dei suoi aspetti, un certo colore, una luce particolare, un viso, una figura, un colpo di vento, un profumo, colpisce l’attenzione umana, se essa è ancora sveglia, accade che le parole entrino in tensione e non sono più come prima, quando comunichiamo normalmente. “‘E il reale che tende a dirsi, attraverso l’emozione e le parole di qualcuno”. Tutto questo non può avvenire virtualmente. Bene inteso che nessuna preclusione a ricerca e sperimentazioni di nuovi moduli espressivi dev’essere fatta, l’innovazione va perseguita per evitare di restare fermi e “impantanati” nella tradizione. “Il compito dell’arte è quello di essere sempre diversa dal passato, di aggiornarsi. Esiste soltanto l’arte aggiornata” (da intervista a Gillo Dorfles su Panorama, ott. 2014). L’arte attinge la sua concretezza dalla vita in generale e dalla vita della cultura i cui contenuti confluiscono in essa, impregnati e fatti propri per diventare una nuova energia. L’arte non ha nulla a che fare con i tempi immediati della comunicazione, della condivisione e dell’essere in rete. Con tutto il rispetto alla genialità di Mozart e di altri grandi, la creazione artistica non è un gioco, un passatempo, non corre, al contrario ha bisogno di tempi lunghi, di riflessioni, di approfondimenti, di solitudine, di attesa e non deve essere di pochi, ma poter parlare a più persone possibili (il sistema dell’arte è un’altra storia). Creativo nell’arte è colui che rompe le regole estetiche precedentemente formulate. Soltanto utilizzando chiavi di lettura della realtà inedite ed anticipative, è possibile vedere al di là dei consueti modelli di percezione, partendo dalla curiosità e dall’intuizione e sviluppare idee nuove e invenzioni utili con un valore riconosciuto. Per tagliar corto, voglio citare questo intenso giudizio di Robert Hughes, scritto qualche anno prima della sua scomparsa nel 2012: “Ne abbiamo davvero avuto abbastanza di fast art, ora abbiamo bisogno di slow art. Abbiamo bisogno di un’arte che racchiuda in sé il tempo, così come fa un vaso con l’acqua. Un’arte che tragga origine dai modi di percezione e creazione, che con capacità e ostinazione faccia riflettere e tocchi gli animi. Un’arte che non sia sensazionale, che non lasci trapelare subito il suo messaggio, che non sia falsamente iconica, ma che penetri nel profondo delle nostre nature. In breve, un'arte che sia l’esatto opposto dei mass media”.
Mario Benedetto è nato a Scilla (RC), laureato al Politecnico di Milano e diplomato all’Accademia di Brera vive e lavora a Vernate (MI). Autore di numerosi articoli sulla storia e la critica d’arte, è stato docente di Discipline Pittoriche in alcuni licei artistici. Tra le numerose esposizioni personali si ricordano: 100 opere sulla civiltà contadina e marinara in Calabria, Zurigo, 1985, con tavola rotonda sullo stesso tema, che ha visto la partecipazione di numerose personalità della cultura; l’Antologica 1964 – 1994 al Castello Carlo V di Lecce, 1995, con 140 opere, di cui, alcune di grande formato. Da anni è attivo nel campo dell’arte sacra con la progettazione e realizzazione di vetrate, mosaici (Trinità ed Immacolata, Duomo di Scilla,1986) e opere scultoree per chiese (Timpano della Chiesa di San Rocco, Scilla, 2003).
Jacopo Ricciardi, da “Sonetti reali”, Iride/Rubbettino Edizioni, 2016, nota di Flavio Ermini
Jacopo Ricciardi è poeta e narratore. Ha pubblicato diversi libri di poesia e due romanzi.
Sonetti reali, edito nel 2016 da Iride – marchio del gruppo Rubbettino –, dà corpo a una tensione verso un altrove irraggiungibile, verso una compiutezza che sembra non appartenere al nostro mondo.
L’incompiuto connota l’intera realtà. Tanto che, nel testimoniare questo limite, la poesia normalmente procede a salti e balzi digressivi; commenta tramite note a margine e postille l’esistenza, attratta com’è dall’indeterminato, dalla forma aperta.
Va in direzione contraria il lavoro di Ricciardi, impegnato com’è a dire questa frammentaria realtà puntando su di un’aura di completezza formale, sul finito, un’armonia che si rivela nell’articolarsi dei testi come la vera porta di accesso alla realtà.
La compiutezza dell’opera in Ricciardi evidenzia una totalità sempre mancata, mette in luce il carattere irregolare e frammentario del mondo. Si presenta come una specie di officina in cui viene forgiato un processo di scrittura che non si distingue per imitare la realtà (e dunque rispondere alla frammentazione con la frammentazione, all’oscurità con l’oscurità), ma piuttosto si configura come un’esperienza-limite della lingua: nella sua determinatezza (testimoniata dalla chirurgica precisione dei titoli delle singole poesie: velocità, dono, età, lite…).
Termine
Il giorno si converte nella notte.
Nelle epoche i giovani sempre uguali.
Amate i figli a cui date i natali.
Poi vecchi si guarda il fondo di grotte.
Il resto è sulla tavola periodica.
La luna sta lì per caso e non vive.
Le guerre hanno sempre ritmiche argive.
L’uomo distrugge l’uomo, è vita iconica.
Il vivo riluce non si sa dove.
Il caso illude e conduce alla morte.
Ora è l’epoca nuda senza corte.
Oggi la poesia è dura su Giove.
Ogni persona è un fragile frammento.
Il mondo è un otre ricolmo di vento.
Jacopo Ricciardi è nato nel 1976 a Roma, dove vive e lavora. Vincitore di diversi premi, ha pubblicato sette libri di poesie - Intermezzo IV (Campanotto, 1998), Ataraxia (Manni, 2000), Atòin (Campanotto, 2000), Scultura (con Teodosio Magnoni; Exit, 2002), Poesie della non morte (con Nicola Carrino; Scheiwiller, 2003), Colosseo (Anterem, 2004), Plastico (Il Melangolo, 2006), Scheggedellalba (con Pietro Cascella; Cento amici del libro, 2008) - nei quali il suo modo di procedere è “vasto quanto un luogo poiché lì è qui ma quando/ci si avvicina al luogo qui e lì già accade tra la/parola e l’universo che si toccano”. Ha ideato e curato dal 2001 al 2006, per Aeroporti di Roma, il progetto culturale “PlayOn” e ha diretto l’omonima collana presso Scheiwiller. Ha pubblicato due romanzi, Will (Campanotto, 1997) e Amsterdam (PlayOn, 2008). È presente nell’antologia “Nuovissima poesia italiana” (Mondadori, 2005) curata da Maurizio Cucchi e Antonio Riccardi.
Alessandro Assiri, una poesia inedita, “Senza titolo”, nota di Ranieri Teti
"La nostalgia ha un suo colore, un bisogno di visi, un asservirsi alle cose; perché ricordiamo facce e desideriamo assenze. Un’atmosfera furiosa, la nostalgia, dalla quale emergono uomini che avrebbero potuto, ma non hanno osato. Poi, dopo, molto dopo, tra gli effluvi del giorno, affiorano sogni possibili”.
Nel 2006 Alessandro Assiri pubblicò un volume di poesie in prosa, “Il giardino dei pensieri recisi”, da cui ho tratto la citazione. Questa riproposizione mi è sembrata una delle migliori vie per accompagnare il breve testo presentato quest’anno al “Montano”, in cui la nostalgia non è tanto il dolore di un ricordo quanto un pensiero dolente che dal presente arriva a qualcosa di là da venire, che sicuramente avverrà.
In questo rovesciamento l’esplorazione del sentire viene emancipata da Assiri con gli occhi del poeta e con la sensibilità di un uomo che osa e dipinge in astratto un pensiero senza tempo, dettato dai sogni possibili, orientandosi, come i marinai “a stelle fisse”.
Quale può essere il rovescio della nostalgia se non un sogno possibile, come quello di invecchiare accanto a una voce cara?
***
I dibattiti sui maestri non mi interessano, mi oriento a stelle fisse.
Vivere è un gesto intero dove si perde nella stessa lingua
dove si rimane sino al giorno giusto a invecchiare accanto alla tua voce
Alessandro Assiri, nato a Bologna nel 1962, da molti anni risiede in Trentino. Presente in diverse antologie poetiche, ha pubblicato per Aletti Editore "Morgana e le nuvole" e "Il giardino dei pensieri recisi", con la prefazione di Paolo Ruffilli. Per Lieto Colle "Modulazione dell'empietà", con prefazione di Aberto Mori, "Quaderni dell'impostura" con la prefazione di Chiara de Luca, “Appunti di un falegname senza amici”, “Lettere a D.”, “Ontologia della Maddalena” con Augusto Pivanti. Con Manni Editore, “La stanza delle poche righe”. Con le Edizioni CFR “In tempi ormai vicini”. A quattro mani con Chiara De Luca “Sui passi per non rimanere”, Fara Editore. L’ultimo lavoro, “L’anno in cui finì Carosello”, vincitore del Premio Giorgi, è stato pubblicato da Le Voci della Luna.
Anna Maria Giancarli, da “E cambia passo il tempo”, Robin Edizioni, 2014, nota di Flavio Ermini
Anna Maria Giancarli è nata a Roma e vive a L’Aquila. Dopo un’intensa attività politica, si è dedicata completamente alla poesia.
Ha pubblicato oltre 10 raccolte di poesie.
Due dati autobiografici confluiscono in E cambia passo il tempo (Robin Edizioni, 2014): l’impegno politico e la residenza a L’Aquila. Sono due dati che s’intrecciano e si saldano alla luce del devastante terremoto del 2009, allorquando il tempo ha cambiato passo e ha rivelato la nostra fragilità sia di fronte alla potenza della natura, sia al cospetto del degrado culturale, civile e umano del nostro Paese, incapace di far fronte a questa terribile emergenza.
Le parole che Anna Maria Giancarli pronuncia vogliono essere, come lei stessa si propone, un vero e proprio materiale “ricostruttivo”. Intendono legarsi a quelle di coloro che – come noi – ritengono insopportabile assistere al cinismo dei profitti, alle mani rapinose dei potenti di turno sulla città.
Ma “ancora si scrive e si vive” dopo la crudeltà della natura e la malvagità degli uomini. Davanti a tanto orrore è necessaria la figura del dissidente, ossia del ribelle del pensiero nell’odierno tempo della miseria, un tempo in cui a eclissarsi è la stessa capacità di dire-di-no. Hegel definisce queste figure come “eroi della ragione”.
Giancarli ci impone di riflettere sulla dissidenza. Farlo significa confrontarsi con una pratica che si è eclissata cedendo il passo all’ebete adattamento, tipico di chi accetta l’apatia del pensiero che opera sulle coscienze per poi impadronirsi finanche dei corpi.
Dopo
ancora si scrive e si vive
una vita così
ripensando tutto finendo mai
di pensare e rimare e prosare
ideando finali ad effetto
nell’impazzita periferia
ché la città è un non-luogo
che strappa stelle e
ricordi brucianti
alle tre e trentadue della vita
di tutte le notti
di tutti i giorni d’attesa
diciamo pensieri sparlanti
ma qui si resta
col pianto di ieri si tace
si urla si sussurra
si muore una vita così
si vive una morte
Anna Maria Giancarli è nata a Roma e vive all‟Aquila. Laureata in Filosofia e Pedagogia, ha insegnato nelle Scuole Medie ed ha svolto una intensa attività politico-culturale, ricoprendo numerose cariche istituzionali.
È presidente dell‟Associazione culturale “Itinerari Armonici”, con la quale realizza iniziative multimediali, quali Poetronics (Poesia elettronica, alla sua XVII edizione), lapoesiamanifesta! (Giornata mondiale della poesia, 21 marzo – alla sua II edizione) ed il Festival internazionale di poesia Nuove Dimensioni, con la presenza dei più prestigiosi poeti e musicisti. Nell‟agosto 2016 ha realizzato a L‟Aquila – in collaborazione con la Società dei Concerti “B. Barattelli” e all‟interno della manifestazione annuale “I Cantieri dell‟Immaginario” - Di-versi incontri, serata di poesia multimediale.
Ha collaborato come critico letterario con la casa editrice Tracce di Pescara, curando anche la collana “Segni del suono”, e con il Centro Documentazione Artepoesia Angelus Novus dell‟Aquila. È stata membro dell‟AS.P.A. (Associazione Poeti Abruzzesi) ed ha fatto parte del comitato di redazione della rivista «Finisterre».
Fondatrice e membro della giuria del Premio Letterario Internazionale di poesia “Città dell‟Aquila” (intitolato a Laudomia Bonanni); organizza ed è membro della giuria del Premio Letterario Nazionale “Scriveredonna” (XXII edizione); è membro della giuria del Premio Penne.
È stata membro dei C.d.A. della Società dei Concerti “B. Barattelli”, della Compagnia Teatrale “L‟Uovo” e del Consorzio dei Beni Culturali della Provincia dell‟Aquila.
Ha pubblicato: Frammenti da una rivolta, Laboratorio delle Arti, Milano 1983 (con prefazione di Domenico Cara); Punto di caduta, Laboratorio delle Arti, Milano 1992 (con prefazione di Mario Lunetta e postfazione di Maria Luisa Spaziani); Stato di emergenza, Edizioni Tracce, Pescara 1997 (con prefazione di Biancamaria Frabotta); Realtà fuori misura, Edizioni Portofranco, Taranto 1998; I trucchi del reale, Piero Manni editore, Lecce 1999 (con prefazione di Marcello Carlino); Confini diversi, Fermenti editore, Roma 2002 (con prefazione di Nanni Balestrini); Sconfina/menti (raccolta antologica dal 1997 al 2005, con inediti; prefazione di Mario Lunetta), edizioni Campanotto, Udine 2006; In/canto per Eloisa, edizioni Tracce, Pescara 2008 (prefazione di Maria Luisa Spaziani); la parola indocile, edizioni Le impronte degli uccelli, Roma 2011 (prefazione di Francesco Muzzioli); E cambia passo il tempo – poesie su L’Aquila, Robin edizioni, Roma 2014.
Suoi testi sono stati tradotti nelle lingue Serba e Inglese.
Sono state pubblicate due antologie di suoi testi: Trucurile realului, antologia bilingue romeno– italiano, edizioni Autograf, Craiova 2004 (con traduzione e prefazione di George Popescu) e Arqueología del presente (Antologia poética 1997-2008) antologia bilingue spagnolo-italiano, Ediciones Amargord, Madrid 2013.
Nel 2007 ha curato le pubblicazioni del volume Elzeviri di Laudomia Bonanni, dell‟antologia La poesia femminile in Italia e, nel 2013, del volume Ballate di Edoardo Sanguineti, tutti per le edizioni Tracce di Pescara. Nel 2010 ha curato la pubblicazione dell‟antologia La parola che ricostruisce – poeti italiani per L’Aquila, sempre per le edizioni Tracce di Pescara. Nel 2012 dell‟antologia La poesia luogo delle differenze per le edizioni Marcus di Napoli.
Presente in numerosissime antologie; tra cui: Storia della letteratura italiana (Guido Miano Editore, Milano 1998); Botto 3000, antologia elettronica sul nuovo millennio (sito internet: www.arstv.com/botto3000), a cura di Romapoesia ed Editrice Zona, Dicembre 1999; antologia di Haiku Frecce e stelle (edizioni “Le impronte degli uccelli”, Roma 2000); antologia La ricerca poetica attuale, edita su CD-rom e sito web (www.cirps.it) dall‟Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (Maggio 2001); antologia No alla guerra sempre e comunque («Bollettario», Ottobre 2001); antologia Pace e libertà (edizioni “La comune” - in collaborazione con l‟Associazione Internazionale di Amicizia e Solidarietà con i Popoli, Genova Dicembre 2004); Almanacco di scritture antagoniste (edizioni Odradek, Roma 2003 – Roma 2005); Antologia della poesia erotica contemporanea, ATì editore, Milano 2006; La montagna (Ferrari editore, Cosenza 2007); Poesia a comizio, Empiria editore, Roma 2007; LUCI da IL FOSSO – ventiquattro segni terrestri per Laudomia Bonanni (edizioni La Vita Felice, Milano 2008); Poesia senza kuore (a cura di Mario Lunetta, Robin edizioni, Roma ottobre 2008); Haiku Lei (edizioni Le impronte degli uccelli, Roma 2010); Donnine biciclette scarpe stringhe (edizioni Le impronte degli uccelli, Roma 2012); Anatomia del sentimento (edizioni I quaderni del lavatoio, Roma 2012); Europa e cultura (Aracne editrice, Roma 2014); Guarda che luna (Mincione edizioni, Roma 2015); Poeti e poesia (rivista internazionale diretta da Elio Pecora, Roma aprile 2015, n. 34); Nutrimenti (antologia di poeti italiani per l‟EXPO 2015, edizioni Tracce, Pescara 2015); Arobaleno liquido della creatività (venticinque libri d‟artista, realizzati da cinque poete e cinque artiste, L‟Aquila 2016).
Presente nel DVD Dialoghi con i poeti Sanguineti, Muzzioli e Perilli (2004).
Presente ancora con recensioni in numerose riviste (tra le altre, «Quasar», «Fermenti», «Avanguardia», «Poesia», «L‟immaginazione», «La Nuova Rinascita», «Vario») ed in quotidiani e trasmissioni radiofoniche nazionali (tra cui “Zapping”, Radiouno e “Rai 3 Suite”, RadioTre).
Della sua produzione poetica hanno scritto i maggiori critici e scrittori contemporanei (Domenico Cara, Mario Lunetta, Maria Luisa Spaziani, Biancamaria Frabotta, Plinio Perilli, Mariella Bettarini, Marcello Carlino, Francesco Muzzioli, Nanni Balestrini, Rosaria Lo Russo, Giovanni Fontana, Marco Palladini, Michele Fianco).
Come autrice ha partecipato a numerosi readings, letture pubbliche ed importanti manifestazioni nazionali, tra cui: “Europa Festival” di Ferentino (Luglio 2000); “Fiera del libro di Torino” (Maggio 2001); Festival dei popoli mediterranei (Bisceglie, Agosto 2003); Carovana della poesia sotto il patrocinio dell‟UNESCO (Marzo 2003); XXXX Meeting dell‟Associazione scrittori serbi (Belgrado, Settembre 2003); Festival internazionale “Romapoesia” (Roma, Ottobre 2003 - Ottobre 2004 - Ottobre 2010); letture varie al Lavatoio Contumaciale (Roma); letture al Festival nazionale di Liberazione (Roma, Settembre 2004 – Roma, Settembre 2005); lettura nella manifestazione “Poesia in Via Giulia” - Libreria Einaudi (Roma, Maggio 2005); Boomerang, incontri di poesia e arti visive (Roma 2008); letture all‟Università di Treviso (8 Marzo 2009); letture al Salone del libro di Torino (Torino, Maggio 2010 - Maggio 2011 - Maggio 2012 - Maggio 2013); reading Poeticazione (presso CaseMatte, L‟Aquila 2011); reading La città delle donne (Montesilvano, PE 2011); lettura all‟Isola Tiberina (Roma Giugno 2012); reading Versisuoni per L’Aquila (Monte San Giovanni Campano, FR 2014); reading L’altra poesia (“Roma Vintage”, Roma 2014); lettura alla Saletta della Regina (Montecitorio, Roma 2015).
Suoi testi poetici sono stati utilizzati per composizioni musicali da: Giorgio Sollazzi (Sintetica, Pescara 1995); Caterina Imbrogno (Liriche cromate, L‟Aquila 1997); Roberta Vacca (Grido concentrico, Palazzo delle Esposizioni, Roma 1997); Fausto Razzi (Insogno, Sermoneta 1998); Fausto Razzi, (Emergenze, “Teatro di documenti” Roma Ottobre-Dicembre 2000; Sala Chierici del Forte Spagnolo, L‟Aquila Aprile 2001; Auditorium Diocleziano, Lanciano Ottobre 2001); Maria Cristina De Amicis (Significato e senso, L‟Aquila 2005 – Università di Tor Vergata, Roma 2013); Elisabetta Capurso (Alfa ... senza origine, L‟Aquila 2008 - Festival “Nuova Consonanza”, Roma 2008 – Teatro Cassia, Roma 2009); Domenico De Simone (Talking k [NOT]s – I Quipus della memoria, Teatro Cassia, Roma 2009 – Casa Onna, L‟Aquila 2011 – festival elettroacustico Re-volt, Forte Fanfulla, Roma 2011 - Università di Tor Vergata, Roma 2012 - Palazzetto dei Nobili, L‟Aquila 2013 – “Emufest”, Roma 2013); Sabatino Servilio (A lezione di sogni, L‟Aquila 2010); Roberta Vacca (Nuvolabirinto A/Z); Francesco Marchionna (La voce oscura, 2016).
Ha ottenuto una “Menzione speciale” al Premio Feronia (Fiano Romano 2005); è risultata finalista al Premio Montano (Verona 2005) ed al Premio Tassoni (Modena 2006, Modena 2009); ha vinto il Premio Penne 2006; riconoscimento speciale, XXIV Premio “Estonium” (Vasto 2009); secondo premio al “Premio Internazionale di Poesia „dal Tirreno allo Jonio‟ (2017).
Gabriele Pepe, una poesia inedita, “Metafisiche da passeggio”, nota di Ranieri Teti
Un testo, sin dal titolo, peripatetico. Allo stesso tempo dichiaratamente ontologico.
Mentre si passeggia, distratti e attenti, senza fretta, è possibile soffermarsi non solo nel veduto o nel linguaggio che ci accompagna, non solo nel pensiero, ma anche negli accadimenti di un intorno mobile che vanno astraendosi per diventare, tutti insieme, fondamenti.
Come ci ricorda Remo Bodei, “la via del concreto transita per l’astratto”.
Gabriele Pepe ci conduce quasi per mano lungo questa strada “tra luce ed eclissi”, a partire dal “mito del concreto” che tramuta poeticamente in astratto. Le cose raccontate sono insieme leggere e dense, spaziano nello scibile, nel celeste, collassano ma si irradiano, “tra il battere delle ciglia e l’eco delle palpebre”, innestano il poetico nel pensiero e viceversa. Una lunga passeggiata diventa il testo di una lunga ballata, in tre tempi, senza mai perdere potenza espressiva, senza mai perdere ritmo.
Gli avvenimenti intorno sono molteplici, tradotti in senso si accavallano, creando inusuali digressioni.
Ogni frammento colto dall’occhio, ogni bagliore anche inconsapevolmente intravisto può tramutarsi nella parola acuta del poeta, così come al contrario da ogni pensiero possono scaturire immagini mentali: “un bagliore di nervi”, “il duplice affabulare” della retina che “il mondo capovolge spacciandolo per vero”, “il calco che affondiamo”, “il sapore delle nuvole”, “le cause del partire”.
Camminando in questi versi di Pepe, dove ogni dettaglio visto diventa pensato e dove ogni pensiero diventa visivo, dove convivono esteriorità e interiorità simultaneamente, siamo alla fine arrivati, senza accorgerci del tempo trascorso, all’imbrunire “tra le pieghe della sera”.
1.
Necessario, a volte, immergersi in un intimo spiraglio:
farsi frammento clandestino d'un calendario umano
il rintocco residuo di un tempo mai cronometrato
e immaginare meridiani e paralleli inquieti
fino all'estremo di un orizzonte obliquo
appeso all'attimo incoerente quando lo spazio
distorce la matrice e precipitano visioni
presagi archetipali di solstizi ed equinozi
ben oltre la dottrina dei nostri sguardi indagatori
che, come steli di pupilla, oscillano tra luce ed eclissi
Nel mito del concreto, frequenza e costanza d'onda,
di vita in vita, la vita, vivendo, s'infiamma.
Fragile e densa carne di stella
nel fulcro dei sensi collassa e s'irradia
raggio per raggio, pigreco miraggio,
giostra e giostraio del palio mentale.
Il vento indifferente agita ancora
le dotte affermazioni di filosofi e scienziati
gli ultramondi sensibili di santi e sciamani.
Scende insolente la pioggia. Senza contegno liquida:
memorabili tesi, argute teorie, incrollabili certezze
nel luccichio sapiente d'acque dolci e salmastre.
Brucia assoluto nei campi del vuoto
il fiore quantico dell'infinito mutare:
da fiamme a fibre, bagliore di nervi
siamo un dardo cosciente di luce che genera forme
e polvere alla polvere, cenere alla cenere
ogni scintilla torna al fuoco originale
Ma conquistare l'ignoto alquanto ci costa:
un patrimonio faticosamente accumulato di gesti
fin troppo dissoluti, ineffabili crudezze, nodali
esperienze sperperate a braccia conserte e passi felpati
Forse se avessimo tentato un'altra insurrezione
una rivolta nuova senza mai sfiorare il grilletto
inesorabile delle parole dolorose;
se avessimo parlato una lingua accorta
senza mai vendicare quel barlume a volte
incandescente a volte rassegnato che ci precede
tra il battere di ciglia e l'eco delle palpebre
forse staremmo tutti bene e ancora del tutto vivi
2.
Tra basso cielo e vasta terra concedersi una tregua:
una promessa di purezza totalmente disarmata
il nostro armamentario inferno deposto per la resa
e aprirsi al perdonare come sempre fa la retina
ogni qualvolta che, nel suo duplice affabulare,
il mondo capovolge spacciandolo per vero.
Simulacro intellegibile tutto mirato a lucido
sottoposto a ragionevole interpretazione
ben oltre i sacri canoni del giorno e della notte
le ambigue volontà del sonno e della veglia
Perché materia ardente materia oscura,
progetto sintomatico dell'endoverso,
qualunque fosse all'origine la causa del dividere
l'oggetto del comprendere, in conclusione
ignari come fragili conchiglie gettati a capofitto
tra le scabrosità dell'ego, guerreggiando, stiamo.
Sperduti a dismisura in ogni pianto nascituro,
e luogo alieno a qualunque verità di fuga
senza requie: respiro per singolo respiro.
Un velo esteso dentro e fuori e tutt'intorno
come se al mondo fosse un altro del tutto estraneo
al ciclo circadiano a sognare l'umanità che erige
il sogno quotidiano dei fatti e dei misfatti.
Per tutto il resto di certo non bastano le forze
che appena avanzano a porgersi domande
che ansiose tremano e volteggiano nell'aria
in trepidante attesa che oracolo risponda,
sperando, invano, che orecchio le raccolga
Istante per istante, sorge e risorge il moto
dei pianeti: e nel punto preciso, incrocio di creato
e ricreato, si compie l'ennesima illusione: il trucco
del coniglio che spunta dal cilindro del mago universale..
Forse se avessimo guardato da un altro punto d'osservazione,
diretto, con mirabile saggenza, l'intero caleidoscopio
su cieli assenti e galassie tra gli specchi
senza mai contestare il prodotto eterno lordo
del buio e della luce;se avessimo solo goduto
il senso univoco dei fiori e dei colori,
senza mai offuscare il lume dell'artista
forse staremmo tutti in pace, finalmente liberi
3.
Concedersi di tanto in tanto il dolce lusso
il sano dubbio : è meglio stare oppure andare?
Ma nulla a questo mondo è davvero bifocale
Se un passo segue l'altro, una è l'orma che lasciamo.
Che sia traccia indelebile impressa quasi in vuoto,
grande balzo del genio umano a spasso sulla luna,
che sia l'impronta fossile del pensiero vestigiale,
uno e soltanto uno è il calco che affondiamo
ben oltre le frenetiche scalate, le atroci scorribande,
le nevi, il fango, l'erba cruda, e il buio da squarciare.
Perché, a memoria d'uomo, le cause del partire
le contrastanti e solitarie ragioni del restare
di pari passo vanno lungo le anguste vie
che corrono e attraversano ogni dannata storia:
siamo le piste insanguinate dell'ultimo bisonte,
le irriducibili barricate prima dell'orrido sentiero
E dunque rinnegarsi a decifrare eventi:
soggetto oggetto; causa effetto; esterno interno.
Quel complesso intento, quel rito tutto biologico
che ad ogni costo vuole sempre travasare senso
in un compendio logico a misura di cervello
come se lingua e segni del cammino ci appartenessero
incisi a fuoco tra le rughe della fronte, le valvole
del cuore, il vorticoso eccedere di formule e preghiere.
Le presunzioni, dicono, rendono l'uomo scaltro
perfettamente in grado di comprendere
con le dovute cautele il sonno delle rocce,
l'onore delle querce, il sapore delle nuvole
Ma infine scienza o metascienza quel che forse
a malapena emerge dall'utero del mondo
è un'esigenza chimica che aspira al cielo
una ghirlanda accesa tra le pieghe della sera
Gabriele Pepe, finalista, segnalato e vincitore in diversi tra i maggiori concorsi di poesia, ha pubblicato: “Parking luna” edizioni Arpanet, Milano 2002; “Di corpi franti e scampoli d’amore” e “L’ordine bisbetico del caos” con le Edizioni Lietocolle libri, Faloppio (Como) 2007. Figura nelle antologie: “Ogni parola ha un suono che inventa mondi”, edizioni Arpanet, Milano 2002;
“Fotoscritture”, edizioni Lietocolle libri Faloppio (Como) 2005; “Poesia del dissenso II”, a cura di Erminia Passannanti – Edizioni Joker ( Collana Transference) 2006; “Blanc de ta nuque. Uno sguardo (dalla rete) sulla poesia italiana contemporanea”, Edizioni Le Voci della luna (2006-2011), a cura di Sergio Rotino, Collana Segni, volume n. 7, pp. 272; “Forme concrete della poesia contemporanea”, studio critico a cura di Sandro Montalto, Edizioni Joker.
Suoi testi, recensioni e segnalazioni sul suo lavoro sono apparsi in rete e su carta.
Fausta Squatriti, da “Olio santo”, New Press Edizioni, 2017, nota di Flavio Ermini
Fausta Squatriti è poeta e artista. Il suo più recente libro di poesia ha per titolo Olio Santo ed è edito da New Press.
È un titolo che rimanda esplicitamente all’unzione degli infermi e dunque alla cura.
In questa opera, infatti, Fausta Squatriti ci parla di un essere umano situato sul crinale che divide l’età moderna dall’epoca che verrà. E ci avverte che angoscia e sofferenza stanno operando in molti punti dell’epoca contemporanea, tanto da indurci all’apatia.
Olio Santo impone una presa di posizione di rilevante responsabilità: non accettare lo scacco e dire una parola nuova. Una parola che esprima gli spostamenti dell’anima in profondità.
Come? Abbracciando l’idea di raggiungere la struttura poetica dell’esistere, la miracolosità dell’esistenza, quel carattere di magia che è proprio di ogni cosa quando viene liberata dalla gabbia della semplice interpretazione.
40
Senza talento d’osanna
stona
nel secolo breve
conta di morti e compianto.
Nessuno
sperava il contrario.
Sangue di vittime e carnefici
ingrassa
terra smossa
ad arte semina ombre
divora solo qualche nome
lungo i muri
ombre scivolano snelle
timide
ombre nella fuga disfate
al corpo negato tornate.
Nel chiuso anfratto
minuscolo tesoro di mano amica
profana quel poco
tramanda il sopruso.
Per nessuno
pregare.
41
Più o meno a quintali
stracci
piaghe ossa polvere d’odio
pasto infetto a
memoria di giustizia
orfana figlia male amata.
Impari conto e non c’è
nulla da vedere.
Del bello si va cercando
enigma disonore
e pentimento.
Morte lenta.
Dopo il diploma all’Accademia di Brera di Milano nel 1960, Fausta Squatriti tiene la sua prima personale alla Galleria del Disegno di Milano, e nel 1964 vince il Premio San Fedele, all’epoca il più prestigioso riconoscimento italiano per i giovani artisti, raramente assegnato a una donna. Nel 1968 il mercante d’arte svedese Pierre Lundholm, si interessa alla sua ricerca, e la espone nella sua galleria di Stoccolma, punto di partenza per la carriera internazionale dell’artista. Questa si sviluppa inizialmente fra gli Stati Uniti (Kozmopolitan Gallery, New York e Huston), Israele (Mabat Art Gallery, Tel Aviv), e il Sudamerica (due le personali a Caracas, nelle gallerie Estudio Actual e Artecontacto, e personali al Museo di Arte Contemporanea “Jesus Soto” di Ciudad Bolivar, e alla Jack Mizrachi Gallery di Città del Messico). Un altro incontro cruciale è quello con il gallerista Alexander Iolas, uno dei più importanti mercanti d’arte degli anni Settanta, che espone il lavoro di Squatriti nella sua galleria di Ginevra e la coinvolge anche in qualità di art director, facendole realizzare cataloghi, libri e manifesti per gli artisti che espone nelle sue gallerie di Parigi, New York, Milano, Ginevra, Roma, Madrid e Atene.
A Milano nel 1979 Squatriti tiene una personale alla Galleria del Naviglio, nel 1980, sempre a Milano presenta allo Studio Marconi le sculture di ferro nero, di grandi dimensioni, saranno apprezzate anche da Denise Renè, che nell’82 le espone in una personale a Parigi, e in alcune mostre di tendenza. Espone a Milano da Bianca Pilat nel 1995, alla Fondazione Mudima nel 2001, al Museum am Ostwald, a Dortmund, a cura di Ingo Bartsh, nel 2001, al Museum of Modern Art di Mosca, a cura di Evelina Schatz, nel 2009, da Assab One, Milano, nel 2012. Sue opere fanno parte di alcune collezioni pubbliche, tra cui il Centre Pompidou, Parigi, il Musèe d’Art Moderne de la Ville de Paris, le Gallerie d’Italia, Milano.
Nel 2017 ha esposto sotto il titolo “Se il mondo fosse quadro saprei dove andare…” presso la Triennale di Milano, Le gallerie d’Italia Piazza Scala e la Nuova Galleria Morone.
Esperta di editoria d’arte, grafica, e multipli, Squatriti ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Carrara, Venezia e Milano, ed è stata due volte visiting professor alla University at Manoa di Honolulu, U.S.A e all’Académie des Beaux-Arts di Mons. Ha tenuto conferenze sul proprio lavoro e su altri argomenti a Honolulu, Tel Aviv, Haifa e Parigi, oltre che in Italia.
All’attività come artista, editore e docente si aggiunge, a partire dal 1986, quella di saggista. In quell’anno è una dei tre curatori di ''Arte e scienza: colore'' alla Biennale di Venezia, con saggi pubblicati in catalogo. Numerose sono le raccolte di poesia pubblicate in Italia. Una antologia dei suoi testi poetici è tradotta in francese e pubblicata nel 2016 presso L’Harmattan, Parigi. Altri suoi testi sono stati tradotti e pubblicati in inglese e in ebraico. Ha pubblicato i romanzi, “Crampi”, 2006, Abramo editore, e “La Cana”, 2016, ed. Puntoacapo, e di recente ha pubblicato le sue poesie, “Vietato entrare “edizione La Vita felice, 2013 e “Olio Santo”, New Press Edizioni, 2017
Roberto Valentini, dalla raccolta inedita “La Passione”, nota di Laura Caccia
Trittico
“La Passione”, che Roberto Valentini mette in versi nella silloge omonima, si declina pensosa nel confronto tra il divino e l’umano sui temi del male e del dolore, dell’angoscia e della morte, della verità e del mistero.
Quasi fossero dipinte sulle tavole di un trittico, siamo di fronte alle immagini e alle voci, in dialogo tra loro, della narrazione biblica, del pensiero umano e della poetica personale dell’autore. Possiamo tentare di intravedere, su una tavola, la Via crucis che i testi evangelici, rigorosamente citati, declinano nella loro narrazione; su un’altra, i testi poetici in cui l’autore, nella prima parte della raccolta, “La Passione”, si pone a confronto con le questioni che essa pone per l’uomo; su un’altra ancora, i testi della seconda parte, “Altri versi”, dove emerge una poetica personale colma di fatica e smarrimento e insieme di spiragli di luce e di altrove.
Nel fluire dell’endecasillabo che spesso accompagna la riflessione dell’autore, si susseguono, all’interno della trama evangelica rivisitata in chiave poetica, le grandi domande sul senso dell’umano e del divino.
Lungo le stazioni del dolore, attraverso pennellate di meditazioni, si declinano, come leggiamo, i temi della paura, “l’angoscia che ti sa uomo”, dell’iniquità e del significato del male, “il male dell’uomo, / finché la sua polpa dia altra vendemmia”, del valore della sofferenza e del supplizio, “il naufragio che bisogna cercare / in sé stessi, per trovare l’approdo”.
In una tensione verso l’interrogarsi umano sul dubbio e sulla verità, quando, come scrive l’autore, “si sporge / il senno oramai sordo alla parvenza / del vero. Ma cos’è la verità?”, e insieme sull’orrore e sullo sgomento per il “brullo precipizio della morte”. Per concludersi infine nel segno del mistero divino e della speranza “Abiti in noi, / nello spazio che è degli Altri l’incontro”.
E in tutto questo la parola?
Il dire è una parola di veglia, “che altrove / cerca il responso”, una “cenere di voce nel gorgo / del tempo” e, come Roberto Valentini esplicita in “Altri versi”, ricerca mai sopita: “Così camminiamo in un bosco / di voci che ne intreccia la fatica / di ritrovare il discorso alla resina / sui larici”. Pennellando realtà e riflessioni a partire da una tavolozza di ombre e dissolvenze, faglie e cicatrici, fino al germogliare di possibili luci, forse “astri di un’altra radura”.
***
Giovanni. 18, 37-40
Pilato disse a Gesù: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante.
V Gesù è giudicato da Pilato
Alla balaustra del dubbio si sporge
il senno oramai sordo alla parvenza
del vero. Ma cos’è la verità?
Ciò s’insinua sull’orlo della voce
versandola nel cratere del cuore;
lì non giunge l’illustre potere,
l’udienza della parola che altrove
cerca il responso. Solo l’acqua esigua
della scelta già scorre sopra il marmo
del sentire che le mani non sfiorano.
***
Giovanni 19, 32-34
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
Marco 15, 42-43, 46
Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro.
XIV Gesù è deposto nel sepolcro
Mentre trafora una lancia il tuo fianco
ne sgorga l’acqua dal fondo divino,
si versa un sangue di rose alle mani
che supplici riaccolgono uomo e figlio
nelle spoglie del cielo. Poi rimbomba
il tuono di questo strazio infinito
sulle stigma dell’aria. In un lenzuolo
le ricopre il sudario della sera,
se anche la tua tomba come un enigma
rinserra – e lo può? – un macigno di morte.
Nato a Milano, Roberto Valentini dal 1999 lavora come insegnante nella scuola secondaria superiore e sopra(v)vive a Bernate Ticino, al confine occiduo della provincia milanese. Laureatosi in filosofia all’Università degli Studi di Milano, ha collaborato con la cattedra di Storia della filosofia contemporanea II quale redattore della rivista “Magazzino di filosofia” diretta dal Prof. A. Marini; attualmente, oltre a proseguire tale attività, è fra i curatori del relativo sito web di filosofia contemporanea (www.filosofiacontemporanea.it). Si è interessato in modo particolare della filosofia francese post-strutturalista, della Nietzsche-renaissance e del pensiero di autori quali Blanchot, Derrida, Deleuze, Bataille; in questi anni ha pubblicato, fra gli altri contributi (recensioni e florilegi), saggi sull’insegnamento della filosofia, sul cinema di Kubrick e Il gesto di Alcesti (“Magazzino di filosofia” n. 19/2012), una interpretazione letteraria di alcune tematiche della riflessione di Maurice Blanchot. Ha presentato un proprio lavoro nell’opera collettiva Vita, concettualizzazione, libertà (Mimesis, Milano, 2008).
Sue liriche inedite, articoli, escursioni di carattere saggistico-espressivo ed un racconto sono presenti sul sito web della rivista letteraria “Lunarionuovo”, diretta dallo scrittore e saggista Mario Grasso, e sulla rivista “L’EstroVerso”. Ha pubblicato il volume Dante a rovescio. Il XXXIV canto dell’Inferno capovolto (selfpublishing, Tricase, 2012), le raccolte poetiche Il peso dell’ombra (Prova d’Autore, Catania, 2013), Fra terra e luce. Antipodi dell’uomo (selfpublishing, Tricase, 2014) e Il male degli occhi (Puntoacapo Editrice, Pasturana 2014). Per i tipi di Puntoacapo Editrice è in corso di stampa la raccolta Il beneficio delle brume. Sue liriche sono presenti nelle antologie Enciclopedia di Poesia contemporanea (Fondazione Mario Luzi Editore, 2015), Atti della XVII Biennale di Poesia di Alessandria (a c. di Aldino Leoni e Mauro Ferrari, Puntoacapo Editrice, Pasturana 2015) e sul numero XXVIII di “Carte nel Vento”, periodico on-line del Premio “Lorenzo Montano”. Per una collana della rivista “Magazzino di filosofia” è in corso di stampa il volume monografico La pietra, il dono e lo specchio. Sisifo, Alcesti, Narciso: tre gesti per esautorare la morte.
Ha ricevuto riconoscimenti al Premio “Lorenzo Montano” (2013, 2015), al Premio Internazionale “Cinque Terre” e la Menzione d’onore per l’opera Il male degli occhi al Premio Casentino 2015. Scontando come tutti la “nera foga della vita” di sabiana memoria, continua a coltivare l’impaziente passione delle lettere, preservando epistole, esercizi di stile, prose rapsodiche e innocenti endecasillabi – né pretenziosi né insinceri – dalla (nella) loro lieve agonia dentro uno stipo.
Rossella Cerniglia, una prosa inedita, “Vicissitudini di Giovanni Drogo”, nota di Davide Campi
“…la vicenda di Giovanni Drogo e degli altri, ufficiali e soldati, che presidiano la fortezza Bastiani, non è che una metafora della vita nei suoi termini più universali e drammatici.”
In questa non banale constatazione iniziale risiede il nucleo dell’analisi che questo breve saggio compie del romanzo “Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati.
In particolare in esso, pure accennando puntualmente alla semplice trama generale del racconto, viene dedicata particolare attenzione alla parabola esistenziale del protagonista, dalla necessità imperativa delle sue scelte iniziali alla drammatica simbologia del finale.
Rossella Cerniglia, con la sua analisi, rende conto lucidamente dell’evoluzione di Giovanni Drogo, della progressiva incomunicabilità e impossibilità di condivisione delle sue scelte etiche nonché della sua crescente inconciliabilità con i valori normali e comuni, all’interno dei quali era peraltro nato e cresciuto; infine, del suo progressivo processo di allontanamento dalla normalità sociale, simbolicamente rappresentato dall’atteggiamento dello stesso Drogo verso la città durante le licenze.
Ne emergono tutti gli squilibri, le instabilità e le microfratture di questa lenta epopea esistenziale, fino all’evidente sproporzione fra il peso della scelta iniziale del protagonista e l’esito ultimo finale della storia.
Vicissitudini di Giovanni Drogo: l’attesa del sogno nella realtà
Così, in questa stasi del tempo, a un certo punto, Drogo sentirà gli anni pesare su di sé, quasi all’improvviso. E nel racconto è come se il tempo - prima fermo, stagnante - si fosse messo in moto, scorrendo più velocemente, depositandosi sulle cose con ritmo crescente: improvviso segnale che la giovinezza è finita.
Ed è così che sotto il peso degli anni che, quasi a sua insaputa, si sono accumulati sul corpo e sullo spirito del protagonista, nel cadere delle speranze e delle illusioni, il tempo riaffiora e riprende il suo corso, divenendo divoratore inesorabile: infatti, solo all’interno di una vita vissuta come necessaria ricerca di senso e di valore, espressa attraverso l’ineffabile luogo che è la Fortezza, il tempo ha una connotazione tutta interiore. Fuori, il tempo reale, quello che fluisce nella “dimensione cittadina” -da cui Drogo si allontana per scegliere la Fortezza- è invece sotterraneo, inesplorato ed incessante mutamento. La dimensione della Città e quella della Fortezza rappresentano, infatti, due modi possibili di vivere, anzi di affrontare la vita, ne sono i simboli: dissipato e superficiale l’uno; interiorizzato e profondo l’altro. Non per nulla, nel suo breve ritorno in città per una licenza, Drogo ne coglie ormai la distanza definitiva, irrecuperabile dal suo sé. Avverte la strana improvvisa lontananza da tutto, che lo avviluppa con un senso quasi fisico di malessere; ogni cosa gli appare perduta per sempre, inspiegabilmente estranea, persino la vecchia casa, la sua stessa stanza, la madre, la sua quasi-fidanzata. Tutto, allora, i mobili, gli oggetti che gli erano familiari, le voci e i gesti delle persone care, quanto era stato per lui assai intimo, gli diventa,
a un tratto, remoto ed estraneo; ed egli, dolorosamente, prende coscienza di tale estraneità come pure del fatto che egli stesso è divenuto distante ed estraneo agli altri.
Ed è proprio questo senso di estraneità e lontananza dalla vita degli altri, dalla vita comune, che gli fa compiere quella scelta radicale - e di per sé eroica – che è la vita nella Fortezza, col suo farsi giornaliero non meno disadorno e incolore di quello da cui prende le distanze, anzi ancor più marcatamente monotono e vuoto, ma più consapevole della solitudine e del mistero di esistere, e col miraggio lontano di una irraggiungibile pienezza e felicità.
Tuttavia, il sogno, per Giovanni Drogo non giunge, o giunge troppo tardi, a dire che la sua vita si consuma priva di senso, anche e proprio per colui che tanto lo aveva desiderato, tanto invocato, e la morte è lo straziante epilogo di tanta attesa.
Giovanni Drogo, che per Buzzati è il paradigma non solo di se stesso, non solo dell’intellettuale che si misura con la realtà insormontabile del destino, ma dell’uomo intero che vive entro una realtà inesplicabile, Giovanni Drogo morirà solo, reietto e oscuro, lontano dalla dimensione ideale che tanto aveva invocato. I Tartari, infine, muoveranno guerra, ma solo quando egli, debole e malato, non potrà più prendervi parte. E questo – sembra voler dire lo scrittore – è il destino dell’uomo quando si misura con cose che sopravanzano i suoi angusti confini, la finitudine dell’esistenza stessa: il “senso” di essa rimarrà imperscrutabile, trascendente, e all’uomo sarà consentito solo un sofferto e dignitoso accettare, nel momento estremo, l’inevitabile struggente sconfitta: il limite insopprimibile, connaturato alla nostra esperienza terrena.
Rossella Cerniglia è nata a Palermo, dove vive. Laureata in Filosofia è stata a lungo docente di materia letterarie nei Licei della stessa città. La sua attività letteraria ha inizio con la pubblicazione di Allusioni del Tempo (con presentazione di Pietro Mazzamuto), ed. ASLA – Palermo 1980; seguono Io sono il Negativo (con prefazione di Nicola Caputo), ed. Circolo Pitrè – Palermo 1983; Ypokeimenon (con introduzione di Elio Giunta), ed. La Centona – Palermo 1991; Oscuro viaggio, ed. Forum/Quinta Generazione – Forlì 1992; Fragmenta (con introduzione di Giulio Palumbo), Edizioni del Leone – Venezia 1994; Sehnsucht (con prefazione di Maria Grazia Lenisa), ed. Bastogi – Foggia 1995; Il Canto della Notte (con nota critica di Ferruccio Ulivi), ed. Bastogi – Foggia 1997; D’Amore e morte, stampato a Palermo nell’anno 2000; L’inarrivabile meta (con prefazione di Elio Giunta), ed. Ila Palma – Palermo 2002; Tra luce ed ombra il canto si dispiega (antologia e studio critico comprendente anche i testi di altri quattro autori palermitani, a cura da Ester Monachino), ed. Ila Palma – Palermo 2002; Mentre cadeva il giorno (con introduzione di Giorgio Barberi Squarotti), ed. Piero Manni – Lecce 2003; Aporia (con prefazione di Salvo Zarcone), ed. Piero Manni – Lecce 2006; Penelope e altre poesie (con prefazione di Pietro Civitareale), ed. Campanotto – Pasian di Prato 2009. In ultimo, nel giugno del 2013, per l’Editore Guido Miano di Milano, ha pubblicato un’Antologia che propone un breve saggio delle prime dodici sillogi poetiche, con disamina di Enzo Concardi. Altre opere sono in attesa di pubblicazione.
Nel 1999 ha, altresì, pubblicato il romanzo Edonè...edonè. Nel 2007, ancora per l’editore Piero Manni di Lecce, viene stampato il suo secondo romanzo dal titolo Adolescenza infinita e infine, per l’Editore Aletti di Villalba di Guidonia, il libro di racconti Il tessuto dell’anima.
Collabora ad alcune riviste, ha ricevuto favorevoli riconoscimenti e attestazioni da parte di numerosi critici e letterati ed è stata premiata in diversi concorsi letterari. Suoi versi e profili critici sono presenti in antologie e riviste letterarie, tra cui L’Altro Novecento (vol. II e III) a cura di Vittoriano Esposito edito da Bastogi, 1997; nella rivista Poesia dell’editore Crocetti di Milano; in Poeti scelti per il terzo millennio (2008),in Storia della Letteratura italiana (vol. IV, (2009) e in Poeti italiani scelti di livello europeo ( 2012), dell’Editore Guido Miano di Milano; più recentemente in Il rumore delle parole ed. Edilet, 2014, e in Come è finita la guerra di Troia non so, ed. Progetto Cultura, Roma, a cura, entrambi, di G. Linguaglossa, e più volte sulla rivista telematica L'Ombra delle parole, diretta dallo stesso G. Linguaglossa.
Stelvio Di Spigno, da “Fermata del tempo”, Marcos Y Marcos, 2015, nota di Flavio Ermini
Stelvio Di Spigno ha conseguito la laurea in Lettere e il dottorato in letteratura italiana. Vive a Gaeta e insegna ad Anzio. È poeta. Il suo ultimo libro ha per titolo Fermata del tempo ed è edito da Marcos y Marcos (2015).
Questa opera ci parla, come lucidamente certifica Umberto Fiori nella prefazione, “di un passaggio dall’adolescenza all’età matura, di una iniziazione al vero”. Tale passaggio viene registrato cercando di azzerare il flusso del tempo, imponendo al tempo una “fermata”, affidandosi all’ora per eccellenza: quella in cui ha luogo il ritorno al passato.
L’ora in cui la vita compie una svolta ha i suoi segni: i segni del tempo nei quali si ha a che fare con l’oscuro fondamento dell’essere. Ma, attenzione, quell’oscuro non significa tenebra, ma ombra che appartiene alla luce e che con la luce forma il mistero della vita.
La gentilezza e la mitezza, il sorriso e le lacrime sono forme di vita che ci aiutano a riconoscere e a rispettare le attese dei nostri compagni di viaggio, i loro desideri, le loro speranze, le loro angosce. Non c’è colloquio, non c’è dialogo, assicura Di Spigno, se non è accompagnato dalla ricerca e dal rispetto delle reciproche attese.
Confrontarci con il tempo, cercare addirittura di fermarlo significa confrontarsi con l’esperienza dell’ignoto che incessantemente emerge dalle nostre relazioni con le ombre enigmatiche e fragili che si intrecciano con le nostre esistenze.
Da “Le radici sepolte”
Largo e intento
il lago dove siamo stati congedati
dal sogno di una maniera di pace
fatto per uomini con gli occhi addolorati,
le acque che avremmo voluto dentro casa
nel tranquillo fluire del traffico cancellato dal mondo,
la completa fissità, l’essere corporalmente raggiunto,
vivere con gli amati e gli antenati, insieme nel puro silenzio,
per sempre nello stesso giorno
magari d’infanzia o adolescenza,
perché molto è il desiderio
di un paradiso abbarbicato al tutto
uniti con la faccia solo in questa terra,
senza dovere niente alla fatica e al lutto,
al mancare interno e al rischio dell’eterno.
Stelvio Di Spigno vive a Napoli dove è nato nel 1975. È laureato e addottorato in Letteratura Italiana presso l’Università “l’Orientale” di Napoli. Ha scritto la monografia Le “Memorie della mia vita” di Giacomo Leopardi – Analisi psicologica cognitivo-comportamentale (L’Orientale Editrice, Napoli 2007). Ha collaborato all’annuario critico “I Limoni” con recensioni e note sotto la guida di Giuliano Manacorda. Per la poesia, ha pubblicato la silloge Il mattino della scelta in Poesia contemporanea. Settimo quaderno italiano, a cura di Franco Buffoni (Marcos y Marcos, Milano 2001), i volumi di versi Mattinale (Sometti, Mantova 2002, Premio Andes; 2a ed. accresciuta, Caramanica, Marina di Minturno 2006), Formazione del bianco, (Manni, Lecce 2007, finalista Premio Sandro Penna), La nudità (Pequod, Ancona 2010), Qualcosa di inabitato, con Carla Saracino (EDB, Milano 2013). Il suo ultimo libro, Fermata del tempo, (Marcos Y Marcos, Milano 2015) ha ottenuto il Premio Nazionale di Calabria e Basilicata.
Lino Grimaldi, dalla raccolta inedita “Filosofia e poetica”, nota di Laura Caccia
Le direzioni dello spirito
Non è una riflessione ragionata, come potrebbe apparire dal titolo, la silloge di Lino Grimaldi ”Filosofia e poetica”, né l’espressione in versi del rapporto tra il pensiero e la parola.
Piuttosto si tratta di un flusso di scrittura, una prosa poetica senza scansioni di ritmo e di punteggiatura, affidata al ritmo interiore, al “vero spirito sognante”, in cerca di una direzione, di un verso, propriamente di una vertigine.
Tra le direzioni nord-sud, nei grovigli del mondo, “poi cos’è questo / Mondo un groviglio di vie disperse”, come scrive l’autore, è nella centralità il luogo in cui poter trovare orientamento, “Al centro da dove diparte ogni moto d’universo”, e dove è possibile un punto di contatto sorgivo tra la parola e il pensiero: “Dal quadrivio vincolato al sapere di poesia e filosofia sorge l’alba rifratta dello / Spirito eccelso”.
Nell’intersecare narrazioni del mondo, proiezioni di altrove, inserimenti di citazioni religiose, letterarie, mitologiche, storiche e filosofiche, nell’accumularsi di visioni del reale e del sogno, Lino Grimaldi affronta i temi del mistero, dell’infinito, della conoscenza, dell’essere e del divenire.
Evidenziando un ostacolo, che incontra più volte, un limite diversamente declinato: “il limite della mente umana” di fronte al mistero dell’infinito e insieme il “Limite invalicabile dell’umano mistero”. Occorre allora un altro verso, un’altra direzione: dai percorsi lineari ad
un movimento che si verticalizzi, nella tensione verso l’alto, come scrive l’autore, “Si ergono pareti verticali nello spaccato del cuore del mondo si verticalizzano / Orizzonti” e ancora: “In saliscendi che ripetono le cantilene spoglie / Messe a nudo dalle crepe aperte sul divino”.
E la poesia e la filosofia?
Con una scrittura appassionata e dolente, variopinta, disillusa, sognante, che in alcuni tratti ci porta al dire di Maria Zambrano, anch’essa già occupatasi di filosofia e poesia nel libro omonimo, Lino Grimaldi porta il pensiero e la parola nei suoi incroci e nelle sue verticalizzazioni: dove un tempo trovava spazio il “pensiero del poeta ritrattore anche del / Principio filosofico” e ora “l’incerto filosofico / ridiventa spirito poetico”. E dove l’assoluto “si è riprodotto fuori e qui / Ancora moltiplicato per dolci colline”.
Filosofia e poetica
Diramazione sud
Diramazione nord
Mi pongo al centro come per ogni dove si spartisce un vero spirito sognante
lascia ai bordi stretti d’incompreso scorie sciatte di lungo pensare stare
penzolante senza cadere da una parte all’altra mi pongo al centro senza sbandare
anche quando ti cerco affannata ti cado al fianco così divori la mia
arrendevolezza se il cartello del destino indica l’alba gira a sud oppure
diramazione nord sempre equilibrato al centro del mondo anche e sempre
quando si fa una scelta tocco l’incrocio di meridiani e paralleli accorto per non
restare nelle paludi del dubbio fuori dalla catastrofe del mondo poi cos’è questo
mondo un groviglio di vie disperse sulla pelle di piane e monti e anche i grandi
mari che si incrociano e i grandi fiumi che si scaricano tutto prende
diramazione sud
Lino Grimaldi è nato nel 1935 a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia.
Vive a Cava dei Tirreni. L’ultimo suo libro è “Miscellanea” (seconda parte) pubblicato da Unigester nel 2018.
Dario Benzi, da “I frammenti, la musica”, Cierre Grafica, 2016, nota di Flavio Ermini
Dario Benzi, poeta, è stato più volte segnalato al Premio Montano.
In questa edizione il riconoscimento gli è stato conferito per la raccolta I frammenti, la musica edito da Cierre Grafica nel 2016.
Sono tre i movimenti attraverso i quali si articola in questo libro il cammino poetico di Dario Benzi.
Il primo movimento prevede un confronto tra la pienezza della physis e la finitezza dell’esserci. Il secondo movimento impone un dialogo tra due finitezze: l’io e il tu. Il terzo movimento sperimenta un incontro corale: un convegno tra le molteplicità dell’apparenza.
Ogni movimento ci parla di un accordo che tutti gli altri esclude. Ci parla di un esilio. Ogni volta che apriamo gli occhi e scopriamo che niente è più come prima. Scopriamo che qualcosa è apparso finché le nostre palpebre erano abbassate. Apprendiamo che vi è del rivelabile ogni volta che apriamo gli occhi, ogni volta che lo sguardo, incontrando un altro sguardo, viene “ricambiato”.
Lo sguardo compie la sua opera diurna e notturna semplicemente facendosi largo tra le palpebre o nascondendosi dietro di esse. È persino pensabile, a questo punto, l’irruzione di un miracolo. E il miracolo è nel canto silenzioso che non ha più bisogno di parole; in quel suono primordiale dalla cui inudita vibrazione sorge invisibile l’armonia del tutto: danza e moto cosmico.
***
Tempo di tracce e di segni
apparenti scomparenti pulviscolari
vetrine di cose di parole
vendute discaricate
rallentano strade dendriti
inquinate le falde dell’acqua del pensiero.
Dario Benzi è nato a Crema il 12/10/1950, medico ormai in pensione.
Nel 1990 ho pubblicato la raccolta di poesia “Il Gioco infinito” presso l’Editore Lalli, su proposta del Premio Letterario Editoriale “L’Autore” di “Firenze Libri”
Alcune poesie sono state pubblicate sulla rivista Cremona Produce, e inserite nel volume annuale “Si scrive” 2001, edito dalla Provincia di Cremona in collaborazione con gli scrittori del P.E.N. International, e alcune poesie sono state scelte per l’Antologia PO… ETARE 2004 di Cremona Produce.
Nel 2005 ho conseguito il 2° premio nella X Edizione del Premio Nazionale di Poesia Abbadia Cistercense del Cerreto
sempre nel 2005 una mia raccolta poetica inedita è stata menzionata nell’ambito della XIX Edizione del Premio Lorenzo Montano
nel 2006 ho ricevuto il “2° Premio ex aequo” al Premio Nazionale di Poesia Monte Netto di Capriano al Colle
nel 2004 sono stato inserito nell’antologia poetica “Rane.Un dito nell’acqua”, e nel 2007 nell’antologia “L’uomo il pesce e l’elefante”, entrambe appartenenti alla collana I quaderni di Correnti di Crema
nel 2007, una mia poesia inedita dal titolo “Il Vento” ha ricevuto una menzione d’onore nell’ambito della XXI edizione del Premio Lorenzo Montano, e sono stato invitato a partecipare alla Biennale di Poesia di Anterem
nel 2008, la raccolta inedita “Il rosso il nero/ il desiderio il vento” ha ricevuto una menzione d’onore nell’ambito della XXII Edizione del vostro premio,e sono stato di nuovo invitato a partecipare alla Biennale di Anterem
nel 2009, la poesia inedita “E qui” ha ricevuto la terza menzione d’onore nella XXIII Edizione del vostro premio, e sono stato di nuovo invitato con mia grande soddisfazione alla Biennale di Anterem
nel 2009 ho pubblicato la raccolta poetica “Il desiderio, il vento”, a cura di Flavio Ermini e con l’introduzione di Giò Ferri, nella la collana Via Erakleia, presso Cierre Grafica Verona
e nel settembre 2016 ho pubblicato “I frammenti, la musica ovvero Lo sguardo ricambiato” con la prefazione di Franco Gallo e la postfazione di Flavio Ermini, sempre nella collana Via Erakleia, presso Anterem Edizioni.
Giusepppina Rando, una poesia inedita, “luce altra”, nota di Ranieri Teti
Un transito di ore, a partire da un’alba, si rappresenta nel testo "luce altra" di Giuseppina Rando.
Una poesia scarnificata nella sua essenza lirica, che sembra essere nata per sottrazione.
Una poesia che da un lato concede la lettura e nell’altro si fa petrosa, senza concessioni.
Nella parte in luce si concentra la descrizione del momento.
Nella parte in ombra, dopo l’attraversamento degli istanti più fulgidi, appare progressivamente un dolore sempre più forte.
I passaggi del tempo sono evidenziati dalla meridiana del sentire. Permettono di andare dal “rifulgere ogni istante” agli “anfratti dell’io”, consentono di passare, nel breve volgere di alcuni versi, da “un aperto orizzonte” a “piaghe senza sangue”.
Per quanto il giorno possa essere meraviglioso, il poeta sa quanto ne sia effimero lo splendore.
luce altra
sillaba dell’anima
d’antica alba
rifulgere ogni istante
di stelle
negli anfratti dell’io
nel silenzio dell’incognita terra
tra le cose
e accogliere
nell’aperto orizzonte della meraviglia
il principio
ricevono
piaghe senza sangue
fogliame di bosco
su corpi dolenti
ombre
dilaniate dal nulla
Giuseppina Rando poetessa, scrittrice e saggista , è presente in numerosi volumi di poesia, antologie e saggi. Collabora con diverse riviste.
Ha pubblicato testi di Poesia tra i quali :
Spuma di mare. Poesie (1970-1981),
Statue di gesso. (1982-1995),
Duplice veste ( 2001),
Immane tu ( 2002 )
Figura e parola (2005), -Cierre Grafica Verona –
Vibrazioni (2007) Noubs Chieti
Bioccoli ( 2008) Anterem Edizioni, Verona;
Geometria della Rosa, Aletti editore, 2017
Saggi : Profili di donne nel Vangelo (2001) Bastogi, Foggia,
Chiara. Una voce dal silenzio (2002).Edizioni San Paolo , Cinisello Balsamo,Milano .
Le belle parole ( 2013 ) Scrittura Creativa Edizioni, Borgomanero ( Novara ).
Nel Segno ,Racconti, (2011) Pungitopo, Patti Marina (Messina) ha ricevuto il Premio di narrativa - Sesta edizione - Joyce Lussu, Offida (Ascoli Piceno)
Claudia Pozzana, da “Elisioni”, Damocle Editore, 2014, nota di Flavio Ermini
Claudia Pozzana è docente di lingua e letteratura cinese all’Università di Bologna. Ha tradotto i principali poeti cinesi contemporanei. Lei stessa poetessa, ha pubblicato con Damocle nel 2014 un libro di poesie scelte: Elisioni.
Da questo volume emerge con chiarezza l’idea di poetica di Pozzana, idea che così l’autrice sintetizza: “La poesia è nel vuoto delle parole, negli interstizi, là dove il verso sembra incagliarsi, dove la lingua inciampa”.
In quel “dove” c’è l’alterità. Ci sono la complessità e la profondità che l’essere umano fa sempre più fatica a reggere. Il calcolo e l’interesse ordiscono il nostro mondo e noi diventiamo dimentichi di noi stessi per non disperare.
Terrorizzato dalla morte, l’essere umano impiega ogni forza per occultarla. Ed è così che il mistero del dolore resta velato. È così che disimpariamo ad amare.
Pozzana ci chiede di non sottrarci all’enigmatico. Ci chiede di non vedere il mondo come terra di conquista e di conflitto, ma come terra da amare e da accogliere. Qui, amore e morte invitano a una danza armonica, che si configura come sperimentazione d’identità. Sottratto a questa danza, ci avverte Pozzana, il mortale è consegnato all’immobilità.
Elisioni ci guida su una terra pericolosa, vero e proprio banco di prova per gli umani, luogo di avventura; uno spazio in cui si cerca ciò che è stato represso e censurato dalla modernità e dalle macchine.
Ancora
Ancora dei versi?
Di versi àncora
l'ancora diversa
idea di tante lei
riversa convessa
disposta ancora
Quartetti
Su cui scrivere
una storia secolare
immanente al reale
un’astrazione
indicibile, arroccata
su corde e note
glissata e vibrata
allegra e pizzicata
che riesce a scuotere
l’apatia del giorno,
riapre un possibile
di invenzioni
incrostando di verde muschio
i raggi radenti
Claudia Pozzana ha pubblicato le raccolte di poesia Segmenti singolari (Poedit, 1995), e il trittico Scelte, Poetra e La curva del mare (Poedit, 2006). È docente di lingua e letteratura cinese all’Università di Bolo- gna. Ha insegnato negli Usa e in Cina. Ha tradotto e presentato in italiano i principali poeti cinesi degli ultimi decenni (La poesia pensante. Inchieste sulla poesia cinese contemporanea, Quodlibet, 2010); ha curato la raccolta del poeta Bei Dao, Speranza fredda (Einaudi, 2003), e quella di Yang Lian, Dove si ferma il mare (Scheiwiller, 2004). Ha inoltre pubblicato in colla- borazione con Alessandro Russo varie antologie di poesia cinese, tra cui alcuni numeri speciali della rivista “In forma di parole” (Poeti cinesi contemporanei, 1988; Un’altra Cina, 1999), e il volume Nuovi Poeti Cinesi (Einaudi, 1996).
Danilo Di Matteo, una prosa inedita, “Lucio Magri e i soggetti sociali”, nota di Davide Campi
In questo breve saggio Danilo Di Matteo ci ricorda innanzitutto la misura del pensiero di Lucio Magri, parlamentare, “comunista eretico”, co-fondatore del PdUP e del Manifesto, teorico della politica nella sua accezione più nobile di servizio alla collettività.
Particolare importanza nel pensiero di Magri sono l’incontro e il confronto fra politica e istanze sociali.
In questo senso, sottolinea Di Matteo, è da vedere il rapporto privilegiato della sua formazione politica con le reti di partecipazione democratica (consigli di fabbrica, movimenti come medicina democratica etc.) che proliferavano negli anni ’70.
Nel mondo contemporaneo, rileva ancora Di Matteo, dopo la diluizione delle ideologie e i riflussi individualistici, l’individuazione di soggetti sociali che possano essere interlocutori credibili nel confronto democratico diventa sempre più problematico.
Ma, ovviamente, in assenza di veri soggetti sociali, identificati con chiarezza, le istituzioni e la politica non possono raccordarsi ai singoli, aumentando confusione e disagio.
Per questo, esorta Di Matteo, pure nelle difficoltà del periodo storico, è necessario ripensare corpi intermedi che, oltre a motivare l’azione politica, rappresentino anche il giusto collante e il necessario tramite.
Lucio Magri e i soggetti sociali
(incipit)
Vi sono dei nomi, dei volti, delle idee che appartengono al nostro background, pur maturando negli anni posizioni e convinzioni diverse. Ѐ il caso, per me e per altri, di Lucio Magri, fra i fondatori de il manifesto e segretario del Pdup. Fece discutere e soprattutto riflettere la sua scelta di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera. Ma non è su quello che mi soffermo ora. Ha destato di recente il mio interesse la pubblicazione in due volumi degli interventi parlamentari di questo comunista eretico. E scorgo nell’articolo di Luciana Castellina riguardante il Convegno alla Camera dei deputati dedicato a tali testi motivi e argomenti di grande interesse, veri e propri spunti per ulteriori considerazioni e domande.
Da un lato ella ricorda la capacità di una piccola formazione politica come il Pdup di rappresentare un punto di riferimento per la crescita di reti di partecipazione democratica “che ebbero – negli anni ’70 – una particolare fioritura”: dai Consigli di fabbrica a quelli di zona, da movimenti come Medicina democratica a Psichiatria democratica. Dall’altro evoca l’esperienza della nuova Rivista de il manifesto, rinata proprio sotto la direzione di Magri nel 1999. Un’esperienza conclusa sempre per sua scelta nel 2004 per mancanza – ecco la motivazione – di referenti sociali. Detto altrimenti: a lui sembrava troppo angusta e a suo modo macchiata di ignavia la prospettiva della semplice testimonianza. E qui si ripropone il tema della tensione fra il ruolo dell’osservatore e quello del partecipante, della capacità di coniugarli.
Danilo Di Matteo, nato a Lanciano (CH) il 22 marzo 1971, vive a Chieti e lavora come psichiatra e psicoterapeuta.
Collabora con il mensile mondoperaio, con il settimanale Riforma, con diversi siti web, scrivendo note e commenti di psicopatologia, politica, filosofia, teologia e recensioni di libri e riviste. Ha intervistato diversi personaggi pubblici.
È laureando alla triennale di Filosofia presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
Guido Garufi, da “Fratelli”, Nino Aragno Editore, 2016, nota di Flavio Ermini
Guido Garufi è poeta e critico letterario. Ha fondato e diretto con Remo Pagnanelli la rivista “Verso”.
Le numerose raccolte di poesia che ha pubblicato sono tra loro connesse da quello che Mario Luzi ha definito “paziente lavoro unitario”. Fratelli è la sua raccolta più recente e di quel “paziente lavoro” è il vertice.
In Fratelli viene rappresentata dolorosamente una condizione umana ferita dall’esilio. E dalla solitudine che all’esilio si accompagna.
Come non capirlo? L’essere umano è prigioniero. È prigioniero di una terra arida e desertica. Qui pare smarrirsi ogni speranza. Eppure, ci dice Garufi, è proprio questo smarrimento che lascia intuire la vera dimensione della vita.
È proprio la sofferenza che fa riemergere la situazione emotiva della nostra origine, dove – sostiene Garufi – ancora vivono le ragioni del cuore, quelle ragioni che sanno cogliere il tema del dolore e nominarlo.
La spiaggia
(ai miei fratelli)
Penso a te, liberato nell’aria, sciolto e rarefatto
tra le nuvole del cielo e penso
ancora a quanto sia lieve per te, risorto,
il respiro e quanto ancora duri quaggiù l’affanno…
Se fosse così che dall’alto alitasse la vertigine
che dentro senti tu dolce amico o voce che esplori
la campagna e a volte siedi invisibile al mio fianco
quasi un tocco o un piccolo fiato che avverto
tra amicizia filiale e coro degli esclusi
mai assenti perché sempre qui ancora convocati
tra versi e non detti eppure forti, irrevocabili
e dolci presenze, nonostante il dolore
nonostante l’apparente lontananza.
Voci e lingue inquiete dell’infanzia
di questa strana maturità
sigillo tra profezia e amore.

Ultima pagina, Collage serie MAGARI (sfondo di Emilio Vedova) e biografia di Nicoletta Bidoia
Collage serie MAGARI, 2013 (sfondo di Emilio Vedova)

Sono nata a Treviso nel 1968 e ho pubblicato i libri di poesia Alla fontana che dà albe, quasi una preghiera ad Alda Merini (2002), Verso il tuo nome (2005, con prefazione di Alda Merini), L’obbedienza (2008, con prefazione di Isabella Panfido) editi da Lietocolle, e Come i coralli (2014) con Edizioni La Vita Felice.
Nel 2013 è uscito per Edizioni La Gru il racconto Vivi. Ultime notizie di Luciano D.
Mie poesie, apparse anche in raccolte e riviste e più volte trasmesse a Rai Radio3, sono state tradotte in spagnolo in Jardines secretos, Joven Poesìa Italiana, a cura di E. Coco (Sial, Madrid, 2008).
Con la cantautrice Laura Mars Rebuttini ho realizzato lo spettacolo Un piccolo miracolo, partecipando ad alcuni festival italiani di poesia.
Compongo anche collages e teatrini di carta (reperibili in rete su youtube o instagram).
Nota di Ida Travi su “Come i coralli” pubblicata su il manifesto del 19.6.2014
http://media.poesia.lavitafelice.it/news/allegati/manifesto_bidoia.pdf
https://ilmanifesto.it/parole-come-silhouettes/
Nota di Alberto Cellotto su “Come i coralli” pubblicata sul blog librobreve del 12.5.2014
https://librobreve.blogspot.it/2014/05/come-i-coralli-di-nicoletta-bidoi...
Nota di Marco Scarpa su “Come i coralli”
http://poesia.lavitafelice.it/news-recensioni-marco-scarpa-per-nicoletta...
Intervista a Felice Cimatti - Fahrenheit Rai Radio3 per la rubrica “Il libro del giorno’ del 27.12.2013 “Vivi. Ultime notizie di Luciano D.”
https://www.youtube.com/watch?v=VRmHioX-Taw
Finalista all’edizione 2018 del Premio Lorenzo Montano con la raccolta inedita “Finiremo per trovarci”.
Giugno 2018, anno XV, numero 40

La giuria del Premio Lorenzo Montano, composta da Giorgio Bonacini - Laura Caccia - Davide Campi - Mara Cini - Flavio Ermini - Marco Furia - Rosa Pierno - Ranieri Teti, è lieta di presentare i risultati della 32^ edizione.
Le premiazioni di segnalati, finalisti e vincitori si terranno a Verona sabato 20 ottobre 2018, sabato 27 ottobre 2018 e sabato 16 marzo 2019, nell’ambito del “Forum Anterem 2018/19”.
Opere vincitrici del XXXII Premio Lorenzo Montano

La giuria, composta da Giorgio Bonacini - Laura Caccia - Davide Campi - Mara Cini - Flavio Ermini - Marco Furia - Rosa Pierno - Ranieri Teti, ultimati i lavori, esprime un profondo ringraziamento a tutti i concorrenti. Grande è stata la qualità delle opere proposte.
Le premiazioni di segnalati, finalisti e vincitori si terranno a Verona sabato 20 ottobre 2018, sabato 27 ottobre 2018 e sabato 16 marzo 2019, nell’ambito del “Forum Anterem 2018/19”.
Opera edita
Finalisti
Dino Azzalin, Il pensiero della semina, Crocetti;
Maria Grazia Calandrone, Il bene morale, Crocetti;
Alessandra Carloni Carnaroli, Ex – voto, Oèdipus;
Carmen Gallo, Appartamenti o stanze, D’if;
Mariangela Guatteri, Tecniche di liberazione, Benway Series;
Vincenzo Mascolo, Q. e l’allodola, Mursia;
Mario Novarini, Radiazione del rosso, Book;
Daniela Pericone, Distratte le mani, Coupd’idée;
Irene Santori, Hotel Dieu, Empirìa;
Italo Testa, Tutto accade ovunque, Nino Aragno;
Maria Luisa Vezzali, Tutto questo, Puntoacapo;
Nicola Vitale, Chilometri da casa, Mondadori
Opera edita vincitrice: Hotel Dieu, di Irene Santori, Empirìa
Raccolta inedita
Finalisti
Daniele Barbieri, Cuore amore dolore
Nicoletta Bidoia, Finiremo per trovarci
Fabrizio Bregoli, Logomachie
Lella De Marchi, Bianca
Patrizia Dughero, Sensibili all’oblio
Marica Larocchi, Polveri e piume
Romano Morelli, Un difficile partire
Umberto Morello, Nuvolas
Francesco Vasarri, Rerum creatarum pavanae
Raccolta inedita vincitrice: Nuvolas, di Umberto Morello
Una prosa inedita
Finalisti
Allì Caracciolo, Barbablu
Nicola Licciardello, Sempre
Adelio Fusé, La parola è l’immagine che si stacca dalle cose
Giuseppina Rando, Alla caduta
Patrizia Sardisco, Disdire
Ambra Simeone, Provare a salvarsi
Prosa inedita vincitrice: Disdire, di Patrizia Sardisco
Una poesia inedita
Finalisti
Davide Castiglione, Domanté
Silvia Comoglio, Lucore
Margherita Orsino, La traversata infinita
Massimo Rizza, Costellazioni ferite
Lia Rossi, Principio di rivoluzione
Poesia inedita vincitrice: Principio di rivoluzione, di Lia Rossi
Opera edita - esiti
32° Premio Lorenzo Montano
Esiti per “Opera edita”
Riconoscimento di merito
Henry Ariemma, Giuliano Ladolfi; Rosanna Cracco, Simple;
Marco Franco D’Astice, Prospettiva; Valeria Di Felice, Di Felice;
Sergio Gallo, LietoColle; Giuseppe Guidolin, Fusibilia;
Natino Lucente, Genesi; Enrico Macioci, Marco Saya;
Valentina Maìni, Arcipelago Itaca; Vincenzo Mastropirro, Terre Sommerse;
Brina Maurer, Italic; Michele Miccia, L’arcolaio;
Salvatore Pintore, Centro ricerche filosofiche letterarie;
Laura Tonelli, Helicon; Lucia Triolo, Controluna
Menzione d’onore
Con pubblicazione nel sito di “Anterem”
Roberto Ariagno, Italic; Daniele Beghè, Consulta;
Marco Boietti, Polistampa; Stefania Bortoli, Book;
Antonio Bux, Marco Saya; Mariagrazia Carraroli, ETS;
Simone Cattaneo Martini, LietoColle; Donato Di Poce, i Quaderni del Bardo;
Monica Guerra, Samuele; Giovanni Ibello, Terra d’ulivi;
Giulio Maffii, Arcipelago Itaca; Maurizio Manzo, Zona;
Marco Nuzzo, Youcanprint; Ilaria Palomba, Augh;
Max Ponte, Granchiofarfalla; Simonetta Redolfi, Campanotto;
Silvia Rosa, Giuliano Ladolfi; Francesco Russo, Terra d’ulivi;
Enza Silvestrini, Oèdipus; Giuseppe Talia, ProgettoCultura
Segnalazione
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Nadia Agustoni, La Camera Verde; Viola Amarelli, Sartoria Utopia;
Angelo Andreotti, Manni; Alessandro Assiri, LietoColle;
Vanni Bianconi, Casagrande; Simone Maria Bonin, Arcipelago Itaca;
Simone Burratti, Nuova Editrice Magenta; Roberto Capuzzo, Gli Ori/2RC;
Maria Benedetta Cerro, LietoColle; Morena Coppola, Formebrevi;
Annamaria De Pietro, Marco Saya; Maria Grazia Galatà, Marco Saya;
Leandro, Vigone Vecchia; Alberto Mori, Edizioni del Verri;
Clemente Napolitano, L’arcael’arco; Riccardo Olivieri, Passigli;
Mario Pezzella, Zona; Roberto Piperno, Progetto Cultura;
Marina Pizzi, Macabor; Filippo Ravizza, La Vita Felice;
Gianni Ruscio, Eretica; Liliana Ugolini, FlorenceArt;
Luca Vaglio, Marco Saya; Cesare Vergati, ExCogita
Finalisti
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Dino Azzalin, Crocetti; Maria Grazia Calandrone, Crocetti;
Alessandra Carloni Carnaroli, Oèdipus; Carmen Gallo, D’if;
Mariangela Guatteri, Benway Series; Vincenzo Mascolo, Mursia;
Mario Novarini, Book; Daniela Pericone, Coupd’idée;
Irene Santori, Empirìa; Italo Testa, Nino Aragno;
Maria Luisa Vezzali, Puntoacapo; Nicola Vitale, Mondadori
Opera edita vincitrice: Hotel Dieu, di Irene Santori, Empirìa
Le note di lettura saranno prodotte dalla redazione di “Anterem”
Raccolta inedita - esiti
32° Premio Lorenzo Montano
Esiti per “Raccolta inedita”
Riconoscimento di merito
Matteo Anghinolfi, Celestino Casalini, Claudio Cencetti,
Luigi La Vecchia, Alessandro Lanucara, Vanna Mazzei,
Ingrid Tere Powell, Paola Puzzo Sagrado, Roberto Romanato,
Giustina Selvelli, Pierantonio Tanzola,
Fabio Tirone, Claudio Veronesi, Valeria Zagami
Menzione d’onore
Con pubblicazione nel sito di “Anterem”
Stefano Allievi, Gabriella Becherelli, Angela Caccia,
Alessandra Chiavegatti, Alceo De Sanctis, Paolo Durando,
Giancarlo Fascendini, Francesco Fedele, Danilo Grossi,
Paola Novaria, Salvo Nugara, Sr Melisa Palumbo,
Fabio Poggi, Rosa Salvia, Giancarlo Stoccoro,
Eloisa Ticozzi, Massimo Viganò, Adalgisa Zanotto
Segnalazione
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Luca Bresciani, Martina Campi, Enrico De Lea,
Fernando Della Posta, Riccardo Deiana, Roberto Fassina,
Raffaele Floris, Gian Paolo Guerini, Vincenzo Lauria,
Domenico Lombardini, Raffaele Marone, Gabriella Montanari,
Stefania Portaccio, Andrea Rompianesi, Enea Roversi,
Fausta Squatriti, Carlo Tosetti, Claudio Zanini
Finalisti
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Daniele Barbieri, Nicoletta Bidoia, Fabrizio Bregoli,
Lella De Marchi, Patrizia Dughero, Marica Larocchi,
Romano Morelli, Umberto Morello, Francesco Vasarri
Raccolta inedita vincitrice: Nuvolas, di Umberto Morello
Le note di lettura saranno prodotte dalla redazione di “Anterem”
Una poesia inedita - esiti
Riconoscimento di merito
Riccardo Benzina, Melania Bortolotto, Alessia Bronico,
Emilio Capaccio, Alessandra Cerminara, Corrado Chierici,
Gabriele Civello, Stefano Colli, Edoardo Firpo,
Mimmo Gerratana, Lino Grimaldi, Giovanni Ingino,
Lorenzo Nicola Mazzoni, Alice Pareyson, Gabriella Rovagnati,
Daniel Skatar, Monica Silvestrini, Maria Zanolli
Menzione d’onore
Con pubblicazione nel sito di “Anterem”
Lea Barletti, Francesco Cagnetta, Anna Maria Carpi,
Alda Cicognani, Lino Giarrusso, Sonia Giovannetti,
Ugo Mauthe, Riccardo Martelli, Angelo Mocchetti,
Stefania Negro, Anna Maria Pes, Renzo Piccoli,
Evaristo Seghetta Andreoli, Claudio Maria Zattera
Segnalazione
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Doris Emilia Bragagnini, Giusi Busceti, Lia Cucconi,
Anna Maria Dall’Olio, Antonella Doria, Franco Falasca,
Fabia Ghenzovich, Stefano Iori, Marco Mioli,
Francesca Monnetti, Giovanni Parrini, Gabriele Pepe,
Ivan Pozzoni, Alessandro Ramberti, Alfredo Rienzi,
Giuseppe Schembari, Sergio Sichenze
Finalisti
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Davide Castiglione, Silvia Comoglio
Margherita Orsino, Massimo Rizza, Lia Rossi
Una poesia inedita vincitrice: Principio di rivoluzione, di Lia Rossi
Le note di lettura saranno prodotte dalla redazione di “Anterem”
Una prosa inedita - esiti
Riconoscimento di merito
Ester Cecere, Antonino Giordano, Barbara Serdakowski,
Carlo Tarabbia, Francesco Valente, Luca Vecellio
Menzione d’onore
Con pubblicazione nel sito di “Anterem”
Salvatore Bossa, Patrizia De Vita, Francesca Favaro,
Giuseppe Gorlani, Giorgio Mancinelli, Marika Orlando,
Irene Sabetta, Mariannina Sponzilli, Elide Maria Taviani
Segnalazione
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Rinaldo Caddeo, Paola Casulli, Rossella Cerniglia,
Gabriella Colletti, Paolo Ferrari, Ettore Fobo,
Iria Gorràn, Giulia Martini, Alessandro Mazzi
Finalisti
Con nota di lettura, pubblicazione in “Carte nel vento”, invito al Forum Anterem
Allì Caracciolo, Adelio Fusé, Nicola Licciardello,
Giuseppina Rando, Patrizia Sardisco, Ambra Simeone
Una prosa inedita vincitrice: Disdire, di Patrizia Sardisco
Le note di lettura saranno prodotte dalla redazione di “Anterem”
Aprile 2018, anno XV, numero 39

Tra lacerazioni e suture, tra abbrivi e destinazioni, un titolo, una frase, un verso, ci chiedono di pensare diversamente: alcune prospettive dinamiche, di notevole rilevanza, della poesia e della prosa contemporanee vengono presentate in questo nuovo numero di “Carte nel vento”, che accoglie opere segnalate e finaliste nell’edizione 2017 del Premio Lorenzo Montano.
Ancora una volta l’esperienza della parola è duplice: da un lato i testi, prosastici e poetici, dall’altro le note a commento prodotte dalla redazione di “Anterem”, che coincide con la giuria del premio.
Questo 39° numero di “Carte nel vento” si apre e si conclude con l’arte: grazie a Bianca Battilocchi con un reportage da Dublino e, in chiusura, documentando per immagini la mostra allestita dal Liceo Artistico “Nani-Boccioni” di Verona sul tema Figure dell’immaginazione, avvenimento finale del Forum Anterem 2017.
Continuerà anche nel 2018 la collaborazione del premio con Licei e Istituti superiori attraverso i temi della filosofia, dell’arte, della prosa e della poesia.
Entro il 20 aprile attendiamo le nuove opere al “Montano 2018” per proseguire, con le stesse modalità, un appassionato lavoro che dura da trentadue anni: scarica il bando della 32^ edizione
In copertina: scene dal Forum 2017 (immagini di Laura Liberale e Massimo Girelli)
Bianca Battilocchi, “Performative Arts Today” a Dublino: un evento all’insegna della bellezza interdisciplinare delle arti
Perfomative Arts Today è il titolo di un evento multidisciplinare tenutosi lo scorso 2 febbraio presso Trinity College Dublin, in una data che casualmente è venuta a coincidere con il genetliaco di un grande irlandese auto-esiliatosi in Italia, lo scrittore James Joyce. Promossa e organizzata dalla Dr. Giuliana Adamo e dalla dottoranda Bianca Battilocchi, con direzione artistica di Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi, la giornata ha ospitato studiosi e artisti provenienti da differenti campi di indagine, poesia e traduzione, pittura, scultura, land art, cinema, fotografia e teatro. Il sottotitolo Like the Grave of a Stone, Like the Cradle of a Star – come tomba di un sasso, come culla di una stella – suggerisce orficamente lo spirito eletto a protagonista di una ‘rete’ che si è voluta iniziare ad intessere tra gli ospiti e il pubblico per recuperare il senso del ‘fare artistico’. Una rete di connessioni che inserisce autori incisivi e produttivi soprattutto dalla seconda metà del secolo scorso, ma ancora troppo oscurati e poco frequentati dai maggiori canali della cultura italiana. Ci riferiamo innanzitutto a Emilio Villa, Alberto Burri, Carmelo Bene e Salvatore Sciarrino.
Giuseppe Sterparelli, con Variazioni: a Visual Polyphony, suo film sul connubio tra Villa e Burri, Gianluca Pulsoni e Maurizio Boldrini con una doppia lezione su Bene e Cosimo Colazzo, allievo di Sciarrino ed esecutore di pezzi tratti da Villa, hanno reso esplicito il potenziale ancora fertile che questi artisti ci offrono. Partendo da una rivalorizzazione di questi, ci siamo proposti di guardare al presente e al futuro. Antonio Presti, fondatore di Fiumara d’Arte, avviando la conversazione, ha incarnato perfettamente questo slancio che non si apre solo temporalmente al ‘domani’, ma è anche geografico, con messaggi universali che vogliono spaziare dall’Italia all’Irlanda e ovunque ci sia il desiderio di ritrovare l’energia del creare bellezza attraverso le arti; eredità che l’epoca contemporaneo-capitalistica sembra aver dimenticato, troppo spesso annebbiata dalla volgarità e superficialità imperanti, dalla crisi delle università, dei centri culturali (e del loro senso) e quindi da potenti barriere, recentemente rese più spesse da infelici revival nazionalisti. Il G37 della poesia, summit siciliano promosso dallo stesso, il 25 maggio 2017, è una traccia di questo necessario andare controcorrente, e ha riunito 37 poeti e scrittori di diverse nazionalità in nome di un futuro basato sulla politica della bellezza.
 Pieghevole con il programma della giornata
Pieghevole con il programma della giornata
a cura di Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi.
In sintonia con questa iniziativa, nell’arco della giornata abbiamo tentato di eliminare barriere linguistiche e disciplinari, e voluto mostrare inoltre come, tra Italia e Irlanda, ci siano dei vasi comunicanti ancora attivi, a partire dagli archetipi, come quello del labirinto, esplorato in profondità anche da Joyce. Per questa ragione è stato scelto, a copertina dell’evento, un poema visivo di Vincenzo Consalvi che raffigura il poeta Emilio Villa e, in filigrana, un suo appunto sul labirinto, leitmotiv, mitologema che lo appassionò quasi ossessivamente e che, in analogia, ritroviamo inciso in forma spiraleggiante sulle pietre millenarie di Newgrange, all’ingresso di Dublino.
Nell’insonnia di avere in sorte la luce, il film presentato da Cornelio e Rossi, indugia particolarmente su queste migrazioni di simboli e vuole delineare le corrispondenze tra artisti contemporanei italiani – tra cui Magdalo Mussio, Silvio Craia, Franco Ferrara, Mariano Prosperi e Stefano Scodanibbio (le cui partiture sono inserite nella colonna sonora del film) – e la mitologia irlandese, sviluppando le riflessioni dell’Atlante Mnemosyne di Aby Warbug. L’Atlante è stato infatti esposto in una mostra curata dagli stessi, ad integrazione visiva degli interventi che si sono succeduti, e ospitante opere originali di Corrado Costa, Silvio Craia, Mario Diacono, Franco Ferrara, Osvaldo Licini, Magdalo Mussio, Nuvolo, Remo Pagnanelli, Pinuccio Sciola, Stefano Scodanibbio, Aldo Tagliaferri, Emilio Villa, tra i nomi più noti; tra gli altri Andrea Balietti, Bianca Battilocchi, Giuditta Chiaraluce, Vincenzo Consalvi, Giorgiomaria Cornelio, Simone Doria, Valentina Lauducci, Elisabetta Moriconi, Mariano Prosperi.

Picatrix Variations © Radek Przedpełski 2018.
Catalogo dell’evento a cura G. Cornelio e L. Rossi.
Un’altra prova di questa comunanza è il legame che si è intrecciato tra le due poetesse e traduttrici Antonella Anedda e Eiléan Ní Chuilleanáin, invitate a dialogare sul loro operato e a farci entrare nel loro immaginario poetico. Se Anedda non è potuta partecipare fisicamente, ‘la conversazione’ ha potuto avere luogo ad ogni modo. La poetessa irlandese ne ha letto alcune poesie tradotte da lei in inglese e gaelico e, a loro volta, sono state lette le parole della prima di cui riportiamo alcune righe eloquenti per i simboli evocati: “La poesia di Eiléan così autorevole e così priva di arroganza, ha la naturalezza di questo dicendo, di questo andante del gerundio. È un’oscurità luminosa, quella che viene dai chiari del bosco, dalla luce che filtra dai cespugli, ha a che fare con l’acqua, le pietre, la memoria”. La giornata si è conclusa proponendo nuovi intrecci con un concerto di Cosimo Colazzo e Patrizia Zanardi dedicato alle poesie di Pascoli, Villa e alle voci femminili di Anedda e Attanasio, entrambe protagoniste del G37 della poesia.

Poster dell’evento musicale a cura di G. Cornelio e L. Rossi.
Dublino, 23.03.2018
Bianca Battilocchi
Nadia Agustoni, da “Racconto”, Nino Aragno Editore, 2016, nota di Rosa Pierno
Fra parole e cose traghetta, senza mai toccare riva, la scrittura di Nadia Augustoni. Ma anche tra passato e futuro. Forse incollocabile è l'oggetto, insituabile il luogo, indecidibile il tempo. Eppure la memoria è tangibile, offre come su un vassoio le certezze, "gli odori delle lunghe estati", il colore delle foglie. Tuttavia è da registrare che nei verbi è la distanza e che "le parole sono un nome". Di conseguenza, gli oggetti, con le percezioni a cui danno luogo, sembrerebbero fornire, nel tempo della presenza, l'unica concreta sponda dell'esistenza. Se le parole tessono racconti, lo fanno adagiandosi come polvere sulla fitta rete degli alberi, delle case. La pacata voce della Agustoni, con il suo vocabolario ridotto alle cose prime, ci introduce in un mondo diradato e sul punto di dileguarsi. Eppure con esse tramiamo la rete di relazioni che aggancia anche l'altrove, il passato al presente. Se dovessimo restare deprivati del mondo, ancora ci resterebbero parole per ricostruirlo e allora sarebbe la memoria la salda tavola che ci sorregge.
***
nell’esilio degli alberi nel fragore dei secchi
o l’eleganza della volpe nel tracciato di neve
il bianco porta il silenzio l’ora scende ovunque
e resta uguale:
il tempo delle parole riempie le stanze
il silenzio ripara i gesti mentre il cuore
finge un’altra cosa.
***
parli con un gesto quel segno da solo ti scrive
:non posso raccontarti né raccoglierti ma siamo
nelle frasi: ora il mondo è perduto per sempre
sentiamo l’arrivo del vento, un’aria tra le mani
colpisce le parole :scriverò il mare dopo le
onde e prima del mare come cominciava:
***
i fiori sono uno a uno uno alla volta il prato
ti chiedo una frase senza la parola vento
un’immagine della solitudine
senza abbandono –
:i residui della luce diventati colore:
un’altra luce e i girasoli
le mani senza duello.
Nadia Agustoni (1964) scrive poesie e saggi. Suoi testi sono apparsi su riviste, antologie, lit-blog. Del 2016 è Racconto Aragno, del 2015 Lettere della fine Vidya e la silloge [Mittente sconosciuto] Isola Edizioni; del 2013 è il libro-poemetto Il mondo nelle cose (LietoColle). Una silloge di testi poetici è nell’almanacco di poesia Quadernario (LietoColle 2013). Nel 2011 sono usciti Il peso di pianura ancora per LietoColle, Il giorno era luce, per i tipi del Pulcinoelefante, e la plaquette Le parole non salvano le parole, per i libri d’arte di Seregn de la memoria. Del 2009 la raccolta Taccuino nero (Le voci della luna). Altri suoi libri di poesie, usciti per Gazebo, sono: Il libro degli haiku bianchi (2007), Dettato sulla geometria degli spazi (2006), Quaderno di San Francisco (2004), Poesia di corpi e di parole (2002), Icara o dell’aria (1998), Miss blues e altre poesie (1995), Grammatica tempo (1994). Vive a Bergamo.
Riccardo Benzina, una prosa inedita, “Collasso e apparizione”, nota di Davide Campi
Collasso e apparizione
Il giorno della scomparsa aveva ancora due nomi. Il mio nome, il tuo nome.
Aveva lo scontro, aveva bisogno. Il fallire, ancora – e adesso, invece, di tutto questo niente, niente più.
Metteva da parte il sonno e si dimenticava. In un momento.
È tornato ad essere io, è tornato ad essere te. Bambino, buttava mille oggetti giù dal suo balcone. Per la strada. La forma che si rompe il suo diletto. Infante, incosciente. Dopo, ogni singolo frantume rinveniva: tutti quanti a riempire le grandi buche sul retro.
Ogni volta un collasso, una apparizione.
Sono, meno che. Inalo ed esalo, ma non respiro mai. La irriconoscibile creatura sotto il peso di valanghe immense. Continua esitazione. Non ne ho parlato mai. Lascio un biglietto, bianco senza parole. “Come stai?” Nulla da capire. Non più per le strade appartengo alle fessure. Ci ho messo molto tempo a morire. Perché mi guardi in faccia oh sapessi un altro nascondiglio. Qui pare non ci sia più nulla da imparare. Che non si possa più fare amicizia. Gli sconosciuti resteranno sconosciuti. Così mi siedo al tavolo, e mi presento a tutti: tacendo. Pesante di cose nascoste, il cuore non cede. Nessun mancamento. Nessun rinvenire.
Ogni volta un collasso, una apparizione.
Una cosiddetta deriva, oppure dono. La contraddizione che cammina. Parla. Chiede indicazioni e aspetta. Aspetta. Aspetta. Segue il suo istinto. Si perde in un volo di secondi. Finisce nei campi, la terra senza strade. Né angoli. Controlla, paziente, il suo dispositivo. La mappa differisce in gran misura. Prende poco, lontano dalla rete. Chi ha chiamato, chi ha scritto. Adesso non importa.
Vede in lontananza verdi gambi con le spine. Petali che brillano al sole del mattino.
Ricorda, ricorda. Ricorda il sole i rovi. Ricorda le lacrime il sangue. Le rose che cercava e che ha trovato.
***
In questa breve prosa di Riccardo Benzina il titolo è un manifesto esplicito e coerente di tutto il testo.
Non si tratta della descrizione di un flusso della percezione continuo, per certi versi rassicurante; le parole qui si donano ad un pensiero assalito contemporaneamente dall’esterno, dalle frenetiche immagini del mondo, ma anche dall’interno, dai balzi della memoria o di una esperienza logica priva di costrizioni.
Nella lettura si viene scaraventati in un mondo di ritmi irregolari, a volte sincopati, in cui la lingua si nega a qualsiasi funzione naturale che non sia il puro pensiero.
In questa prospettiva l’uso frequente dell’interruzione segnala il dialogo perenne fra la caduta e l’emersione. Nella caduta, nel collasso, un pezzo di mondo in qualche modo sparisce nell’assoluto oblio, trascinandosi dietro tutte le sue logiche; in ogni emersione e apparizione le parole testimoniano logiche completamente inedite.
È un pensiero minoritario, poetico, cui questo testo riconosce la necessità di venire alla luce.
Riccardo Benzina è nato in Italia nel 1988.
Risulta fra i finalisti del Premio InediTO 2016 (Sezione Poesia) e del Premio letterario russo-italiano Bella 2016.
Ha ricevuto una menzione speciale per la prosa inedita al Premio Lorenzo Montano 2016.
Suoi testi sono apparsi nei volumi antologici Zenit Poesia (La Vita Felice, 2015) e Novecento non più (La Vita Felice, 2016).
Maria Grazia Calandrone, da "Gli scomparsi", Lietocolle, 2016, nota di Rosa Pierno
La scelta di una scrittura del tutto libera, in cui predomina il verso libero, che si vuole accampare tra cronaca giudiziaria e racconto dalla diretta voce dei protagonisti dei terribili eventi è, in realtà, immediatamente ricondotta alla voce autoriale: il linguaggio subito ci indirizza verso un'esposizione a tratti filosofica o lirica che denuncia l'artificio della voce narrante, o meglio rende tale voce dichiaratamente 'attoriale'. La volontà di comprendere, di spingersi negli oscuri meandri esistenti in ciascuno di noi, è il vero oggetto di questi testi: ecco perché ascoltiamo invero la sola voce della Calandrone senza interruzioni. Indossare abiti altrui non è tout-court il modo per essere l'altro, forse quello per rivivere le proprie paure o fascinazioni, per affrontare le angosce personali. Il teatro istituito dalla carta e dalla penna rende fluida la scrittura di quest'ultima prova, catturante, capace di restituire la dimensione della perdita e del riscatto, del lutto e della relazione affettiva e di porgere il messaggio di chi è andato e di chi resta. Eppure parola, quando troppo piena narra d'altro, non della morte, non di quelle esperienze necessariamente afasiche.
Frammento in memoria
[...] ora sappiamo, poi che ne abbiamo rimosso il corpo
azzurro e cedevole, che lei era stata una cosa che non opponeva
resistenza e adesso era
esaudita, mentre tubercoli
di larve ne intaccavano gli occhi e la canala dei liquami era stata
scavata profondamente
quanto
il fatto che chi se n’era andato non era più
con lei da molto tempo e lei aveva concluso nel corpo quel separarsi lentissimo come in presenza di ostacoli e scendendo le scale quella
mattina
con la fronte addolcita dal sole
sulla spalla
della piccola indiana con il nome da uccello aveva detto questo
essere stata in mani estranee è stata
la vita mia
Roma, 22 gennaio 2010
Deposto il nome
Diceva sempre
ditele che la amo
e ditele che ho fatto tanta strada
per amarla.
Ditele che se uscivano
angeli e diavoli dalla sua bocca,
io vedevo soltanto la sua bocca.
Ditele che mi abita
per sempre.
Diteglielo, vi prego. Diceva sempre.
30 aprile 2016
Maria Grazia Calandrone (Milano, 1964, vive a Roma): poetessa, drammaturga, artista visiva, performer, autrice e conduttrice per Radio 3, scrive per “Corriere della Sera”, “il manifesto” e “Poesia”. Tiene laboratori di poesia nelle scuole (applicando un metodo associativo da lei stessa ideato per studenti, da elementari a universitari), nelle carceri, nei DSM, con i malati di Alzheimer e con i migranti e presta servizio volontario in "Piccoli Maestri", scuola di lettura per ragazzi. Collabora con Rai Letteratura e Cult Book. Libri: La scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premio Pasolini Opera Prima), Come per mezzo di una briglia ardente (Atelier, 2005), La macchina responsabile (Crocetti, 2007), Sulla bocca di tutti (Crocetti, 2010 – premio Napoli), Atto di vita nascente (LietoColle, 2010), L'infinito mélo, pseudoromanzo con Vivavox, cd di sue letture dei propri testi (sossella, 2011), La vita chiara (transeuropa, 2011), Serie fossile (Crocetti, 2015 – premi Marazza e Tassoni, rosa Viareggio), Per voce sola (ChiPiùNeArt, 2016), raccolta di monologhi teatrali, disegni e fotografie, con cd allegato di Sonia Bergamasco con EstTrio e Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?” (Gialla Oro pordenonelegge, 2016); è in Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 2012). Sue sillogi compaiono in antologie e riviste di numerosi paesi. Porta in scena in Europa il videoconcerto Senza bagaglio. www.mariagraziacalandrone.it
Anna Maria Carpi, dalla raccolta inedita “I rifugiati”, nota di Laura Caccia
Invocazione
“Invocare, e se fosse / questo la poesia?”, si chiede Anna Carpi che, nella raccolta “I rifugiati”, colloca il suo dire dalla parte di chi è in cerca di senso: una condizione comune a tutti i viventi, di fronte all’ineluttabilità che domina l’esistere, inasprito dalla brutalità umana e dall’incuranza che sancisce il contrasto tra l’orrore del mondo e il quotidiano passivo sconforto: “A noi, scrive l’autrice, qui sul divano / rimane impressa solo la rovina, / mezzo milione i morti, solo numeri atroci / e un'idea confusa dei motivi”.
La ferita non appare solo storica, contingente; è uno strappo più profondo, certo privato, umano, ma forse rintracciabile ancora più a fondo, a livello ontologico: “Il senso è al largo”, precisa Anna Carpi.
Una condizione umana che riguarda tutti, dalla perdita di senso allo stato di erranza e di esilio: rifugiati, per l’autrice, sono certo i profughi e i clandestini “affamati, gelati, senza dove”, ma ugualmente la situazione riguarda chi, dall’altra parte, assiste impotente e trova rifugio nella quotidianità, ”E rifugiati siamo anche noi, / a tavola in cucina che ceniamo”.
Così tutti possiamo sentirci esclusi: oltre che dai più elementari diritti, anche dalla natura, dalla comunicazione e dal contatto reale. E tutti considerarci smarriti, confusi nella solitudine e nella lontananza dal divino, nell’autentica sofferenza come nella falsa commiserazione, come leggiamo: “Ma quel po' di pietà durante il giorno / per le sventure altrui / non lo chiamare il bene, / piomba nel sonno insieme a te ogni sera. // Così anche tu sarai fra gli smarriti”.
E la poesia? È anch’essa da includere tra i rifugiati, come implicitamente i versi lasciano intravedere, sbigottita tra follia e incuranze, tra guizzi di senso e oblio, tra speranza e abbandoni? E che cosa invoca?
Forse “nel suo strazio invoca un altro mondo”, come scrive l’autrice nei versi dedicati a Rilke, un’invocazione che è desiderio, non supplica, forse il “desiderio di un oltre oltre oltre” con cui si conclude il testo dedicato a Nietzsche.
Un’invocazione, nella ricerca insoluta del divino e nella sofferenza per la precaria condizione umana, che richiede fiducia: “Invocare, e se fosse / questo la poesia? / Ci proviamo: con minimi / travasi di dolore e di speranza”.
E che presuppone soprattutto, come ci mostra Anna Maria Carpi, un grande amore per la parola.
***
RILKE CHE SCRIVE lettere
a migliaia, a poeti
e a nobildonne primo '900,
e le sue oscure e splendide elegie
e i suoi inni ad Orfeo
il padre d'ogni canto, canto umano.
Ma ogni momento supplica
in prosa e in versi:
vi prego non mi amate,
è un inganno l'amore,
chi m'ama mi sfigura,
sta a me di amare,
a me questa violenza che mi salva.
"Lascia suonare, dice, ciò che in te fa strazio"
e cerca le parole e poi le trova
questo genio-fanciulla d'altri tempi
e nel suo strazio invoca un altro mondo
fra le braccia degli angeli,
e non solo per sé. Per tutti noi.
Invocare, e se fosse
questo la poesia?
Ci proviamo: con minimi
travasi di dolore e di speranza.
***
DUE I NOSTRI COMPAGNI.
Uno è il passato –
mezzobastardo dell'immaginario –
e ognuno ha il suo
o un muto un tremebondo un coda bassa,
o un inquieto che latra, un lupo, un labrador.
Poi verrà l'altro
anche lui un fedele. Però non scelto, però insospettato,
un disguido da poco sulle prime
giù nella dépendance, nel caro corpo,
un nulla, intermittente. Cosa vuole?
Non ascoltarli, guarda: fra gli ignoti,
ce n'è tanti
che ti toccano il cuore.
Anna Maria Carpi, di famiglia tosco-emiliano-irlandese, vive a Milano. Ha insegnato letteratura tedesca all'Università di Macerata Marche e a Ca'Foscari a Venezia. E' autrice di saggi, racconti e romanzi (fra cui Vita di Kleist, Mondadori 2005, Rowohlt 2011, e Uomini ultimo atto, 2016) e traduttrice della lirica tedesca (Nietzsche, Rilke, Benn, Bernhard, Gruenbein e a.), premio Ministero dei beni culturali (2011) e Città di S.Elpidio (2015), premio Carducci (2015). Nella poesia esordisce con A morte Talleyrand (1993, premio Pisa 1993), cui seguono Compagni corpi (2004, 22005), E tu fra i due chi sei (2007), L'asso nella neve (2011, 2 edizioni), Quando avrò tempo (2013) e L'animato porto (2016). Da Hanser (Monaco 2015) è uscita l'antologia con testo a fronte Entweder bist du unsterblich e da Marcosymarcos, Milano 2016, il complessivo E io che ancora parlo. Sue poesie sono apparse su "Oktjabr' (Mosca,1998), "Akzente"(Monaco 2001 e 2011), e di recente su "Ulisse", "Nuovi argomenti", "Le parole e le cose".
Morena Coppola, dalla raccolta inedita “Sgorbie e Misericordie di Fratelli Elettrici”, nota di Laura Caccia
Una sacra dissacrazione
Nella ricerca di coniugare arte e poesia e, nello stesso tempo, di creare una rottura di prospettiva, si muove la scrittura contaminata di Morena Coppola nella silloge “Sgorbie e Misericordie di Fratelli Elettrici”.
Molteplici sono le rivisitazioni nel mondo dell’arte, dal dipinto di Rembrant, Il filosofo in contemplazione, alla video-intervista, Il sogno di una testa, di A.Giacometti, così come nel corpus poetico, con citazioni da D. Campana a J. Brodskij, da P.P. Pasolini ad A. Zanzotto. Non solo: unitamente ai richiami a diversi poeti ed artisti e a molteplici opere musicali, letterarie e pittoriche, l’autrice mette in atto la reinterpretazione di narrazioni bibliche, con l’invenzione di nuove, laiche, dissacrate parabole.
Parrebbe che tutto il dire di Morena Coppola si faccia, laicamente, parabola: un dire allegorico in cerca della sua verità, o post-verità, una parola in cerca di sé, propriamente, come precisa l’autrice, delle “sorgenti di segni primordi che segnano le linee dell'avanti parola”, una scrittura che arde “nell'apice di un estremo, nelle profondità nascondiglie di coni a rovescio. / In quei cunei roventi, noi stiamo” e che dissoda, trafigge e perfora: “Con pseudo dotta giuntura trivello il reale … Opus incertum; in ciò sta il fine, la teleologica rissa tra scavi e reinterri”.
Il tutto attraverso fratture di visioni, pluralità dei punti di vista, rovesciamenti di senso, nello stesso modo con cui operava l’artista G. De Dominicis, più volte citato in exergo.
Con tensioni e accentuazioni espressive, che ci conducono anche a Pasolini, che l’autrice ci mostra in una reinventata crocefissione e di cui fa dire: ”Veramente quest'uomo era Poeta di Dio!”. E con l’uso di figure del doppio, in particolare espresse in “Due Pater come due Frida”, che danno titolo a diversi testi.
Pare proprio di scorgere in tutta la raccolta, come nel doppio autoritratto di Frida Kahlo, Le due Frida, con il loro doppio cuore, la duplicità del sentire e della parola di Morena Coppola, tesa tra il sacro e la sua dissacrazione, tra passioni ardenti e immagini stranianti, tra “mete oltresoglia” e “recapito certo”, e, come si conclude la raccolta, tra “salvezza distante e apocalisse privata”.
Dalla sezione: .II. Utensili Nuziali
***
sottratta l'anemica anatomia al vedere
il cemento armato di espiro sospeso
ostruiva la vista
non l'effettiva esistenza
scarnificata da visioni
incrociate a sempre uguali
In pozzo di mari noi indosseremo reciproci archetipi
LE DEDICHE
Ti vedo girare dietro angoli chiari senza sporgenze.
Architravi smontati di mattoni e cemento esistono nei luoghi dell'incerto e del dove.
So che sei in alto e pascoli nuvole cieche.
La luce offuscata manda attimi e tremiti.
Paura riarde che occhi vacui contagi germoglino. Non voglio languire per questo.
Sono anni che conservo il tuo viso, lo raggiungo così.
Dietro la pietra, delle ali di marmo sembrano dire Vieni a vedere.
Il santo è disteso nel campo, ma è andato a morire lontano da qui.
Pupilla opalina proietta memorie, apostrofe senza video né audio.
L'umano non si distacca da Nulla, soltanto lo accetta e lo inventa.
ALTRE DEDICHE
Non riesco a raggiungerti ora.
Ricordo pianti e sorrisi che ci fecero fanti di picche.
Non potrei pensarti senza le spine negli occhi.
La bellezza del vivo si ripercuote sulla fotoceramica sbianca.
Sotto lo choc dei giorni trasuda perennità di pensiero.
Aspettami ancora in quel tuo posto appartato.
Morena Coppola è nata a Roma nel 1958. Ha vissuto a Venezia, attraversando lo studio letterario e poetico nell'Associazione La Settima Stanza di Grazia Sterlocchi e Laura Guadagnin. A Roma, frequenta letture lezioni e laboratori; in particolare, gli incontri di lettura poetica tenuti da Daniela Attanasio negli spazi della casa editrice Empirìa. Si interessa delle forme calligrafiche rintracciabili nell'espressività visiva e di arte contemporanea. Le sue sillabe, e il flusso che porta all'esterno logos e pensiero, spesso rilasciano immagini stipate nel magazzino retinico. E' stata selezionata al Premio Lorenzo Montano, nel 2013 per la sezione della poesia inedita, nel 2014 per quella della prosa poetica inedita. Nel 2016, in occasione della pubblicazione di Avrei fatto la fine di Turing, di Franco Buffoni, un suo scritto è stato pubblicato sul sito del poeta. Finalista al premio letterario Interferenze – Bologna in lettere, edizione 2017. Un suo testo accompagna l'immagine xilografica dell'artista Andreas Kramer per le Edizioni PulcinoElefante.
Giovanni Duminuco, da “La ferita distorta dell’agire”, Formebrevi Edizioni, 2016, nota di Rosa Pierno
Nelle prose poetiche di Giovanni Duminuco sentiamo immediatamente l'assenza di un referente esterno e del corpo che dovrebbe esserne il ricettore. Siamo già implacabilmente nel mentale, con tutti i suoi dubbi, con una logica che è inoltre inficiata non solo da sé stessa, ma anche dall'immaginazione, la quale proietta sul tendone, tutto visivo, virtuali aperture, fughe e pieghe. La parola vi ha però una posizione egemonica, perché è l'unica con cui poter risalire la corrente, dominare l'onda (fra emozioni e logica), venire a capo perlomeno del filo che può consentire l'uscita dal labirinto. Ed essa, scorre fluente, senza interruzioni, svolgendo sotto i nostri occhi un vero e proprio resoconto diaristico relativo a un viaggio, in cui la coscienza è attiva almeno quanto lo è un'onirica visione. Le parole indicano simboli e questi simboli sono boe nel passaggio, le quali non costituiscono un obiettivo e non offrono una salda presa. Eppure, solo la parola consente almeno di passarci attorno, di toccarle.
***
Sono le circostanze del nulla, il segno dell’alterità
costretta sulla pelle nel tremore della colpa perenne,
stretti al vento dei commiati nel gioco del morire: l’a-
ria di polvere che ingrossa il respiro nelle notti che
spezzano le ossa, ruvide metamorfosi di un corpo di-
sabitato.
***
Per una strada aperta all’errore ripiega il cranio nel
dolore prima che giunga il vento dietro il vetro per-
duto alle logiche del tempo: dirige lo sguardo all’al-
trove impietrito, chiude il riflesso in fessura nel gesto
dietro il muro l’impronta ostentata del freddo.
***
Abitare l’errore nel tragitto che segna il passo ai muta-
menti, tra le visioni scoscese del niente che attraversa
la pianura dove culmina lo sguardo, stretto nel corpo
consegnato al vento il declivio indecifrabile del mondo.
Giovanni Duminuco (1980) vive e lavora in Sicilia, attivo nel campo della ricerca filosofica e letteraria. Ha pubblicato diversi studi in riviste specializzate. Nel 2013 vinse il XXVII “Montano” con la raccolta inedita “Dinamiche del disaccordo”, successivamente pubblicata da Anterem Edizioni.
Valentino Fossati, da "Inverno", CartaCanta editore, 2016, nota di Rosa Pierno
L'uso intensivo della memoria, fino al punto da mostrane l'afasia, con il suo venir meno, quasi a causa dell’essere così strenuamente cercata, apre di fatto una separazione netta fra il sé adulto e il bambino che si è stati. Ora proprio questa netta separazione, equivalente a una perdita innaturale, poiché non possiamo essere, nel presente, che tutto quello che siamo stati, offre anche la misura della ferita e del dolore di cui ci parla Valentino Fossati. Confessione centellinata, in pillole, in cui gli "avrei potuto" e i "non sapeva" ci raccontano di un rovello tutto presente che si traveste con verbi all'imperfetto. Un presente che ha necessità di servirsi del ricordo, che parla di un passato riportato in vita come di un fantasma, un’ossessione che scrive una pagina sulla quale gli spazi bianchi sono maggiori di quelli stampati e le parole sulla riga si distribuiscono ricercando la rarefazione, segno ineludibile della difficoltà di rintracciare la continuità, e che inevitabilmente troveranno un epilogo nella perdita del tempo, la cui presenza è il vero tormento di Fossati. Il tempo indistinto, perenne, è il traguardo agognato.
***
Inverno,
in quel tempo dei bambini
nascosti,
come palloni sui terrazzi
le ronde
(periferia – nord)
Le ronde dei padri –
tempo dello scoppio
seminati
i bambini sul selciato
in quel tempo…
Poi,
silenzio di tutto
silenzio
di noi
necessario il buio
necessità di noi …
Riprenderanno a parlare dietro ai balconi
Riprenderanno
a ricordare
(di noi)
le luci sui piatti,
bagliori sui corridoi
inabitati…
Nessuno provò tanta gioia
(nessuno)
come il bimbo nella cucina
dopo la scuola,
solo,
(silenzio
Compatto) –
Nessuno.
Oscurità dello sguardo,
oscurità
di noi
bianco di noi
nessuno.
Valentino Fossati (Genova, 1974), si è laureato con una tesi sulle antologie di poesia italiana. Ha pubblicato, in poesia, “Gli allarmi delle stelle” nel 2007 e “La gioia” nel 2014. Per il teatro ha scritto “Quel grido dell’altra notte” e “Alba infinita”.
Kiki Franceschi, da “Non c’è tempo per il tempo”, Edizioni Polistampa, 2016, nota di Flavio Ermini
Kiki Franceschi è poeta, artista, saggista. Il suo lavoro è dunque complesso e poliedrico. Precisamente com’è complessa e poliedrica la struttura di questo suo libro: Non c’è tempo per il tempo.
In questa opera, parola poetica e segno, parola riflessiva e canto si intrecciano. E forniscono del mondo una visione colma di contraddizioni insanabili.
Il nostro mondo, ci dice Kiki Franceschi, è sottoposto all’incombere di un disegno che appare inestricabile. Un disegno che a tutti rimane celato.
I protagonisti dell’opera (esseri umani, esseri animali, o cose che siano) sono condannati all’errare e al patire – che dell’errare è la conseguenza. La sventura pare essere la condizione inerente a noi tutti… Eppure, Non c’è tempo per il tempo non teme di affidarsi a un puro anelito verso la pace. Un anelito puro e tormentato che pervade e scalda i nostri cuori, lacerati come sono tra pena e fortuna.
Sotto
mentite spoglie
Ho due anime, un falso sé o un
inventato sé. Sono sempre sotto mentite
spoglie, in duello con me stessa nel tentare
di uscire dai grovigli interiori che strozzano
l’impulso ad esprimermi e frenano la pulsione
al silenzio. Combatto con la voglia di tacere,
il desiderio di riposo e silenzio, la fine delle
inutili fatiche, l’abbandono della
tensione costante. Fuggo. Entro in
un dialogo tra ombre e doppi.
Inevitabilmente.
Rebus
Labirinto della mente
enigma inconsapevole
non oscuro specchio
né museo di cangianti forme.
Io sono il mio ricordo
come in sogno
nessuno dietro il viso
che ignaro mi guarda.
Kiki Franceschi nasce a Livorno, dove giovanissima si distingue nel campo pittorico vincendo numerosi premi nazionali. Al suo attivo ci sono circa quaranta mostre personali e collettive. Esperimenta poesie sonore, alcune delle quali saranno trasmesse negli anni 1990 e ’91 dalla Radio Nacional de España in occasione della rassegna Ars Sonora. Scrittrice, poeta e saggista pubblica diverse opere tra cui Giornale(Aglaia, Firenze 1991), Segnali da nessun luogo (Polistampa, Firenze 1997), Fontechiara e dintorni (Polistampa, Firenze 2000), Divorare l’infinito, (Morgana, Firenze 2001), Riflessi da fortezza assediata (Angelus Novus, L’Aquila 2002), Isola (Meta, Firenze 2003), Sono fuori del tempo i fatti umani (Gazebo, Firenze 2012). I suoi testi drammatici sono stati tutti rappresentati in teatri italiani tra i quali la Goldonetta di Firenze, il Teatro delle Commedie di Livorno, la Sala Vanni di Firenze o il Piccolo Elliseo di Roma. I saggi su Mary Shelley e sul gruppo Berenson sono apparsi sulla rivista «Berenice», nel 1996, nel 1997 e nel 2001. Un altro è contenuto nel volume a cura di Eleonora Chiti, Monica Farnetti e Uta Treder La Perturbante(Morlacchi, Perugia 2003). Una sua biografia critica è apparsa in Scritture femminili in Toscana, a cura di Ernestina Pellegrini (Le Lettere, Firenze 2006).
Angela Greco, una poesia inedita, “Studi comparati”, nota di Ranieri Teti
"Perché siamo qui, Angela? Dove stiamo andando?”
Se pensiamo a generi collaterali alla poesia come siamo soliti immaginarla, con gli a capo canonici, restando nell’ambito lineare e senza sconfinamenti nel visivo o nel sonoro, probabilmente viene subito in mente la prosa poetica.
Angela Greco, in questo “Studi comparati”, propone invece un testo di poesia narrativa: è poesia, ci sono gli a capo, ma tutto si configura come un racconto. Con tanto di frammenti dialogici, flash-back, stacchi e inquadrature da cinema, musica e recitazione, “fuorionda” colti nel momento massimo della verità. Le voci fuori campo dettano il tempo di una sceneggiatura complessa, serrata e insieme profonda. Una sorta di “marchio di fabbrica”, ripensando a una precedente prova dell’autrice, “Campo di grano con corvi”.
Ma è necessario porre molta attenzione, perché tutto quello che viene messo in scena, talvolta abbagliando, in altri momenti in modo sommesso, potrebbe depistare noi lettori dalla costante visione, esclusivamente poetica, che innerva l’intero brano. La poesia è nel pensiero che sottende interamente il testo, ora carsico e appena percepibile, ora affiorante e portatore di rara, e inedita, espressività. Forse siamo davvero diretti dove abbiamo sbagliato, oppure dove possiamo liberamente confondere i segni con i sogni, soffermandoci su una vecchia foto che ancora ci parla.
Studi comparati
«Dove abbiamo sbagliato, Claire? Dove siamo diretti?
Chi ha preso il nostro posto?»
Non sappiamo più leggere i segni, i sogni,
il fondo delle tazze di caffè e nemmeno il Braille.
Sono lontane le stelle, le notti chiare e le mattine senza dolori.
Si ride per una bugia. Inizia a piovere.
Il grigio ha valenza plurima e capacità statica.
Giorno monocromatico da vecchio film muto
aggressione inevitabile alla giugulare.
E’ tutto un gioco di fogli bianchi e mascelle.
Anche il cielo morde.
Al piano inferiore spostano continuamente le sedie
in un gioco da bambini che ogni volta ne sottrae una.
Il falegname bussa tutti i pomeriggi dopo pranzo.
Dal balcone guarda i miei giorni stesi ad asciugare.
Io lo saluto sempre. Per l’ultima volta.
Inverno rigido tra febbraio e aprile;
maggio è soltanto un ricordo.
Le gocce sui vetri mosaicano l’immagine.
«Claire, non allontanarti. Ho bisogno di mani, di fiato
e di presenza, in questo quotidiano senza punteggiatura».
La luce accesa nella stanza col soffitto blu aspetta la sera.
Temo il suo silenzio più che la neve.
Astronomy domine, cinquant’anni di anticipo.
Scatola degli spilli, forma avveniristica, un altro secolo:
uso sapiente di mani, rotazione di vinili, asole da riparare.
Fili tutti tirati.
Lascia che giochi, Claire, oggi. Fuori c’è confusione.
Cinque settimane per ritrovarsi e un bonus per sola andata.
Penso spesso che sia necessaria una vacanza dalla poesia,
ma poi qualcosa arriva e tutto allora diventa chiaro, lucido.
A marzo sarà un anno dalla foto in bianco e nero con foulard.
Angela Greco è nata il primo maggio del ‘76 a Massafra (TA), dove vive con la famiglia. Ha pubblicato: in prosa, Ritratto di ragazza allo specchio (racconti, Lupo Editore, 2008); in poesia: A sensi congiunti (Edizioni Smasher, 2012; in uscita la seconda edizione con prefazione di Flavio Almerighi); Arabeschi incisi dal sole (Terra d’ulivi, 2013); Personale Eden (La Vita Felice, 2015, prefazione di Rita Pacilio); Attraversandomi (Limina Mentis, 2015, con ciclo fotografico realizzato con Giorgio Chiantini e nota introduttiva di Nunzio Tria); Anamòrfosi (Progetto Cultura, Roma, prefazione di Giorgio Linguaglossa). E’presente anche in diverse antologie e su diversi siti e blog. È ideatrice e curatrice del collettivo di poesia, arte e dintorni Il sasso nello stagno di AnGre (http://ilsassonellostagno.wordpress.com/). Commenti e note critiche sono reperibili all’indirizzo https://angelagreco76.wordpress.com/.
Francesca Ippoliti, dalla raccolta inedita “I poteri”, nota di Laura Caccia
I domini interiori
Se pensiamo al potere immediatamente riconduciamo l’atto di autorità o di forza ad un agente esterno e, nella sua forma plurale, alle diverse istituzioni o forme di dominio che hanno agito e agiscono nel mondo.
Ad un diverso significato ci conduce invece Francesca Ippoliti nella sua silloge “I poteri”, dove, alternando nella sua ricerca linguistica prose poetiche e strofe, ci parla di dolori e dispersioni, di contagi e guarigioni, di promesse e di perdono, di speranza e di vuoti: “Discorsi tagliati a metà, un mucchio di polvere. Dicci ancora della forza, nei deserti conosciuti e vuoti. Faccelo toccare il vuoto”.
Un vuoto che non si colloca solo nell’esterno circostante, dove, come scrive l’autrice, “Tutto finalmente smette di esistere”, ma che si fa soprattutto esondazione interiore, come “diventare vuoto meccanismo o una bolla grande, inutile e perfetta / dirigere l'orchestra delle voci / rotolare lungo la linea, rinunciare a salvarsi”.
Accogliere il vuoto è quanto ci indica Francesca Ippoliti, all’interno di una dinamica in cui agiscono forze opposte, poteri interiori che al termine della raccolta vengono precisati essere propriamente l’assenza e la vigilanza.
Sono stati di veglia, capacità di selezionare, concentrazione e razionalità, la possibilità di salvezza, anche, a declinare il potere della vigilanza, come esprime l’autrice: “Il pensiero lineare e giusto doveva conservarci la salute, tenerla in serbo per le stelle”, ma anche la durezza nei confronti di sé: “Mi faccio la violenza - la cura - di un'attenzione continua e opprimente”.
Sono, al contrario, movimenti di dispersione, sogno, apertura, azzardo, linguaggio dell’errore e impossibilità di salvarsi a caratterizzare il potere dell’assenza, come leggiamo: “Ad un certo punto ho dovuto rinunciare alla mia concentrazione disperata e usare le parole sbagliate”, così come sottrarsi alla conoscenza razionale, cercare “di non capire”.
In bilico, patendone l’inconciliabilità, tra vigilanza e assenza, attenzione e rischio, ragione e desiderio, Francesca Ippoliti si muove eticamente in un percorso umano e poetico in cui la parola è in cerca della sua autenticità e il dolore riesce a farsi stato di grazia, “ma”, ci ricorda, “quanta gioia da scacciare via, quanta luce / da spostare con le mani”.
Rituale
Mentre giri su te stesso rapidamente
e con un colpo di frusta svanisci
...........
Guardi tutto nell'assenza di Dio
resti fermo e sicuro nel vento
La linea del davanzale
è l'unica cosa rimasta del mondo.
L'infezione
Preghiera
Discorsi tagliati a metà, un mucchio di polvere. Dicci ancora della forza, nei deserti conosciuti e vuoti. Faccelo toccare il vuoto, finalmente tutto intero, a masse d'aria corrotte, a blocchi d'aria finissima. Dimmi dei nostri figli, del taglio fuori le mura, a fine giornata – arrivano dopo, i pomeriggi estivi d'aria, fluttuanti e scomposti
Postilla descrittiva
Le cadono le pastiglie di mano, crollano le espressioni, fa le smorfie, non vi guarda, io la guardo e vorrei che smettesse, vorrei aiutarla. Cedo, mi lascio commuovere da un motivetto pop di cattivo gusto.
Sogno
Ci sarebbe un grande riposo,
senza distizione tra giorno e notte.
Ci sarebbe un aereo in volo nello spazio
Un razzo
Una scia perfettamente inutile,
infinitamente perfettibile.
Tutto questo non è la chiave di niente
Un aereo non apre niente
Tutto finalmente smette di esistere
Svolta
Lo senti, lo capisci: l'infezione sta tornando. Diventi un'altra volta cattivo, ti guardi intorno, li odi. Presto tutti se ne accorgeranno, ti chiederanno di andartene, ti stringeranno la mano sorridendo.
I poteri
Una dinamica
E tu, proprio tu, ma forse io, devi sapere che:
ci sono solo due forme di potere – l'assenza e la vigilanza – e non potrai conciliarle, non potrai farcela, non ci riuscirò.
Francesca Ippoliti è nata a Napoli nel 1988 e vive a Roma. Si è laureata in Lettere a Siena e attualmente sta svolgendo un dottorato di ricerca presso Roma “Tor Vergata” in cotutela con l'Università di Losanna. Si occupa soprattutto di metrica e stilistica del Novecento, con particolare riguardo al ritmo e all'intonazione. Ha scritto sulle riviste Ospite ingrato e Sinestesie, e collabora stabilmente con il semestrale Per leggere, con Nuovi Argomenti e con il blog formavera, dove sono apparse sue poesie, traduzioni e articoli.
Gabriella Montanari, da “Si chiude da sé”, Gilgamesh Edizioni, 2016, nota di Flavio Ermini
Gabriella Montanari è poeta, narratrice, critica d’arte, fotografa.
Oggetto di studio della sua poesia vuole essere la vita nel suo complesso. Vita intesa non come cosa tra le cose, non come oggetto da definire.
La domanda che Gabriella Montanari si pone è questa: sulla vita in quanto tale, da dove è lecito iniziare a interrogarsi? Per subito soggiungere: chi o cosa interrogare per raggiungere questo scopo?
Ed ecco cosa impone Si chiude da sé: impone di accettare la finitezza e la fragilità costitutive della nostra esistenza; impone di vivere ora e qui la nostra morte futura, come se ogni momento fosse l’ultimo; impone di decidersi finalmente per una vita autentica!
Diciamolo con maggiore chiarezza: Si chiude da sé svela che il vero male, la nostra vera disgrazia è quanto avviene non per la Natura, ma nell’andare contro la Natura.
Detto ancor più chiaramente, la vera catastrofe avviene quando non facciamo i conti con le nostre passioni, quando cerchiamo di sfuggire all’attrito della vita.
***
passato è stato il nostro tempo verbale. futuro condizionato, sottovuoto. poco igienico.
spietata grammatica dei fuoritema per la maestrina spiumata e l’alunno redento,
banchi d’imputati in fila ignara, bacchetta e bacio, e il fiume rosso delle sviste.
fossimo stati la malacopia dell’otto e mezzo sperato, o anche solo una merenda
o un suggerimento, un vocabolo capace di rimare con comprensione.
bocciata a pieni voti, svuoto la cartella dalle ultime, pesanti briciole di lezioni
e raccolgo camomilla per la sera lunga e senza compiti.
in controluce, io senza contorno, tu calco, leggi il doppioverso che ti mando.
ripetente in amore, ammaccata dalle prove, lucida da scegliere tre volte te.
***
testimone un mare ampio di vedute, mi avresti legato un’alga d’argento all’anulare.
ti avrei dato un figlio morbido, con la mappa dei tuoi nei e i miei alluci ellenici,
nome di punta e di cognome di tacco per calzare il nostro ritorno all’utero del sud.
sul castagno dei cento cavalli avresti modellato per noi un nido di saliva e salvia,
tetto aperto su saturno, risa nel piatto e tavola spalancata agli appetiti del bosco.
tu e i tuoi pazzi, io e la mia poesia, lui e le sue biglie dai mille volti: mondi alleati
in un serio gioco di famiglia. e fuori un giardino di anime vispe, da invitare a cena.
e poi pigmenti e crete per tappezzare i muri dei vuoti, vaccini e cerotti per i bui.
ti avrei dato un inferno. ma di qualità.
Gabriella Montanari
(1971, Lugo di Romagna)
Laureata in lettere moderne all’Università di Bologna e diplomata in pittura presso la Scuola d’Arti Ornamentali San Giacomo di Roma, è poeta, scrittrice e fotografa. Traduttrice di poesia e narrativa dal francese e dall’inglese, collabora con riviste di critica letteraria, d’informazione e d’arte italiane e francesi.
È co-fondatrice e direttrice editoriale della casa editrice WhiteFly Press (Ravenna http://www.whiteflypress.com).
Esordisce in poesia con la raccolta Oltraggio all’ipocrisia– Prefazione di Dante Maffia (seconda classificata al Premio R. Farina, 1° Davide Rondoni, 3° Sauro Albisani) per le edizione Lepisma di Roma (2012), a cui ha fatto seguito Arsenico e nuovi versetti(La Vita Felice, Milano, 2013 – Prefazione di Lino Angiuli) e Abbecedario di una ex buona a nulla (Rupe Mutevole Edizioni, Parma, 2015 – Prefazione di Enrico Nascimbeni). Sue poesie, racconti brevi e traduzioni sono raccolte in antologie italiane e internazionali.
Antonio Pibiri, da “Chiaro di terra”, L’Arcolaio, 2016, nota di Flavio Ermini
Antonio Pibiri con Chiaro di terra è al suo terzo libro di poesia. La casa editrice è L’Arcolaio. L’anno di pubblicazione, il 2016.
Con Chiaro di terra Pibiri vuole rompere i diaframmi dell’oscurità. Ma non per tornare a un improbabile “chiaro di luna” e lì affidarsi a ormai apatiche certezze veritative. No. Pibiri ci sta comunicando che siamo davanti a qualcosa come un gioco d’ombre, in cui proprio attraverso il messo-in-ombra, appena illuminato dalla terra, rende accessibile il senso della vita.
È il passo nella penombra della verità, nel cammino della sapienza, nel gesto dell’amore, ma – ancor prima – nell’abbacinamento dell’ombra. Perché è qui che Pibiri ci vuole portare: all’illuminazione che viene dall’ombra.
La poesia è mossa da un’originaria meraviglia e da sempre la sua domanda è in cosa consista un’ombra. Ebbene, questo libro mostra come il pensiero-che-interroga metta in discussione innanzitutto se stesso. Incessantemente Chiaro di terra si fa paladino della compresenza essenziale di luce e oscurità, compresenza che si costituisce come principio germinativo della parola poetica, tanto da giungere a sovvertire la lingua che essa stessa parla.
Ciò accade in modo particolare nella sezione “Visioni dell’ultimo”, dove il poeta ipotizza che la luce sia in fondo quella cosa che nasce dall’ascolto di una voce.
Ecco cosa ci rivela Pibiri. Ci indica che se la poesia poco sa della luce è perché pur avendola sempre pensata non l’ha mai pensata a partire dalla terra, dall’evento della terra, dal suo chiarore.
***
Al primo centro abitato, autogrill,
lungo la strada, non so dopo quale
tornante dopo senza tormento.
Al primo ceppo o donna nel paesaggio,
bestie da tiro, dressage, la carne rossa
al banco, i domestici nella fretta di rincasare.
Lungo la strada impervie sinòpie,
smarrita, franta in un prisma
di gioco a perdersi ovunque
comunque.
***
Due studi sul corpo inclinato
I
Insiste batte violento
Il chiaroscuro alle finestre.
Ma i pugni bramano disertare
Le ferree file dei fianchi.
E in favore di penombra
avanzando dallo spoglio
delle stanze rinverdisce
lungo la sua nudità.
II
Quello che la nudità cela si versi pure
per intero sulle tavole d’alabastro
il servizio buono i panieri profumati,
sulle parole senza lisca, in tondo
a-embrice, la presentazione
ineccepibile.
Antonio Pibiri è nato a Sassari nel 1968 e risiede ad Alghero. In poesia ha pubblicato: Di quinta in Quinta (Magnum editore – Sassari, 2007 e Il mondo che rimane (Lampi di Stampa, 2010).
Daniele Poletti, da “Ottativo", Edizioni Pufrock, 2016, nota di Rosa Pierno
L'incistazione di linguaggi specialistici (medico, geometrico, semiotico) sembra espungere di fatto la necessità della cesura dal verso e così anche la necessità dell'inarcatura, ove d'altronde la rottura dei legami sintattici costituisce comunque discontinuità all'interno della consequenzialità lineare, dichiarando la volontà di spingersi nei labirintici corridoi della lingua alla ricerca dell'impossibile lingua ‘perfetta’: intenzione simile, in questo, alla ricerca condotta da Michaux sul versante visivo. Il testo problematico che si dispiega sotto i nostri occhi si sbarazza dei generi e prosegue verso un'accumulazione che solo nell'insieme ritrova la sua capacità di esprimere una vicenda umana: la percezione del proprio corpo. Ma è anche, al contempo, registrazione della metamorfosi del segno verbale, della sua capacità polimorfica e plurisemantica, che si accampa quale vero soggetto sulle pagine.
deprivazione del sonno - B
misurare una grandezza significa determinare quante volte essa
contiene l’unità di misura; non sempre si potrà avere di un dato
segmento la misura esatta; nei rapporti tra grandezze differenti si
crea un obbligo di coordinazione, tale obbligo è indipendente dalla
visione.
VII.
L’incrocio di passanti produce tremolio una sfocatura disapparire
della forma sulle pieghe del guanciale restanza il fiume senza
il fiume scorre negli occhi, risospinti alla vita i morti acque della restituzione
ritroso a scorrere le forme elementari non soffrono il tempo.
È questo il punto da raggiungere impazienza della risacca ritroso a scorrere
pancia dell’onda onde pancia delle acque pancia e onda hanno fattezza
gravida nell’etimo. Per dire che c’è qualcosa e che questo è fatto in un certo modo.
IX.
La masticazione è un adattamento uno dei primi segni
durante le due dentizioni è discontinuo, tutto ciò che può essere addentato
fonda sicurezza radicamento; liso di masticatura.
In trentadue giorni si appalesano i distretti venosi
: continuano a perdere foglie per torsione
: il frasario dei tigli è liso e scopre un’armatura saia
: cedono le valvole a nido di rondine sporgendo nel suo lume
c’è reflusso, desiderio di una cella
nuova, uno dei primi segni il desiderio di
per mordere ogni mattina un carminativo rende
lieve un mordicativo per non separarsi.
La nervatura rimane diagonale i decidui rimangono e variano.
Daniele Poletti nasce a Viareggio nel 1975. Poesia e teatro del corpo sono le attività che animano la sua ricerca. Pubblicazioni: Dama di Muschi (1995, edizione privata), con i testi introduttivi del poeta visivo Arrigo Lora- Totino e dall’artista Antonino Bove, Una giornata... particolare (2003, Mauro Baroni editore) e Ipotesi per un ipofisario (2005, Marco Del Bucchia Editore). Tra le partecipazioni: L’ora d’aria dei cani (2003, Mauro Baroni editore), Parabol(ich)e dell’ultimo giorno. Per Emilio Villa (2013, Dot.Com Press), I racconti della metro (2016, Aracne editore). Sue poesie e lavori concettuali sono apparsi su varie riviste e contenitori d’artista (Offerta Speciale, Risvolti, Geiger, BAU, Italian Poetry Review tra le altre e su l’immaginazione 10 poesie con una nota di Edoardo Sanguineti). È presente su alcuni blog letterari come Il fiore del deserto, Poetarum Silva, Rebstein, Trasversale, blanc de ta nuque.
Fondatore e promotore del progetto culturale [dia•foria: www.diaforia.org, che all’inizio del 2013 ha inaugurato un nuovo spazio dedicato alle scritture di ricerca: f l o e m a - esplorazioni della parola (http://www.diaforia.org/floema/).
Gilda Policastro, da “Esercizi di vita pratica”, Edizioni Prufrock, 2016, nota di Flavio Ermini
Gilda Policastro è poetessa, romanziera e critica letteraria. Dal 2017 è docente di poesia presso la scuola di scrittura “Molly Bloom”.
Il suo ultimo libro di poesie è edito da Prufrock (2017) e ha un titolo molto esplicito: Esercizi di vita pratica. Esplicito perché? Perché, come annuncia la stessa autrice, il volume “si nutre di elementi orecchiati sull’autobus o per strada, ma anche captati dalla televisione o da internet”, giungendo a configurarsi come un vero e proprio “apprendistato” della vita comune.
Sono poesie della conoscenza quelle di Gilda Policastro, un’immersione nel presente, dove vagare senza direzione, dove cogliere ciò che è privo di storia e di identità accertabile. Rispecchia, in forma poetica, la stoffa e la destinazione dell’esistenza umana: frutto dell’immediatezza e subito sommersa nell’oblio, tanto da rivelarsi priva di memoria.
Una sospensione è la vita degli esseri umani. Una sospensione letteraria che si manifesta tra un “non ancora” e un “non più”.
La vita e l’opera costituiscono un’unità totale. La vita opera sempre, che si scrivano versi o che si traffichi in internet.
Esercizi di vita pratica è l’esempio di un’esistenza che è ovunque, in ogni atto; tanto che può essere letta anche come una riflessione sulla scrittura. Una scrittura che non vuole più cadere in errore, ovvero non vuole più distinguere tra vita e letteratura.
***
La gente, è faticoso.
È un lavoro, ti guarda dritto negli occhi e tu non puoi distrarti, sennò ti
dice: a che pensi o non mi ascoltavi o altre note di biasimo. La gente man-
gia mentre ti parla e tu invece sei ancora lì che cincischi col menu, non
hai scelto, la gente sono a ne pranzo e tu sei lì imbambolato che decidi
tra un primo e la cotoletta panata. La gente si mette il cappotto e paga le
bollette aprendo il portafoglio mentre parla al telefono, guida e scrive una
mail, apre l’ombrello e si soffia il naso, guarda la tivù legge i libri scarica
la lavastoviglie la gente è multitasking totale. La gente riesce a correre nei
posti senza sudare senza fargli male le scarpe o rallentare se passano le
macchine che quando mai sulle strisce non ti possono inv...ma non guardi,
quando attraversi? Sì, ma le stris...la gente è utile agli altri, le agende, gli
appuntamenti, la cena, il vernissage, il calcetto, pilates, le merende dei
figli, lo scambio di coppia, la gente è pieno di gente, è faticoso.
Puzzle
Quando vai a trovare qualcuno malato
di solito passi davanti a un altro
malato nella stanza solo
nel letto sbagliato
Quando esci dalla stanza lo vedi
addormentato sul fianco uguale
al tuo malato soltanto
nel letto sbagliato
Te ne ricordi l’indomani
che sei passato dritto
non hai salutato
e nemmeno guardato
quell’altro
malato
uguale
solo
nel letto
sbagliato
Gilda Policastro è poetessa, romanziera e critica letteraria. Ha pubblicato i romanzi Il farmaco (Fandango, 2010), Sotto (Fandango, 2013) e Cella (Marsilio, 2015, vincitore del Premio Trivio 2017) e i libri di poesia La famiglia felice (Premio d’if, 2010), Antiprodigi e passi falsi (Transeuropa, 2011, con un cd di letture con musiche di Massimiliano Sacchi), Non come vita (Aragno, 2013) e Inattuali (Transeuropa, 2016, Premio “Interferenze” di Bologna in Lettere 2017). Ha collaborato con «il manifesto», il «Corriere della Sera, «Pagina99», «il Reportage» e con i siti «Le parole e le cose», «Doppiozero» (per il quale ha ideato e cura la rubrica Vite che sono la mia) e «pixarthinking». Ha pubblicato saggi di critica tra cui Polemiche letterarie dai Novissimi ai lit-blog (Carocci 2012), organizzato rassegne e festival con le associazioni “Poetitaly” e“Romapoesia” e dal 2017 è docente di poesia presso la scuola di scrittura “Molly Bloom”.
Maria Pia Quintavalla, una prosa inedita, “La tragedia di Augusta”, nota di Mara Cini
Un affresco dalle tinte bluastre, un immenso camposanto marino dove le forme della morte, nell’incessante trasformazione delle cose, diventano di nuovo vita. E’ una vita liquida, germogliante, vibrante nelle correnti profonde di acque ascensionali in una vertigine che avvolge.
Certe disperate vicende, nella cornice del racconto, luccicano di sacralità e bellezza (donne che come vele si alzano, non è un Compianto di Jacopo della Quercia? morti che volano, non è una scena del Correggio nella Cattedrale di Parma?).
Sono notizie di migrazioni e naufragi che i reportages giornalistici non riescono a descrivere nella loro portata tragica, Quintavalla le ricompone in un contrappunto di immagini fluide attraversate da musica e silenzio, acqua e siccità, luce e buio dove gli accenti di tutte le lingue si fondono in un salmo.
Da qualche parte Maria Pia Quintavalla ha parlato di una sua lingua apneica, una lingua e una scrittura che non sembrano estranee a questo testo.
La tragedia di Augusta
-
I pesci scappati dal fondo del mare impazziscono come asteroidi in forze centrifughe, ma dividendosi esplodono divergono tuttavia in lampi, come luminosi spazi, da entità marine stellari. Le assi diagonali in legno sembrano già fradice da notti, se hanno bevuto tutta quest'acqua e la trattengono; da questi legni fessurati dall'acqua. Da questi tagli uno strano mormorio di attese sembra salire e alludere a un intrecciarsi anche là dentro, ai gesti: del povero cibarsi, e dei corpi, ma poi deposti e abbandonati, poi enfiatisi nell' acqua, che si avvinghiano. Chi può vedere da quale occhio celeste vivente l'intreccio, non ancora marcescente ma mobile, e quasi di gomma, di bocca e piedi, di teste annodate che cercano di separarsi dal blocco che fu di carne. Ma questo ultimo è nascosto dalla fuga dei pesci. il fetore è nascosto o velato dalla fuga dei pesci. Le grida indisseppellibili a oratorio, ecco sono nei gesti di abbraccio, un poco come nelle camere pompeiane finite sotto la cenere. Mi avvicino, lentamente, e guardando da una fessura, un sottile taglio come l'interno del legno, subito ammollato e marcito, che mi fa intra-sentire intra-immaginare, e vedere infine il groviglio dei corpi, intrappolati come acini di un frutteto divino.
Ma io lo vidi già, era narrato: fin da bambina, nella corona di nudi e angeli della Cattedrale di Parma, disegnata e dipinta nella visione di Antonio Allegri, detto il Correggio, e questa è una simile ascensione, ma orizzontale, dove tutti cercano spazio, e lo comprimono anche, tutti, e si disperdono, anche alla fine. Materia nel liquido, carne che fu ossa e sangue e non gomma, e non blu morte ma vita, delicatamente corpi sacco, velati dalle acque, lì sprofondati e che l'hanno bevuta fino al punto della terra un equatore zenith, dove eravamo oceano su oceano. Una forza centrifuga, a onde, disegna un movimento come cullato, una leggera distonica musica spezzata: sono i morti, i semplici (e bellissimi) morti che volano nel cielo delle acque profonde, al largo della costa libica, nel blu scuro e macchiato di morte, del mare Mediterraneo. Quelle dita tumefatte hanno perso escrescenza, dopo che reso molle e gommoso lo scheletro tutto, ma non hanno esaudito un destino, o l'hanno fermato alla domanda impigliata nell' enigma dei gesti, nelle strette ultime dei tumefatti: queste voci sono nella gola del mondo. E loro: gli afflitti, i perseguitati, gli assetati di giustizia, lo hanno sottovalutato troppo il peso del mondo, questo peccato dei poveri di spirito. La potenza della realtà che sconfigge il loro atavico, il loro grande - di già perduto – sogno di vivere nella vita, la propria vita. Vivere nella pace l'esistenza di sé, e dei propri figli. nella onesta ricerca di un lavoro una casa una patria terra. In un esodo non scelto, ma dovuto alle guerre e alle carestie alla fame e alla predazione.
Ora, questo immenso camposanto è marino, l'assenza di pietà umana ha scelto il colore dell’acqua per manifestarsi, un cielo capovolto e profondo pieno dei pesci ora in frotte, ora in fuga. Secondo le parole di papa Bergoglio questa è la bancarotta dell'umanità che non ha trovato per ora, salvatori e salvezza. "All'interno del relitto, secondo quando accertato dalla Marina italiana, sono stati recuperati :458 corpi senza vita; a questi ne vanno aggiunti altri 169 raccolti sui fondali circostanti altri 48 ritrovati, che si avvicina molto alle 700."(Corriere della sera, 16 luglio 2016, Claudio Del Frate). Ma la scoperta che in cinque, in piedi, stavano in poco meno di un metro quadro disegna bene il come.
-
Hannina e Omar viaggiano da due lune e imprecisati soli, hanno poco alla volta smesso di parlare, e raccontarsi a parole nell' intreccio delle mani; a sera, quando il vento è calato e l 'acqua del mare da bere è stata sostituita dall' urina, e dal succhiare vecchie bucce sudice, che erano già seccate, o la pelle di frutta. Il loro silenzio è più soave dei pasti infetti della fame, croce che sta dentro il corpo e lo taglia in parte muta e parte che emette strano risucchio, doloroso sempre; i pasti dei bambini e dei più vecchi, non ci sono più né come favoriti né come protetti; né quelle donne che come vele si alzano, da accovacciate e strette, e solo a volte attaccano al nero dei capezzoli i loro piccoli, ma senza cavarne nulla.
Quando la luna si stacca dal fondo del mare, e sorge, è splendente anche per quelle anime di disperazione, e il vento le illumina, lente ombre di tenerezza. Conosciute nella vita dapprima, e sole, era tutto diverso, erano giovani erano vecchi, erano uomini nel fiore degli anni, erano coppie come Hannina ed Omar, e camminavano, avevano strade bianche e sabbiose o piene di terra, camminavano. La secchezza e il non farsi più domande ha fatto posto al miraggio di silenzio e alla rassegnazione. In realtà silenzio non ce n'è mai abbastanza, fra il rumore di acque irreali e immobili e dei venti, delle scie del barcone che trascina sé e loro, noi tutti e nessuno, esclusa questa notte al termine della notte... Gli accenti di tutte le lingue si fondono in un salmo.
Che succede. Staremo qui? ma no, era solo una pressione fra l'aria e il carburante, chi l'ha detto. Perché quel ragazzo piange allora? Ma lo vedi quel punto sotto la luna. E' una barca chiede Amina. Ashef batte le mani, ha quasi dieci anni, se è una barca ci salva e ci porta in Italia, vero? No, non lo sappiamo e non ci sono barche qui vicino, risponde la madre.
Non è nessuno, dice Mohammed, è una stella, e tu stai male, vai a dormire. Chi dorme mi stringe un osso. della mano fino a farmi malissimo, ma non la sento.
Maria Pia Quintavalla, nasce a Parma, ma dal 1983 vive e lavora a Milano. Poetessa e narratrice, si occupa anche di critica letteraria e collabora con l’Università Statale di Milano.
Tra le sue opere di poesia: “Cantare semplice”, (Tam Tam Geiger, India-USA 1984); “Lettere giovani” (Campanotto Editore, Pasian di Prato 1990); “II Cantare” (Campanotto Editore, Pasian di Prato 1991); “Le Moradas” (Empiria, Roma 1996); “Estranea” (canzone) (Piero Manni, San Cesario di Lecce 2000); “Corpus solum” (Archivi del ‘900, Milano 2002); “Canzone, Una poesia” (Pulcinoelefante, Osnago 2002 e 2005); “Napoletana” (Copertine di M.me Webb, Domodossola 2003); “Le nubi sopra Parma” (Battei, Parma 2004); “Album feriale” (Rosellina Archinto, Milano 2005); “Selected poems” (Gradiva, New York 2008); “China. Breve storia di Gina tra città e pianura” (Edizioni Effigie, Milano 2010); “I Compianti” (Edizioni Effigie, Milano 2013).
Gianni Ruscio, da “Interioranna”, Algra Editore, 2017, nota di Flavio Ermini
Gianni Ruscio è nato nel 1984 a Roma, dove vive. Pubblica il suo primo libro di poesie a 23 anni. Con Interioranna (edito da Algra nel 2017) è al suo quinto volume.
Tra queste pagine assistiamo allo spettacolo della nascita di un essere umano. Assistiamo alle vicende di un piccolo corpo che si nutre di un corpo più grande. Nella sua lucidissima prefazione, Gabriella Montanari ci parla di “amore dentro l’amore”, di “carne dentro la carne”, e definisce la maternità come un non-luogo, “un altrove in cui la sostanza muta mantenendosi intatta”.
La nascita è il moto originario che ogni volta si ripete e conosce un nuovo inizio. Vivere umanamente è un andare nascendo, è un continuare a nascere.
Assistere alla nascita di un corpo è assistere al rivelarsi dell’interiorità, al manifestarsi di labbra che hanno la forza e il coraggio di aprir bocca e parlare.
Si esce dalla casa materna con il desiderio di qualcosa, ma anche con la nostalgia di un possesso che alla luce del giorno non c’è più. Con la nascita non si cresce più nelle radici, ma nei rami. Non ci facciamo da soli: la vita è sempre qualcosa di ricevuto, ha sempre la natura del dono. E in questo dono ineliminabile è la tensione tra il sentirsi-parte e il voler essere-per-se-stessi.
Ruscio ci parla proprio di questa relazione d’intimità, di questa gratitudine che ci fa sentire anelli di una catena, parti di un tutto.
***
Nel bolo dell’ignoto che digerisce
sé stesso.
Due corpi uno.
Liquor
che ubriaca l’ego
e torna a rendere
uno
ciò che un tempo
era doppio.
***
Dai nervi incorniciati dal manto
della sera,
s’esprima la voglia, penetrazione
di un istante. s’annodi intorno
intorno nostra voce, richiamo
calamità e nastro breve.
***
se respirate, da questi
polmoni, uscirà
neve e sogno.
Rumore
miserabile e solenne, permea
e devasta, ricostruiscici sublimi.
Gianni Ruscio nasce a Roma il 7 dicembre 1984, dove vive tuttora. Ama il buon cibo, l’arrampicata e la vela. È un musicoterapista, un docente e, da poco, un papà felicissimo. Pubblica il suo primo libro di poesie nel 2008, a 23 anni. Continua la sua ricerca e nel 2011 esce il canzoniere “Nostra opera è mescolare intimità” per le edizioni Tempo al libro. Nel 2014 esce “Hai bussato?” per le edizioni Alter Ego, con prefazione di Roberto Gigliucci (ricercatore, italianista, esperto di poesia del 600, autore, tra le sue altre pubblicazioni, del libro edito da Bruno Mondadori “Cesare Pavese”, e docente di letteratura presso la cattedra di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza). Nel 2016 pubblica con la casa editrice Ensemble di Roma “Respira”, che si aggiudica una menzione al Premio Lorenzo Montano - XXX edizione - e vince il premio di poesia italiana indetto dall’editrice Laura Capone (tra l’altro gli unici due premi cui partecipa). Interioranna, edita dall’editore catanese Algra, è la sua quinta pubblicazione, con prefazione di Gabriella Montanari.
Marco Saya, una poesia inedita, “Stanza bianca”, nota di Ranieri Teti
Un’ambientazione filmica, costruita in piena luce, in un interno giorno che la regia dell’autore descrive come in un disadorno atelier e che trasforma in esterni mediante le onde di una radio, con il suo sonoro che passa, seguito dallo sguardo di una telecamera, da una parete a un marciapiede, con il semplice spostamento dell’operatore, fino a quando “cambia il set”. Fotogramma per fotogramma, inquadratura dopo inquadratura, decibel per decibel.
Come se avessimo ricevuto una nuova innervazione, l’aggiunta di un nervo che determina un senso ancora da sperimentare, che ci consente per la prima volta di esplorare un destino. In questo tempo in sospensione, il destino coincide con l’origine, resa evidente da una “scimmia primordiale”.
La sceneggiatura di Marco Saya all’improvviso prevede un ciak che muove nell’introspezione, dominato da un nero diffuso che allontana le stelle, fino alla redenzione del bianco.
Non tutto è incorreggibile. Non tutto accade come sembra. Rimane sempre un tempo senza nostalgia che recupera e motiva il nostro presente, nella metafora di una stanza bianca.
stanza bianca
Sei in una stanza bianca,
vuota con dei chiodi alle pareti,
cornici senza tele sul pavimento,
legni sparsi contorni di una
radio che urla la sua frequenza
sulla strada, una macchina
in retromarcia azzoppa la folle corsa
dei decibel, cani che latrano nel saloon
di un bar, rivoli-bava di birra lungo
il marciapiede.
Cambia il set:
un punto solitario,
la scimmia primordiale,
una stella lontana,
il nero del buio acceca la luce
della domanda.
Scuse ... in ritardo
la stanza bianca ti chiede scusa,
la pelle della specie non ha saputo
proteggerti dal sole del tempo.
Marco Saya è nato a Buenos Aires il 3 aprile 1953.Dal 63 risiede a Milano. Editore, musicista jazz e autore. Ha alle spalle diverse pubblicazioni per la poesia.
Giuseppe Schembari, una poesia inedita, “A conti fatti”, nota di Ranieri Teti
Giuseppe Schembari è stato uno degli ultimi esponenti dell’Antigruppo Siciliano, movimento letterario nato quasi parallelamente alla Beat Generation americana.
Da questo inizio, fino a oggi, il cammino per l’autore è stato lungo. Ha condotto alla fine il poeta in un luogo che somiglia a un’altura, da cui si può guardare indietro fino al tempo zero, ma dove è possibile contemporaneamente guardare avanti.
Questa zona poetica travalica le consuete coordinate: l’ago magnetico oscilla in ogni direzione. Dense nuvole nascondono la stella polare, quella parola che è ancora “imperfetta”.
D’altro canto, “A conti fatti”, non rappresenta soltanto la prova di una sintesi, un bilancio in versi reso ancora più tale dalla scrittura a epigrafe, così lapidaria, ma permette di intra-vedere i potenziali sviluppi di una poetica in divenire: senz’altro esito, ma insieme passo d’inizio, moto a luogo.
In eccesso o per difetto, se l’esistenza è un’iperbole e siamo nell’ambito del poetico, “la somma dell’accaduto / non dà mai // l’esatta proporzione delle sciagure”.
Proprio delle sciagure, perché l’esperienza letteraria ed esistenziale di Giuseppe Schembari si è sempre posta al fianco di chi subisce ogni sorta di violenza. Proprio qui, nell’incrocio dove la vita coincide con la poesia, si riesce a fotografare nitidamente l’immane, nell’immagine filtrata da un “sopravvivere senza cura”.
A conti fatti, e a quelli che saranno ancora da regolare, questa poesia così conclusiva di un periodo, ci lascia nell’attesa dei nuovi capitoli della “cronologia / di tutte le disobbedienze”.
A conti fatti
Conosco
la disciplina dell’assenza
in questo sopravvivere senza cura
sta qui
nell’ansia metafisica
dove si colloca
imperfetta la parola
Un alibi
dimentico di ogni scoria
nell’esausta
iperbole esistenziale
come la liturgia del suicidio
A conti fatti
la somma dell’accaduto
non dà mai
l’esatta proporzione
delle sciagure
nella cronologia
di tutte le disubbidienze
Giuseppe Schembari (Ragusa, 1963) ha pubblicato nel 1989 “Al di sotto dello zero” e nel 2015 “Naufragi”, entrambi con l’editore Sicilia Punto L.
Vincitore di numerosi premi, collaboratore di giornali e riviste, è compreso in varie antologie: tra queste, “Bisogna armare d’acciaio i canti del nostro tempo”, curata da Gian Luigi Nespoli e Pino Angione.
Ambra Simeone, una prosa inedita, “bette devis insegna”, nota di Mara Cini
Una storia raccontata in non più di dieci minuti, dice Ambra Simeone della sua prosa “bette devis insegna”.
La protagonista di questa storia, raccontata in non più di dieci minuti, è una signora ottantenne, con il suo maglioncino color grigio chiaro e un filo di perle. La donna è al confronto con ragazzi dalla giovinezza troppo pesante, i ragazzi di oggi. Il suo racconto, apparentemente surreale e un po’ cinematografico, testimonia una vita che è esistita veramente: un mondo annicinquanta dove un quarantenne è un uomo attempato, una donna di ventiquattro anni forse zitella a vita e i vestiti sono cuciti in casa con la “Singer”. Allora i binari della vita scorrevano lineari, la speranza di farcela era praticabile. In fondo la prospettiva di una carriera da casalinga, non era poi tanto male! Regina della cucina in fòrmica, una donna normale, non un’attrice!
Accontentarsi non vuol dire perdere, non vuol dire fallire, dice Ambra Simeone.
Anche affidarsi a un linguaggio basso, quotidiano, mimetico, scrivere la vita come uno se lo aspetta può diventare un atto di resistenza da contrapporre a certi abissi di tv e social network, ad invasive e sterili dimensioni virtuali. In un tempo dove non c’è tempo, in un susseguirsi di precarie emergenze, le storie di una signora ottantenne sembrano realtà aumentata, ma è vita vera vista con occhi veri…
bette devis insegna
la giovinezza è qualcosa di troppo pesante per noi che vorremmo essere vecchi, non semplice- mente vecchi è basta, ma vecchi come i nostri padri, uguali a loro, non affannarci più per un futuro che non riusciamo più a vedere, e mai saremo come loro adesso, con pensione assicurata, casa di proprietà, soldi in banca, che loro hanno un solo pensiero, vorrebbero avere tutti sedici anni, rughe scomparse, tempo persino mai esistito, venuti dalla guerra dei loro padri arrivati in pieno boom, ve- nuti dal boom arrivati in piena crisi, noi, che ci vuoi fare? quando penso a certe storie raccontate nei bar, che solo nei bar di certi paesi puoi sentire delle storie così, che proprio quando pensi di aver capito tutto, sbam!!! ecco che la senti, arriva un esempio di vita dei nostri padri o meglio madri, che è difficile accontentarsi per me, per noi, ma per loro, oh, no per loro no, una volta era così che an- dava, ora sono solo troppe rughe da cancellare e voglia di farsi rincretinire in tv per trovare l’anima gemella a settant’anni, oh, no...
questo esempio di vita è esistito veramente, non stiamo qui a raccontare falsità, dicono, trattasi di donna sui ventiquattro, anni ’50 del secolo scorso, ormai è andata non si sposerà più dicono quelli del paese, ma chi se la prende più dicono i genitori, occhi azzurri, bette devis insegna, e voglia di lavorare più che di accasarsi, passano gli anni, quasi trenta compiuti, zitella a vita ormai, signorina che vive in affitto da sola mantenendosi col proprio stipendio, vergogna, che donna! chi è questa qui che non vuole mettere la testa a posto? sputano le comari di paese, chi si crede di essere? appuntano le già mogli, le già madri annoiate dalle faccende di casa, otto figli, e mariti che fanno sempre più tardi la sera a lavoro, nessuno la guarderà più se continua ad uscire con le amiche, da sola, poveret- ta, neppure un uomo che le fa la corte, chissà come si sentirà sola, apostrofano le pie donne di chie- sa, e gli uomini indugiano, chissà se potrà ancora avere figli, pensano.
un giorno mette piede in una balera, donna sola che si mantiene lavorando, affitto mensile e ge- nitori ormai rassegnati, chi la guarderà più, ora? mette piede in una balera per passare la serata con le amiche, conosce un uomo attempato, magari solo quarant’anni portati bene, un sguardo cade dall’altra parte del tavolo, un cenno e un ricambio e poi la bella notizia, neppure un ballo da soli, ma voglia di accasarsi, lui vedovo e due figli a carico, niente romanticismo, le offre solo un contratto da firmare, un accordo, un patto da onorare a vita, lei ancora esce con le amiche, ma il primo pensiero deve andare ai figli, i suoi nuovi figli e la casa, lui ha trovato mamma e casalinga, lei ha trovato modo di metter fine alle malelingue, di mettere fine ad una vita diversa da quella che si poteva desi- derare negli anni ’50, di mettere inizio ad una buona routine, via alle danze, via al matrimonio, sen- za tante parole, senza troppo clamore, niente buffet per duecento invitati, né fotobook ricordo, due fedi sottili, il filmino non esiste, abiti cuciti dalla madre, finalmente è sistemata questa figlia mia! due sì che volano nella chiesa e bastano a suggellare il patto di una vita tranquilla, serena, monoto- na, normale, figli di lui, casa, amiche, lavoro di tanto in tanto, l’altra medaglia del patto, lui che por- ta a casa i soldi, tanto lavoro lui e minestra in tavola assicurata a cena, lenzuola calde la notte, tutto quello che serve per una vita come uno se l’aspetta, niente di più, niente di nuovo, cosa ti aspetti da una vita? cosa? accontentarsi non vuol dire perdere, non vuol dire fallire.
la raccontava al bar, ora la signora quasi ottantenne con gli occhi veri, sorriso negli occhi, bette devis insegna, la sua camicina stretta da un maglioncino color grigio chiaro, i bottoni fin su al collo e un leggero filo di perle, l’odore quasi di incenso, non c’era altro da dire che vita semplice era sta- ta, o forse non l’aveva raccontata tutta, ancora più semplice ora, passeggiate con le amiche al parco, pranzo e cena da sola, qualche volta coi nipoti, visite periodiche dal medico di famiglia, casa di proprietà lasciata dal marito, ricordi e cartoline perdute, forse niente lettere, niente libri, solo vita vera non raccontata ossessivamente su facebook, noi, loro, diventano un tutt’uno, eternamente sepa- rati da un abisso di tv, social network, non accontentarsi mai, volere qualcosa di più, sempre di più.
un secolo è passato, non si torna indietro, ora il matrimonio è da favola per due anni e il divorzio finché ce n’è e per il resto della vita, non si torna indietro dalla giovinezza mai avuta, ora c’è quella perpetua, un’anima gemella all’anno, come le votazioni del sindaco, e noi che vorremmo diventar vecchi come loro, noi o solo alcuni di noi, un secolo è passato e niente più posto fisso, un abominio anche solo parlarne, no, per carità, tutto cambia, tutto deve cambiare, niente più casa di proprietà, che da domani si vola in germania per trovare lavoro, per mantenere il lavoro, per cercare di non farsi più una vita, non abituarsi a niente, non accontentarsi di niente, non avere il tempo di innamo- rarsi di nessuno, non amare niente, figli meglio di no, che se è troppo tardi è un sacrilegio, se troppo presto a chi li lascio dopo la separazione? una vita rassegnata, accontentata, tutta lì, anni sugli anni, un secolo è passato, non si torna più indietro, mettitelo nella testa, se ancora ne hai una, una storia raccontata in non più di dieci minuti, quanto tempo ci avete messo a leggerla? e se un giorno vi ca- pita di incontrarla per strada, la signora dagli occhi azzurri che racconta la sua vita senza andare in tv a viverla in diretta, lei vi dirà, io mi sono innamorata di lui col tempo, con gli anni ho imparato ad amarlo, un giorno alla volta, ma non so, e neppure gli ho mai chiesto, se lui veramente mi amasse. sbam!!!
Ambra Simeone è nata a Gaeta il 28-12-1982 e attualmente vive a Monza. Laureata in Lettere Moderne, ha conseguito la specializzazione in Filologia Moderna con il linguista Giuseppe Antonelli e una tesi sul poeta Stefano Dal Bianco. Collabora con l’Associazione Culturale “deComporre”. La sua ultima raccolta di poesie “Lingue Cattive” esce a gennaio del 2010 per i tipi della Giulio Perrone Editore di Roma. Di quest’anno è la raccolta di racconti “Come John Fante... prima di addormentarmi” per la deComporre Edizioni. Alcuni suoi testi sono apparsi su riviste letterarie nazionali e antologie; le ultime due per LietoColle a cura di Giampiero Neri e per EditLet a cura di Giorgio Linguaglossa.
Liliana Ugolini, da “Appunti sul taccuino del tempo. I dolmen”, Fermenti Editore, 2016, nota di Flavio Ermini
Liliana Ugolini è poeta e autrice di testi teatrali. Il suo lavoro può essere definito come “teatro da camera per opere in versi”.
Coerente con questo spirito è l’ultimo suo libro edito da Fermenti: Appunti sul taccuino del tempo. I dolmen.
L’essere umano – registra Liliana Ugolini – ha due nascite: una nascita avviene nel mondo, ed è improntata sulla carne; un’altra nascita avviene nella parola, ed è fondata sull’essenza.
Il segno più chiaro della nuova nascita è la coscienza della nostra finitezza. La consapevolezza di essere per la morte.
Liliana Ugolini ci porta con la sua poesia dove spira il soffio dello spirito. Lì, sperimentiamo – in un unico magico momento – entrambe le nascite. Lì sperimentiamo la pienezza dell’essere, per cui il
finito si colora dell’indefinito e il presente diventa eternità.
***
…1893 Il voto alle donne
Nuova Zelanda. La nazione è piccola ma l’esempio di democrazia è grande. La voce in maggioranza è avanguardia di conquista e prende forma dal silenzio di secoli.
Ogni ciclo ha un inizio nei dolmen
Del sommesso sommerso ecco la voce.
Goccia pende parola e nel concetto
s’alza lo staglio di quel detto
che si doveva dire e che dà peso.
Misconosciuta sagoma d’oscuro
svela ora l’epigrafe e lì sta il vero
brivido assoluto e qui ti sento dentro
accolta nel gruppo dell’inciso
memorabile assurto al già compiuto.
***
…2014 Immigrazioni
Morti per acqua, vittime della speranza tradita.
I dolmen non esistono. Le pietre sono acqua.
Si sa che son del sogno le speranze
gioco infernale del precario.
L’innocente marea dello stupore
affonda in notti/pece
dove la lastra liquida livella i corpi vivi.
Lo strappo che ci porta sulla terra non terra
sostiene solo voci che si spengono
al lume delle fiaccole
e il grido terrifico che sale
è immane nell’abisso del sognare.
Il lungo sonno sia l’ultimo di rabbia
e i nomi dell’appello siano qui
vivi alla meta.
Liliana Ugolini ha pubblicato 19 libri di poesia, 4 in prosa e 4 di teatro. Da questi sono stati prodotti 12 spettacoli teatrali e 2 opere/concerto. Ha curato per 16 anni in “Pianeta Poesia” la poesia performativa e multimediale documentata in tre libri. Collabora con l’Associazione Multimedia91 all’Archivio Voce dei Poeti e fa parte del gruppo performativo “Cerimonie Crudeli”. E’ stata redattrice della rivista “L’Area di Broca”.
Annarita Zacchi, una poesia inedita, “Cantionum inventor 2”, nota di Ranieri Teti
Annarita Zacchi ha scelto un titolo latino, e bellissimo, “Cantionum inventor” per un testo decisamente moderno nel suo svolgersi, fino alla sua spiazzante conclusione.
Solo in poesia può accadere che un gesto tanto quotidiano, quello raccontato in questi versi, abbia una trasfigurazione così ricercata?
Solo in poesia può succedere, all’improvviso, di “raccogliere pezzi di ciò che sembrava indivisibile”? O di vedere una collina ad esempio viola, e l’oro, scintillante in ogni immaginario, cupo?
Annarita Zacchi non possiede solamente forza visionaria, ma in questo testo riesce a produrre, assolutamente fuori dalla metrica classica, una musicalità incantatoria e mutevole, un ritmo esattissimo che alterna versi brevi e lunghissimi, che assecondano le fasi del sonno e forse del sogno.
C’è qualcosa di onirico.
C’è qualcosa di ipnotico, che non deriva solo da alcune ripetizioni dello stesso incipit, è contenuto in maniera decisa nel suono complessivo del testo.
Nei vasi comunicanti tra la vita e la scrittura, sulla soglia che unisce e separa, questa poesia riesce a raccontare “giorni inspiegabilmente netti / come se il fuori contribuisse al nitore del dentro”.
cantionum inventor 2
questo non significa che non abbia una sua tana
dove si è trattenuta con resti e nuovi incontri
in questi giorni inspiegabilmente netti
come se il fuori contribuisse al nitore del dentro
imparare a dilatare la rete e da lì
infilare una mano a raccogliere pezzi
di ciò che sembrava indivisibile
questo non significa perdere la vista
non sentire l’avvicinarsi dei corpi anche a distanza
dalla collina viola, si sporge verso di lui
nell’ oro cupo cala con un'altra corrente
più calda, trovata e ritrovata nel tempo
questo non significa cadere addormentati
lei porta e riporta le ciotole
piene e poi vuote, va e viene tra il fuori e il dentro
questo le ha richiesto nel tempo di non distogliere lo sguardo
non è detto che l’amore accudente sia sonno
sia solo sonno. Forse lo sguardo che lo coglie è nella nebbia
non è detto che la donna - la stessa - sia addormentata,
lei scrive e fuori è molto buio, scrive nel nero e questo è pauroso
e se è pauroso significa non piatto quanto si crede, quassù
le notti passate scuotevano il corpo, il vento lo frustava
occorreva afferrarsi al letto, legarsi a un ricordo di pace
e non era detto che tutto ciò fosse solo male,
la donna sembra portare la ciotola ancora piena,
mentre l’altro pare sazio, ma questa
non è detto che sia la conclusione.
Annarita Zacchi è nata in Garfagnana e vive a Firenze.
È insegnante di italiano a stranieri all’Istituto Universitario Europeo di San Domenico di Fiesole (EUI) dove tiene anche laboratori di scrittura, camminate letterarie ed organizza eventi legati alla poesia e alle arti.
Lavora inoltre come volontaria di corsi di lingua italiana a rifugiati e richiedenti asilo per la Caritas di Firenze ed altre associazioni.
In passato, ha lavorato come giornalista e redattrice presso quotidiani e case editrici.
Per la poesia, oltre a Rotte Terresti ha pubblicato Voi e lo sparso, Chipiuneart editore, 2015 Roma. Suoi testi sono stati pubblicati sulle riviste “Semicerchio” e “Clandestino” e nel volume collettivo Varianti urbane, mappa poetica di Firenze e dintorni, Damocle Edizioni, Venezia. Ha realizzato letture sceniche da raccolte proprie, tra cui Lavoro e antilavoro. Sogno dell’insegnante errante, con suoni, video e registrazioni di Leonardo Gandi. Collabora a riscritture poetiche e letture sceniche da testi classici, come Genesi e Qohelet, a cura della poeta Elisa Biagini.
Alcuni testi ed informazioni nel sito web di Annarita: http://annaritazacchi.weebly.com/
Ultima pagina: le immagini di Massimo Girelli per la mostra “Figure dell’immaginazione”, con la presentazione di Consuelo Tosi
Febbraio 2018, anno XV, numero 38

Il nuovo numero di Carte nel vento accoglie i poeti che hanno animato la giornata conclusiva del “Forum Anterem - Premio Lorenzo Montano” 2017. Ogni autore è introdotto da un redattore della rivista, così come avvenuto in diretta sabato 18 novembre scorso, presso la Biblioteca Civica di Verona. Sono, ed erano, presenti Maria Angela Bedini, Enzo Campi, Mauro Caselli, Silvia Comoglio, Lia Cucconi, Franco Falasca, Federico Federici, Vincenzo Lauria, Laura Liberale, Marco Mioli, Francesca Monnetti, Alberto Mori, Paola Nasti, Alice Pareyson, Chiara & Loredana Prete, Massimo Rizza.
Grazie a questi poeti, ancora una volta il luogo della poesia diventa un composito paesaggio verbale, in continua metamorfosi: la sua lingua è una sintesi di suono, respiro, senso, pensiero. Una sinestesia che coinvolge similmente nell’ascolto dal vivo e nella lettura.
Quale miglior viatico per la nuova, 32^ edizione che scade il prossimo 20 aprile?
https://www.anteremedizioni.it/files/file/BandoMontano32.pdf
In copertina, Federico Federici “Concrete poetry” (Calligrafia, disegno, scrittura)
Maria Angela Bedini, una poesia inedita, “Come la prima volta”, nota di Marco Furia
Espressive articolazioni
“Come la prima volta”, di Maria Angela Bedini, è una sorta di viaggio poetico (non a caso il componimento si apre con la pronuncia “io parto”) attraverso immagini, emozioni, sensazioni, pulsioni, che, per così dire, tendono a mostrare la non discordanza delle loro diverse fisionomie.
Una delicata, assidua energia è presente in versi che si soffermano con elegante intensità su singoli tratti e su un tutto scoperto e riscoperto, con equilibrata meraviglia, per via di ritmiche, tenaci, sequenze: l’autrice non si accontenta, vuole procedere e chiede al mondo di permetterle di osservarlo.
Maria Angela, esistendo con tutta sé stessa in una scrittura capace di offrire inedite possibilità di comprensione, invita il lettore ad assumersi la responsabilità di un nuovo vedere.
Sotto questo profilo i versi
“e la pianta dei piedi che trattiene il cammino
e lo inchioda a un passo dal firmamento”
mi paiono particolarmente efficaci.
Non mancano pronunce in cui si avverte una sorta d’intimo distacco
“e qui arrivo pellegrina del mio stesso sguardo
straniera nel mio corpo meticcia della mia pelle albina”,
né fanno difetto immagini affascinanti nel loro dinamismo cristallino:
“ombre fuggite dal calice del mondo”.
Naturalmente, la poetessa non può fare a meno di soffermarsi sulla materia della propria arte: il linguaggio.
Cito a questo proposito:
“come la prima volta ogni parola era detta”
e
“e una parola spaccava a terra e fa barcollare la casa”.
Ecco, a mio avviso, il testo preso in esame consiste proprio in una parola, “detta” per “la prima volta”, capace, con delicata perseveranza, di spaccare “la terra” e far “barcollare la casa”.
Siamo al cospetto di un originale espressionismo raffinato ma per nulla gracile?
Direi proprio di sì.
Come la prima volta
io parto dalle mie ossa bianche di sasso
da questa soglia tramortita
dove il piede slancia, svetta, chiede il varco pauroso
domanda i sorsi di buio e il calice della definitiva luce
come l’ostia che nella gola apre il medaglione
del mondo e lo inghiotte nel fiele dell’ostinato tramonto
io canto questa nota bassa che mi dà la febbre di vita
questa covata morte come nidi d’aprile che mi fa viva
adesso e lieve e scaltra di dolore e marchiata
nelle mie membra segnata appena di un parto
breve che fa purpureo l’occhio dei fiori
e cede il segreto balsamo del respiro
io vado allora per il fango
e canto l’abito inzuppato
la toppa della tunica sul cuore
lo strappo che scoperchia la vita
il brandello docile del viso
e la pianta dei piedi che trattiene il cammino
e lo inchioda a un passo dal firmamento
e marzo battezza i prati con un filo di brina
che somiglia al fiotto di una ferita
(…)
Maria Angela Bedini è nata a Buenos Aires, dove ha trascorso l'infanzia. È docente all'Università Politecnica delle Marche. Ha pubblicato le raccolte di poesia Trasgressioni (Premio "Senigallia - Spiaggia di Velluto", 1987), Essenze Assenze (Premio "La Rosa Editrice", 1991), Ma il vuoto fu scarso a sparire (in Nuovi poeti italiani 4, Einaudi 1995), Sempre tornò un inverno (Premio "Alessandro Tanzi", 2003), e, nella "bianca" Einaudi, La lingua di Dio (Premio “Lorenzo Montano”, 2004).
Enzo Campi, dalla raccolta inedita “L’inarrivabile mosaico”, nota di Giorgio Bonacini
In ogni libro c’è una zona di oscurità, uno spessore d’ombra
che non si sa valutare e che il lettore scopre a poco a poco.
Ne è irritato, ma sente chiaramente che in questo sta il libro
reale, intorno a cui si organizzano le pagine che legge.
(Edmond Jabés)
Scrivere un testo poetico a partire a una parola altra; proseguire la scrittura come fonte di formazione e deformazione di un nuovo atto significante; addentrarsi nel libro primigenio e riportarne a sé la metamorfosi compiuta di una nuova sostanza. Sebbene la scrittura poetica non abbia luoghi privilegiati di nascita, ma tutto e tutti, potenzialmente, possano realizzare – con elaborazioni, furti, svuotamenti, ricostruzioni e ogni altro paradigma selettivo – le potenzialità illimitate di questo dire, non c’è dubbio che il gesto comporti una dose di azzardo non comune. Se poi l’autore di riferimento è uno scrittore così fortemente aperto e interrogante come Edmond Jabès, che a partire dalla parola, attraverso la lingua, costruisce il testo arrivando al libro, come conglomerato ampio e stringente dell’impresa umana più audace, allora non si può non restare piacevolmente meravigliati. Ma Enzo Campi è poeta di solido pensiero e di progettualità linguistica costantemente tesa alla sperimentazione e ricerca di significati inesausti, quindi l’opera di Jabés è un approdo, per certi aspetti gravoso, ma ricco di sviluppi e diramazioni, e sentito necessario per le sue esplorazioni poetiche.
I libri di Edmond Jabés sono opere di profonda sapienza evocativa, dove la scrittura ha il suo senso iniziale nel vocabolo che, generoso e inesorabile, conduce il pensiero finale verso il libro: luogo aperto di vortici abissali; ma anche spazio dove inizio e fine, parola e cosa, nel fluttuante movimento della scrittura, altro non sono che spostamenti percettivi, posizioni concettuali o prospettiche che interagiscono e interscambiano se stessi, lì dove chi scrive deve necessariamente provare a superare i limiti, per far sì che il principio diventi anteriore e la fine divenga apertura. E in tutto ciò, lasciarsi scrivere o respingere o porsi in ascolto nell’inquietudine di una lingua.
Un’opera, dunque, che per essere accolta nella sua pienezza deve trovare una totale disponibilità nell’accostarsi alla domanda, prolungandosi in essa ma senza affondare, allontanando così da sé le rigidità della risposta. Perché se è vero che la parola può far luce, spesso è invece il silenzio a non oscurare. Nel libro (e allo stesso modo in noi, nella nostra solitudine), dice Jabés, la voce sta alla scrittura come il dire sta al testo, e tutto si intreccia e si apre continuamente, e non c’è spazio, nell’opera autentica, per chiuse definizioni. Enzo Campi, di tutto questo ben cosciente, procede per scelta esemplare dal corpus dei libri di Jabés, e sceglie un’opera apparentemente esigua, ma in realtà fulcro centrale di sintesi di un pensiero, di una scrittura e di narrazione poetica. Per dirla con Roland Barthes, estrae la parola infinitamente vasta che giunge a lui e ne fa la spinta propulsiva per la formazione e lo sviluppo del suo inarrivabile mosaico.
L’opera è Récit (accompagnato dalla Lettera a M.C), racconto poetico, evocazione immaginante dove le parole sembrano germogliare in chi parla. In uno spazio senza luogo chiamato isola, metafora pensante di una solitudine esistenziale (“gravida di fonemi impronunciabili”, ci dice Campi), Il e Ile, i pre-iniziali in questo esilio naturale, si volgono ad accogliere il dire mancante che sta nella lingua di una poesia che è sempre voce anteriore di una parola indecidibile. Parola precisa, però, nel suo imprimere il segno della condivisione e del rimescolamento di ciò che è l’isola e di ciò che nell’isola sta. In questo senso la scrittura ulteriore di questa raccolta poetica, si determina forse a partire dal rumore che l’onda produce insistentemente contro l’isola.
È il graffio della scrittura sulla pagina, il gesto “sovversivo” che risuona tra un vuoto e l’altro; con la leggerezza che il silenzio trasporta in sonorità foniche e grafiche; ma anche la fisicità dei sensi irriverenti che, in queste pagine fanno dire a Il: “il tuo corpo è una mappa./Da poro a poro le linee lungo le quali transitare e in cui transitarsi”. E fanno rispondere a Ile: ”il tuo corpo è un libro di carne./Mi cibo di te leggendoti.”. E tutto il poema è attraversato dal monologo dialogante che l’isola ospita. Parlanti che depositano concatenazioni vocali, sillabe come filamenti fluidi, pensieri contratti o dilatati dal respiro, dove “nessuna virgola sopravvive/alla spaziatura della pausa/che annuncia l’intervallo”. Ma anche luogo che isola nei granelli di sabbia, nei chicchi di sale, e dentro di loro brulica, lasciando o concedendo voce all’onda, che con il suo “vasto rumore indocile”, dice Jabés, dà voce alla sostanza fonica che sorregge il mosaico di questa poesia. Una friabilità espansiva che muove nel fruscio intimo del pensiero e cresce nel brusio interiore della lingua. Eppure, ad un certo punto, lo stesso Campi ci avvisa che “...l’ingrato compito dei viventi/ è quello di assecondare il flusso delle/parole che precipitano come foglie/secche...”, quindi quasi un’apoptosi naturale del dire, verso la morte dei suoni significanti. Ebbene, se così è, perché in questa opera invece, l’autore, porta la poesia da una vita (Jabés) a un’altra (Campi)? Con quale fiducia nella voce detta? Nella parola scritta? Forse una risposta sta nel vocabolo “assecondare”: non come cedimento passivo a un destino ineluttabile, bensì nel senso di seguire un movimento, accompagnandolo anche là, in sentieri possibili non percorsi. Dunque non un’opera di specularità mimetica; ma nemmeno una scrittura apocrifa, come avrebbe potuto essere: bensì un dire ulteriore che prende avvio dalla vicinanza con l’autore di riferimento; dal desiderio di introiettare il suo dire pensante; dal piacere intellettivo che la metaletterarietà produce. Il tutto sempre alla ricerca, non di un astratto esercizio, ma di quella parola che la poesia rende tangibile, pur nella costante ondulazione dei sensi che si rendono inafferrabili. Perciò bisogna dimenticare il testo di riferimento, che pure ha la sua presenza, e partire da un nuovo oblio. Perché se è vero, come scrive Jabés che “il senso delle parole è quello della loro avventura, allora Enzo Campi ha sperimentato proprio questo. E l’avventura lo ha portato oltre l’origine, verso la pensosità di altri libri – delle descrizioni, dei flussi, delle interruzioni, delle cancellazioni – dalle cui frasi, all’orizzonte o tra i margini della pagina-isola, da Il e Ile prendono vita Ilio e Ilèa. Lei, selva naturale, lui il sostegno. Capaci di sovvertire lo sguardo sulla realtà per regalare “un’immagine rivelatrice”: il principio poetico vero e reale che ricompone il mosaico attraverso figure rovesciate.
Nel frattempo, essendo risultata vincitrice del 31° “Montano”, la raccolta di Enzo Campi è stata pubblicata da Anterem Edizioni, come prevede il bando. Per la lettura di alcuni testi: /linarrivabile_mosaico_di_enzo_campi
Enzo Campi è nato a Caserta nel 1961. Vive e lavora a Reggio Emilia dal 1990.
Autore e regista teatrale con le compagnie Myosotis e Metateatro dal 1982 al 1990. Videomaker indipendente, ha realizzato svariati cortometraggi e un lungometraggio: Un Amleto in più. Suoi scritti letterari e critici sono reperibili in rete su svariati siti e blog di scrittura, su riviste e antologie. Ha curato numerose prefazioni e note in volumi di poesia. Ha pubblicato Donne - (don)o e (ne)mesi (Genova, 2007), Gesti d’aria e incombenze di luce (Genova, 2008), L’inestinguibile lucore dell’ombra (Parma, 2009), Ipotesi Corpo (Messina, 2010), Dei malnati fiori (Messina, 2011), Ligature (Sondrio, 2013), Il Verbaio (Milano – Sasso Marconi, 2014), Phénoménologie (Bologna, 2015), ex tra sistole (Milano, 2017). Principali curatele Poetarum Silva (Parma, 2010), Parabol(ich)e dell’ultimo giorno – Per Emilio Villa (Milano – Sasso Marconi, 2013), Pasolini, la diversità consapevole (Milano, 2015). Ha diretto, per Smasher Edizioni, la collana di letteratura contemporanea Ulteriora Mirari e coordinato le prime due edizioni dell’omonimo Premio Letterario. È stato ideatore e curatore del progetto di aggregazione letteraria “Letteratura Necessaria”. È direttore artistico del Festival “Bologna in Lettere”.
Mauro Caselli, dalla raccolta inedita “Zamejca”, nota di Giorgio Bonacini
Mauro Caselli ci presenta un poemetto, con andamento a scansione di quartine in rima e prologo ed epilogo in versi sciolti a chiusura. Le quartine, che sono il corpo dell'opera, alternano la voce interiore di un figlio, con le parole dirette a lui, del padre che non c'è più.
Così, chi di sé ha solo il ricordo, (il padre) rivive un’esistenza che si manifesta nel figlio, quasi come rispecchiamento, in una triste apparizione di ciò che, " ora e completamente/è quel che lui non è più ".
E le quartine rendono, attraverso la rima, ma senza meccanicità, il rimo del padre che parla al figlio, la cui pensosità parla e autoriflette sulle condizioni di un rapporto esistenziale.
Dunque, non un dialogo, ma qualcosa in più, che la forma poetica rende in soggettività e concettualità. Dove, il pensiero del figlio, in uno " spazio di presenza" , chiama la parola diretta a lui dal padre, " in un'imprevista apertura".
***
Il mondo intero, le persone e il resto,
si trovano davanti, sotto, sopra,
tutto intorno allo spazio di presenza,
giusto nel mezzo degli accadimenti.
Da qui si parte nelle operazioni
di raccolta, di analisi dei dati,
e qui si torna con i risultati,
continuamente. Eppure quel confine,
il punto esatto in cui si dà lo scarto,
da sempre è già varcato, oltrepassato.
La comprensione avviene dopo, a cose
fatte, nelle volute di memoria,
quando il perenne ritardo si piega
alla necessità di previsione.
***
C’è un figlio, con l’età
di suo padre, e ci sono
gli spazi vuoti tra
persistenza e abbandono.
***
Tu hai il passato, il presente
e hai anche un futuro, tu
sei ora e completamente
quel che io non sono più.
Mauro Caselli ha studiato filosofia con Pier Aldo Rovatti, laureandosi con una tesi sul concetto di riso in Nietzsche. Sulla scia del pensiero speculativo del Novecento – con riferimento in particolare ad Heidegger, Merleau-Ponty e Lévinas - ha proposto un’indagine sul linguaggio letterario e le sue implicazioni ontologiche pubblicando in rivista studi su autori quali Penna, Dickinson, Shakespeare e su quelli di area triestina e giuliana, quali Saba, Marin, Giotti e Svevo. Professore a contratto presso l’Università di Trieste, in qualità di cultore della materia in psicologia dinamica Caselli ha ricevuto incarichi d’insegnamento nei corsi di perfezionamento della materia. Nello stesso ateneo attualmente insegna Information Literacy.
Caselli, oltre a collaborare con riviste del settore critico-letterario, è autore dei volumi di saggistica La voce bianca: su Virgilio Giotti (2004) e Il banderaro importuno: saggio su «Otello» (2013). Come poeta ha pubblicato le raccolte Il giogo (2004), Per un caso o per allegra vendetta (2008) e È veramente cosa buona e giusta (2014). Sulle sue poesie hanno scritto Roberto R. Corsi, Stefano Guglielmin, Tiziano Salari, Mary Barbara Tolusso.
Silvia Comoglio, una poesia inedita, “Antimondo”, nota di Marco Furia
La voce del dire
Con “Antimondo”, Silvia Comoglio presenta una breve versificazione il cui intenso ritmo sembra derivare da naturale necessità: le parole sono proprio quelle e non potrebbero essere altre.
Come staccando il frutto maturo dal ramo, la poetessa propone il risultato di un impegno poetico che chiede di essere ascoltato poiché c’è: insomma, la sua voce è spontanea.
Spontanea? Certamente, se con tale aggettivo non intendiamo un’immediata espressione (ad esempio il pianto del neonato), ma l’esito di tenace lavoro su un linguaggio che si vuole il più possibile aderente alla vita.
Il comune idioma, talvolta (anzi, spesso), si avvicina soltanto a ciò che vogliamo dire, delimitando uno spazio senza riuscire a entrarvi.
Affidandosi alla poesia, Silvia riesce finalmente a parlare, a comunicare agli altri un vivido quid che non può essere spiegato ma al quale ci si può riferire mostrandolo nei suoi molteplici aspetti.
Entrare in un territorio non implica necessariamente esplorarne ogni angolo e definirne i confini, al contrario può comportare il riconoscimento di un aperto divenire la cui mancanza di frontiere non deve scoraggiare, bensì indurre a promuovere ulteriori ricerche.
Ricerche linguistiche nel caso in esame, ma tali in senso proprio, ossia collegate a un vivere che non sta dietro le parole ma nelle parole medesime e che, dunque, esce allo scoperto, senza riserve, con sincerità.
Concludo con una citazione:
“Come rima di gechi trapassati nel cuore –
cuore della voce venuta in emergenza
la-cerando, a guado della bocca, il Sempre –
che si sghemba, in nudi, nudi melograni
virati in afasia”.
Antimondo
l’antimondo! è il solo punto
in cui l’alba si sorride : il forte
bacio di chi bacia noi che siamo
tutti - i paradisi!
*
Luogo dopo mondo ―
fu l’albero-miraggio di immobile silenzio
a fame declamato : avvento di terra già discussa
dopo che tu parli, a basso muro basso, di tánti
tanti fiori disciolti, in eco di fessura, cóme
come rima di gechi trapassati nel cuore ―
cuore della voce venuta in emergenza
la-cerando, a guado della bocca, il Sempre ―
che si sghemba, in nudi, nudi melograni,
virati in afasia
Silvia Comoglio (1969) è laureata in filosofia e ha pubblicato le raccolte di poesia Ervinca (LietoColle Editore, 2005), Canti onirici (L’arcolaio, 2009), Bubo bubo (L’arcolaio, 2010), Silhouette (Anterem Edizioni, 2013), Via Crucis (puntoacapo Editrice, 2014) e Il vogatore (Anterem Edizioni, 2015 – Premio Lorenzo Montano – XXIX Edizione - Sezione raccolta inedita) ed è in corso di pubblicazione la raccolta scacciamosche con la casa editrice puntoacapo.
Nel 2016 ha scritto per The small outside di Gian Paolo Guerini Piccole variazioni, concerto apparso a puntate sulla rivista on-line Tellusfolio (http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=19913). Per Il vogatore è stata composta nel 2015 una partitura dal compositore e pianista Francesco Bellomi e per Via Crucis nel 2016 sono stati realizzati quindici disegni dall’artista Gian Paolo Guerini.
Suoi testi sono apparsi nei blog “Blanc de ta nuque” di Stefano Guglielmin e “La dimora del tempo sospeso” di Francesco Marotta; nei siti www.nannicagnone.eu, www.gianpaologuerini.it e www.apuntozeta.name, sulle riviste “Arte Incontro”, “Il Monte Analogo”, “Le voci della luna”, “La Clessidra”, “Italian Poetry Review”, sulla rivista giapponese “δ” e nelle riviste on-line Carte nel vento, Tellusfolio e Fili d’aquilone.
E’ presente nei saggi di Stefano Guglielmin Senza riparo. Poesia e Finitezza (La Vita Felice, 2009) e Blanc de ta nuque, primo e secondo volume (Le Voci della Luna, 2011 e 2016), nell’antologia Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta (puntoacapo Editrice, 2012) e nell’opera di Marco Ercolani Annotando (La Biblioteca di Rebstein, 2016)
Ha partecipato, tra l’altro, al Festival di poesia di Ferrara “In gran segreto” e alla XXII edizione del Festival internazionale di poesia di Genova.
Lia Cucconi, una poesia inedita, “Tatuaggio”, nota di Marco Furia
Una tatuata denuncia
Con “Tatuaggio”, Lia Cucconi presenta un componimento davvero conciso in cui ogni pronuncia occupa un posto molto ben definito in una sequenza poetica breve ma ricca di valenze evocative.
La poesia si apre con un richiamo a una
“Imprimitura dell’ordine indiviso”
che, nella sua articolata e vivida dimensione, risulta “passeggera” e “parallela”
“dentro a regioni di paesaggi
nei feticci delle quinte
dell’immaginario quotidiano”.
Proiettati in un enigmatico mondo in cui la poetessa già vive, siamo chiamati
a riconoscerci in un’esistenza che sembra misteriosamente inquieta nel suo angosciante persistere.
Tuttavia qualcosa rimane:
“ma resta
fratturazione visionaria
della solitudine tatuata nel noi”.
Certo, la “fratturazione visionaria” di una “solitudine tatuata” non è molto, ma per la poetessa è abbastanza, poiché la sua, lungi dall’essere semplice presa d’atto, è vera propria denuncia che chiede ascolto e condivisione.
Qualcosa di non irrilevante, dopo tutto, si può sempre fare?
Senza dubbio e il richiamo di Lia è appunto questo: la parola non è fine a se stessa, ma è uno strumento che è in grado d’indicare una via da seguire, un àmbito entro cui è possibile mettersi in gioco in maniera feconda, sicché, anche nei suoi aspetti più sfingei, mostra una direzione, un itinerario.
Anzi, proprio certi misteriosi tratti, con la loro prossimità a un dire lontano dai comuni canoni, dunque più vero, possono essere tali da svegliare le coscienze assopite “nei feticci” di un “immaginario quotidiano” invadente e imposto.
Insomma, una denuncia e un monito.
Tatuaggio
Imprimitura dell’ordine indiviso:
nell’aridità
nella calcificazione
nell’essere
sopra la gloria del limite
della mancanza del cerchio:
è passeggera
è parallela
dentro a regioni di paesaggi
nei feticci delle quinte
dell’immaginario quotidiano:
ma resta
fratturazione visionaria
della solitudine tatuata nel noi.
Lia Cucconi ha pubblicato tredici libri di cui cinque in italiano e otto in dialetto di Carpi. Con i volumi dialettali è sempre stata finalista al Premio Pascoli. Tra gli ultimi editi in italiano ricordiamo “Intrusiva” (2000) e “L’imposta” (2010), prima di “Luoghi riemersi” pubblicato nel 2017 con Anterem edizioni. È presente in riviste e antologie.
Si sono occupati, tra gli altri, della sua poesia Giorgio Luzzi, Sandro Montalto, Giorgio Barberi Squarotti, Stefano Verdino, Manuel Cohen.
Vive a Torino.
Franco Falasca, una poesia inedita, “Le musiche”, nota di Marco Furia
Un necessario enigma
Franco Falasca, con il suo componimento intitolato “Le musiche”, ci introduce in un territorio la cui inquietante atmosfera (che ricorda certe pellicole ambientate in drammatici dopoguerra) non è esente da pronunce che rimandano al mondo della scienza.
Cito ad esempio:
“danze di protoni”
e
“abbeverandosi a una fontana di protoni”.
Una scienza vista (e vissuta) quale partecipe di una folle distruzione: l’annichilimento totale, tuttavia, iniziando a dissolversi, consente l’emergere di tratti esistenziali in cui meraviglia, stupore e, forse, barlumi di speranza, si mostrano secondo cadenze poetiche controllate e chiare.
Si possono citare, a questo proposito, l’incipit
“Camminavamo in una luce che era altra,
sfioravamo superfici che avevano altri colori,
pensavamo pensieri che erano come dolciumi”
e sequenze in cui non manca la presenza del sentimento e del giudizio, per quanto stravolti
“pulsazioni scambiate per sentimenti
giudizi preventivi scambiati per identità”.
Sul finire, il poeta si chiede
“se è possibile che tutto sia possibile”
e, naturalmente, non scioglie simile enigma.
Tuttavia nell’ultimo verso, ossia in quelle
“e tante e tante musiche per pulire gli orizzonti”
mi pare di avvertire l’emergere di una speranza o, addirittura, di un senso di fiducia che accetta il mistero rifiutando di esserne vittima.
Ciò da cui non si può prescindere, per quanto susciti interrogativi privi di risposta, va riconosciuto come un ineliminabile aspetto che non necessariamente deve essere considerato ostacolo da superare.
Forse, “è possibile che tutto sia possibile”.
Le musiche
Camminavamo in una luce che era altra,
sfioravamo superfici che avevano altri colori,
pensavamo pensieri che erano come dolciumi,
l’aria che respiravamo era fatta di onde,
le parole che usavamo era zampilli caldi,
le distanze erano immense,
gli occhi non esistevano,
la poesia non esisteva,
tutto era roccia,
bordate calde frenavano all’improvviso,
e nei rari incontri esseri colorati
dal collo lungo
ci chiedevano perché dove e quando,
imbruniti esseri smarriti
percorrevamo quel tratto di strada
poggiata sul niente,
diritti verso una meta fatta di niente,
come brutali filosofi falliti,
oh mente occulta che spadroneggi,
follie sensazioni tariffe,
danze di protoni,
moltiplicate per esigenze mediocri,
pulsazioni scambiate per sentimenti,
giudizi preventivi scambiati per identità,
le luci dell’alba sparite,
le ossa sparite,
i sentimenti spariti,
solo una calda luce viola all’orizzonte,
niente apocalisse o giorni del giudizio,
ma solo fili d’erba,
e nessun nocchiero,
solo una specie di birra come alimento,
non occhi per guardare,
vedendo tutto senza occhi,
abbeverandosi a una fontana di protoni,
e ripensando a queste bardature,
questi invisibili filamenti,
queste occasioni,
queste non-visioni
chiedendosi
se è possibile che tutto sia possibile
riuscendo a distruggere il sogno
che mi fece credere terrestre
in un lugubre inganno,
continuando a scambiare la morte per la nascita,
e tante tante musiche per ripulire gli orizzonti.
Franco Falasca è nato a Civita Castellana (VT), vive a Roma. Ha prodotto, oltre a poesie e racconti, anche poesie visive, films super 8, video, fotografie, performances. Ha organizzato rassegne e manifestazioni.
Nel 1973 fonda (con Carlo Maurizio Benveduti e Tullio Catalano) l’Ufficio per la Immaginazione Preventiva con cui collabora fino al 1979; partecipa come artista alla Biennale di Venezia 1976.
Suoi testi e materiali vari sono stati pubblicati, oltre che nei cataloghi delle mostre alle quali ha partecipato, anche su varie riviste ed antologie e nei volumi:
"UNA CA SA NEL BOSCO Prose e racconti", Edizioni Latium/Ouasar, Roma, 1990, vincitore del Premio Letterario Orient Express 1990
“NATURE IMPROPRIE (poesie 1976-2000) ” , Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2004, vincitore del Premio di Poesia Lorenzo Montano XIX edizione (2004-2005) della Provincia di Verona “LA FELICITA E LE ABERRAZIONI (poesie 2001-2010) ” , Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2011 “LA CR EAZIONE NOTA” , Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2017
Federico Federici, una prosa inedita, “Diario di alcune ore della notte”, nota di Mara Cini
L’idea di stare nello scorrere delle ore lasciando una traccia scritta “ravvicinata” è un espediente narrativo sempre produttivo. Nel caso di questa prosa di Federico Federici ne esce una forma a canovaccio piena di appigli e risonanze, anche per il lettore. Modulazioni, arresti di pensiero, riflessioni, percezioni che sembrano respirare ad ogni granello di sabbia che la clessidra rilascia.
Una registrazione quasi fisica dei sensi, all’erta nella notte.
La sacralità del buio con tutte le sue forme brulicanti (di preghiera?)
L’ansia che precede il sonno (ci sarà un risveglio?)
Poi viene un tempo che non divide le ore, un tempo inquieto d’ossa e di foglie.
La dimensione onirica e quella letteraria sembrano avere elementi in comune: ogni cosa è segnata nell’esilio del significato, ci si riconsegna all’alfabeto primordiale per destinarsi a un’altra alterità.
Diario di alcune ore della notte
La prima stesura di questi testi risale alla notte tra il 25 e il 26 gennaio 2014, unico ospite in una stanza di pietra sull'Appennino, nel disarmo della fine del mondo. Di queste pagine, esiste una versione in lingua tedesca, che le completa e accompagna.
(21:00) Arrivare fino al fondo, fino al peso morto, al salto del respiro che ci riconsegna il vuoto.
(21:04) La notte respira del mio respiro, pronuncia parole di pace.
(21:06) Diradare lentamente l'ombra intorno, muro di figure o suoni, dietro cui stanno la voce e il volto.
(21:10) Fu vera Luce a resistere al buio del mondo?
Fu ancora Luce, che si radicò in questi muri?
Sette le stelle e sette le rose che lo sguardo non spegne.
(21:13) Più del dolore da solo, abbiamo scosso anime nel sonno.
Dove è diretto il respiro dell'Amen? Dove si spegne sotto le palpebre?
Prima di te e di me, brulicava d'anime il fondo degli occhi, brulicavano intorno foglie nei boschi, un canto di spine.
Tutto un piccolo morire, che rompe i sigilli del mondo.
(21:15) Il fiato puro del bosco ci conta le ore di cielo, le ore di terra: soffiando sopra la scuote, sino a che il suono si spegne. Non è un prodigio?
Non tutte le porte sono porte del mondo.
(21:19) Dal nostro angolo di vento, rendiamo grazie a Sorella Tenebra, soffiamo sulla sua fronte.
La sua stella si muove dove tutte le porte si chiudono.
Un filo d'aria: un'altra anima sfugge al bosco.
(21:24) Le porte e le bocche rimarginano il vuoto, la cicatrice del mondo.
Parole, che noi non indoviniamo, custodiscono la piaga del tempo, in attesa del Giudizio.
(21:28) La parete non respinge il bosco.
Echi di detriti scossi, voraci assalti di radici, tra la soglia e il bosco.
Si ammassano le anime alla soglia e vacillano le pietre.
Le ossa, addentate negli anni dagli alberi, si pietrificano.
Una stella cerca la sua orbita. Piena di vento respira la croce.
(21:35) In certi vuoti intervalli, cade una foglia sotto la ruota dei mondi, scivola un altro tempo e altra oscurità.
Nessun ramo teso tra gli alberi. Di buio si copre anche l'albero, che regna e sorveglia sul buio.
(21:40) Non il buio di nomi carichi di spine. Non il buio di fiori mortali.
(21:48) Viene l'ora che nessun tempo prolunga.
Viene un tempo che non divide le ore.
Una foglia respira. Ancora una volta accade qualcosa, che alla fine dischiude il mondo.
(21:53) Ogni cosa si compone della stessa polvere elementare, ogni singola parola delle stesse lettere.
I resti sono inestinguibili.
(22:00) Qui più notturne che altrove sono le ore e le pietre e le stelle compongono i muri. L'Universo galleggia come un'anima nera, natura morta residua nel cielo.
Ascoltalo: stride. Il tempo agisce in fretta.
Di queste parole, una soltanto deponi sul mondo, affnché la tenebra alle origini abbia una scintilla.
(22:13) Ogni cosa è segnata nell'esilio del significato.
(22:15) Si ripete sempre ogni parola, si trascrive sino a cancellarla, sino a che ne resti solo il segno.
(22:20) La ferita scopre il vivo nella carne. Nella mia ferita son feriti tutti.
(22:23) Dopo il primordiale scoppio, il silenzio rimargina le parti.
(22:32) La Natura sopporta sillabe e cifre che, senza risposta, ricadono sul suo scudo ruvido di pietra.
Essa tace. Il respiro intorbida il pensiero. La misura disturba la qualità. Tutto è perso senza prova.
Ogni verso è uno stato tra i significati, un ritmo di continua metamorfosi, un canto di fallite incarnazioni.
(22:40) Rallentare anche il respiro: la vita è confine a due morti, è il fiorire da uno stesso stelo.
(22:50) Se ci sia davvero un Essere irriducibile al Creato, non fenomeno o fantasma che trasmigra da una forma all'altra, non è scritto nel poema del mondo, o non in questa lingua, perché frantumata dalla Creazione, mentre Chi crea è innominato, innominabile.
(23:05) Un lato dell'ombra è tenebra, un altro del silenzio è Dio.
(23:07) Ci separa da questa coscienza il vuoto spazio di significato tra una parola e l'altra, dove attingere al silenzio della Creazione.
(23:44) Non un soffio tra i visibili mondi.
Nessun volo attraversa la distanza. Il significato è isolato.
È uno spazio vuoto a cui non dà sponda la parola, perché nata per tacerlo.
(00:02) Si dibatte tra parola e corpo l'anima, creatura ancora incerta. Giunge al cervello, filtra attraverso tutte le ossa e ci trascende.
Ci rimanda al senso che lega identiche strutture.
Chi può fermare lo spazio e chi scuotere il tempo? Mente scinde ciò che Spirito coglie.
(00:50) Muro, pagina compatta.
Parole e pietre non esistono per sé, sono dettagli di visione, dettagli di un perimetro all'interno, o esterno al mondo.
L'occhio si fa della luce un'immagine propria. Solo la tenebra resta nitida.
(00:51) Tra le crepe è Realtà.
(01:03) Morire allora è un atto puro: dimenticare il senso della lingua in cui si è scritti,
riconsegnarsi all'alfabeto primordiale e destinarsi a un'altra alterità.
(02:00) Se quel senso invece è anima, particella d'io profondo, indivisibile, scarto minimo,
concreto, tra il sé e l'altro, nella morte non si rompe che uno specchio.
(02:25) Nello schianto del silenzio una stella esplode.
(03:00) [...]
(03:01) Il sussurro di un'allodola nell'orecchio vuoto della notte.
Federico Federici (1974) vive tra l'Appennino ligure e Berlino. È ricercatore, insegnante di Fisica, traduttore e scrittore. Nel 2008, ha tradotto dal russo e curato la prima raccolta postuma di Nika Turbina.Su rivista: «Conversation poetry», «Ditch», «Le Monde Diplomatique», «Maintenant – Journal of contemporary dada writing and art», «Nazione Indiana», «SAND, Berlin’s English Literary Journal», «Semicerchio. Rivista di poesia comparata», «The New Post-Literate», «Ulisse», «Utsanga» (et al.).
Raccolte: L'opera racchiusa (2009; Premio Lorenzo Montano), Requiem auf einer Stele (2010); lùmina (2012); Appunti dal passo del lupo (2013, collana a cura di Eugenio De Signoribus); Dunkelwort (2015; Berliner Literaturfestival “Stadtsprachen” a cura di Martin Jankowski, 2016); Parabellum (2017, in stampa); Mrogn (2017, in preparazione, Premio Elio Pagliarani 2016).
Vincenzo Lauria, dalla raccolta inedita “Teatr/azioni”, nota di Giorgio Bonacini
Trarre poesia dall’esperienza teatrale appare come un naturale prolungamento della materia scenica, verso una sintesi essenziale di sola parola e scrittura. In realtà non è così semplice. Il teatro è una multi-struttura di svariate componenti, mentre la sostanza poetica, nella sua unicità, le contiene tutte dentro un’unica materialità vocale. In questo poemetto, Vincenzo Lauria, riesce nell’impresa di farci vedere“i respiri e le pause” del recitare, con un dire che asciuga e scarnifica il fare teatrale. Con i suoi versi l’autore scioglie il rito dell’essere in recita, per trasportare il lettore dentro il tratteggio che fa spettacolo. Si percepisce, in queste pagine, il modo in cui l’andamento della visione porta a un vuoto d’opera, che solo la poesia può rimettere in struttura. E ciò attraverso un pensiero fonico che segue i retroscena e li oltrepassa.
Cliché III
Replica di se stesso il passo
il tempo breve
nell’intervallo tra un atto e l’altro.
Promesse d’inverosimile
carnet di carni fresche di macello
nel retroscena.
Ci apparterremo nell’appartarci
tra le poltrone numerate
si mormora d’acrobazie
a fine sala.
E nel salir s’inscena
per il sottile filo
che ci proietta
nell’al di qua
del vero.
Cliché IX
Prove costumi
delle ingentilite pose
si segnano misure
per dar corpo all’interpretazione.
La sostanza dei fatti
è nelle posizioni marcate al suolo
dislocazione di punti da cui partire.
Il moto a luogo porterà
al dove della parte
per un perché che non sa di sé
mentre nell’intreccio dei ruoli
è il reiterarsi
dell’alchimia,
rituale di vestizioni
in svestizioni
teatr/azioni.
Vincenzo Lauria nato nel 1970, inizia la condivisione del suo percorso nel 2001 all’interno di “Stanzevolute” gruppo di 11 poeti selezionati da Domenico De Martino (collaboratore storico dell'Accademia della Crusca e docente universitario di Filologia Dantesca a Udine).
Dal 2010 collabora con Liliana Ugolini ai progetti multimediali Oltre Infinito, Oltre Infinito 2.0, OL3 Infinito, Oltre Infinito 4 (Le stanze della mente). Dal 2012 Collabora con l’Associazione Multimedia91- Archivio Voce dei Poeti.
Ha partecipato a più di 30 reading e stampato in proprio 4 sillogi.
Riconoscimenti:
Set 16: Premio Casa Museo Alda Merini I edizione è tra i 20 finalisti con la raccolta inedita INF – INFernità IN Fieri
Lug 16: : Premio Lorenzo Montano XXX edizione segnalazione per la raccolta inedita Oltre Infinito scritta con Liliana Ugolini
Giu 16: Premio Nazionale Elio Pagliarani II Edizione - la silloge inedita Teatr/azioni è tra i 9 selezionati
Giu 16: Premio Internazionale Città di Como – III Edizione: la videopoesia FEDRA (in 3 minuti) è tra i 3 selezionati (video: Vincenzo Lauria, musiche: Tommaso Pedani, testi: Liliana Ugolini, voce: Gaia Nanni)
Mag 16: Festival Visioni Shakespeariane 2016 selezione e proiezione del video blob OFELIA – (Rilettura), testi poetici di Liliana Ugolini, Montaggio video: Vincenzo Lauria
Nov 15: Premio Lorenzo Montano XXIX edizione segnalazione ricevuta per la raccolta inedita Le stanze della mente scritta con Liliana Ugolini
Laura Liberale, da “La disponibilità della nostra carne”, Oèdipus 2017, nota di Rosa Pierno
La versificazione, in cui comunque la presenza di rari versi liberi accentua la percezione ritmica dei restanti, s'ispessisce con l'utilizzo di parole che costruiscono immagini erose ai bordi da una luce abbagliante, almeno quanto nel loro centro sono precise come un disegno stilizzato, e va costruendo una sorta di parabola privata della linearità del racconto, avente per fulcro la carne, luogo del pensiero e della colpa, delle percezioni e dell'espiazione, del tradimento e della rivincita. Il corpo è il teatro del mondo e la Liberale raccoglie nella sua silloge le gesta di eroine prelevate da testi epici, mostrando una particolare capacità di dipingere la scena coi colori del sangue rugginoso e dei germogli trasparenti, del chiarore dei volti delle madri e del nero dell'implacabilità, invitando a riflettere sul ciclo vitale del corpo che ritorna alla natura e poi ridiviene corpo ancora. Frutto, dunque, di quei "paratesti" studiati da Genette, la scrittura della Liberale sa condurre su vie cesellate e adorne di riflessi preziosi una riscrittura che è nuova creazione.
***
Dimmi di questo oltre.
Se, smerigliato il sé che fummo
abraso l’ego, raschiate via le scorie
di tamas, di nigredo
riluce la pepita
ritorna a sfavillare.
Ma lui non può rispondere.
Sapere, dice, ti fredderebbe il sangue.
Ti basti questo, dice:
l’odore della carne
portato nell’abbraccio.
***
Viene con la statura di un cipresso
presidia il buio, lo stento della lingua.
Non ti voltare finché le parole
non siano assolute come ossa.
***
La prima volta fu per l’addio
che febbraio condensava sui vetri.
Le tue mani, implorava
e attecchiva in te.
La seconda, il fantoccio
dissestato a tuo uso
traboccava nel poco
che di te concedevi.
In entrambe ordinasti
tempesta su quel seme:
Vieni disastro, mieti.
Laura Liberale è laureata in Filosofia, dottore di ricerca in Studi Indologici e ha conseguito il diploma del master Death Studies & the End of Life presso l'università di Padova. Ha ottenuto riconoscimenti in svariati premi di poesia e narrativa. Suoi testi sono apparsi su riviste e antologie. Ha pubblicato, oltre ad alcuni saggi indologici, i romanzi Tanatoparty (Meridiano Zero, 2009), Madreferro (Perdisa Pop, 2012); Planctus (Meridiano Zero, 2014); le raccolte poetiche Sari – poesie per la figlia (d’If, 2009) e Ballabile terreo (d’If, 2011), La disponibilità della nostra carne (Oedipus, 2017). È inoltre tra gli autori di Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 2012). Dal 2006, tiene corsi e seminari di scrittura creativa per adulti, adolescenti e bambini, oltre che di Cultura e Filosofia dell'India.
Marco Mioli, una poesia inedita, “Senza titolo”, nota di Marco Furia
Descrivere l’enigma
Con un componimento il cui esordio richiama certi serici tessuti cinesi, Marco Mioli mostra una non comune capacità di collegare immagini evocative e visionarie a comprensibili tratti descrittivi, quali ad esempio:
“ cementizi a milano il liberty
si scontrò con le bombe americane”.
Non mancano accostamenti davvero sorprendenti
“i sassoni i cimbri l’educazione sessuale
i rifugi alpini i confini le bombe chimiche”.
Siamo di fronte a una propensione al surrealismo?
Senza dubbio, a condizione, però, di tenere ben presente come le trame poetiche del Nostro si nutrano, più che di cortocircuiti linguistici o iconici, di molteplici elencazioni straniate e stranianti.
È forse, quello di Marco, un mondo del tutto inesistente?
Non direi, poiché ogni anche minima pronuncia non è per nulla priva di collegamenti con il comune idioma.
Insomma, il lettore si trova coinvolto in una dimensione conosciuta e, nello stesso tempo, ignota, misteriosa e affascinante.
L’enigma dell’esistere, certo, deve essere accettato, ma il Nostro va oltre: per lui simile accettazione è già un illusorio porsi fuori da un mondo di cui ognuno di noi fa inevitabilmente parte.
Sotto questo profilo il verso
“ogni parola è luce ogni parola è ombra”
non appare sfingeo, bensì descrittivo.
Descrittivo di una totalità che è anche individualità, perché per il poeta non esistono contrari che si negano l’un l’altro ma aspetti diversi mai in assoluta alternativa tra loro.
Un’originale sorta di coerenza, a mio avviso, pervade una versificazione che chiede di essere letta secondo se stessa, ossia secondo quell’originale continuità del dire propria di un autore capace di riflettere, con acume, sul mondo e sull’uomo che in esso vive.
***
lampassi di striate atomiche
cariche d'ercole glabro
stagno intraprendo scalfisco
la spuria noia lambire un tratto
d'asfalto trema il mare le suoie
cenere neve pizzo e noie (seni
siffatti plastici apocalittici)
caustici plagi di plagi
agonie diffuse sequenze ritmiche
attanagliamo i cuori attorno
a sinonimi rispondere moderatamente
un canto dove il marmo trova fine
eravamo a milano nasceva la sete
nasceva la sete tra i rulli d'arbusti
cementizi a milano dove il liberty
si scontrò con le bombe americane
ritorno dopo spari tra le pietre
vulcaniche e i dossi
tra gli aspetti aperti di vasellame neolitico
adriatico come il rollio di barche
cumuli di creta a cono per le donne
antiche le donne nuove
ma quelli decorati con le onde
ricordano l'affetto del mare
ritaglio dopo millecinquecento pasti
un comò una credenza
un pò di sonnolenza
stiva segmenti onnivori
presse e calcestruzzi marini
rimetto in luce l'esposizione
di lune
le lune dormono rovesce
sedimentano i semi del po
sabbia ruggine riotorto nel grembo
scanalato arcuato tele estroflesse
ebbre lontane pietre contemporanee
i sassoni i cimbri l'educazione sessuale
i rifugi alpini i confini le bombe chimiche
le teste dei bambini che non si muovono più
ogni parola è luce ogni parola è ombra
oscuriamo stanchi della luce
illuminiamo stanchi della notte
Marco Mioli (Vicenza 1982) si laurea in Architettura presso l'Università IUAV di Venezia e successivamente studia S cienze e Tecniche del Teatro approfondendo una ricerca sulla relazione tra suono, spazio e scenografia.
Attualmente si occupa di poesia, design e arte contemporanea.
Vive e lavora tra Trissino (Vi) e Pola.
Francesca Monnetti, una poesia inedita, “(F)orma”, nota di Marco Furia
Forma come possibilità
“(F)orma”, di Francesca Monnetti, è un vero e proprio poemetto le cui diverse direttrici, pur restando distinte, convivono e s’intersecano.
È presente il deserto, con la sua sabbia e le sue dune, ma non mancano riferimenti a città, a centri commerciali e, perfino, alla circolazione stradale (“aiuole spartitraffico)”: il tutto secondo cadenze brevi e sospese.
Sospese non soltanto per via degli abbondanti puntini (cito, a questo proposito:
“… volta … scorcio … cornice … squarcio
… ponte …poliedro … totem …
… monolite …anello … obelisco …),
ma, soprattutto, per via di un tono tendente a richiamare quello che non c’è.
Siamo al cospetto di una propensione allusiva presente ovunque, per esempio nelle sequenze:
“all’origine di ogni mio gesto
in ogni mio operare
confido in un trasalimento”
e
“Il carattere sinuoso
e la complessità delle forme
indicano ovunque
una combinazione di venti”.
Qualcuno potrebbe chiedersi: ciò che è evocato esiste o, almeno, potrebbe esistere?
In altre parole: la poetessa si riferisce a qualcosa di concreto?
Domanda inopportuna: il poemetto tende a mostrare un’immensità vivida e non circoscritta, sicché sarebbe davvero poco consono impegnarsi in ricerche riguardanti realtà esterne intese quali definite fisionomie.
Certo, il lettore è libero d’immaginare specifici aspetti e argomenti, nondimeno credo sia atteggiamento più appropriato lasciarsi coinvolgere, respirare quest’aria poetica, entrare a far parte, senza riserve, di un’atmosfera intensa e ricca di fascino.
La forma, per Francesca, è il presentarsi d’infinite possibilità?
Non ho dubbi in proposito.
Da "D’attacco"
Per lunghe distanze il vento
assume e trasporta rocce
in minuti frammenti
…reciproca consunzione
di particelle
soggette al trasporto
Materiali minutissimi
in sospensione…
…del tutto incapaci
di produrre l’attacco
…
In assenza di vegetazione
l’abbondanza di sabbia
e il forte vento
creano alveoli
…vere e proprie solcature…
Il trasporto di particelle
operato dal vento
incide e smeriglia
…nicchie di distacco…
…
Sollevata da un vortice
la particella ricade…
…delinea una traiettoria orbitale
risultante dalla forza del vento
e dalla forza di gravità
Tanto più la particella è piccola
tanto più lentamente…ricadrà
al suolo
A seconda della stabilità
della elasticità del granello
su cui cade…rimbalza
più o meno lontano
…il movimento…poi
riparte da capo…
(…)
Francesca Monnetti è nata a Firenze dove ha compiuto studi in ambito filosofico-morale. La sua prima raccolta, “in-solite movenze”, finalista al “Montano” 2008, è stata pubblicata da Cierre Grafica l’anno seguente. Una sua silloge inedita ha vinto la IV edizione del Premio Sergio De Risio nel 2010. La sua poesia è stata presentata nel sito blanc de ta nuque da Stefano Guglielmin. Una selezione di suoi testi poetici inediti è uscita on-line su “Arcipelago Itaca”.
Alberto Mori, da "Quasi partita", Fara Editore 2016, nota di Rosa Pierno
Se una partita di tennis consta soprattutto del suo percorso temporale, di cui il punteggio o la vittoria sono solo gli esiti finali, il suo iter si svolge, allora, entro l'indecidibilità o meglio l'iter è il regno assoluto di ciò che accadrà e che non si conosce in anticipo. È un momento nel quale non si può decidere che continuare a giocare, ma anche il modo non passa che per una constatazione del fatto, la traiettoria della palla, quasi fato. Lo scopo che Alberto Mori insegue, in questa difficoltosissima partita, davvero vinta, è appunto quello di dare voce a questa insolubile condizione del presente, che si determina esclusivamente attimo dopo attimo. Le parole usate da Mori sono del tutto eloquenti in proposito: un varco oltre che sguarnito è ‘incompreso’, la piega dei muscoli è appena ‘taciuta’, un impatto è ‘assordato’ e la parità giunge ‘scoscesa’. La "quasi partita" è partita linguistica, dove anche nel dialogo, nonostante vi giochino le regole della sintassi, esistono insondabilità che giocano tutte a favore del poetico, ma, appunto, sorprendenti.
#5
***
Affanno a parti invertite
Rapporto avverso
Prossimo al rovesciamento
dove preme assoluto recupero
***
Ora possibili punti stringono assidui
Sempre addentro continuano la serie
***
Dialogo interlocutorio
Poi la chiamata ferma
Oltrepassa la risposta
Immette lo stigma al controllo perduto
Alberto Mori, poeta performer e artista, sperimenta una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando di volta in volta altre forme d’arte e di comunicazione: dalla poesia sonora e visiva, alla performance, dall’installazione al video ed alla fotografia. La produzione video e performativa è consultabile on line sulla pagina YouTube e Vimeo dell’autore e nell’archivio multimediale dell’ Associazione Careof / Organization for Contemporary Art di Milano.Collabora inoltre,con molti fra i più noti poeti contemporanei, italiani e stranieri, per la realizzazione di letture pubbliche, manifestazioni ed eventi dedicati alla poesia.Negli ultimi anni più volte finalista del premio di poesia “ L.Montano” della rivista Anterem di Verona. Dal 1986 ha all’attivo numerose pubblicazioni, tra le quali ricordiamo Iperpoesie (1997), Cellule (2001), Raccordanze (2004), Utópos (2005), Bar (2006), Raccolta (2008), Fashion (2009), Objects (2010), Financial (2011), Performate (2011) Piano (2012), Meteo tempi (2014), Direzioni (2017).
Paola Nasti, dalla raccolta inedita “Cronache dell’antiterra”, nota di Giorgio Bonacini
Con questa raccolta Paola Nasti ci porta in un mondo altro: atopico, ulteriore, postumo, ma anche in una metafora poetica dove la disgregazione, attraverso una scrittura di notevole capacità visiva e visionaria, sembra muoversi ai fondamenti di una nuova creazione. Ma questo mondo di disappartenenza, sembra non avere solidità e gli esseri che la abitano sono divisi, anche frantumati, o ancor più sciolti dentro e fuori, tra odio e non amore. Al centro la nostalgia delle origini. Non una nostalgia ingenuamente intesa come ritorno a ciò che non c'è più, ma riassunta in un rito di finzione verosimile, vissuto nello sguardo di una natura virtuale. Tutto e tutti sono senza corrispondenza e senza rispondenza, e la poesia dell'autrice si incarica di dirlo con la precisione delle parole dove “cucite le rime/niente più bacia”.
***
sotto le coltri soffici seguivamo il trascorrere delle stagioni, le foglie
erano le stesse, non cambiava quel senso di sconforto
quando qualcosa cessava - fosse un sogno o una vita
nessuno si poneva le domande
che oggi irrompono e ci spezzano i vetri
i giorni passavano lenti e senza noia, noi
con gli occhi bene aperti a guardare fuori
da lontano perlustravamo i perimetri dei continenti
ne seguivamo il contorno con il dito
cercando di essere attenti
ad ogni insenatura di costa, alle faglie che da quaggiù
si vedono anche ad occhio nudo
non speravamo di essere lontani
non c’era sogno che potesse distoglierci
dal contemplare quell’orizzonte buio, il suo sfumare lieve
nel punto di sutura tra terra e cielo
***
per le barche non c’è approdo
disse
per i natanti non c’è gomena che tenga, le ancore
non possono saldarvi, disse, ad alcun fondo
resta il fluttuare, il girovago moto intorno al pianeta
la richiesta inevasa di un porto, il grido per ottenere
il grido per non perdersi del tutto
così disse
Paola Nasti è nata a Napoli nel 1965, dove vive e insegna filosofia nei licei. E’ redattrice della rivista di poesia Levania. I suoi testi – poesie e racconti - sono pubblicati in antologie, riviste e blog.
Alice Pareyson, una poesia inedita, “Santificati Uffizi”, nota di Ranieri Teti
Quando una poesia si conclude con una domanda lascia una sorta di sfida al lettore, a una ideale platea.
Il testo si trasforma in una proposta di condivisione che rilancia con più forza ancora il tema originario. Tutto questo non è semplice, ma Alice Pareyson ha il dono di non preoccuparsene, inserendo nell’opera una dose di arguzia produttiva ed efficace.
Grazie all’alternanza tra discorso diretto e indiretto, scarti semantici e versi ora brevi ora lunghissimi, grazie alla coscienza e al suo flusso, in “Santificati Uffizi” si succedono svariate sequenze, tra lo sgradevole e l’apparentemente inenarrabile in versi, raccontati nell’incandescenza di una lingua che si presta a qualsiasi richiamo dettato dall’autrice.
Attraverso le sue pieghe più graffianti, tra neologismi, onomatopee e mistilinguismo, vertiginosi cambi di ritmo e improvvise interferenze, il linguaggio travalica e dilata fatti anche scabrosi, che possono essere accaduti ad esempio oltre i cancelli che non sempre sono quelli del paese delle meraviglie.
Santificati Uffizi
la radio interconnessa trasmetteva fonemi significanti al cervello che rielaborava le
informazioni nell’apprendimento ipnopaideutico.
la strada deserta
un uomo
anzi due
si parano a catena
prendendo per mano
una bambina
anzi due
la bambina
vicina
evapóra
assecondando Volontà irrepressa
avventurarsi abbandonando l’Io
negando l’Esistenza
riportando l’Essere all’Ente
in dubbio se parte del materialismo teologico
irruzione
nel paese delle meraviglie
dal cancello rimasto aperto
senza sviste
-doveva essere visto-
ma non a tu per tu
punto per punto
cancello 1
-non sbattere
appiattiti accovacciarsi
cancello 2
cosa vedi?
-non ignoto
bene entra
-ma dobbiamo andare non arriveremo
non importa devi guardare
-il capo di gabinetto sonnecchia
starà perfezionandosi lui pure
(nel giallognolo scuro tendente alla terra
liquefatta):
ma che ci fai tu ancora qui
ma che ci faccio ancora qui
se non mi ami più
se non ti amo più”
-ma che corbellerie va dicendo
non lo so ma ha ostaggi
no non uscire
-mi è impossibile restare
allora evapora pena la morte di entrambi
lampi di luci soffuse
sulle strade dublinesi
poche anime
il centro pullula di ragazzi e ragazze vestiti a festa
la strada deserta -again- con accento nordirlandese
nessun uomo
nessun velocipede
-come si sposterà
i piedi faranno cilecca nel parlare.
(puntinipuntini per ragioni ignote ma ignifughe)
questioni irrisolte
bisogna andare
qualcuno volerà
non importa chi.
-il cane diabolico ci osserva
non darti pensiero, ci penserà lui a disvelare
ancora il capo di gabinetto
ha uno scagnozzo bau bau
più che vestiti a festa
abbigliati da doppio agente
molto borghesi poco in borghese
nerissimi bucano gli occhi e nessun Hail Mary ci salverà, non questa volta. Ah, Holy
Hazelhatch! che fare?
-scagionali
no bisogna far presto e bene
-rimbrottali
scoprire cosa vale un diretto
-castrali- era la soluzione, idiota!
non muoveranno un dito
belli dopotutto
distesi
al sole del corridoio di un ospedale circense anzino -pardondisse- ecclesiastico
-i bambini?
saranno fuggiti senza il tuo aiuto becero rettile dattilico
temporeggiasti di fronte a cancelli
semiaperti
per poi semplicemente castrare l’anima di inetti – attenzione che ciò potrebbe fare di te
pure un inetto
come il capo di gabinetto
che ascoltava ostruzioni
-istruzioni
tsk! alla radio che trasmetteva
interconnessa
fonemi significanti al cervello che rielaborava le informazioni nell’apprendimento
ipnopaideutico.
volete raccontare voi pure un’esperienza giovanile
andata a buon fine?
Alice Pareyson è nata a Milano il 15 novembre 1994. Ha frequentato il “Liceo Classico Alessandro Manzoni”, è dottoressa in Lingue e Letterature Straniere e attualmente è iscritta alla “Facoltà di Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee” dell’Università degli Studi di Milano, dove studia in particolare Lingua e Letteratura Russa e Lingua e Letteratura Inglese.
Con un saggio sul sequenziamento del genoma, nel 2012 ha vinto il 1° Premio all’International DNA Day Essay Contest 2012.
Paolo JACHIA e Alice PAREYSON “Franco Battiato. La cura. 27 canzoni commentate 1971” – Fabio D’Ambrosio Editore, Milano, 2016, pag. 224
“Maurizio Cancelli arte del territorio” – a cura di Franco Falasca – Fabio D’Ambrosio Editore, Milano, 2016, pag. 128 – traduzioni in inglese di Alice Pareyson.
Chiara & Loredana Prete, dalla raccolta inedita “Orbitale”, nota di Giorgio Bonacini e delle Autrici
Con questi versi le autrici riescono a dar vita a un’opera che solo la poesia, che è uno speciale organismo linguistico, è capace di produrre: far aderire completamente la significanza del suono e del senso, dentro una materia naturale e così specifica, com’è quella degli elementi chimici.
Con un fluire sonoro di precisazioni emozionali, concettuali e fisiche, questi testi generano la meraviglia di un dire senza sbavature. Una scrittura che manifesta la sua limpidezza e che resiste alla dismisura, ma ugualmente attinge all’infinito stupore, verso un reale che trasmuta le cose in parole, e le aggrega in una forma di mondo pulsante. E ciò richiama a sé i tratti distintivi di ogni sostanza, con trasfigurazioni di voci e di immagini. Una poesia, dunque, che porta voce e figura ai componenti materiali del nostro vivere.
Ti 22 (Titanio)
Decade
Emivita
Stemperata
Aurea resiste
A refrattario soffio
Dissalazione Sparsa
come
cenere
azzurra
LIQUIDA
denti
spezzati
dissolvono
ruggine
Sc 21 (Scandio)
Volteggiano
(Foglie) scarnificate
su
Aritmiche pulsioni
Reflusso
di
cellule caustiche
Densificano
VAPORE
Tirannie
Ostentano
Morbosa
GRAVITÀ
Nota delle Autrici
In Orbitale nulla è lasciato al caso. Ogni poesia, ogni singola parola, è il frutto di un'accurata ricerca. La scrittura è dettata dall'anima, dalla decantata musa ispiratrice, dalla musica e dalla chimica. Ogni elemento è fondamentale nella composizione. La poesia esce dalle più segrete e profonde viscere dell'essere umano ma quando incontra la genialità della chimica la soluzione è esplosiva. Si consiglia una doppia lettura. La prima, quella più emozionale, è quella che si fa sul divano, a casa, magari sotto una coperta e con una tazza di tè fumante in mano. È quella che ti prende semplicemente perché riesce a cogliere quelle corde che si credevano spezzate o inesistenti. E se la musica gioca un ruolo fondamentale allora, per poter cogliere pienamente quello che si legge, bisognerebbe ascoltare David Bowie, Lou Reed, gli Smiths, i Radiohead, i Placebo, i Graveyard e del buon blues, perché anche loro sono parte palpabile di questa raccolta. La seconda lettura, quella più critica, richiede la conoscenza di ogni elemento trattato, delle sue proprietà. Solo così si potrà capire per esempio il motivo per cui in Ag 47 (argento) una poesia è "capovolta" come se fosse riflessa in uno specchio.
Nonostante sia un lavoro a quattro mani la differenza stilistica è minima, quel tanto che basta a rendere piacevoli le piccole discrepanze, i differenti moti del cuore delle scrittrici nel momento esatto in cui si gettavano a capofitto nei meandri più oscuri del loro essere. Lo stile è quasi identico grazie allo stesso vissuto familiare e alla stessa educazione letteraria.
Sono 919 i km che separano le due sorelle ma la loro connessione emotiva è strettissima ed è alla base di questo progetto letterario.
Nota bio-bibliografica per Loredana Prete
Raccolte di Poesie:
- Latitudine 49° 7’ 13,08” N Longitudine 17° 42’ 0” E (2005-2012 raccolta di 365 poesie, classificate per mese, scandiscono un periodo; scritte tra Metz e il paese natale, San Vito dei Normanni; un viaggio attraverso i sensi, le disillusioni, le paure, le sensazioni. L’incontro con ricordi; la latitudine è quella de Metz, la longitudine quella di San Vito dei Normanni).
- OSSA (2013) in corso d’edizione
- LIQUIDO (2014)
- AERIFORME (2015) edito da Limina Mentis Collana Ardeur 67 ISBN 978-88-99433-08-06
- SOLIDO (2016)
Antologie:
500 poeti dispersi, Libro secondo, AA.VV., Edizioni La Lettera Scarlatta, ISBN 978-88-908601-8-8
Habere Artem vol.16, AA.VV., Aletti Editore, ISBN 978-88-591-1399-7
Soglie IV 2016, Limina Menti Editore, collana Ardeur
Segnalazioni:
-30° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “Raccolta inedita“ con la raccolta di poesie intitolata Solido.
-29° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “Raccolta inedita“ con la raccolta di poesie intitolata Aeriforme.
-28° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “Raccolta inedita” con la raccolta di poesie intitolata Liquido.
-27° Premio Lorenzo Montano, per la sezione “Raccolta inedita“ con la raccolta di poesie intitolata Novembre.
Conferenze:
L’8 marzo 2013 partecipazione come autrice alla giornata poetica “Sbatte l’aria. Era una vanessa!”. (Università di Lussemburgo - Les lettre romanes – section italienne. L’incontro fa parte del progetto di ricerca del TIGRI – Textualité des Italiens de la Grande Région et Intégration).
Racconti
- Adele (2010)
- La messe rouge (2010)
- Iadava (2010)
- Accidia (2011)
- il vento di Cordoba (2011)
- Purificazione (2011)
- Amandoti (2012)
Sceneggiature
- Sogni in penombra (il cortometraggio ha partecipato al Festival Internazionale Cortometraggio Salento Finibus Terrae).
Massimo Rizza, una poesia inedita, “Senza titolo”, nota di Marco Furia
Urbane visioni
Massimo Rizza presenta una sezione della sua raccolta inedita “I corpi delle città”: tale sezione è dedicata a Urbino.
Per via di una prosa poetica ricca d’immagini, di rimandi a eventi storici e a un’attualità che di simili episodi è erede, secondo cadenze molto ben calibrate nel loro dinamico divenire, il Nostro descrive Urbino in maniera visionaria ma anche molto concreta.
È d’obbligo, a questo punto, la citazione
“antiche prigioni attigue alle stanze della lussuria, vasche di marmo dai caldi vapori, bagni / promiscui di penitenti delle passioni e delle malattie inguaribili, custodi di segreti familiari / violenze parentali tra lenti rintocchi della clausura, ossari sconsacrati e passaggi segreti / pietre dure e manoscritti oscuri che conducono al cuore del grigio antracite delle miniere / mutilata e orgogliosa, rifiuta le apparenze e le parentele, nell’unico occhio Urbino si fissa”.
Nella pronuncia finale (che ricorda il verso di Dino Campana “Genova canta il tuo canto!”) è possibile riconoscere un’infinita estensione che riesce a condensarsi in una vivida immagine la cui persistenza, come dicevo, partecipa del visionario come del reale.
La visione, anche la più mistica, non nasce dal nulla ma è espressione di un essere umano e del suo esistere nel mondo e dunque, in ogni modo, è collegata alla vita e al linguaggio.
Un collegamento che, nel caso in esame, oscilla e, tuttavia, non intende sacrificare la valenza comunicativa al puro immaginare.
Il risultato appare fecondo proprio per il suo poetico insistere, ossia per un tenace tentativo di dire di e nel il cui felice esito è una sorta di premio per il lettore e, perché no, per lo stesso autore.
***
dal profilo adunco, calva suonatrice di strumenti a corde, patria dei
traditori e delle faide familiari, dalle porte lignee mute e senza battenti,
custode di nobili segreti e di leggende, con le strade arcuate a spine dorsali
molli, luci taglienti dai vetri istoriati, di strani fantasmi gobbi e storpi che
si aggirano di notte, dove gli uccelli lasciano i nidi incustoditi e muti,
antiche prigioni attigue alle stanze della lussuria, vasche di marmo dai
caldi vapori, bagni promiscui di penitenti delle passioni e delle malattie
inguaribili, custodi di segreti familiari violenze parentali tra i lenti
rintocchi della clausura, ossari sconsacrati e passaggi segreti pietre dure e
manoscritti oscuri che conducono al cuore del grigio antracite delle
miniere mutilata e orgogliosa, rifiuta le apparenze e le parentele, nell’unico
occhio Urbino si fissa.
Massimo Rizza è nato a Sesto San Giovanni e vive a Segrate (Mi). E’ laureato in pedagogia e ha operato nel campo dell’istruzione in qualità di dirigente scolastico. E’ condirettore e redattore della rivista letteraria Il Segnale. Ha pubblicato la raccolta poetica Il veliero capovolto, Ed. Anterem (2016)
Suoi testi narrativi sono pubblicati in antologie e on line sul sito della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Testi di poesia, saggistica e critica sono apparsi su diverse riviste letterarie italiane tra le quali: “Il Segnale”, “Pagine”, “Anterem”, “Scibbolet”, “ Capoverso”, “ l’immaginazione”, " "Erba D'Arno".
Galleria fotografica del 18 novembre: immagini di Maria Grazia Veroni
Ultima pagina: Federico Federici artista visivo, nota dell'Autore
«Uno degli elementi sovversivi che giustificano il paradosso della comunicazione asemica risiede nella non esistenza di un genoma riconoscibile o implicitamente accettato dalla comunità. Ogni testo, indipendentemente dalla propria estensione, incarna l'espressione massima e unica di una lingua oscura, che ne costituisce lo stimolo e l'essenza. La potente sintesi iconica operata assorbe tutti gli elementi fonici tradizionali, consegnando la lettura a una pura esperienza visiva, contemplativa, anche laddove il carattere sequenziale delle tavole apre al recupero di possibili dinamiche narrative.
Ogni forma asemica non è, in sé, un enunciato. È piuttosto unaussprechbare Aussage che attiva le modalità interpretative dell'inconscio, rendendo superfluo il concetto di un a priori del significato. La lettura non consiste più in due fasi ravvicinate ma separate, una di decodifica e una di interpretazione, ma diventa attività creativa unica, condotta autonomamente sulla superficie libera del testo. [...]
Attraverso la pratica asemica, ogni artista sperimenta la condizione estrema delle minoranze linguistiche, incarnando la figura del primo e ultimo rappresentante di una neolingua o di una variante dialettale in estinzione.»
link:
http://federicofederici.net/projects/
https://leserpent.wordpress.com/category/asemic-and-concrete-poetry/
https://www.behance.net/federico_federici
Dicembre 2017, anno XIV, numero 37

Alla fine è bello quando succede. Quando succede realmente quello che tanto si è pensato.
In questo caso è anche possibile fermare il tempo, ritornare al ricordo nitidissimo di una giornata speciale, quella dell’11 novembre scorso al Forum di Anterem, che rimarrà irripetibile e che desideriamo celebrare nella sua interezza in questo numero di “Carte nel vento”. La foto di gruppo, poetica, che idealmente si rappresenta, è stata resa possibile grazie alla presenza di Doris Emilia Bragagnini, Fabrizio Bregoli, Marilina Ciaco, Gabriella Cinti, Aurelia Delfino, Roberto Fassina, Paolo Ferrari, Zara Finzi, Ettore Fobo, Michele Lamon, Attilio Marocchi, Raffaele Marone, Paola Parolin, Silvia Rosa, Claudia Zironi, tutti introdotti dalla giuria del “Montano”, che corrisponde alla redazione di “Anterem”.
Simile a un esergo è l’intervista di apertura a Bianca Battilocchi su Emilio Villa.
Se da un lato guarda alla sua recentissima storia, dall’altra parte questo Premio è già rivolto al futuro con la nuova, 32^ edizione.
Scarica il Bando del Premio
In copertina, Massimo Girelli, “Sonata”, tecnica mista, 1992-93
Bianca Battilocchi intervistata da Giorgiomaria Cornelio a proposito di “Una musa indiscreta” (quattro saggi su Emilio Villa)

INTRO di Chiara Portesine
Nell’ambito di una contingenza di occasione - il Convegno «I Verbovisionari. L’altra avanguardia tra sperimentazione visiva e sonora», svoltosi nelle giornate del 24 e 25 novembre 2016 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa - e a partire da settori di ricerca consolidati e felicemente paralleli, gli autori di questi saggi hanno cercato di mantenere una direttrice comune, all’insegna dello sconfinamento e della sfida costante che l’opera villiana richiede di mantenere aperta e operativa, al di là e al di fuori di rassicuranti soluzioni definitive. Il risultato è questo prisma conoscitivo, che offre al lettore un caleidoscopio di prospettive divergenti, se guardate con la lente della microscopia, ma che regalano una coerente visione d’insieme, non appena si abbia il coraggio di indietreggiare di qualche passo e concedere alla lettura uno sguardo d’insieme. Al di là degli approcci e del bagaglio metodologico dei singoli autori, il collante che unifica gli interventi è l’idea di forzare i confini del perimetro villiano, aprendo nuovi territori di intersezione e di intertestualità –ravvicinata (Costa) o a distanza (Joyce)–, oppure dilatando e andando a verificare in profondità gli esiti di alcuni macrotemi (i tarocchi e il «gesto» artistico).
G Bianca Battilocchi, che cosa segnala a tuo avviso la pubblicazione di questo nuovo volume di studi villiani?
B Penso che Una musa indiscreta sia un segno concreto di quanto stia accadendo in Italia e all’estero negli ultimi anni, ovvero un avvicinarsi sempre più e sempre più numerosi ad un autore così imprendibile e spesso ignorato in sede universitaria, ma ammirato da molti poeti (da Zanzotto a Raboni, da Spatola a Vicinelli). Il volume raccoglie infatti gli interventi ospitati in una cornice prestigiosa che ha finalmente dato meritevole spazio ad argomenti solitamente pochissimo frequentati dall’accademia italiana. Si è dato voce a Villa e ad altri autori ‘verbovisionari’ a lui vicini, James Joyce, Carmelo Bene, Corrado Costa, Adriano Spatola… come aspirando a quella “comunità di artisti dedita alla creazione e al recupero di una diaconia dell’immaginario” progettata dal poeta stesso: “Oggetto indefettibile della ‘diaconia’ che proponiamo, è l’IMMAGINARIO rilevante / rivelante; l’IMMAGINARIO da sorprendere come immanente / transmanente; e di conseguenza, l’IMMAGINARIO come illimite depuratore e depositario dell’INIMMAGINABILE.” Questi versi programmatici fanno luce su un immaginario proposto e sempre ricercato che è totalmente distante da quello imposto dalla società vigente, dal mondo dei mass media così come, in buona parte, da quello dell’arte e della cultura, soffocate da una mentalità conformista, all’inseguimento di trend o di baroni pronti a elargire ‘lasciapassare’. Tuttavia, chi si interessa a Villa sta facendosi sentire con più voce, dentro e fuori i circuiti accademici, con tesi di dottorato, pubblicazioni ed eventi interdisciplinari di varia natura, soprattutto in Italia, ma anche in Irlanda, negli Stati Uniti e in Brasile.
G Emilio Villa scrive “Ogni incontro o urto … sarà un contagio reciproco”. Credo che questo volume indichi soprattutto una strategia, una pratica di ribaltamento rispetto alle divisioni in parti, alla cronologia, ai pesi del genere o dei ‘generi’. È possibile pensare ad un’attività critica che, nel rispetto di questo scarto, sappia comunque rivelare il carattere della poesia villiana?
Io credo che sia necessario fare ricerca in questo senso, così come lo è stato a partire da Joyce, grande modello di un linguaggio inaudito per Villa. Come ci spiega Tagliaferri nel suo eloquente saggio, circa gli intrecci profondi e la “dipendenza agonistica” del secondo rispetto al primo, si tratta in entrambi i casi di una “letteratura come via d’accesso a una libertà assoluta, come presidio estremo in difesa del reale”. Villa scriveva per il futuro, era cosciente che ciò che stava producendo sarebbe stato fruito con più consapevolezza dai posteri, e in effetti oggigiorno sembrerebbe che le possibilità ci siano, considerando l’attenzione per l’interdisciplinarità, il focus sulla congiunzione di immagine e testo, e dunque sui binomi scrittori-pittori, poeti-teatranti, ecc. Certo Villa richiede più energie e collaborazione tra competenze disciplinari diverse per poter comprendere fino in fondo la natura del suo agon poetico, soprattutto richiede l’abbandono di appigli sicuri (“poetare è produrre crepe”). Il potenziale e l’attualità villiane sono enormi, Fracassa ne ha rivelato ad esempio le implicazioni con la neuroesterica a proposito dello stile e del contenuto dei testi raccolti negli Attributi dell’arte odierna, in particolar modo quelli dedicati all’arte-azione, del “gesto come fatto interno, pensoso”. Tagliaferri ha setacciato l’ancora inesplorato campo di convergenze, distanze e oltrepassamenti tra Joyce e Villa, pedinando le conseguenze testuali di un’“affinità elettiva” le cui premesse e punti di contatto costituiscono un bacino potenzialmente inesauribile di suggestioni. Portesine ha aperto uno stimolante caso di studio sulla positiva relazione tra il poeta e Corrado Costa, un esempio di collaborazione e ispirazione necessario per comprendere la nascita e il successo di tanti artisti che hanno gravitato intorno a Villa e che ne confermano l’autorità di ‘Padre’, come nel caso di Adriano Spatola o Patrizia Vicinelli.
G Quali sono secondo te le remore da valicare per poter dedicare maggior spazio a questo autore e alla sua opera?
B Gli ostacoli al momento sono differenti, per tanto tempo il principale è stato la reperibilità delle opere. È in circolazione fortunatamente da qualche anno l’Opera poetica a cura di Cecilia Bello Minciacchi, e stanno fiorendo le pubblicazioni di studi villiani, la nuova biografia del poeta per mano di Tagliaferri, differenti studi comparati, eloquente il caso Villa-Zanzotto ben delineato da Portesine. Quanto al resto dell’opera che comprende preziosi scritti sull’arte non più in commercio, traduzioni e vari altri testi poetici inediti bisogna rifarsi a specifiche biblioteche, se non direttamente agli archivi o, nel peggiore dei casi ai privati, che raramente aprono le porte. Un secondo problema, soprattutto nel ‘Bel Paese’, è l’interdisciplinarità villiana, il fatto che l’autore non sia catalogabile o accostabile a nessuna corrente letteraria precisa ma che le mescoli o meglio che ne tragga ispirazione per poi scavalcarle tutte; che tiri in causa al contempo le letterature semitiche e gnostiche, la filosofia presocratica, le arti preistoriche, le diverse avanguardie e neoavanguardie artistiche (tra i primi Breton, Duchamp, Bataille e Artaud), mirando sempre a non farsi soffocare da nessuno stile ma conquistando terreni sempre nuovi e fertili, distinguendosi nella sua magmatica unicità. Villa ha bisogno di questi “nodi” in quanto “ordigni”, strumenti necessari per le sue indagini che vogliono scuotere e fecondare l’“Immaginario” labirintico, per andare oltre al già visto - il dialogo avviene all’interno come per Carmelo Bene - e aspirare a epifanie, a una “revelation où rêve élation”.
G Nel titolo del tuo saggio parli di ‘perdita’ e di ‘riscatto’. Quale legame congiunge queste due parole?
Il mio titolo vuole riassumere l’invito poetico ad abbracciare il reale, nella accezione lacaniana elaborata da Tagliaferri nel suo confronto tra la poetica di Joyce e quella di Villa: abbracciare dunque il labirinto interno della mente e respingere la realtà esterna, giudicata gnosticamente come trappola, prigione. Aprirsi all’interno comporta il contatto con una dimensione illimitata che ci connette a qualcosa di superiore che in Villa equivale all’‘Eternità’, luogo-non luogo in cui ricercare incessantemente risposte, segni, come attualizzazione di un leitmotiv eracliteo: “Incontro è legare, e insieme, per slegare, slogarsi per logarsi”. I Tarocchi villiani, composti a fine carriera, sono un esempio di una poesia di segno apotropaico, che distrugge il conosciuto percependolo come limitato e limitante, e che costruisce senza posa nuove possibili vie d’uscita.
Bianca Battilocchi ha studiato all’Università di Parma, alla Sorbonne Nouvelle (Paris 3) e attualmente sta terminando un dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Studi Italiani a Trinity College Dublin. Il suo progetto di studio vuole offrire una prima edizione critica degli scritti inediti di Emilio Villa dedicati ai Tarocchi. Partendo da un primo focus sulle Diciassette variazioni (1955), ha discusso e pubblicato a proposito di Villa in Italia e all’estero, con un approccio di analisi testuale comparativo che mira a far luce sulla performatività e magmaticità della poesia villiana, i suoi legami ad esempio con l’opera di Antonin Artaud e Carmelo Bene. Recentemente ha pubblicato per «Engramma-La tradizione classica nella memoria occidentale» (n. 145, Maggio 2017) e un suo saggio è uscito per il volume di studi villiani Una musa indiscreta, edito dall’Archimuseo Adriano Accattino.
Fabrizio Bregoli, dalla raccolta inedita “Optoclastie”, nota di Laura Caccia
La rottura della visione
Il rispecchiarsi, nella silloge di Fabrizio Bregoli “Optoclastie”, di scienza e poesia, elementi di calcolo e parola, linguaggio tecnico e pensiero poetante pare mostrarci essenzialmente uno scarto: non tanto tra i diversi modi di esplorare il reale e di indagarne i sensi, quanto tra il reale e la necessità di aprirvi un varco, di violarne i confini.
Appare allora evidente l’esigenza di partire da atti di violazione e di rottura: la trafittura della materia, la profanazione della luce, la frammentazione dello sguardo e della visione, tese a spezzare l’apparenza, a penetrare l’oscurità, operando però non con la violenza del potere scientifico o della padronanza linguistica, bensì con un’azione di sottrazione e di scarnificazione del dire.
A premessa e conclusione delle due parti della raccolta, “Diario di Galileo” e “Eniac”, l’autore dichiara esplicitamente la sua scelta poetica: “Per questo scelsi minima / l’arte, perfetta / la sottrazione”, e il suo cammino teso a sfaldare il reale, proteso verso un oltre dove, come conclude, “per oscurità / fu se vi giunsi”.
È infatti un’opera di perforazione e di riduzione a caratterizzare la poetica della silloge, come precisa Fabrizio Bregoli, analogamente alla creazione dei supporti di registrazione nella prima generazione di computer, “Alfabeto di sottrazione. / Arte del togliere”, di natura sia linguistica che etica, per i linguaggi scientifici come per quelli poetici: passaggi stretti, angoli ridotti di visione, quasi un bucare la materia attraverso “minime crune di cannocchiale”. Per perseguire l’obiettivo di una parola chiara e netta: “un accento nitido / un asserire secco, senza chiasmo”, così come il “marchio a fuoco / di un idioma esatto: indecidibile”.
Un percorso irto di difficoltà, perché arrivare a tanto, cercare il calcolo come l’idioma preciso, è questione certo di ricerca, ma di una ricerca tesa ad una “voce primordiale”, per cui anche il calcolatore ci riporta ad “una sapienza antica”, ad “un idioma ruvido / dialetto dell’origine”.
E ciò a cui la ricerca poetica di Fabrizio Bregoli conduce non è sicuramente uno svelare significati, quanto piuttosto l’aprirsi ad una visione dissonante, a un diverso modo di approcciare il reale, la sua oscurità, il suo senso profondo, come leggiamo: “Non è d’atomo in atomo / un addensarne il plasma / un distillarne o concentrarne il senso, / piuttosto un chiuderne in un otre il vento / scioglierne in un bicchiere / la pastiglia di tenebre”.
Da “Optoclastie”
Dalla sezione “Diario di Galileo”
***
Da minime crune di cannocchiale
orbite, macchie o eclittiche celesti...
e tutto per ghermire la misura
d’un ordine, tutto nel calco esatto
di numero e compasso.
Campire la natura
coglierne in una smorfia il disegno del viso.
Farne un falso d’autore.
***
Non è d’atomo in atomo
un addensarne il plasma
un distillarne o concentrarne il senso,
piuttosto un chiuderne in un otre il vento
scioglierne in un bicchiere
la pastiglia di tenebre.
***
Quando in ipostasi si circonflette
l’orizzonte e d’antracite si sradica
il giorno, o in una trafittura docile
di nuvole quella luce artica... forse
allora hai scovato un cardias riottoso,
la biella da oliare, un glifo o una rosa
camuna su qualche rupe inviolata.
Il marchio a fuoco
di un idioma esatto: indecidibile.
***
Controverso se quando il buio
si maturò in materia, si scavò
il contorno d’uno spazio, vi fu
la pronuncia netta d’una sillaba
un verbo, il precipizio d’una luce.
Credo fu una corona di silenzio
a compitare la parola d’ordine
non lo scatto di qualche serratura. Qualcosa
più simile a un ronco quasi inudibile.
Di meno: un borborigmo.
Fabrizio Bregoli, nato nella bassa bresciana, risiede da vent’anni in Brianza. Laureato con lode in Ingegneria Elettronica, master in Marketing, lavora a Milano nel settore delle telecomunicazioni.
Ha pubblicato alcuni percorsi poetici fra cui “Cronache Provvisorie” (VJ Edizioni, 2015 – Finalista al Premio Caproni) e “Il senso della neve” (Puntoacapo, 2016 - Premio Rodolfo Valentino e Finalista ai Premi Gozzano, Merini, Saturnio). Ha inoltre realizzato per i tipi di Pulcinoelefante la plaquette “Grandi poeti” (2012).
Suoi lavori sono stati pubblicati in antologie di Lieto Colle, della Fondazione Mario Luzi e sulle riviste Euterpe, Alla Bottega, Circolo Pickwick e Versante Ripido.
Partecipa a letture poetiche, dibattiti culturali e blog di poesia. Ha preso parte ad alcuni eventi di azione poetica mito-modernista e alcune sue poesie sono state esposte congiuntamente a opere pittoriche in eventi organizzati dall’associazione Civico32 a Bologna.
Doris Emilia Bragagnini, dalla raccolta inedita “Claustrofonia” (sfarfallii - armati - sottoluce), nota di Laura Caccia
La voce al chiuso
Si misura con il limite del chiuso la voce di Doris Emilia Bragagnini nella raccolta “Claustrofonia - sfarfallii - armati - sottoluce”, a partire da un silenzio invalicabile e dalla conseguente dolorosa assenza di parole per accedere al mondo.
Nella ricerca di un dire che penetri il limite, la chiusura viene evidenziata dal susseguirsi di termini riferiti a barriere e oscuramenti: muri, porte, chiuse, pareti, sotterranei, stati di clausura, storie nascoste: “nulla chiama forte da farsi udire, è un movimento sotterraneo / il dispetto conquistato d’alfabeto”.
Allora dove cercare il movimento della voce, la sua possibilità di farsi ascoltare, di dire?
Una risposta, forse, ci può pervenire dal sottotitolo della raccolta e da un testo che precisa il rapporto con la delimitazione posta dal chiuso: “il muro tace, non risponde più / si lascia guardare angolandosi / in riproduzioni lessicali nei passi / o sfarfallii - armati - sottoluce”.
E sono appunto ciò che sfarfalla nel tremolio svolazzante, “come una farfalla”, quindi ciò che si attrezza alla lotta, come precisa l’autrice “cerco la nota distorsiva - quella - capace di cancellare il nesso”, e infine ciò che vive nell’oscuro, nei movimenti nascosti, nelle storie segrete, a consentire alla voce la possibilità di penetrare le chiusure, di schiudersi ad altro, come ancora leggiamo: “fu talpa farsi sorda di clausura / tremando poi - tellurica - nel raggio d’oltremondo / così tenero e malsano da penetrarvi il cuore”.
Poiché i muri sono essenzialmente interiori, nello sgomento di trovarsi nel vuoto e nell’assenza di sé, come della propria voce: “forse ti ho persa tu voce che vieni da inferi smessi / o il cervello s’infilza di vuoto come un cancello”, ma anche nello stupore di uno spiraglio, nella scelta di una diversa possibilità di uscita, “nell’altrove di un non c’ero”.
E quello che Doris Emilia Bragagnini pare mostrarci, con una scrittura che utilizza diverse possibilità espressive, è che, se da un lato è forte il bisogno di una lingua, un “desiderio la parola da dire / o bramosia di parole mancanti”, dall’altro è forse il non dire ad essere in grado di esprimere quella distanza “tra l'essere di ora e la parola”, l’apertura preziosa all’oltre, l’attimo in cui “le parole non dette / valgono più di un'aurora di maggio”.
Allora forse più che di claustrofonia, forse si tratta, per la parola e propriamente per la parola poetica, di claustrofilia, poiché è lì, nel chiuso, nel silenzio e nell’oscuro, nei suoi sfarfallii e nei suoi conflitti sottoluce, che la poesia affonda le radici, è lì che può custodire il suo senso profondo, segreto.
Da "Claustrofonia"
come sembra stretto il mondo
senza una parola per entrare
Dalla sezione “sfarfalliii – armati – sottoluce”
L’amaca fenice
nulla chiama forte da farsi udire, è un movimento sotterraneo
il dispetto conquistato d’alfabeto e ho un piccolo lobo d’orecchio
o forse meglio un lobo piccolo
c’è sempre un modo migliore di dire le cose per esempio
c’è un posto che non so quando dovrei dire quello che c’è
ma che non trovo - lo faccio scomparire
vorrei trovarlo per intero mi manca almeno quanto l’aria
tutta intorno se ci si sveglia nei giorni come crisalidi abbozzate
in un futuro pocket che pesa d’eterno
piccole dosi di massiccia confettura è limacciosa la sostanza
congetturale stringe sugli arti come carta moschicida
ti dondola sul nulla il palinsesto della vita, a favore di vento
il gancio - sospeso - al diritto d’uscita
Poco prima
c’è un’ora sulle scale quanto certi passi di piombo
si trascina luce dopo luce come una fiammella intirizzita
getta le ombre e i suoni lungo il muro del cordoglio senza nome
i sacchi di sabbia tenuti tra i pensieri li ha usati tutti
li ha usati tutti i sacchi di sabbia tenuti tra i pensieri chi dilaga
Dalla sezione “ipernauta”
La visura
mi sono chiesta dell’intorbidire i sensi
dell’ipernauta che abita la luna - oddio ho detto luna? -
che viene a farsi strada nella notte per parlarmi nell’orecchio buono
dice che ho venduto l’anima fingendola già morta che ho riso
danzato sopra i gorghi del contratto, come una fiammella già epurata
Oggetto della prassi
resta uno spazio sempre
tra l'essere di ora e la parola
colmato solo poco dall'esistere di sguardo
il rimandare stop del fotogramma
per timore che non abbia buona luce
imprimere una copertina sulla pagina invisibile
la non rivelazione - da qui all'eternità
Dalla sezione “nonnulla da tenere”
ho un’ora di tempo per darmi tempo
*
sinopia disgregandomi
al contrario essere traccia
transitorio è il mare come berbero
assordato dall’azzurro, teme il giorno
*
così dannatamente evidente
la pagliaccia tentazione del vero da dire in forma breve
architettura perfetta sfacciata geometria di pensieri tesi a incastro
oppure, starò ferma un giorno al numero tot del gioco dell'oca
*
del feretro riposto, un cappotto in panno topo
non ho mai sentito caldo - il bavero rialzato
come guglia emozionale fino alle guance
cinque dita in cucitura a interrompere lo sguardo, viola
*
allo stato organico del dispiacere di vivere
la similitudine intesa come non sufficientemente
permette piccolo spostamento strutturale
la percezione che consente di resistere
*
avevo un corpo un tempo lo sentivo contro il vento
ci sono punti d’attracco che sanno perdermi lo stesso.
Doris Emilia Bragagnini è nata nel nordest, vive da sempre a due passi da sé, qualche volta v’inciampa e ne scrive. Partecipa in qualche antologia (tra le quali Il Giardino dei Poeti ed. Historica e Fragmenta premio Ulteriora Mirari ed. Smasher), in blog e siti letterari come Neobar (redattrice), Filosofi Per Caso, Torno giovedì, Le Vie Poetiche, Linea Carsica, Il Giardino Dei Poeti (redattrice), Carte Sensibili, Words Social Forum, Via Delle Belle Donne, La Poesia e lo Spirito, La Dimora del Tempo Sospeso, Poetarum Silva. Ho partecipato ai poemetti collettivi “La Versione di Giuseppe. Poeti per don Tonino Bello” e “Un sandalo per Rut” (ed. Accademia di Terra d’Otranto, Neobar 2011). Menzione speciale per il testo “claustrofonia” al premio Lorenzo Montano 2013 e per “di fuga Soluta” nel 2016. Presente in alcuni periodici on line e cartacei tra cui Carte nel Vento a cura di Ranieri Teti, Espresso Sud a cura di Augusto Benemeglio.
Il primo libro edito: “OLTREVERSO il latte sulla porta” ed. Zona 2012.
Silvia Rosa, dalla raccolta inedita “Tempo di riserva”, nota di Laura Caccia
Sulla scorta di niente
È un tempo di resa o di attesa, quello che Silvia Rosa declina nella silloge “Tempo di riserva”, dove vengono messi a nudo disincanti e inquietudini, o meglio: il disincanto del pensiero e l’inquietudine della parola poetica?
“Un altro giorno spremuto in fretta / impastato intero - un grumo - / dentro tutto il tempo del mondo”: sono i versi d’esordio della raccolta, in cui l’autrice, nel dipingere vivide immagini e insieme desertificare il senso del vivere, fa crescere dubbi e schiudere tremori, non riflettendo unicamente un sentire soggettivo, ma facendosi implicitamente interprete dell’intera condizione umana, dell’essere gettati nel tempo, ora in un presente, colmo di assenze e di perdite, che non apre prospettive al futuro, come leggiamo, “Qui è dove il tempo / ci ha costretti / a un sogno in miniatura”, dove “Ci sono giorni da rosicchiare / come pane duro, / dal bordo annerito dell'alba / lungo la crosta delle assenze”.
I temi del tempo e della condizione umana, che hanno trovato numerosi interpreti nel pensiero filosofico e poetico, vengono declinati da Silvia Rosa attraverso un dire che ci parla di corpi e di stagioni, di stati d’animo e di voragini e che declina lentamente, con pacata inquietudine, in un precipizio dal sogno alla vertigine, dal reale all’abisso, “in questo / vuoto di noi”, come scrive, e nel “poco più del niente / che mi porto addosso”.
È un tempo di resa, “all'improvviso, inevitabile, arriva la resa, / la china dei giorni”, insieme di sottrazione e di rinuncia, di disattenzione “al buio di un tempo così distratto” e di indifferenziazione “l'amore o la morte, non saprebbe dire adesso / in effetti, la differenza”, con tutta la sua scorta di assenze e di vuoti interiori.
È anche, però, un tempo di attesa, di contenimento, quasi di protezione, come a farsi scorta invece di qualcosa da custodire, in cui contare i giorni “al calendario di un'attesa senza data”, tentando di recuperare il senso dell’esistere e di aprirsi a nuove prospettive.
E, in questa attesa, cosa ne è della voce, che, nel tempo personale dell’autrice, è passato dalla costruzione di “geometrie golose di parole” a “una scia di parole mute” e ora “torna ai suoi silenzi / collusi con le ombre, torna / a non dire a dire a metà”?
Restano soprattutto per Silvia Rosa, nel suo tempo di riserva, “il vizio mio identico / di cercare una forma, una qualsiasi / di assomigliarle un pochino” e il desiderio di crescere tale forma, farne nido di parola: “Quando tornerai ad abbracciarmi / avrò cresciuto un piccolo bosco / d’inverno, bianchissimo, / dentro le vertebre e in bocca”.
Da "Tempo di riserva"
Frontiera
Agosto ha uno scampolo di giorni
in movimento, una coda sfilacciata
una preghiera imbastita contro
il vento, una striscia rossazzurra di labbra e
cielo, leggera, dove mattino e sera
si confondono d'abbracci,
e noi siamo i punti di sutura
che chiudono l'estate e con spago fino
si aggrappano al momento: è qui, in questo
adesso di bandiera che scuote il tempo,
che ti verrò a cercare quando l'inverno
sarà una cappa bianca sbiadita, è qui
che resterò in attesa delle tue mani
per sentirle ancora mie dentro quest'abito
di corpo che mi sfila via e tu mi cuci addosso
vivo, un ricamo di mare, l’irrequieta frontiera
che sento fino in fondo mia solamente
nel nodo stretto del tuo sguardo.
Nera
Gli occhi in punto
in questo mezzo giorno
di precisa assenza,
ti guardo ripetuta in una foto
che rincorre la tua vita intera:
sempre nera la maschera
che indossi per ricordare
il lutto ‒ quando da bambina
hai mancato per un soffio l’appiglio
confortante dell’attesa, quel treno
spoglio, le mani che parlano
la tua stessa lingua nella forma
che il codice genetico detta
ai tuoi silenzi
ma io lo so che nonostante tutto
sei la stessa in ogni dove per
sempre quell’anima piccina
turchese e zucchero, nascosta
dentro un’armatura nera
in questa mezza notte bucata
al centro, il tempo che si inceppa
parallelo alla corsa decisa
delle tue parole, spalle al vento,
è il credito che tieni in pugno
nera impronta di un addio.
Prospettive
Il cielo ha una gobba di nuvole
in processione balene che danzano
allegre, ha un aereo di carta da zucchero
che vira in picchiata dentro un’acqua
turchese, un cigno di pietra che
mastica l’aria nell’accenno del becco,
una casa senza finestre vestita di gelo,
ma soprattutto il vizio mio identico
di cercare una forma, una qualsiasi
di assomigliarle un pochino
troppo difficile, forse, guardare all’azzurro
impalpabile senza una gabbia di occhi
domestici, senza un volto già noto che ammicchi,
senza prospettive plausibili – un appiglio –
per il volo di Icaro: l’informe è il buio
accecante oltre l’ultimo sprazzo di blu,
sfiorare l’immenso e perdersi il corpo,
il contorno dei sogni sfumato che resta
soltanto una scia del nostro giro di vite
e poi si richiude dietro di noi, come
una scheggia di vento.
Silvia (Giovanna) Rosa nasce nel 1976 a Torino. Laureata in Scienze dell'Educazione, ha frequentato il Corso di Storytelling della Scuola Holden di Torino (2008/2009). Organizza eventi letterari e mostre di arti visive e presiede l'Associazione Culturale ART 10100. Fa parte della redazione di Argo, cura per Words Social Forum la rubrica "Verso||Doppio||Senso" e per NiedernGasse la rubrica "L'asterisco e la Margherita", firmandosi con il nome di Margherita M.
Pubblicazioni:
2014: "Genealogia imperfetta", La Vita Felice, opera segnalata al Concorso Faraexcelsior 2014, menzione al Premio di poesia e prosa "Lorenzo Montano" XXIX edizione 2015.
2013: saggio di storia contemporanea "Italiane d'Argentina. Storia e memorie di un secolo d'emigrazione al femminile (1860-1960)", Ananke Edizioni, II ediz. 2014.
2012: "SoloMinuscolaScrittura", La vita Felice, opera segnalata al Concorso Faraexcelsior 2012, Premio Giuria al concorso "Cinque Terre - Golfo dei poeti Sirio Guerrieri" XXVI edizione, opera finalista alla XXVII edizione del Premio Lorenzo Montano, opera finalista con segnalazione di merito e Premio Speciale della Critica Giuria Scuole alla VI edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari.
2010: "Di sole voci", LietoColle Editore (II ediz. 2012), finalista con una menzione d'onore alla V edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari.
2010: racconti "Del suo essere un corpo", Montedit Edizioni, Collana Le schegge d’oro - i libri dei premi.
Alcuni dei suoi testi in versi e in prosa sono presenti in volumi antologici, fra gli altri: "Le donne pensano, le donne scrivono" Ananke Edizioni, 2008; "Pensieri d'inchiostro III", Perrone Editore 2008; "Rac-corti II", Perrone Editore 2009; "Corale per opera prima", LietoColle 2010; "Mosaici-Fragmenta", Edizioni Smasher 2011 e 2012; "Verba Agrestia", LietoColle 2011, "(S)frutta il segno" , La Vita Felice 2012, "Dicò Erotique", Lite Editions 2012, "Labyrinthi" vol. 4 Limina Mentis Editore 2013, "Stelle cadenti nel fiordo di Atlantide" Osteria del Tempo Ritrovato Editore 2013, "Come farfalle diventeremo immensità" , FaraEditore 2014, "Teorema del corpo - Donne scrivono l'eros" , FusibiliaLibri 2015, "Pasolini La diversità consapevole" MarcoSaya Edizioni 2015, "I semi di poesia in azione. Pace", SECOP Edizioni 2015, "Divergentemente", Matisklo 2015 e-book gratuito, "Novecento non più - verso il realismo terminale", La Vita Felice 2016, "Umana, troppo umana. Poesie per Marylin Monroe", Aragno Editore 2016, "La grande madre", Di Felice Edizioni 2016.
I suoi lavori sono apparsi anche in riviste, siti e blog letterari, fra cui: Specchio (de La Stampa), 003 e Oltre (allegato a "Lezione Seconda"), FemminArt, Historica-Il Foglio Letterario, La poesia e lo spirito, RivistaInutile, Musicaos, Rebstein, Poiein, Viadellebelledonne, Imperfetta Ellisse, Poetarum Silva, Filosofipercaso, Cartesensibili, Gliocchidiblimuda, Torno Giovedì, EstroVerso, Cartiglio d'ombra, FuoriAsse, UT Ediland Edizioni, WSF Centro Sociale dell'Arte, Illustrati, Versante Ripido, La presenza di Erato, Otra iglesia es imposible (traduzione in spagnolo del poeta Jorge Aulicino), Il divano Muccato's Blog, Perìgeion, Limina Mundi, Centro Cultural Tina Modotti, "Bibbia d'Asfalto: poesia urbana e autostradale" (numero 8, 2017).
Progetti/collaborazioni nel campo delle arti visive:
2013: "Cartoline dal luna park", Migranze E-edition (con immagini fotografiche di Gepe Cavallero).
2012: "Iridescenze", Migranze E-edition (con immagini fotografiche di Romina Dughero).
2011: "Alfabetomorso"- mostra collettiva di arti visive e poesia presso la galleria d'arte EnPleinAir di Pinerolo (To).
2011: "Corrispondenza (d)al limite [Fenomenologia di un inizio all'inverso]", Clepsydra Edizioni - con immagini fotografiche di Giusy Calia -, testo finalista alla XXV edizione del Premio Lorenzo Montano, sezione prosa inedita.
2011/2013: Progetto fotopoetico MeTe, di Fabio Trisorio e Silvia Rosa.
Traduzioni:
Progetto "Italia Argentina ida y vuelta. Incontri poetici", pubblicato a puntate sulla rivista internazionale di poesia Iris News, 2015 e su Versante Ripido, 2016. Il progetto è stato pubblicato in ebook nel 2017, a cura di Versante Ripido e La Recherche.
Curatele:
Festivart della follia
Medicamenta - lingua di donna e altre scritture
Marilina Ciaco, dalla raccolta inedita “Verbosinapsi”, nota di Laura Caccia
Contatti anomali
Si propaga ovunque, nella sua ricerca linguistica, la scrittura di Marilina Ciaco in “Verbosinapsi”, spalancando domande di senso: è una scrittura che genera nessi e connessioni o piuttosto che si muove libera in un dire lasciato fluire senza interruzioni? Che crea contatti e comunicazione o che prolifera incustodita? E che si muove in modo sinaptico o metastatico?
Il richiamo alle sinapsi nel titolo e nei testi ci pone di fronte ad una precisa indicazione dell’autrice che scrive di “vili scritture sinaptiche” e ancora: “come sempre / intern-arsi e tesi e ottusità di sinapsi”.
Il richiamo all’ottusità che, in semeiotica medica per quanto riguarda la risonanza di un suono, rivela condizioni anomali o patologiche, parrebbe confermare che di questo si tratti: di anomalie, di guasti, come precisa l’autrice: “sul guastarsi dei rami / e l'inerpicarsi di questo meno infinito / meno tutto menovita menadito / forme infibulate sul proliferante / inventario catastale di fibromi”.
Se il dire riflette la condizione sofferente di chi scrive, se ha perso drammaticamente la possibilità di parola, “nel grido che è stato / che scivola in balbuzie e non ha / conchiusione, è solo silenzio / di palpebre stremate e bocche”, allora è solo a partire da tentativi di lallazione, come il balbettio nell’apprendere a parlare, che si apre una qualche possibilità di parola e di senso, come leggiamo: “noi non siamo / ci siamo e ci risiamo / ridendo al dom-dom-domande / riposte male ma cosa / posti oggi? Nuovi posti / da radiografare sgrammaticare / ricodificare nella lingua che hai perso / che penetra le maglie / della ma ma ma la madre materia”.
Marilina Ciaco ci pone di fronte agli urti del vivere , “Sono tornata e non trovo / né trama né perduto / né fine né filo”, e agli indissolubili contrasti della condizione umana, “tutto è altrove io non sento / che l'urlo scuoiato di un'assenza”, ma la sua ricerca è chiaramente a favore della parola, anche nello sperimentare nuove forme di scrittura, poiché alla fine di tutto “c'è questa voglia che è quasi strana / di incominciare a parlare”, dove un nome può ostinarsi ad insistere “come masso sulle macerie” e la carta riuscire a sbocciare “in perle d'oltreoceano”.
Da “Verbosinapsi”
Vetro
Pioggia rigoccia puntella
l'esaurimento lento della sera
ronza ancora in questa finestra
che non dice, fiorisce e inficia
i grumi di cobalto dove la vita si disfa
contorta – morta come le carni
che hai assorbito ti sei fatta assorbire,
l'onta della superficie
mi ha mangiato il midollo
e questo è il maledire stradire stranire
che quando non voglio riluce
questa è la finestra
grande iperbolica
mefitica finestra asfittica
che quando non voglio si schiude
e spreme e infradicia e guasta:
la sera geme, la sera è marcia – io
sono il rigetto del mio seme inesistente.
Festa
Potresti essere solo questo
protettivo-incoativo dentro
e invece lumesco exardesco
ridicolmente, dal fondo del fuori
che è il gesto sordo che non mi appartiene –
filtro il contatto meccanico di due tessuti eterogenei,
la ferocia rieducata striscia cinge le sedute vuote
fende (non difende) i tuoi bulbi – onda onda stravuota
frastuono frammisto roboante risuono
delle vostre voci che amplessano
senza toccarsi.
Denoto un afflato adolescente (le precauzioni, le precognizioni)
e il cerimoniale eterosessuale dei corpi
che ballano, che esistono.
Dev'esserci un modo
la quadriglia è necessaria, in generale,
per usare i loro segni
per essere tu il segno
e sii più pratica, pratica, la pratica
e poi fruibile pubblicitaria biodegràdati
perché è sempre tempo,
procede in silenzio
l'asta dei tuoi organi
rispetteranno i protocolli
di un espianto riuscito:
senza slittamenti
un pezzo al giorno.
Marilina Ciaco nasce a Potenza il 23/01/1993. Vive l'infanzia e l'adolescenza a Muro Lucano (PZ), dove frequenta il Liceo Scientifico Enrico Fermi. Nel 2011 si trasferisce a Bologna per compiere gli studi universitari e, contestualmente, approda alla scrittura poetica.
Nel 2014 consegue la laurea triennale in Lettere Moderne (voto 110/110 e lode) con una tesi in Letteratura e civiltà greca intitolata “Soltanto il cieco sa la tenebra”: il mito edipico nei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, con relazione del prof. Federico Condello. Nel 2017 consegue la laurea magistrale in Italianistica, culture letterarie europee e scienze linguistiche (voto 110/110 e lode) con una tesi in Poesia Italiana del Novecento, Trauma storico e sperimentalismo linguistico in Andrea Zanzotto, con relazione della prof. ssa Niva Lorenzini e correlazione del prof. Francesco Carbognin.
Attualmente vive a Bologna e continua la propria personale ricerca poetica. Collabora inoltre all'organizzazione di eventi culturali come il Festival Bologna in Lettere e alla realizzazione di un progetto documentaristico indipendente.
Raffaele Marone, una poesia inedita, “raffaele marone. (auto)ritratto nel nome”, note di Ranieri Teti e dell’Autore
Come si torna a casa, dove su una porta è scritto il tuo nome e il cognome?
E se la porta è quella di un poeta?
Come si può (auto)ritrarre un poeta, partendo dal nome?
La strenua scomposizione del soggetto prevede un ricostituirsi nella filigrana della lingua.
Il testo ci racconta quanto ci si possa spingere in questa lingua per ritrovarsi,
per ritrovare la radice di sé, a strappi, con dolcezza, con dolore.
Da questi frammenti è possibile finalmente coniugare nome e azione, da parole che diventano ritmo e suono,
e che tra riduzioni e accrescimenti ci conducono, tramite una catena linguistica
che ricerca improvvisi e inaspettati accoppiamenti, in una zona ancora inesplorata.
Raffaele Marone propone un ultra acrostico, l’oltre di un’idea, il verso estremo.
Dove siamo, prima di tornare a casa, al nome, se siamo poeti?
Possiamo trovare una risposta grazie a questa poesia, al suo asimmetrico e ostinato andare
che non rappresenta un inciampo della lingua ma il suo continuo e inesauribile propagarsi.
Grazie a questa poesia, possiamo sentire la doglia colta nel momento finale della riproduzione:
la seconda vita dell’autore, una nascita attraverso la scrittura.
Qui ogni scavare in un ricco vocabolario conduce alla sofferta identificazione del poeta con il nome,
del vivente con la parola.
“raffaele marone. (auto)ritratto nel nome"
rame
ramo
rane
rare
raro
re
rema
remare
remo
reo
a
aere
affama
affamare
affare
affarone
afro
al
ala
alma
ama
amare
amaro
amarone
are
fa
falene
fama
fame
fare
faro
e
elea
elmo
ere
ero
eroe
la
le
lea
lane
leone
lo
ma
mane
mare
me
o
ne
Nota dell’autore a “raffaele marone. (auto)ritratto nel nome"
L’esplorazione di un nome, tra le sue lettere. L’esplorazione del mio nome.
È cominciato come un gioco, poi come spesso accade giocando, la cosa si è fatta più seria.
Mi son messo a scoprire le parole che ci portiamo dentro, dentro il nostro “nome e cognome”, per andare oltre il parlare distratto.
Sono parole nascoste che pure sono dette, involontariamente, anzi forzosamente. Echi bui.
Ogni volta che scriviamo “nome e cognome”, scriviamo tante parole allo stesso tempo.
Ogni volta che qualcuno ci chiama, dice tante altre cose e magari chiama pure altre persone, allo stesso tempo.
Parole che sono nomi propri, sostantivi, aggettivi, verbi, interiezioni, popoli, ere geologiche, termini scientifici del mondo animale o vegetale.
Il nome si rivela una “scatola magica” piena di immagini, tutte da scoprire, basta aprire.
Tutto questo genera una sequenza di immagini, in apparenza sconnesse tra loro. La sequenza c’è, c’è un ritmo possibile come nella poesia.
“nome e cognome”, come poesia possibile.
Allora, se è poesia, ognuno, con un vocabolario a portata di mano, può scriversi la sua.
È un bene sapere che cosa si nasconde dentro il nostro “nome e cognome”, scavando dentro le parole che contiene,
avventurandosi nella scoperta di nessi e relazioni tra quelle parole che erano rimaste in ombra, e noi;
se l’identità è quel che si sa di sé.
Raffaele Marone (Napoli 1960) è architetto, ricercatore universitario.
Sue poesie sono state pubblicate su “Le Voci della Luna” e, in rete, sul blog “Blanc de ta nuque”.
Ha ricevuto riconoscimenti al Premio Lorenzo Montano.
Ha pubblicato libri, progetti e saggi di architettura.
Scrive il blog www.ilfattoquotidiano.it/blog/marone/
Michele Lamon, una poesia inedita, “Reperto”, nota di Ranieri Teti
Michele Lamon con “Reperto” non ci racconta una storia, ma la nostra storia.
Lo fa per capitoli, che corrispondono al progressivo aumentare di una data popolazione,
che si accresce nel tempo, partendo da uno.
Il tono generale sembra quello di un narrato continuo, detto da una voce recitante che, potenza del brano,
possiamo sentire nel silenzio mentre lo leggiamo a mente, come se fosse il testo a parlarci,
come se questo fosse un implacabile specchio senza brame che ci racconta.
La poesia ha una superficie piana che via via si accresce nella struttura:
dai versi brevi dei primi capitoli, assecondata in tutto da un linguaggio tanto preciso quanto metamorfico,
si trasforma, passando a versi sempre più lunghi, fino a giungere alla prosa poetica finale.
Assistiamo a un crescendo, tanto che sembrano ineluttabili gli accadimenti:
più evolve la storia, e aumentano i capitoli, più si sprofonda.
Da uno a dieci miliardi, l’evoluzione è stata sicuramente lunga, fino ai prodromi di un esito già evidente:
“molti vulcani si erano spenti, molti ghiacci ritirati, il cielo si era abbassato”.
La storia è stata vinta dall’indifferenza che lascia dietro di sé solo macerie, memorie corrotte, volontà murate.
Da “Reperto”
Capitolo I
Al principio. Fu uno
e poiché altri non vi era
uno era tutto senza
bisogno di affermarlo
bisogno di saperlo. Senza verbo.
Capitolo II
Fu due. Così non fu più
tutto, perché era due ossia erano.
Nacquero confronto e distinzione
io sono, tu sei e io non sono tu,
tu sei io ma non sei me.
[...]
Capitolo ennesimo
Erano dieci miliardi, ogni io una polvere sotto il numero. Vi era chi si sentiva nel tutto,
chi si sentiva nulla e chi rigettava nel profondo di sé ogni sentire, rigettando poi anche
il profondo di sé. Questi ultimi, le cui bestie non avevano più custodi né gioghi,
possedettero il mondo. Si poté allora sapere quale sarebbe stata la fine della storia.
Capitolo ultimo
Al termine della storia vi sono rifiuti, carte intaccate e disperse, memorie corrotte,
volontà murate. Una figura si aggira, raccoglie, cerca il primo disegno. Sfiora braccia,
richiama sguardi, così che si aggiungano ai suoi. Un anomalo muoversi: passo irregolare,
soste insolite, traiettorie oblique. Ogni attività inclassificabile è facilmente classificabile
come disturbo, agevolmente interpretabile come non lecita.
Al termine qualcuno rimane uno, il più piccolo degli errori.
Michele Lamon è nato nel 1967 a Milano, vive a Torino. I suoi interessi principali sono la musica, che lo ha portato a svolgere attività radiofonica, a comporre radiodrammi, approntare colonne sonore per spettacoli di danza e teatrali, occuparsi di produzioni artistiche e tecniche di dischi, regie sonore, djing; e la letteratura: pubblicazioni sparse di poesie racconti e recensioni, collaborazioni a sceneggiature video e teatrali, un romanzo inedito finalista al Premio Calvino, una raccolta di poesie menzionata e una segnalata al Premio Lorenzo Montano, collaborazioni con la rivista L'Indice, pubblicazione di un libro di poesie per le edizioni Anterem/Cierre Grafica.
Roberto Fassina, una poesia inedita, “Ippocrate”, nota di Ranieri Teti
Roberto Fassina, con “Ippocrate”, attraverso paesaggi poetici decisamente affascinanti,
ci propone un modello di viaggio iniziatico.
In questo viaggio di isola in isola e di porto in porto nell’Egeo, dove realtà e mito si confondono,
ci conduce proprio dal mito verso la sua trasposizione nell’umano.
Tutto avviene a Kos. Qui finalmente si attua il passaggio da Asclepio a Ippocrate,
qui avviene la nascita della medicina che si libera delle credenze e diviene scienza.
Questa mutazione è ben resa dall’immagine di “una mano che scruta”
che diventa una mano che affonda nel corpo malato.
La stessa malattia non è più un castigo divino ma testimonia davvero l’inevitabile fragilità di un corpo.
Anche visivamente, sulla pagina, il testo di Fassina è diviso in due metà, così come la scrittura:
il tono pacato della prima parte “da Ermione vocato disponi / di radici l’impasto”
viene abbandonato per giungere, nella seconda, a dettagli patologici,
a tregende corporali, a “morbi e spurghi / purulente plaghe”,
nella cruda anatomia del dolore.
Ippocrate
Per l’amabile Kos
Omerica vela onda risali
In dote portando il verbo d’Asclepio
Arduo affrancamento dal mythos
D’isola in isola
Nettuno pregando ai marosi
Di porto in porto la mano che scruta
Empatica-mente
(Da Ermione vocato disponi
Di radici l’impasto
Di Clizia la figlia in torpore
La colica acquieti e lenisci)
Il passo della voce
Lenisce il tatto
Empirico sentire et per-cepire
In diagnosi et prognosi
La mano che affonda e dilaga
E scruta borborigmi e reticenze
Secondo le forze e il giudizio
Di sollievo Maestro
……………………………………………….
Indugiando sui bordi
del buio
Non più mali sacri o divini
Rapsodiche intuizioni
Sacerdotali fantasie,
Sed naturalibus causis
Di tregende e malattie
terzane febbri e quartane
morbi e spurghi
purulente plaghe
et foetidae,
catarrosi cancri e tussivi
mal della pietra colica
veruno sasso
mordente vescicale
melmosa bile nera
convulsivi stupori
mancamenti et lipotimie
flegmatici squilibri
melancolici umori
biliose discrasie
in corpore vili
(…mano sine magie)
Roberto Fassina è nato a Curtarolo (Padova) il 18/12/50. Dopo la maturità classica, conseguita nel 1968 presso il Collegio Salesiano Manfredini di Este, si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, dove si è laureato nel 1975 e poi specializzato in Ginecologia nel 1979. Dal 1979 vive e lavora a Curtarolo come Medico di Famiglia.
Nel 1991 ha pubblicato “Nihilissimo Canto” (poesia) per i tipi delle Edizioni del Leone di Venezia. In quel periodo ha collaborato con poesie e racconti nella rivista milanese ‘Alla Bottega’.
Nel 1998 ha pubblicato il romanzo “Equazione Ultima” per i tipi delle Edizioni Amadeus di Treviso.
Nel 2003 ha pubblicato la silloge poetica “pesca sabèa” con la Casa Editrice ‘all’antico mercato saraceno’, di Treviso. Sue poesie sono presenti in varie antologie poetiche.
Suoi testi teatrali satirici, aventi per oggetto il mondo medico, sono stati rappresentati a Piove di Sacco e a Padova, nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2012 e nel 2016.
Nel 2011 ha pubblicato la raccolta poetica “Tangheide – lapsus in fabula” con la Casa Editrice ‘all’antico mercato saraceno’, di Treviso.
Nel 2015 ha pubblicato il romanzo “Il pensiero verticale” per i tipi di Ibiskos Editrice Risolo.
Scrive saggi e note critiche nella pagina culturale del Bollettino dell’Ordine dei Medici di Padova.
Paola Parolin, una poesia inedita, “Una vita”, nota di Ranieri Teti
È una densa prosa poetica, questa dal titolo “Una vita”.
Paola Parolin conosce bene come passi velocemente e fugacemente la nostra vicenda umana,
sa così bene la nostra caducità da anteporre a questa poesia un frammento di video,
il fermo-immagine di qualcosa che arde.
Un’ustione ci contraddistingue, sembra essere senza fine ma brucia per un tempo breve.
L’autrice sa quanto valga ogni momento del nostro vivere:
pur se in una via nel caos, pur se sempre più dominati dalla scienza,
come quando ci parla di una “esistenza genetica non partorita”.
In un coacervo di simultanei sentire, metafora del vivere attuale,
perfettamente resi dalla completa assenza di punteggiatura nel testo,
trovano spazio anche elementi che nel contesto possono sembrare rassicuranti:
una foto color seppia, un piccolo quadro, la grande cornice.
Ma è una breve parentesi, subito dopo si ritorna a quel “fondo inesausto” che non può essere placato.
Troppo breve è il tempo che resta, mentre noi non siamo fermi, ma giorno dopo giorno andiamo alla deriva,
nella corrente.
Una vita
si deve lasciare la mano si stacca dal cuore
si segue estraniati la via nel caos del
mattino inoltrato esistenza genetica non
partorita capace di scelte lontane radici
perdute nei giochi infantili fissate per
sempre in foto di seppia la grande cornice e
il piccolo quadro un soffio vitale di luce e di
acqua a placare il fondo inesausto in
strettissimo filo come un velo di morte un
sudario di sposa
Paola Parolin è nata a Verona. Ha partecipato ad alcuni laboratori poetici coordinati da Ida Travi negli anni 1999-2008. Ha pubblicato nel 2003 la raccolta di versi Interni Esterni Interni.
Dal 2006 al 2010 è stata più volte segnalata al Premio Lorenzo Montano. Nel 2007 ha pubblicato con altri due autori la raccolta Trittico della sera di carta, edita da Cierre Grafica. Ha inoltre dato alle stampe, nel 2011, il volume Parola corale, edito da Via Heràkleia.
Paolo Ferrari, una poesia inedita, “La poesia è”, nota di Ranieri Teti
Spesso ci accostiamo al tema “Cos’è la poesia” in formula dubitativa, chiedendoci “cos’è la poesia?”
Non è così per Paolo Ferrari che, di fronte all’enormità della questione, si pone in maniera
decisamente assertiva. Infatti intitola il suo testo creativo “La poesia è”.
Ci si poteva immaginare, date le premesse, una dissertazione teorica, un saggio.
In realtà il pensiero di Paolo Ferrari viene prodotto in versi.
Il pensiero sulla poesia diventa a sua volta poesia e ci conduce all’interno di un metatesto,
in un viaggio iniziatico ricco di sorprese.
Il piacere della lettura attraversa gli strati più oscuri e profondi del pensiero.
La densità del testo si propaga per 76 paragrafi: da viaggio iniziatico,
alla fine si trasforma in un messaggio lasciato nella bottiglia, in un testamento per la posterità.
“La poesia fa essere ciò che manca”, “La poesia dice ciò che alla realtà manca”, scrive Paolo Ferrari.
In contraltare, quello che approfondisce e arricchisce il testo sono i frammenti in cui la poesia
si libra e prende per un momento il sopravvento sul pensiero, citando ad esempio un paese di mare,
un partire da zero, un ritmo quasi celato, un’assenza che conduce lontano.
Del tutto poetiche sono le libertà stilistiche che l’autore inserisce nell’opera,
accorpando le parole o modificandone i tratti, talvolta addirittura il corpo,
per giungere a una parola ri-creata.
Senza mai naturalmente dimenticare che la poesia, come scrive Ferrari,
“è la festa della parola, il disperarsi della parola”.
Da "La poesia è"
1 Poesia è…
ciò-che-fa indipendentemente dalla cosa che il mondo già conosce
e quotidianamente avvalora
2 Poesia è…
prima che la cosa abbia luogo ovvero
che la nascita sia annunciata, fa essere ciò-che-manca, senza che
sia evidente a-ogni-costo
3 Poesia è…
il mancar della cosa: la parola
che dice (la cosa), senza che necessariamente sia
manifesto l’oggetto di cui si parla
4 Poesia è…
la festa della parola, il disperarsi
della parola, percorso pensoso e accidentato
perché qualcosa sia – e resti – sul filo del
niente
12 Poesia è…
la parola un poco ha gridato:
si sente piangere dietro a una porta:
è lei che prova un’
uscita ma che sia di verasalvezza
19 Poesia è…
“Non c’è più niente da dire (in-poesia) dopo
Auschwitz.” C’è da ribadire unicamente
che nulla si può dire (poeticamente) del mondo
se non della sua scomparsa
23 Poesia è…
poesia è piacere del ritmo e della forma del verso
che subito abbandona per ritrovarsi in un
altrove che ancora nonsi conosce
36 Poesia è…
poesia è il vuoto della materia
che porta in sé – ed accetta – quel suono udibile
all’orecchio assoluto e speciale:
sa distinguere il nientechegenera
dalniente cheannichilisce
41 Poesia è…
poesia è assenzadiparola
che si rifà una vita dove all’apparenza
muore
70 Poesia è…
poesia è (un) nulla: un soffio che va via.
Per sempre si perde nel suo mancare.
Da qui un giorno è da-venire
Costruendo luce e oscurità dove l’opera
Tocca il venirmeno
di spaziotempo da cui
ungiorno è nata.
Aurelia Delfino, da “Danze”, Mimesis 2016, nota di Flavio Ermini
Aurelia Delfino ha insegnato filosofia all’Università di Milano-Bicocca e all’Istituto Voltaire di Monza.
È ballerina e insegnante di danza creativa.
Il suo libro si chiama Danze e raccoglie testi che vanno dal 1993 al 2016. È edito da Mimesis.
Che cosa impariamo da Aurelia Delfino e dal suo libro?
Impariamo che tra chi scrive e chi danza ha luogo un moto di avvicinamento interminabile.
Quando corpo e parola si uniscono, danno vita all’esistenza umana. All’abitare umano.
E ciò non accade in cielo, ma sulla terra.
E ciò non accade in un giardino edenico, ma nel cantiere dei corpi.
Ecco cosa impariamo da Aurelia Delfino e dalla sua poesia.
Impariamo a pensare la vita come unità.
Unità di spazio letterario e respiro.
Da "Danze"
***
Mi fanno senza dubbio male i polmoni
o i bronchi, i bronchioli e gli alvei interstiziali
che saldano l’unità al portento
di una doppia respirazione
monotona e montante
Così quanto può intendere
la meraviglia della macchina
io aspiro, dall’eterno ciclo dell’avvenire
quel che è il suo semplice anticiparsi
***
E dominante
e sgorgata
di mezzo a un silenzio più grave
chiamare il nome perché giunga
corpo a corpo a sgolarsi
La presenza, l’assiduo, il dolore
non è sufficiente
si dovrebbe cominciare
con una trasfusione di peccati
***
Come cade
se non si spegne
il nuovo governo delle cose
arruolati pronomi e preposizioni
semplici
il tratto inombra dalla punta in giù
si sente fare giorno
***
Precessione
Quando al cadere degli eventi
equinozi e solsitizi sommati in un sol giorno
accade d’incontrare qualcuno
all’albore di poche parole
ritransita e volge l’inizio
della stessa stagione
Aurelia Delfino ha insegnato filosofia all’Università di Milano- Bicocca e all’Istituto Voltaire di Monza, è ballerina e insegnante di danza creativa, giornalista e mamma. Ha collaborato per anni con la casa editrice Mimesis. Tra le sue pubblicazioni: Il filosofo clandestino. Spinoza nei manoscritti proibiti del Settecento francese (Ghibli 2009), L’anima e la danza di Paul Valéry (a cura di, Mimesis 2014), Lettera al padre di Karl Marx (a cura di, Mimesis 2015).
Gabriella Cinti, da “Madre del respiro”, Moretti&Vitali 2016, nota di Flavio Ermini
Gabriella Cinti è poeta e saggista.
Si occupa di filosofia del linguaggio, di antropologia, di archeologia delle lingue europee.
Il suo ultimo libro ha per titolo Madre del respiro ed è edito da Moretti&Vitali.
Tra queste pagine è evidente la volontà di Gabriella Cinti di affidarsi a un immaginario ancora memore del giardino edenico.
Qui, Gabriella Cinti aderisce all’accorante richiamo della parola aurorale, quella parola che ancora non subisce sopraffazioni da parte della nuda realtà delle cose.
Qui, vive la magia rivelatrice di ciò che è realmente ed essenzialmente iniziale.
Vive l’infanzia che l’essere umano continua ad avere dentro di sé.
Aprendo uno scenario che lascia trapelare l’occulta presenza del sacro.
Diciamolo chiaramente: la poesia in Madre del respiro è intesa come forza della vita. Come spazio che le macchine non possono soffocare.
Da "Madre del respiro"
***
Sonno d’acqua
Sonno d’acqua – dentro il tempio
sommerso nel segreto –
e le dita schiuse riposano la memoria.
Con altro sguardo scorgo
la danza sovrumana degli atomi,
il gesto cosmico all’alba del tempo,
il cristallo dell’istante.
Sto addossata alle pareti dell’Inizio,
combusta frontiera di nascenza
tra acqua e fuoco.
Aboliti i contorni.
Fantasia azzurra irida
il colore del varco notturno
nel saturnale confuso
propiziante il tutto vita.
Tra barbagli di agnizione
sei giunto, dall’alto del Gioco,
a leggermi le sfere dell’infinito.
***
Il canto dell’ombra
le parole a balzi stamattina,
assembrato esercito mite
a seguire lo slancio della luce.
Mi avvieni nella parola
e ti costruisco un corpo
di sillabe snodate.
Le tue giunture danzano nei miei suoni
e la notte riposi in un silenzio
di pacata armonia.
Cerco scampo dal rimbalzo nel vuoto
– il rischio della voce specchiata nel nulla –
e il tuo fantasma d’amore al mio fianco
concede la sua sola parola,
il volo nel vento a sfiorarmi le ciglia.
Il compasso d’acqua nella fontana
apre l’onda di te,
nata intorno al centro dell’inizio.
Da allora hai sempre mirato
al cuore del segno,
prima di nostra espansa diaspora.
Sei ormai mia lente per intendere
e parola delle tue parole,
pronuncio il tuo vuoto
e lo scaldo di nomi.
Così ti sottraggo al buio muto
che rapina la vita, tua prigione
di crisalide senza divenire.
Chissà se ti giunge il grido mio
quando tempesto lo spazio
interrogando i confini?
Solo nel vento inabissato
riuscirò a decifrare le sillabe perdute,
i raggi del tuo dire strappati alla notte,
per intonare con te
il canto alto dell’ombra.
Gabriella Cinti, nata a Jesi (An), laureata con il massimo dei voti in Lettere moderne presso l’Università di Studi di Genova. Da diversi anni si occupa di poesia, di letetratura, di filosofia del linguaggio, di antropologia, di archeologia delle lingue europee, di etimologia e in particolare di poesia greca antica- di cui è voce interpretante all’interno di varie manifestazioni musicali o performances teatrali.
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Italianistica all’Università di Roma 2 Tor Vergata.
Tra le sue opere pubblicate:
La raccolta di poesie Suite per la parola Péquod Ancona 2008, (vincitrice del Premio Nabokov per la poesia 2008, terzo premio al Concorso letterario “Albero Andronico” (Roma), 2009 e menzione al Premio “L. Montano”). Euridice è Orfeo, Achille e la Tartaruga, Torino, 2016 (presentata in un evento al Salone del Libro di Torino, 2016), con recensione sul Corriere della Sera, inserto LA LETTURA, 31 dicembre 2016 e segnalata da Claudio Magris. Altra recensione sulla rivista letteraria “IL SEGNALE”, Milano, febbraio 2017. Premio della Giuria al Concorso letterario Cinque Terre- Golfo dei Poeti, ediz. 2017.
Il saggio: Il canto di Saffo-Musicalità e pensiero mitico nei lirici greci, Moretti e Vitali, Bergamo 2010 (prefazione del grande grecista e traduttore Angelo Tonelli). (Premio speciale Città di Cattolica 2012, secondo premio al Concorso letterario Cinque Terre-Golfo dei Poeti 2013 per la saggistica), recensito nell’aprile 2010 da Franco Manzoni, nelle pagine Cultura del Corriere della Sera e da Gianluca Bocchinfuso ne Il Segnale, 94, 2013.
Tra gli inediti, la poesia Euridice a Orfeo ha vinto il premio della Stampa, al Concorso di poesia “Città di Acqui Terme” nel 2012, e un’altra poesia, Viaggio verso l’uno, ha vinto il secondo premio dell’altra Giuria nel medesimo Concorso. La stessa poesia ha ottenuto il Primo premio al Concorso Rodolfo Valentino Sogni ad occhi aperti, edizione 2013.
Per l’autunno 2017 è prevista l’uscita del saggio Dioniso, dio del labirinto, rielaborazione dalla sua tesi di Dottorato.
Autrice anche di articoli saggistici per riviste specializzate cartacee e on line (fra queste ricordiamo Mosaico edita a Rio de Janeiro dalle Università brasiliane, 2014), ha ottenuto con i suoi lavori numerosi premi e riconoscimenti.
Zara Finzi, da “Escluso il ritorno”, Manni 2016, nota di Flavio Ermini
Zara Finzi ha studiato Filosofia Estetica e si è laureata con la guida di Luciano Anceschi.
È docente di materie letterarie negli Istituti superiori.
Escluso il ritorno è la sua ottava raccolta poetica. Una prova di grande maturità.
In questa opera, Zara Finzi ci parla delle cose che sono state e non saranno più.
Ma – attenzione – senza mai separarle dalle cose che non sono ancora e sono destinate ad apparire.
È così che la malinconia si unisce alla speranza.
È così che la nostalgia si sposa con l’attesa.
Non dobbiamo diventare prigionieri del tempo cronologico, del tempo della clessidra.
Dobbiamo al contrario affidarci al tempo interiore, quello che scorre in ciascuno di noi.
Questo impone Zara Finzi.
Dobbiamo riappropriarci del tempo e dare inizio a una temporalità poetica, abbandonarci al suo potere creativo.
Affidarci a un eterno presente che non prevede vecchiaia.
Dalla sezione "Escluso il ritorno"
Frontiera
dove nessuno dice
“patria”, dove
non è più prima
e non ancora, se
sarà, futuro
dove la parola
che la predica
indefinitamente ne
ripete il limite estremo
***
è però il tempo
delle apparizioni minime
e massime. così
tutto si tiene tutto
ha un fascino abbagliante.
se vedi
nella musica il “si”
contiene e supera
quel “no” che pure
la pervade
Dalla sezione "Esercizio di memoria"
***
si espande e accelera
il ricordo come l’universo.
si apre a spirale dove è sempre più
facile cadere
***
uscire dal contesto – non sapere di cosa parlano –
non sapere perché sei lì – attimo dopo la preaneste-
sia – domanda sulla presenza – estraniamento –
troppo sfumati i contorni – mancanza di identità –
esonero dal vivere – da qualche parte – senza im-
portanza – colori stanchi – nessuna risposta – al-
trove – oltremodo – oltremare – ancora vita
Dalla sezione "Davanti a noi"
***
il meno e il più, la radice di
due e il due, un palloncino destinato
presto a fare pum.
non è quello che perdi ma quello che
di te è perso con lui
Zara Finzi, insegnante, è nata a Mantova e vive a Bologna.
Oltre a due plaquette con Pulcinoelefante, ha pubblicato Gemente seflente (con introduzione di Ezio Raimondi, 2001), Il trimestre mancante (2005), Compensazioni (2011) e, con l’editore Manni, La porta della notte (2008) e Per gentile concessione (2012). Nel 2014 è uscito il romanzo Verso il giardino, edito da CFR.
Claudia Zironi, da “Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni”, Marco Saya Edizioni 2016, nota di Flavio Ermini
Claudia Zironi, poeta, è laureata in Storia orientale e vive a Bologna.
Il libro per il quale è stata segnalata al Montano – a questa trentunesima edizione – è edito da Marco Saya e ha per titolo:
fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni
L’invito che Claudia Zironi ci rivolge è questo:
lasciare il mondo ingannevole delle illusioni – costituito dalle figure evocate dal titolo – e abbracciare la propria essenza.
Ovvero: abbracciare ciò che fa di un essere umano un essere umano vero.
Il nostro mondo è un mondo illusorio e il nostro compito è proprio quello di liberarci dalle illusioni e dalle loro ingannevoli apparenze.
E ridiscendere nelle viscere della terra.
Tutto ciò che noi conosciamo giorno per giorno – alla luce abbagliante del giorno – è il già-disvelato. È il non-vero.
Il vero – registra Claudia Zironi – si trova là dove persiste oscurità.
Là, dove le tenebre sono più fitte, dove solo la parola poetica può dire qualcosa di sensato.
Dalla sezione I, Il fantasma
nemmeno un nome ho perduto
di quanti sono andati
li sussurro ogni notte per te
che non li hai conosciuti
e tu li vedi intorno
stanno tutti lì
in piedi, guardandoti curiosi
di come io possa
chiamarti un segreto
Dalla sezione II, Fantasmi: la poesia
non senti il profumo della carta
nuova, della musica, del vetro?
ti scaglio contro una ribelle foglia
rossa
ti chiamo tutta la poesia del mondo
Dalla sezione III, Fantasmi, l’amante
almeno l’essere alberi, almeno
mancare di colore, risplendere di luglio
avvinghiati nella terra come forme
giovani d’argilla, riconoscersi nel vero
profondo accordo interno delle fronde.
almeno uno stormire unisono di corpi
duri e dolci, protesi al vento, almeno
una vegetale essenza, una lunga vite
di agili colline.
Dalla sezione IV, Lo spettro
padri nostri che state in terra
non vi perdoneremo il seme
non avremo compassione
che di noi stessi, per gli specchi
che a vostra immagine
avete generato. dalla terra
apprenderemo un abbraccio
quando dei vermi sapremo
la regola dell’esistenza.
dateci oggi un gesto insano
a chi è terra nel silenzio
mentre tutto ride, intorno.
Claudia Zironi è nata a Bologna, dove vive, il 26 marzo 1964. E’ laureata all’Universita’ di Bologna in Storia Orientale, ha conseguito un Master in gestione d’impresa. Ha pubblicato il primo libro di poesie “Il tempo dell’esistenza” con Marco Saya Edizioni nel novembre 2012. Paolo Polvani ha fornito la prefazione. Il secondo "Eros e polis - di quella volta che sono stata Dio nella mia pancia", illustrato da Alberto Cini, edito con Terra d'ulivi Ed. ha visto la luce nel luglio del 2014. La prefazione è di Daniele Barbieri e la postfazione di Giorgio Linguaglossa. “Eros and polis” è uscito nel 2016 anche negli USA con le edizioni Xenos Books / Chelsea in traduzione di Emanuel Di Pasquale, prefazione di John Taylor, quarta di copertina di Alfredo De Palchi.
Nel 2016 con Marco Saya Edizioni è stato pubblicato il terzo libro: “Fantasmi, spettri, schermi, avatar e altri sogni” con prefazione di Francesca Del Moro e postfazione di Vladimir D’Amora.
Sue poesie o notizie sono apparse su riviste, siti internet e antologie. Con editi e inediti dal 2013 al 2016 si è posizionata in finale o menzionata / segnalata in vari concorsi di poesia.
Nel 2014 ha fatto parte dello staff organizzativo di Bologna in lettere. Dal 2013 al 2016 è stata artisticamente legata al Gruppo 77 di Bologna con la direzione di Alessandro Dall’Olio. Collabora con varie associazioni rivolte alla diffusione culturale e al sociale come Civico32 e Le voci della luna. E’ fondatrice, dal 2012 attiva nella direzione e nella redazione insieme a Paolo Polvani ed Emanuela Rambaldi, della fanzine on-line rivolta ai lettori Versante Ripido per la diffusione della poesia www.versanteripido.it
Attilio Marocchi, Una prosa inedita, “Il cavaliere e la luna”, nota di Davide Campi
Cap 5
Fruscio
Il Cavaliere è quasi saggio. Sui propri pensieri. Sulla propria volontà. Stranamente.
E la luna è tante lune, ma ha voluto una sola avventura, una a luce piena.
Ed il Cavaliere di nuovo inventa mille storie. Per ascendere direttamente una enorme strada nello splendore!
"Potendo mai uno splendore raccogliere terre, e silenzi, e rumori, vastità, e piccolezze?"
Il Cavaliere come sempre è seduto di fronte alla notte; ed ancora, è come se andasse contro i mulini a vento, e le chimere. Ignorando le colonne di Ercole, e le maree, e le avversità, e le astuzie; ignorando ciò che non sia un salire di un amore di erbe, od il venire di immensità.
"La stessa cosa, se mai risolve?"
Il Cavaliere è incantato. Ha pensato. E mai un singolo momento si è fermato e si è concretato. E mai, in una veggenza, è stato certo di un assoluto.
Vive ora il Cavaliere in un amore ... di una luna, forse per sempre sconosciuta.
Il Cavaliere.
La luna ... Una entità, due entità, molte illusioni, innumerevoli speranze.
li Cavaliere sta attorno alle idee, quasi divine. In silenzio. E la luna va percorsi di orbite, belle e stregate. La luna cercando ciò che mai si lasci avvicinare, rimanendo così vezzosa in modo
impareggiabile!
"Andando sempre poi, ciò che va, oltre i propri sogni? "
Va la luce; in un fruscio.
Si attarda l'occulto, in ciò che non si appalesa.
E tuttavia mai la luce è certa di vincere ... oltre i colori, le tenebre .... il succedersi. A sapere di essere comunque a lato, in un cerchio, a sapere di non essere il fulcro .... non la magia.
***
Nella prosa di Attilio Marocchi sono inseriti, in modo esplicito o sottinteso, tutti i canoni
della narrazione epica cavalleresca.
C’è il Cavaliere con la sua dirittura morale, il suo rispettoso senso estetico, le grandi imprese
e le nobili gesta del suo passato, c’è infine l’amore cortese, con i suoi simbolismi e con i suoi
corollari di irraggiungibilità e incompiutezza.
Il Cavaliere è vecchio e stanco, vicino alla fine. Si muove in un paesaggio vagamente
naturale, percepito in modo quasi onirico, descritto a sprazzi incompleti o per allusione. Si
presume che il Cavaliere lo percorra lentamente, quasi in trance, costantemente rivolto
all’oggetto del suo desiderio, alla luna, sempre incantato e abbagliato.
Alla luna si rivolge con i suoi sentimenti, le sue fantasticherie, le sue storie e i suoi rimpianti,
a lei palesa i suoi paesaggi interiori e i suoi desideri, a lei pone, insistentemente, le sue
domande, a volte futili, a volte esistenziali, più spesso funzionali ad esplicite forme di
corteggiamento letterario.
La luna, pure sempre rivolta al Cavaliere, è nel suo cielo infinitamente distante. Anche lei si
dichiara, si promette, anche lei, parallelamente pone domande. Ma dall’alto della sua luce e
della sua immortalità.
Le risposte, per entrambi, non arrivano mai, negate dall’abissale differenza di nascita, dalla
distanza di prospettive tra il Cavaliere morente e la luna eterna. Così nessun discorso finisce
veramente, nessun cerchio si chiude, la storia continua.
Ettore Fobo, una prosa inedita, “Fetus la maschera”, nota di Davide Campi
“…e maschera è ciò che dà la visuale sul mondo, su sè stessi, il proprio occhio profondo”.
Ettore Fobo definisce la maschera come il punto, ma soprattutto come atto,
in parte volontario, di congiunzione fra il sé e l’altro, fra il sé e il mondo.
Nella sua parte volontaria, la maschera equilibra il bisogno di riconoscersi in strutture razionali,
complete e moralmente accettabili con la sua tendenza a riconoscere e normalizzare il caos, il disordine,
la mancanza di un centro che caratterizza sia l’espressione concitata del proprio essere individuale,
sia la valanga dei segnali provenienti dal mondo.
Qui l’autore porta alla luce la doppia vita della maschera, che interviene deformando in modo non lineare,
in misura variabile, con esiti incontrollabili, sia l’espressione del sé verso l‘esterno, sia tutta la percezione dell’altro da sé.
Parallelamente il testo si piega, si contrae, si frattura e si ricompone, seguendo le tracce di questa deformazione.
Fobo utilizza una lingua di silenzi e improvvise e quasi ridondanti accelerazioni, dove convivono brevi atti dal respiro poetico,
narrazioni stupefatte di eccessi percettivi, spunti filosofici e impietose fotografie di qualche dimesso brano di realtà.
Così la maschera con le sue visuali/visioni diventa punto d’osservazione privilegiato, naturalmente autonomo.
Fetus la maschera
I
In fondo è sempre una questione di codice, laddove per codice io intendo la maschera e maschera è ciò che dà la visuale sul mondo, su sé stessi, il proprio occhio profondo. Ho detto visuale, ma avrei dovuto scrivere visione. Come il poeta di haiku che si sogna farfalla, e dice:
“Ma sempre incombe sulle nostre farfalle filo spinato elettrificato.”
E
“Ho visto una rondine dibattersi fra i rovi straziata, nell’indifferenza cieca della strada.”
II
Questa è realtà, la struttura delle cose, noi come cani di paglia gettati nel fuoco, alla fine di una cerimonia in cui ci sentivamo sacri.
È la dispersione il segreto della struttura, una struttura esiste per disperdersi, vale a dire: tutto ciò che è cristallizzato si rompe. Il codice no, il codice-maschera è già un’interazione fra sé e l’altro.
Ma quando dico struttura, dico bramosia dell’unità, quando dico maschera, dico che la miriade degli esseri è una mia sintesi ipotetica, amo il caos in ogni sua non forma. Non possono vietarmi di essere anche il negativo di me stesso.
Io, l’altro ... la maschera è il punto di congiunzione, tutte le galassie occhieggiano con la loro meravigliosa mancanza d’unità, di centro.
Come il poeta beat che disperde il suo fiato nel vento, che urla su tutti i tetti: “Catastrofica è la notte ma io grido la mia felicità conto un cielo divino troppo sprofondato e m’inchino al ghigno strafottente del sassofono”. Ha indossato la maschera del cherubino angelico, perché le sue voglie erano troppo demoniache: dicono che così le abbia placate.
III
Tutta la carne sigillata in un’epopea di facce pitturate, danze dissennate per via dell’oppio,”voglio vomitare“ gridato alla mattina in faccia alla metropolitana ”Benvenuti in Patologia” e poi pensare che tutto sommato sottoterra sia proprio da formichine demoniache. Si rimanda la realtà a data da destinarsi, ma questo non è un sogno, sognare è da stupidi, questa è la nostra primitiva destrutturazione, articolata in paesaggio interiore in cui specchiarsi. È l’eco della parola oblio, che tu cerchi? Per indossare facce più definitive, immateriali, come tutto ciò che è stato Feto.
Privo di volto, privo di essere, senza sostanza, fuggevole e fuori dal tempo, in una parola, eterno.
Ecco l’ultima maschera, l’atman, il sé atomico, il multi verso e l’anello degli anelli. L’innocenza del silenzio e del divenire. Domani potrebbe essere già il sogno di un’altra maschera, indossare l’altro, il dio, l’alieno, il lontanissimo dentro lo stellato.
Ma poi torna la realtà, con il suo grugno di Arimane, con la sua strutturazione sociale, gabbia della Verità, volto nudo al sole senza amore. Allora fingo di essere un serpente per sgusciare oltre tutte le sue classificazioni. È come non fossi nato, un’ipotesi di materia pulsante soltanto e allora anche la morte è una finzione.
Io sono qui, se perdessi le maschere, questa nozione mi ucciderebbe, ciò che ho creato qualcuno lo chiama me stesso. Io non posso che vedermi traslato, nell’antichità dello specchio.
Ettore Fobo è nato a Milano nel 1976. Ha pubblicato tre libri di poesia con Kipple Officina Libraria: “La Maya dei notturni “(2006), “Sotto una luna in polvere” (2010), “Dia rio di Casoli” (2015). Alcune sue poesie sono apparse in diverse ant ologie fra le quali “SuperNeX T” (Kipple Officina Lib raria, 2011). Dal 2008 gestisce un blog di letteratura, “Strani giorni “(www.ettorefobo.it). Collabora con la rivista multilingue “Orizont literar co ntemporan” e con il portale di critica letteraria e dello spettacolo “Lankenauta”. Una sua silloge, “Musiche per l’oblio”, è stata tradotta in romeno, in francese e in inglese.
Galleria fotografica di sabato 11 novembre: immagini di Francesca Bertocco
Ultima pagina: Massimo Girelli, dalla recente esposizione “Colourless”, con una nota di Consuelo Tosi

Per ogni informazione sull’attività di Massimo Girelli: www.massimogirelli.it
Luglio 2017, anno XIV, numero 36

La giuria del Premio Lorenzo Montano, composta da Giorgio Bonacini - Laura Caccia - Davide Campi - Mara Cini - Flavio Ermini - Marco Furia - Rosa Pierno - Ranieri Teti, è lieta di presentare gli esiti della XXXI edizione.
Le premiazioni di segnalati, finalisti e vincitori si terranno a Verona sabato 11 e sabato 18 novembre p.v. presso la Biblioteca Civica, nell’ambito del "Forum Anterem 2017" che si annuncia ricco di novità.
Aprile 2017, anno XIV, numero 35

Nuove avventure della parola, della parola che diventa flusso o frammento, della parola più intima o più esposta, scandaglio o periscopio.
Tra riflessioni e visioni, nelle diverse forme e mediante variegati stili, ci accompagnano in questo itinerario alcuni poeti e prosatori dell’edizione 2016 del Premio Lorenzo Montano: Maria Angela Bedini, Michele Cappetta, Enrico De Lea, Mauro Germani, Angela Greco, Emiliano Michelini, Alice Pareyson, Giacomo Rossi Precerutti.
Simili a parole che corteggiano altre parole, le presentazioni dei redattori della rivista “Anterem” per ciascun autore proposto: esperienza che proseguirà anche con la nuova, prossima a scadere, edizione del Premio scarica il bando della 31^ edizione del Premio Lorenzo Montano
In copertina: Forum Anterem 2016, immagini di Franco Falasca
Michele Cappetta, prosa inedita “Rovescio”, nota di Mara Cini
…à rebours, una leggera vertigine ci prende alla lettura, di questo Rovescio.
Una norma acquisita ci porta a pensare a uno svolgimento in avanti del racconto, in avanti anche se parla del passato. Una parola scritta al contrario ci spiazza, ci rende di nuovo principianti se non analfabeti. E così una pellicola riavvolta, una animazione riportata al fotogramma iniziale, una storia che finisce con il suo principio.
Il testo di Michele Cappetta, che la giuria del Premio Montano ha premiato per la sezione Una prosa inedita 2016, ricorda per certi versi il racconto di Tobias Wolff “Una pallottola nel cervello”: La pallottola fracassò il cranio… indietro verso i gangli basali, e in basso fino all’ipotalamo… innescò una crepitante catena di ioni e di neurotrasmissioni… entrò nel tempo cerebrale… *
In Rovescio un cortocircuito temporale ci riporta indietro e indietro, dagli esiti finali dell’azione alle sue cause, dal nucleo fluido della scrittura, ai suoi gangli basali, alla materia ancora informe, al nero di un inchiostro ancora da versare.
*Tobias Wolff, Una pallottola nel cervello in Proprio quella notte, Torino, 2001
Rovescio
Il sangue fluisce nel cranio, il cuscino si sbianca, le schegge d’ossa si saldano, la pallottola esce, segue una linea retta, s’infila nella canna del fucile, l’indice abbandona il grilletto, il cane viene disarmato, l’arma si abbassa lenta, pende lungo il fianco, dal letto il respiro è regolare, l’uomo ha pupille dilatate, occhi vitrei e scarlatti, il lenzuolo si sposta appena, l’acqua lambisce i piedi nudi, si ritira nel bicchiere, il bicchiere riecheggia, disegna un semicerchio sul parquet, si solleva ricolmo, il piede si allontana, l’uomo cammina all’indietro, si avvicina alla porta, percorre il corridoio, il silenzio dilaga, le narici si dilatano, il viso è contratto, bagliori alla finestra, lui entra nel buio, la porta lo incornicia, la oltrepassa deciso, afferra la maniglia, la trascina con sé, attraversa il giardino, un piede si solleva, l’erba si anima, giunge al capanno, entra di spalle, estrae il proiettile, lo mescola con gli altri, si separa dal fucile, chiude il lucchetto, si allontana risoluto, il bosco ronza, la luna dondola, la casa tace, l’uomo l’aggira, varca l’uscio sul retro, accende la luce, si avvicina al lavello, afferra uno straccio, le mani si bagnano, apre il rubinetto, prende la spugna, un piatto pulito, lo strofina, lo sporca, ne prende un altro, l’acqua fluisce, torna nel tubo, il getto s’arresta, lui percorre la cucina, poi il corridoio, una porta è socchiusa, s’infila nella stanza, si accosta al lettino, le labbra sono ceree, le guance umide, sul pavimento un bicchiere, un piede lo sfiora, il liquido vibra, l’uomo allunga una mano, scorre fra i capelli, avvicina il volto, dà un bacio lieve, discosta le dita, indietreggia cauto, chiude la porta, raggiunge il salotto, si siede in poltrona, fissa il camino, le rughe sono crepe, le lacrime le tagliano, il pianto è muto, nel fuoco cenere, si addensa piano, si reintegra in scoppi, il bianco dilaga, acquisisce volume, le fiamme s’attenuano, diventa una palla, la carta schizza, fugge dai ciocchi, sfreccia violenta, torna all’uomo, le mani si uniscono, le dita si rilassano, il foglio si distende, i denti stridono, il respiro è ansimante, il foglio è un documento, il fulgore lo incornicia, le parole sottili, gli occhi braci, sono lucidi e cerchiati, una frase risplende:
-Affidamento esclusivo a carico della madre-. L’inchiostro è nero.
Nota biografica
Michele Cappetta è nato a La Spezia il 21 luglio 1988. Dopo una carriera scolastica movimentata si è iscritto a Psicologia a Parma. Ma, per caso, si è imbattuto in un corso di scrittura creativa online, che lo ha condotto ad un corso di narrazione fiction, che lo ha fatto approdare alla Scuola Holden di Torino. Di colpo si è trovato a suo agio nel costruire altri mondi, nell’immergersi nelle parole e nel tentare di riordinarle, organizzarle.
Ora lavora come bibliotecario e coglie le opportunità che si presentano.
E scrive.
Maria Angela Bedini, poesia inedita “Nell’incudine del bene e del male”, nota di Marco Furia
Con “Nell’incudine del bene e del male”, Maria Angela Bedini, consapevole di condurre la propria esistenza “alpina e fuggitiva”
presenta un ben scandito componimento in cui si riferisce a esperienze intimamente specifiche (si veda l’efficace concisione del verso
“tagliavo le teste ai miei sogni”)
senza tuttavia omettere immagini che richiamano condizioni più ampie, talvolta in grado di provocare meraviglia: cito, ad esempio, la pronuncia
“impigliata tra le nuvole del niente”.
Maria Angela sembra vivere come sospesa tra circostanze esistenziali che tendono a restare divise, prive di connessione.
Scrive l’autrice:
“entravo nella vita con il soffio della poesia
e la poesia mi uccise
aprivo il libro alle pagine d’oro
ed era fatto di sangue”
mostrando come nemmeno la scrittura sia in grado di porre rimedio, di alleviare la pena.
La conclusione
“il bel giocattolo della poesia
giaceva inerte sopra il prato
come uno stelo rotto”
è davvero emblematica (e coinvolgente) nel suo breve sviluppo: un certo tipo di oggetto (il “giocattolo”) che ognuno di noi, specialmente da bambino, ha avuto tra le mani, viene collegato a un’immagine di biologica distruzione tale da non ammettere, nella sua estrema semplicità, alcun possibile rimedio.
Eppure la parola “bene”, presente nel titolo e nell’incipit, svolge, a mio avviso, il ruolo di rendere testimonianza di una drammatica esposizione a una non momentanea contingenza che non esclude, a priori, possibili vie di uscita: è da notare, sotto questo profilo, che lo stile preciso rende particolarmente evidente come nemmeno l’esattezza del linguaggio possa essere considerata la soluzione del problema.
Il dire insomma non basta o, almeno, non basta ancora.
Nell’incudine del bene e del male
nell’incudine del bene e del male
mi muovevo alpina e fuggitiva
come Silvia avevo pozze di buio
negli occhi come Ofelia nei fiori
mi do sepoltura come Giuditta
tagliavo le teste ai miei sogni
come Antigone cantavo i canti dei morti
la bellezza che crolla mi tormenta
inchiodata alla gravità dell’ombra
crocifissa tra quattro fiumi di parole
impigliata tra le nuvole del niente
o innocenza favolosa dell’inizio
o carità della fine
o pazienza infinita della guerra
la ferità della notte è troppo dura
per i miei denti
la mia veste strappata di fango
è troppo corta per questa lunga morte
o principe avventuriero
o scudiero dei deserti
o regine spaesate nel dolore
entravo nella vita con il soffio della poesia
e la poesia mi uccise
aprivo il libro dalle pagine d’oro
ed era fatto di sangue
davo carne alle parole ed erano spettri
chiedevo voce a quelle sillabe
ed erano lame mute
maria adolescente maria furtiva
maria che nel corpo hai il corpo del mondo
maria dalle scritture ferme
maria dei ciottoli macchiati di neve
maria che hai casa in ogni parola
e ferita in ogni crepa del dolore
nella selva dei nomi la vita
incredibilmente scorreva
nella malizia del giorno ogni cosa
mi appariva fatta di vene d’inchiostro
entravo nella sera con il libro
e il libro mi trafisse
pronunciavo i nomi e ogni cosa
gettava i semi dell’abbandono
per amore del mondo la vita appassiva
per la gloria della malattia la carne soccombe
per la miseria della morte spariva
la vita pungente con i suoi atti tempestosi
io non potevo non morire
sopra quei fogli accesi
dove tramavo a fiotti
l’assurdo inganno dell’infinito libro
io non sapevo che morire sopra
le pagine bianche e sbigottite
intrappolata nelle stanze dell’orrore
io non potevo che patire sopra
le pene della malattia
che va diritta verso l’errore
io non portavo che spavento leggendo
a sorsi il libro del dolore
il bel giocattolo della poesia
giaceva inerte sopra il prato
come uno stelo rotto

Mauro Germani, da "Voce interrotta", Italic, 2016, nota di Rosa Pierno
Oscillazione costante tra il sapere e il non volere. Tra una situazione di fatto e una prevista, futura, Germani, dunque, si dispone a un'evasione, prepara con cura lo scenario in cui il rifiuto sia progettuale. Dove però la condizione di "marcata conoscenza " ( trova sinonimo) sia fattore basilare: "Scriverò la mia voce / condannata/ nello strappo del tempo / e mi scorderò / di me, di tutti / una volta / per sempre".
Condizione di un'uscita dal mondo troppo carica di immagini del mondo, oseremmo dire. Allora, forse, rovesciando il guanto, si potrà vedere che il progetto di Germani contempla la possibilità di una parola nuova, di una nuova lingua che sappia inventare un nuovo mondo. Una parola perfetta e impossibile "dove tutto si perde / e si compie". E che inutilmente determina uno scacco per la scrittura, la quale deve farsi carico di questa visione: "È una parola/ impossibile, un gesto / che salta le righe, / l'inchiostro bianco / che serva l'abisso".
La ricerca di una lingua arcana è votata allo scacco poiché s'impasta col corpo dei morti, delle cose inanimate, dei ricordi che man mano ritornano vita. Così come la scrittura stessa si cancella nella voce di qualcuno che non c'è.
IX
quanti delitti
nei corpi
e adesso dove
sono gli indizi,
dove gli anni
che furono raggi
improvvisi
e domande, vene
aperte di fiumi
lontani,
voci d’amore
e d’abisso, partenze
nei mattini
più chiari
XII
mi nascondo sempre
eppure mi guardano
dalle pagine, mi
dicono caro
fratello d’ossa
e di cenere cara
voce deserta
lo sai
noi ti scriviamo
leggendo nella
tana, noi
siamo il vento
delle vocali
e la terra delle
consonanti,
siamo la tua
notte segreta
la lama lucente
della parola
assassina
Mauro Germani è nato a Milano nel 1954. Nel 1988 ha fondato la rivista “Margo”, che ha diretto fino al 1992. Ha pubblicato saggi, poesie e recensioni su numerose riviste, tra le quali “Anterem, “La clessidra”, “La Corte, “Atelier”, “Capoverso”, “Poesia”, “QuiLibri”. E’ autore di alcuni libri di narrativa e di diverse raccolte poetiche: l’ultima in ordine di tempo è Terra estrema (L’arcolaio, 2011), preceduta da Livorno (L’arcolaio, 2008, ristampa 2013), entrambe finaliste al Premio Lorenzo Montano, rispettivamente nel 2009 e nel 2011. In ambito critico la curato il volume L’attesa e l’ignoto. L’opera multiforme di Dino Buzzati (L’arcolaio, 2012). Nel 2013 ha pubblicato Giorgio Gaber. Il teatro del pensiero (Zona) e nel 2014 Margini della parola. Note di lettura su autori classici e contemporanei (La Vita Felice).
Enrico De Lea, dalla raccolta inedita “Anime di carne”, nota di Giorgio Bonacini
Anime di carne è un canto che, a partire dal suono, possiede una voce che abbraccia tutti gli affetti vissuti e vivi della propria terra. Quartine di versi che (con una coda di poesia in metrica più o meno sciolta), ritmano e rimano un’ esistenza che affaccia la sua interiorità sul bordo segnato da una necessità (esistenziale, emozionale o più semplicemente naturale) oscillante tra “inventare e inventariare un mondo).
Una poetica, dunque, della narrazione intima, ma dove non c’è un racconto, non c’è una sequenza, anche minima, di fatti o ricordi; questi, come solo la poesia sa fare, ci sono, ma emergono dai segni plurimi e altamente significanti dell’ esperienza immaginativa a cui l’autore sottopone la sua percezione del reale. “Segnature del ritorno” le definisce lui stesso, sperimentate in parole insonni con grande capacità musicale, e ancor più proiettate in una visione pensante che sogna e segna un ritorno di vita: non una nostalgia ingenua, ma sentire che il richiamo di ciò che senza tempo ha luogo si muove in un altrove che è un momento di completa umanità. Perché la consapevolezza poetica risiede proprio anche in questa capacità di circoscrivere senza limitare, avendo a disposizione una parola vibrante, diffusa, polimorfa. E sicuramente è questa capacità trasformativa il tratto distintivo che Enrico De Lea ci mette davanti: rimemorare la scena col tocco del poco che la concretezza del poema rinnova.
In tutto questo l’andamento ritmico e la rima non sono secondari, ma strutturali: per mantenere in armonia, viva e ondeggiante, il ricordo e la sua presenza che trapassa in un futuro già passato. Così le “anime di carne” sono forma e direzione di un sentimento che veste la forza di una poesia che ha nomi e luoghi fisici, estratti dal tempo che li ha resi “simulacri o teatri” e che la mente possedeva solo come materia vuota, senza uso alcuno, per farne materia di parola vivente. Ecco perchè, nonostante tutto, ciò che è passato ha mantenuto un senso; che è lo stesso della poesia che lo ricrea: cioè parola che era ed è cosa, nei vecchi fantasmi e nella vita presente. E’ così che, in questi testi, la scrittura si muove, con un transito che riporta il canto di una solitudine fuori dal “buio...bordo del precipizio”. Dove la dimensione dello sguardo dell’autore è consapevole di una realtà che neppure la poesia può far tornare, perché l’inizio è andato, perduto in un oggi senza memoria, senza suono.
Tutto il poema è intriso di questa malinconia, che non significa abbandono, ma pensiero in più, sovrabbondante, difficile da tenere e ingiusto contenere. Poetare è anche debordare, attraverso interstizi emotivi o cerebrali, ma sempre sensibili alle ferite invisibili, quelle più intimamente vere. Quindi più buio che luce nell’umano passare; e non perché non ci siano accenni o riverberi d’illuminazione, ma perché questi spesso illudono e deludono. Enrico De Lea ha una percezione dell’esistente senza retorica e senza dogmi di realismo, e questo gli permette di avere coscienza che la ricollocazione poetica dà luogo al mondo di tornare a essere, nel luogo per eccellenza da cui scaturisce la scrittura: la mente. E se anche il mondo può apparire non vivo, egli ce lo dice chiaramente: “dalle ceneri vinto, lo riscrivo”.
(ritmi per voce)
Presto, finché la lingua esiste.
(J. Rodolfo Wilcock)
Io ero, quell'inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a raccontare. Ma bisogna dica ch'erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il genere umano perduto.
(Elio Vittorini)
(certezze)
Ancora incerto
tra inventare e inventariare un mondo,
so per certo
che stirpi di serpi
scesero dalle Rocche dei titani
divenendo umani,
subietti a altoparlanti della Storia,
ebbero dèi e un dio in minuscolo
al cospetto,
accesero bracieri per i crocchi
d’anime d’intorno - anime
tutte di carne, dal racconto…
primi ritmi del cunto
1.
Certo del sangue, del fiume transitato
a un dopo della manifattura e del telaio,
al deserto capitale, al male edulcorato,
era la piazza ieri, l’essenza del merciaio.
2.
La diaccia architettura ci descrive,
gli spazi vuoti del passato invano,
bureaux marciti tra presenze schive,
gente di fuori, scampati da un lontano.
3.
Il ciclico azzardo di Bisanzio grava,
grigia ipoteca sulla civica visione,
non fu solenne il cedere alla fuga
nel lume indenne della possessione.
4.
Sempre in cerchi concentrici si segna
quel perdersi infinito dentro il mondo,
dei padri, delle madri, che non degna
l’epoca, col tempo allo sprofondo.
5.
E non ha luce che dia luce vera
la pienezza del marchio, in un mercato
d’immagini in omaggio, da bottega nera
del corpo umano, affitto o comodato.
6.
Oggi mio padre avrebbe anni ottantotto,
quieto furore nel rosso che albeggiava
per quel bene comune e senza ascolto,
tra Ionio a tutta vista ed occhio della lava.
(30 ottobre 2010)
7.
Sperimento l’insonnia come un bene,
che non fa bene, innanzitutto, al giorno
successivo, per quella sbornia che trattiene
al mondo, parole, segnature del ritorno.
8.
Un piccolo e nodoso codice, o radice,
piuttosto, di una legge di padri luminosi,
brandirlo, onorarlo, contro colui che dice
solo un presente oscuro, di estimi fallosi.
Enrico De Lea (Messina, 25.7.1958), originario del territorio tra Casalvecchio Siculo, nella Valle d’Agrò, la riviera jonica, Messina e lo Stretto, vive e lavora in Lombardia.
Ha pubblicato le raccolte di poesia Pause (1992, Edizioni del Leone), Ruderi del Tauro (2009, L'arcolaio), Dall'intramata tessitura (2011, Smasher), nonché la sequenza-poemetto Da un'urgenza della terra-luce (2012, Ass. La Luna, nella collana diretta da Eugenio De Signoribus).
Suoi testi sono apparsi sulle riviste “Wimbledon”, “Specchio” (de “La Stampa”), “Sud”, “Atelier”, “Tuttolibri”, “Registro di Poesia” (D'If) e “Caffé Michelangiolo”. È presente nell’antologia Poesia di strada 2010 - Licenze Poetiche (Vydia, 2011) e nel volume collettaneo Parabol(ich)e dell’ultimo giorno - Per Emilio Villa, a cura di Enzo Campi (DotCom Press, 2013).
È stato in più occasioni finalista al Premio “Licenze Poetiche-Poesia di strada” (Macerata), vinto nel 2010, al Premio “Miosotis” - D'If (Napoli) e al Premio “Lorenzo Montano” (Verona).
Ha pubblicato in rete in vari siti e blog, tra cui “Rebstein”, “Nazione Indiana”, “La poesia e lo spirito”, “Compitu re vivi”, “Poetarum silva”, “Carteggi Letterari”, “Arcipelago Itaca”, “Atelier”, “Carte nel vento” - Anterem, saltuariamente pubblicando anche su un proprio blog: “da presso e nei dintorni”.
Alice Pareyson, prosa inedita “Verità (s)coperta”, nota di Flavio Ermini
Parlare di filosofia affidandosi alla narrazione è ancora possibile. Alice Pareyson lo dimostra con questo racconto, che ha come protagonista un giovane Schopenhauer qui alle prese con una serie di esperienze che nel 1819 lo condurranno a scrivere un’opera che influenzerà fortemente, tra gli altri, Nietzsche, Freud, Jung: Il mondo come volontà e rappresentazione.
Attraverso un colloquio con la madre e sulla base di elementi simbolici quali una tenda di raso rosso e un vestito vermiglio, il giovane Schopenhauer scopre che i fenomeni non hanno un valore in sé, ma solo in rapporto all’essere umano, come mezzo della volontà. Scopre che il fenomeno è solo apparenza.
“Il mondo è una mia rappresentazione” registra il giovane a conclusione del racconto. Infatti il mondo lo veniamo a conoscere proprio come una rappresentazione che risulta composta da un soggetto rappresentante e un oggetto rappresentato.
Il soggetto in definitiva conosce con le forme a priori, le quali tuttavia distorcono la sua visione, tanto che possiamo definire la vita come un sogno. Ma è un sogno che talvolta ha i connotati della realtà, e dunque ingannevole (pensiamo, per esempio, alla conturbante figura del padre morto “in una pozza di sangue”).
È necessario imparare a guardare nel non-appariscente. Infatti, la realtà non è come ci appare. È necessario andare oltre. Quell’oltre che si trova in noi stessi. Ecco perché solo guardando in noi stessi possiamo trovare l’altra realtà: la volontà.
Verità (s)coperta
«Solo i più superficiali non giudicano dalle apparenze. È una lezione che ho appreso dopo lungo tempo di osservazione del genere umano. E ora che sono vecchia, ho capito che stoltamente, mio caro Arthur, tende a razionalizzare tutto; ascolta tua madre, figliolo! Quel tuo amico, con quel nome lunghissimo, il tedesco... Giorgio Guglielmo Federico Hegel! Quello coi superpoteri filosofici! O quello lì, il francese... quello di tanti anni fa, Renato ... di Carta?»
Arthur la guardò con fare annoiato, sospirò e la corresse con aria di sufficienza: «Cartesio, mamma!»
«Oh, certo! Beh, insomma, guarda loro! Si sono illusi di poter comprendere la realtà! Hanno preso e categorizzato ogni singolo aspetto del reale, ma, dimmi, si può?! Non sai che è una follia tentare di capirla, la realtà? E quell'altro, il Ghepardo, o come diavolo si chiama, l'italiano...?»
Il giovane, di nome Arthur Schopenhauer, fissò ancora una volta la madre con uno sguardo annoiato. «Suvvia, mamma, quando ti ricorderai i nomi? Si chiama Leopardi, per Bacco!» «Ecco, la Natura è matrigna? Sì! Io, invece, sono tua madre, e ti dico: ascoltami! Non cercare di metterti in rapporto con lei, non sfidarla, perché è inutile! Come con quella ragazza che hai conosciuto... Lasciala perdere; può solo far perdere te!»
Arthur alzò gli occhi al cielo. «E poi,» soggiunse, «guarda quello stolto di tuo padre, lui non si ricorda mai nulla!»
Fece una pausa, alzò lo sguardo e, come se avesse avuto una visione, pensierosa ed esitante, sussurrò: «Eppure l'ho sposato...»
Il giovane, da poco avviato allo studio della filosofia, sbuffò: sua madre era davvero testarda e si ostinava su questioni più grandi di lei!
Spesso, nel salotto di casa sua si svolgevano incontri con eminenti filosofi e pensatori venuti da lontano. Arthur, da bambino, si divertiva a stare a sentire di nascosto, da dietro la tenda di raso rosso che separava il soggiorno dal resto della casa.
Quando fu un po' più grandicello e, con un’espressione che sua madre odiava, "nell'età della ragione", venne ammesso anch'egli alle "sedute" della madre e dei convitati di salotto; sentì ciò come qualcosa di mistico, una sorta di rito iniziatico.
La madre si guardò intorno e voltò le spalle al figlio. «Ma… mamma,» cominciò piano Arthur, «Platone diceva che i filosofi devono guidare gli uomini verso la vera realtà, liberandoli dalle apparenze e...»
«TU LASCIA STARE PLATONE!!» lo rimbeccò la donna, seccata; si era girata di scatto verso Arthur e i suoi voluminosi capelli, vorticosamente ondeggiando nell'aria, avevano accompagnato il movimento fulmineo.
D'improvviso, sua madre s'era fatta pallida, quasi cadaverica; Arthur guardò un po' più da vicino e notò che le sue guance erano scavate, e due profonde occhiaie solcavano quel volto sciupato.
C'era qualcosa che non andava, ma cosa? Forse aveva visto qualcosa che l'aveva turbata? Forse che, davvero, com’ella diceva, convinta, la realtà era così orribile ed era meglio rassegnarsi e, anzi, contentarsi, per vivere una vita felice, lontano dalla noia e dal dolore? Questo unico episodio segnò lui e le sue successive elucubrazioni; gli tornava in mente persino nei sogni.
Una notte, Arthur non riusciva a dormire.
Scese piano le scale fino al piano di sotto, e arrivò di fronte alla tenda di raso rosso.
Aldilà, c'era il salotto della madre.
Pervaso da una sensazione di eroismo e di mistero, la stessa che lo coglieva quando si trovava a esprimere un proprio umile giudizio in mezzo a quelle anime eccelse, prese un lembo di quella tenda, di quello che gli era sempre apparso come un sipario sulla realtà del salotto e contò: uno, due, tre... Scostò bruscamente la tenda e... si pentì d'averlo fatto.
Sul tappeto indiano, dono di uno di quegli uomini illustrissimi alla madre, vide una scena raccapricciante, il corpo di un uomo immerso in una pozza di sangue.
Immediatamente realizzò con orrore che si trattava del padre.
A un tratto, da dietro la tenda, che era ricaduta a chiudere il soggiorno, comparve la madre. Indosso, un vestito vermiglio; nel volto, sempre più cadaverica, quasi simile al morto; sulle labbra, un maligno sorriso.
«Ciao, Arthur.»
Il giovane la guardò con orrore ed emise un grido strozzato.
«Ti avevo avvisato che è meglio vivere felici nelle apparenze.»
Arthur chiuse gli occhi e li riaprì, sperando che fosse un sogno - un incubo.
La stanza cominciò a girargli intorno, i contorni andavano confondendosi.
Svenne.
Una mano fredda e morbida sulla fronte lo fece rinvenire.
«Arthur, che ci fai sul tappeto?» chiese con dolcezza la voce di sua madre.
«Nulla, mamma. IL MONDO È UNA MIA RAPPRESENTAZIONE. E tale deve rimanere.»
rispose tranquillizzato Arthur, con un sorriso, e indicò alla madre la tenda di raso rosso.
La madre sorrise compiaciuta: anche Arthur aveva capito la lezione...
Nota biografica
www.facebook.com/alice.pareyson
Alice Pareyson è nata a Milano il 15 novembre 1994, nipote del filosofo Luigi Pareyson. Ha frequentato il “Liceo Classico Alessandro Manzoni”, attualmente è iscritta alla “Facoltà di Lingue e Letterature Straniere” dell’Università degli Studi di Milano, dove studia in particolare Lingua e Letteratura Russa e Lingua e Letteratura Inglese.
Con un saggio sul sequenziamento del genoma, nel 2012 ha vinto il 1° Premio all’International DNA Day Essay Contest 2012.
Angela Greco, poesia inedita “Campo di grano con corvi”, nota di Ranieri Teti
Potenza della poesia, quando è poesia d’autore.
Come nel caso di “Campo di grano con corvi” di Angela Greco, dove l’avan-testo dichiaratamente artistico cita significativi dettagli di due emblemi della pittura, molto diversi tra loro ma caratterizzati da una simile tensione interiore: Vincent Van Gogh e Edward Hopper.
Da questa premessa che ne costituisce l’inaudito sfondo poetico, Greco agisce nell’ambientazione inserendovi una struttura dialogica in versi, come se le figure, quasi appena disegnate, diventassero infine protagoniste in un’opera del tutto nuova, ricca di dettagli colti nel momento massimo della loro forza comunicativa.
L’accrescimento figurale, un uomo e una donna, determina nello stesso tempo l’approfondimento del senso, in un moltiplicarsi di scene e frasi nelle infinite riflessioni di opposti specchi, tracciando con disincanto le possibili declinazioni delle solitudini.
Il risultato ultimo sembra corrispondere alla scena finale di un film, con le immagini che passano dagli esterni di Van Gogh agli interni di Hopper, con i dialoghi come voci fuori campo, tra “una speranza in meno” e qualcosa che “non basta, non in questo momento”.
Campo di grano con corvi
“Campo di grano con corvi”:
Vincent dalla sua finestra vede il giallo e l’azzurro
e segni neri e nevrili come solchi sul suo campo.
Col procedere delle stagioni gli amici si sono diradati
come accade ai fiori di pesco
(perché sia più remunerativo il raccolto).
“Il diluvio non è ancora finito. Dubito che finirà” - dice l’uomo
“Hai sempre una speranza in meno” - risponde la donna
(intanto il campo e i corvi sono sempre più materici)
“Questa pioggia non ha motivo di cessare.
E il corvo non muterà il suo colore al ritorno”
A bordo tela Vincent è fermo, ma non le sue mani:
gli ulivi sembrano attraversati da un vento preciso e pensa:
la creazione è ribellione al caos.
Appartamento in città. Mattinata di lavoro.
Il giallo dei tigli tenta di raggiungere l’azzurro.
La finestra aperta rivela un insolito novembre
e la strada brulica di cani al guinzaglio.
Fuori dal quadro Hopper è anche più infelice
perso nei toni freddi di solitudini alienanti
le sue creature hanno l’ultimo secolo nello sguardo.
“Eppure lei guarda verso il colore del cielo terso
ribatte a se stesso l’uomo
“Non basta. Non in questo momento.”
(Il copriletto sgualcito dice che lei è altrove
nel tentativo di afferrare il significato che sfugge)
Il corvo passa anche su questo cielo
stabilendo somiglianze.
Angela Greco è nata nel maggio del ‘76 a Massafra (TA), dove vive con la famiglia.
Ha pubblicato:
- in prosa: Ritratto di ragazza allo specchio (racconti, Lupo Editore, 2008);
- in poesia: A sensi congiunti (Edizioni Smasher, 2012 di cui è in uscita la seconda edizione); Arabeschi incisi dal sole (Terra d’ulivi, 2013); Personale Eden (La Vita Felice, 2015 premiato con segnalazione al Premio Lorenzo Montano XXIX ed.); Attraversandomi (Limina Mentis, 2015, con ciclo fotografico realizzato con Giorgio Chiantini).
- Ha realizzato: Uscita d'emergenza (2014) e Generazione senza (2014), libri d'artista; Irrivelato segreto (2015), opera poetico-fotografica su alluminio; Messa a fuoco (2015), fotografia su legno, per la sensibilizzazione sul tema Ulivo di Puglia.
È ideatrice e curatrice del collettivo di poesia, arte e dintorni Il sasso nello stagno di AnGre (http://ilsassonellostagno.wordpress.com/); è presente in diverse antologie e su diversi siti e blog, tra cui Literary, La presenza di Èrato, Versante Ripido.
Giacomo Rossi Precerutti, da “Salvezza degli indugi”, Edizioni Ensemble, 2015, nota di Davide Campi
C’è grande sapere formale nella poesia di Giacomo Rossi Precerutti: lo dicono la regolarità del verso, il minuzioso controllo del ritmo, la sintassi essenziale e il lessico raffinato.
Queste caratteristiche permettono di far emergere chiaramente il disincanto diffuso che si respira nel testo, attraverso parole dense, evocative, combinate in modo serrato.
La perizia nella costruzione del verso, la lineare musicalità di questo, fanno da contraltare allo sgretolamento del senso, agli spaesamenti cui il vivere induce.
Non si parla di lievi increspature di superficie o di piccoli disordini quotidiani portati alla luce, ma di abissi e voragini, tumulti di un respiro più ampio contenuti in “ogni mondo remoto”.
III.
Il tepore opaco dell’estate
filtra dalle bocche tese
della città, dalle mani pesanti
che straziano il suolo informe.
Naufraghi sulle stanche vie,
dimenticati i nomi e le forme,
soltanto il suono dei venti
ci soccorre, fragoroso.
Affrettiamoci ad aprire le maglie
sfregiate del pensiero, a zittire
il silenzio che odia ogni
bellezza; non è sbarrata
questa pagina, questa oscura
natura dei luoghi mortali.
La salvezza degli indugi
si spalanca, controluce.
Giacomo Rossi Precerutti è nato a Torino nel 1988. Ha pubblicato presso Crocetti la plaquette Fuoco d’assenza (2006) e la silloge Sono io, quell’ombra (2010). Finalista con un inedito alla XXI edizione del “Montano”, è presente nelle antologie edite da Torino Poesia.
Emiliano Michelini, dalla raccolta inedita “Phanopoeia”, nota di Laura Caccia
Tra realtà e iperrealtà
Sono le immagini, sfigurate, frammentate e sovrapposte in un’accumulazione verbale che ammassa scorie di materiali, impressioni sensoriali e mentali, a connotare la raccolta “Phanopoeia” di Emiliano Nichelini, con riferimento al loro irrompere nell’immaginazione visiva, che E.Pound, definendo con Phanopoeia uno dei tre principi dell’arte poetica, sperimentò nell’elaborazione di una poesia frantumata e vorticosa.
Sono immagini che l’autore addensa in sommovimenti di dettagli lasciati in sospeso, in un dire spesso privo di legami sintattici e interrotto da frequenti cesure: “patire il significato. bilanciando una messinscena sotto il cielo del corpo. al supplizio dei fiori.” e ancora: “stare sulle viscere scorticate. nella gola dire carne e laser. tra le mie braccia voi lo conoscevate. l'intero fracasso meglio. vento dell'alfabeto.”
E sono immagini colme di riferimenti personali, storici, cinematografici, dove il sé e il sociale, la realtà e l’iperrealtà si mescolano in uno squarcio scorticato della contemporaneità, “tra gli oggetti perturbati in lontananza dove / lo sguardo è a mani vuote / impigliato nel solco finale come falce / si fa sentire oltre il reale”.
Quasi sequenze filmiche spezzate e ricomposte senza nessi evidenti, tra inquadrature a campi diversi, “rapidissimi primi piani”, dettagli di figure e “labbra inopportune”.
Nel suo dire che trasforma la realtà e si trasforma, Emiliano Michelini sperimenta stili diversi, quali endecasillabi a rima incrociata, la prosa poetica, terzine, quartine, cinquine e versi liberi.
Come a rispecchiare, nelle frasi frammentate e nelle linee melodiche non coese, il caos personale e storico, che fa i conti con il senso di vuoto che pervade ogni cosa, come batte e ribatte l’autore, in ostinato, nel testo d’inizio: “la lingua batte sul verbo del vuoto / del vuoto ch'è vuoto nel vuoto del fuoco /… senso del nulla che sta sottovuoto / come maceria la lingua e il suo odore”.
***
la lingua batte sul verbo del vuoto
del vuoto ch'è vuoto nel vuoto del fuoco
solo del verbo se piange d'un fioco
fiore a due petali nell'ultravuoto
senso comune nel vuoto remoto
vuoto di senso non un fuorigioco
no niente sarcasmo né videogioco
ma senso che è senso se è fiore di loto
ma no non manca di senso o memoria
e' solo smarrirsi al cuore del senso
ciò che conta qui non c' è controsenso
non c'è né follia né lezzo di gloria
borghese di rappresentanza è scoria
soltanto una scoria niente compenso
in moneta o in natura solo un denso
strepitio di clangori è la storia
tutta la storia è soltanto rumore
o anche terrore del nulla del vuoto
del vuoto di senso vuoto che a nuoto
nuota nel verbo financo al suo odore
lezzo di senso parola d'onore
lezzo e memoria d'un ruolo devoto
senso del nulla che sta sottovuoto
come maceria la lingua e il suo odore
***
una memoria della vita trascorsa, se è
la poesia ad averlo ridotto così. oppure è
il sonno ad averlo ridotto così.
dalla guancia risale il sangue in faccia,
l'interno dei lati, fatti bene.
ha una bocca tra parentesi.
labbra inopportune
Pubblicazioni di Emiliano Michelini:
piccola plaquette poetica inclusa nell'antologia "scorie contemporanee" (e-book edizioni la gru,
2007)
partecipazione con un testo poetico (“io non so se / per questa vita è meglio”)all'interno del volume
collettaneo "Calpestare l'oblio" (e-book 2010, poi cattedrale 2011)
primo libro organico di testi poetici "La circolazione del sangue" maggio 2013 (Sigismundus
editrice, Ascoli Piceno, 2013)
secondo libro organico di poesie "La luna vista dal mc donald's" in corso di stampa presso Oèdipus
Editrice (SA)
presente con alcuni testi poetici su riviste cartacee ed on-line dal 2005.
Ultima pagina: Autori presenti in “Carte nel vento”
Sebastiano Aglieco, Alessio Alessandrini, Pietro Altieri, Angelo Andreotti, Marcello Angioni, Cristina Annino, Gian Maria Annovi, Lucianna Argentino, Davide Argnani, Giuseppe Armani, Alessandro Assiri, Daniela Attanasio, Dino Azzalin
Luigi Ballerini, Paola Ballerini, Maria Angela Bedini, Daniele Bellomi, Primerio Bellomo, Pietro Antonio Bernabei, Armando Bertollo, Giorgio Bona, Leonardo Bonetti, Doris Emilia Bragagnini, Silvia Bre, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani, Antonio Bux
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Maria Grazia Calandrone, Giovanni Campana, Mario Campanino, Enzo Campi, Giovanni Campi, Martina Campi, Emanuele Canzaniello, Maddalena Capalbi, Michele Cappetta, Allì Caracciolo, Alessandra Carnaroli, Lorenzo Carlucci, Peter Carravetta, Alberto Casadei, Mauro Caselli, Guido Caserza, Alessandro Catà, Alessandra Cava, Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Alessandro Ceni, Rossella Cerniglia, Viviane Ciampi, Laura Cingolani, Gaetano Ciao, Domenico Cipriano, Roberto Cogo, Osvaldo Coluccino, Tiziana Colusso, Silvia Comoglio, Federico Condello, Nicola Contegreco, Antonino Contiliano, Marina Corona, Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto, Lia Cucconi, Miguel Angel Cuevas, Vittorino Curci
Mauro Dal Fior, Anna Maria Dall’Olio, Chetro De Carolis, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Lella De Marchi, Evelina De Signoribus, Silvia Del Vecchio, Pasquale Della Ragione, Stefano Della Tommasina, Tino Di Cicco, Vincenzo Di Oronzo, Letizia Dimartino, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria, Patrizia Dughero, Giovanni Duminuco
Marco Ercolani, Franco Falasca, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina, Silvia Favaretto, Francesco Fedele, Federico Federici, Annamaria Ferramosca, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Luca Ferro, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory, Rita Florit, Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Biancamaria Frabotta, Kiki Franceschi, Tiziano Fratus, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Gabriele Gabbia, Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Marinella Galletti, Carmen Gallo, Gabriella Galzio, Paolo Gentiluomo, Mauro Germani, Alessandro Ghignoli, Gianluca Giachery, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Patrizia Gioia, Carolina Giorgi, Marco Giovenale, Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Llanos Gomez Menéndez, Giuseppe Gorlani, Alessandra Greco, Angela Greco, Cesare Greppi, Maria Grimaldi Gallinari, Giovanni Guanti, Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini, Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin, Andrea Guiducci
Giovanni Infelìse, Maria Grazia Insinga, Carlo Invernizzi, Stefano Iori, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Loredana Lacroix-Prete, Marica Larocchi, Vincenzo Lauria, Alfonso Lentini, Tommaso Lisa, Oronzo Liuzzi, Andrea Lorenzoni, Francesco Lorusso, Ghérasim Luca
Loredana Magazzeni, Marianna Marino, Francesco Marotta, Giulio Marzaioli, Stefano Massari, Mara Mattoscio, Luciano Mazziotta, Daniele Mencarelli, Manuel Micaletto, Emiliano Michelini, Francesca Monnetti, Daniela Monreale, Emidio Montini, Romano Morelli, Sandra Morero, Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Gregorio Muzzì
Luigi Nacci, Giuseppe Nava, Stefania Negro, Davide Nota, Marco Nuzzo, Francesco Onìrige, Cosimo Ortesta
Luca Paci, Marco Pacioni, Alessandra Paganardi, Carla Paolini, Alice Pareyson, Angela Passarello, Giuseppe Pellegrino, Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Roberto Perotti, Luisa Pianzola, Renzo Piccoli, Antonio Pietropaoli, Pietro Pisano, Stefano Piva, Gilda Policastro, Chiara Poltronieri, Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Maria Pia Quintavalla
Jacopo Ramonda, Giuseppina Rando, Andrea Raos, Beppe Ratti, Luigi Reitani, Vittorio Ricci, Jacopo Ricciardi, Giuliano Rinaldini, Alfredo Riponi, Gianni Robusti, Marta Rodini, Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa, Sofia Demetrula Rosati, Lia Rossi, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti, Greta Rosso, Enea Roversi, Paolo Ruffilli
Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Rosa Salvia, Lisa Sammarco, Massimo Sannelli, Marco Saya, Viviana Scarinci, Antonio Scaturro, Evelina Schatz, Fabio Scotto, Massimo Scrignòli, Loredana Semantica, Luigi Severi, Ambra Simeone, Stefania Simeoni, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Marco Sonzogni, Pietro Spataro, Fausta Squatriti, Giancarlo Stoccoro, Maria Paola Svampa
Antonella Taravella, Gregorio Tenti, Italo Testa, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato, Silvia Tripodi, Luigi Trucillo, Guido Turco, Giovanni Turra Zan
Liliana Ugolini, Tonino Vaan, Roberto Valentini, Camillo Valle, Sandro Varagnolo, Matteo Vercesi, Maria Luisa Vezzali, Ciro Vitiello, Simone Zafferani, Paola Zallio
Febbraio 2017, anno XIV, numero 34

La storia del Premio Lorenzo Montano continua a rinnovarsi, anche dopo trenta indimenticabili anni ricchi di voci, scoperte, incontri, emozioni, intensità.
Il merito è tutto degli autori che vi prendono parte, contribuendo a raccontare la nostra finitezza e il suo spavento nella radice della creatività, nelle più variegate forme, con i diversi stili che rappresentano il nostro poetico contemporaneo.
Accompagnati dalle note della redazione di “Anterem” ne sono testimoni, nel presente numero di “Carte nel vento”, Enzo Campi, Lella De Marchi, Patrizia Dughero, Carmen Gallo, Maria Grazia Insinga, Sofia Demetrula Rosati, Ambra Simeone e Roberto Valentini: poeti e prosatori della 30^ edizione.
In chiusura Francesco Bellomi, pianista e vera e propria colonna sonora del Forum, compositore che ogni anno si misura con i vincitori del Premio, ci fa entrare nel suo laboratorio musicale.
Tutto questo mentre è in corso la 31^ edizione del “Montano”, organizzata per i poeti, i prosatori e i saggisti che vorranno percorrere un tratto di strada in una lunga storia
Scarica il bando della 31^ edizione del Premio Lorenzo Montano
In copertina: Francesco Bellomi ritratto da Marina Busoni, Forum Anterem 2016
Maria Grazia Insinga, dalla raccolta inedita “Ophrys”, nota di Giorgio Bonacini
Parola che sa diventare quello che è. Questo è ciò che la scrittura poetica riesce a fare quando innesta i suoi gradi di significazione nella materia della voce. Ciò che avviene è una moltiplicazione per spaccatura del senso, e ogni pezzo non è più una parte, ma un nuovo tutto in cui ciò che è prende corpo: si forma e si trasforma, inventa costantemente se stesso, ma mai si conforma. Così la parola di Maria Grazia Insinga è spesso pochi punti di aggancio con le cose conosciute: o meglio, la loro comprensione prende una piega diversa, con una ridefinizione dei parametri conoscitivi. E questo fa sì che sia la parola stessa a dar vita al conoscere, anche in ciò che non si sa. E proprio la suddivisione tripartita del poema in TESTA – TORSO – PIEDI, sembra il segno della dissezione di un essere che c’è ma è metamorfico nel suo andamento di crescita attraverso il lavoro poetico e polimorfico in ciò che alla fine di sé si autorappresenta.
La poesia è un’esecuzione linguistica che cerca vita mentre la dà, e vela e disvela percezioni sentite in metafore e nello stesso tempo in parole che sono ciò che dicono. Voci inaudite – non nell’alfabeta o nel sintagma – ma aurorali, per il principio di senso da cui originano. Un senso che appare oscuro, ma solamente perchè questa condizione è coerente con l’oscurità luccicante che troviamo nell’immersione e nell’allargamento di una lettura , al fondo di un percorso dove “probe di invisibile ci aggrediscono”. Ecco allora che l’indagine al fondamento di una scrittura chiede uno sforzo, seppur benevolo ma incisivo, teso a considerare una direzione dello sguardo poetico che non lascia nulla fuori dal grumo semantico e percettivo, in cui una “visibilissima inesistenza” ci dice cosa vediamo ma non come. Essendo quest’ultimo non solo una modalità dinamica, ma la vera e propria costituzione di materialità (palpabile o impalpabile che sia) di un atto poetico.
La voce che parla in queste poesie è suono preciso: ma di quell’esattezza e unicità che obbligano a un pensiero dislocante, altrimenti si resta in un limbo di insaputo e incompiuta lettura senza movimento alcuno. Ma l’inquietudine resta, perché anche questo è l’effetto di quel’ ondulazione continua in cui è collocata l’impossibilità di sapere dove origina e dove andrà a sfociare la lingua del poeta. E ciò è un bene, un “bene irreparabile” ci dice Insinga, al quale possiamo porre rimedio soltanto disponendoci ad accogliere una parola senza attributi, una parola nuda, forse sperduta, ma capace di essere lei stessa a dar forma e sostanza al pensiero del dire. Le poesie che compongono la raccolta, infatti, sono spinte in armonie che disarticolano la loro stessa sembianza, per trovare un’apparente stabilità dove “il silenzio deraglia”. E se la voce che non ha suono ma solo soffio, è ciò che contiene la parola, allora scopriamo che la sonorità di queste poesie non è solo musica e senso, ma qualcosa di più parcellizzato e diffuso: qualcosa che tocca l’esistenza attraverso “fonemi di vento” che avvolgono, con forza pulviscolare, il segno di ogni sogno e si oppongono alla “fogna civile del dire senza assoluto senza corpo” . Ed è strabiliante scoprire come, grazie a una poesia che possiede visione, si arrivi con un solo verso ad abbattere la falsa dicotomia tra poesia civile e poesia lirica.
Maria Grazia Insinga è poeta totale, di sensi e di senso, e non deborda mai oltre la sola necessità che hanno in sé le parole prima della luce. E lo ripete come un’invettiva che spazza via ogni illuminazione precostituita la di fuori del suo essere lingua di se stessa: veggente “tra un silenzio e l’altro”.
Dalla sezione “Testa”
Specchio
se aggiunge male al male
non starà poi così male
I guado
ora accade l’ordine
ora cada
defalchi l’errore la parola
data, d’amore
ora si taccia
II guado
dovresti procurarti il male
procurarle un filo di lame
obliquo rispetto all’asse
per obliare i dubbi
accelerare la corsa della lama
dovreste guadare lo specchio
nel catino di zinco
una vocazione a parte
spacca al centro
e a parte mette il male
e da parte il bene
da parte a parte
Dalla sezione “Torso”
Apollo
nel luogo
che cala a picco
il luogo che ti vede
I contorsione
la torsione dell’anello in anello
senza uscite e finitezza e infiniti
là non c’è punto che ti veda
non devi cambiare la tua vita
puoi umanizzare la perdita in argento
chiedere cittadinanza tra statue o viventi
II contorsione
la torsione del torso mantiene
l’armonia delle intenzioni
l’invenzione dei cimenti
la circolarità delle stagioni
un senzaquattresimo di visioni
per un eccesso di senso
Dalla sezione “Piedi”
Liste
I fame
eravamo più della somma
ora sottrarsi aggiunge
al digiuno una fame insaziabile
II fame
la lista lunga come la fame
allunga il passo e qui si frenetica
ciò che manca qui si frena e lei
arriva e arriva mille volte
reitera il sonno nel giardino dove
d’un tratto non poggi i piedi
sulle onde e brevi e lunghe forzata
a nuotare l’aria a non arrivare
Maria Grazia Insinga nasce in Sicilia il 20 aprile 1970. Dopo la laurea in Lettere moderne, il diploma in Conservatorio e in Accademia, l’attività concertistica e di perfezionamento e l’insegnamento nelle scuole secondarie, si trasferisce nel 2009 in Inghilterra per poi tornare in Sicilia quattro anni dopo. Nell’ambito degli studi musicologici censisce, trascrive e analizza i manoscritti musicali inediti del poeta Lucio Piccolo. Suona in un duo pianistico ed è docente di Pianoforte presso l’Istituto “Vittoria Colonna” a Vittoria (Ragusa). Nel 2014 la raccolta La porta meta fisica riceve la segnalazione al Premio Montano. Sempre nello stesso anno, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Capo d’Orlando, idea il Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale” La Balena di ghiaccio giunto alla seconda edizione e presieduto da Emilio Isgrò. È membro della giuria del Premio Internazionale di Poesia Don Luigi di Liegro. Alcuni testi si trovano nell’antologia Il rumore delle parole (Edilet) e in vari blog. Nel 2015 vince il concorso Opera prima iniziativa editoriale a cura di Poesia2punto0 con la silloge Persica.
Lella De Marchi, una poesia inedita, “A-polide, A-melia” (omaggio ad Amelia Rosselli), nota di Marco Furia
“A – polide A – melia”, di Lella De Marchi, è un intenso componimento dedicato alla compianta Amelia Rosselli.
L’immagine iniziale presenta qualità descrittive e richiami esistenziali ai quali, ovviamente, l’autrice non è estranea:
“Amelia distesa nella roulotte delle esistenze dette più
volte e rimaste da postulare in fondo alle scale si
lascia guardare da noi dal nostro essere vivi dell’essere
vivi, nuda respira comunque quandanche nel vuoto di
sé nel vuoto creato da sé comunque respira”.
Lella, come si vede, guarda, descrive e, soprattutto, c’è per via di una precisione linguistica efficace e coinvolgente.
E se gli ultimi due versi
“Se non riesco a parlare se non riesco a parlarti se non riesco
a parlarmi perché continuare a”
sembrano ammettere l’impossibilità del contatto, quel “non riesco a parlarmi” potrebbe costituire la presa d’atto di un totale fallimento comunicativo davvero tragico.
Ho usato il condizionale perché ritengo che simile insuccesso non debba necessariamente essere considerato definitivo.
Importa, in ogni modo, che la poetessa sia riuscita a offrire una sequenza poetica agile e assieme complessa, articolata eppure semplice, nel cui àmbito gli opposti tendono a sbiadire in differenze, a convivere rispecchiandosi gli uni negli altri, promuovendo uno stile dal non comune fascino.
Il dire poetico non ha alcun oggetto prestabilito, poiché la sua natura è propensa alla constatazione più che alla soluzione di problemi o a risposte esaurienti: della versificazione in esame si potrebbe quasi dire che consiste in un essere accanto tendente a un essere in.
Il sogno non sempre è espressione di un desiderio irrealizzabile, può anche emergere, mi si consenta l’ossimoro, quale onirica realtà, ossia immagine che si fa emozione, sentimento, inaugurando un’intensa scrittura.
È appunto il caso Di “A – polide A – melia ”.
A-polide A-melia
omaggio ad Amelia Rosselli
Amelia distesa nella roulotte delle esistenze dette più
volte e rimaste da postulare in fondo alle scale si
lascia guardare da noi dal nostro essere vivi dell’essere
vivi, nuda respira comunque quandanche nel vuoto di
sé nel vuoto creato da sé comunque respira.
Nel vuoto creato da sé il suo corpo che non esiste è la stampa
di cose che esistono in controluce, immagine in negativo
dispositivo verbale per la caduta dell’animale. Anche
l’aria ha una forma che fa paura che non è astratta se vista da
noi, una tenuta del suono che dimentichiamo se
preso per mano, un gesto svelto un po’ fuori tempo che
svela l’ipotesi che non abitiamo, la nostra mancanza di
vista la mia la tua mancanza di vista, la forza imperante della
terrena pittorica immaginazione.
Distesa nella roulotte la sua pelle vive d’insonnia si tatua come
una rosa di macchie violacee, non imposte non provocate non
derivate, indifferente è l’origine non è provenienza la
libertà, è bella di una bellezza che viene da prima di sé, prima
di sé dipende dipende soltanto di sé.
Amelia ti esce dagli occhi e dal cuore senza saperti guardare
ti guarda e forse ti parla ti chiede di non fare rumore di non
ascoltare il rumore.
Amelia nuda e distesa nella roulotte è un immenso paesaggio con
ossa, vita che vive senza ornamenti di necessari ornamenti.
Di necessari ornamenti di variazioni a catena si nutre
l’’appartenenza, è paura che fuga la commozione, un pianto
ancestrale, diviso in quadrati mattoni prima di darsi
alle fiamme prima di darsi alla luce prima di farsi feroce
ammissione di colpa e di identità.
Se si resta si resta nel fiume del pianto franto con
intenzione, nel trasporto s’ insegue il processo divino che non
conosce che non dice il tuo nome, il godimento sonoro che
avvera in preghiera il nostro bisogno di povertà il nostro
bisogno di privazione il mio il tuo bisogno di una
completa sterilità.
Se si resta si resta di umanità elevata al cubo, illibata e perduta,
di santità illibata e perduta, di una caduta di tono di una caduta di
luogo di una caduta di spazio scambiate per verità, scambiate
per te e per me piantate come un coltello nel verde mare
della differenza del cuore.
Se non riesco a parlare se non riesco a parlarti se non riesco
a parlarmi perché continuare a.
Lella De Marchi è poetessa, scrittrice, performer.
È laureata in Lettere Moderne con indirizzo in Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha seguito laboratori di Scrittura Creativa e Sceneggiatura Cinematografica a Roma con Andrea Camilleri e Ugo Pirro, a Pennabilli con Tonino Guerra, i corsi di Lettura ad Alta Voce con Lucia Ferrati e il laboratorio di teatro con Giuseppe Esposito a Pesaro, il corso per autori di canzoni di Francesco Gazzè.
Ha pubblicato due libri di poesia: “La spugna” (Raffaelli, 2010) con prefazione di Renato Martinoni e “Stati d’amnesia” (LietoColle, 2013), con un saggio di Enzo Campi e nota di lettura di Maria Lenti, e due raccolte di racconti: “Racconti Nove” (Albatros 2007) e “Tutte le cose sono uno” (ProspettivaEditrice, 2015), vincitore del Premio Braingnu, con prefazione del giornalista Rai Giancarlo Trapanese.
Ha ottenuto sia con l’edito che con l’inedito molteplici premi in concorsi nazionali ed internazionali. Suoi testi compaiono in antologie di poesia contemporanea, in riviste e blog specializzati su internet.
Organizza e partecipa ad eventi di poesia e narrativa, festival, reading, poetry slam in tutto il territorio nazionale. Con la collaborazione del chitarrista Alessandro Buccioletti e con testi tratti dall’omonimo libro di poesia ha realizzato il poetry –reading & percussive guitar “Stati d’Amnesia”, insieme alla ballerina Maddalena Belmondo la performance di poesia e danza “PoesieInMovimento”, con
È membro di giuria di diversi premi letterari nazionali (Premio Città di Cattolica, Premio Città di Fermo, Premio Città di Porto Recanati).
Collabora con la rivista “Versante Ripido” scrivendo recensioni a libri di poesia.
Attualmente sta lavorando al suo terzo di libro di poesie, la cui uscita è prevista entro il 2016 ed allo spettacolo/performance tutta al femminile “Tutte Le Cose Sono Uno – Poesia In Forma Di Band”, con testi tratti dal suo ultimo libro di racconti.
Nel 2012 ha ottenuto il secondo posto al Premio Lunezia, Sez. Autori di canzone con il testo “Imperfetto”.
Notizie aggiornate si possono trovare all’indirizzo del suo sito personale: www.lellademarchi.it
Sofia Demetrula Rosati, “A Trotula che dispensò bellezza e cura – frammenti di un culto misterico”, nota di Mara Cini
Un mediterraneo frammento di racconto situato in un tempo mitico dove regna il principio del naturale, dove, ancor prima che fosse impressa la parola alle pietre e la tradizione orale si potesse srotolare nel tempo della memoria gli elementi vegetali, terresti, marini dominano, in una specie di perfezione primordiale.
Qui la presenza umana, storia e dolore, sapere e carne viva, destinati a diventare opaca polvere, riverberano come pulviscolo luminoso , traccia pulsante che cerca di tenersi alle concatenazioni ancestrali, alle vite vissute come ricordi tatuati.
Allusioni a magici culti femminili, forse analoghi al culto della scrittura, sorella delle sagome, svelano o nascondono il liquido delle parole annegate nel proprio riflesso.
Nota biografica
Nome: Sofia Demetrula Cognome: Rosati
Professione: ricercatrice, poeta dimitra@fastwebnet.it
web: http://trattiessenziali.com
tratti essenziali: https://twitter.com/sofiademetrula
https://www.facebook.com/sofiademetrula
Pubblicazioni/attività:
-
In programma: reading “Bologna in lettere” sabato 28 maggio 2016 https://boinlettere.wordpress.com/2016/04/14/bologna-in-lettere-2016-il-... sabato-28-maggio/
-
Pubblicazione: tre inediti per il blog Trasversale con nota critica di Rosa Pierno (2016) http://rosapierno.blogspot.it/2016/03/sofia-demetrula-rosati-tre-inediti-per.html
-
Pubblicazione: in Words social forum “Senza distrazione – testo poetico di Sofia Demetrula Rosati su book fotografico di Cristina Rizzi Guelfi” (2016) https://wordsocialforum.com/tag/cristina-rizzi-guelfi/
-
Pubblicazione: in Carte nel vento ‘La solitudine della sapienza’ (nota critica di Marco Furia) https://www.anteremedizioni.it/montano_newsletter_anno12_numero26_sofia_demetrula_ros ati
-
Pubblicazione: in Poesia 2.0 ‘La solitudine della Sapienza’ (nota critica di Marco Furia) http://www.poesia2punto0.com/2015/03/15/la-solitudine-della-sapienza-dialogo-con- qohelet-di-sofia-demetrula-rosati/
-
Finalista: XXVIII edizione del Premio Lorenzo Montano (2014) per la Sezione una poesia inedita, con il testo‘la solitudine della sapienza’.
-
Pubblicazione: poesie di Antonis Fostieris (introduzione critica + testi tradotti), in Anterem n.88, Anterem Edizioni, (giugno 2014).
-
Pubblicazione: in Poesia 2.0 ‘XX premio Donna e Poesia’ http://www.poesia2punto0.com/2012/12/08/il-paese-delle-donne-xx-premio-donna-e-poesia/
-
Premio: 1° premio – ex equo (sezione opera edita) volume ‘l’azione è un’estroversione del corpo’, Cierre Grafica, Verona, 2011 – assegnato da Il paese delle donne – XX PREMIO DONNA E POESIA (ottobre 2012) - Dedicato all’artista cilena Maitè (Maria Teresa Guerriero).
-
Pubblicazione: poema ‘il demolito è l’unica dimora del ritorno’ nel periodico on line Carte nel vento di gennaio 2012, anno IX, numero 16, accompagnata da una nota critica di Marco Furia. https://www.anteremedizioni.it/montano_newsletter_anno9_numero16_rosati
-
Reading: Convegno internazionale di poesia “Parola per parola” (novembre 2011) - Rivista Anterem – Biblioteca Civica Di Verona.
-
Finalista: XXV edizione del Premio Lorenzo Montano (2011) per la Sezione una poesia inedita, con il testo ‘il demolito è l’unica dimora del ritorno’.
-
Presentazione: Manuela Fraire e Tiziano Salari hanno presentato il volume ‘l’azione è un’estroversione del corpo’, edito nella collana di poesia Opera Prima, diretta da Flavio Ermini. A Roma, ottobre 2011, presso la libreria Empiria.
-
Pubblicazione: in Poesia 2.0 ‘Tutti gli autori di Opera prima’ http://www.poesia2punto0.com/2011/10/08/tutti-gli-autori-di-%E2%80%9Copera- prima%E2%80%9D-sofia-demetrula-rosati/
-
Pubblicazione: silloge ‘l’azione è un’estroversione del corpo’, Collana Opera Prima – Cierre Grafica, Verona, 2011. Riflessione critica di Tiziano Salari.
-
Reading: VeronaPoesiaFestival 2010- Letture dei poeti segnalati e finalisti.
-
Segnalazione: Premio Lorenzo Montano XXIV Edizione (2010) – sezione raccolta inedita – silloge ‘l’azione è un’estroversione del corpo’.
-
Collaborazione: con la rivista Poesia, Crocetti Editore, per articoli, recensioni e altro.
-
Finalista: nel premio letterario Fili di Parole, con silloge inedita: ‘per farti dimenticare Penelope’, Giulio Perrone Editore, Roma, 2008.
-
Reading: di poesia nell’ambito della manifestazione ‘Parole, Parole, Parole’, Alphaville Cineclub, Roma, 2007.
-
Pubblicazione: in raccolta antologica DI QUEL FUOCO, Giulio Perrone Editore, Roma, 2007.
-
Pubblicazione: in raccolta antologica IOSCRIVO, Giulio Perrone Editore, Roma, 2007.
-
Corso di video-poesia presso la casa editrice Giulio Perrone (2006-2007).
-
Pubblicazione: ‘La poesia è il fiore più antico della terra’, Katerina Anghelaki Rooke (introduzione critica + testi tradotti), in Poesia n.201, Crocetti Editore, Milano, 2006, pp. 16- 28
-
Pubblicazione: ‘Katerina Anghelaki Rooke’, in “Passages – Rivista di Arti Culture Riflessioni”n.8, Passigli Editore, Firenze, 2004, pp. 7-63. Tradotta per la prima volta in italiano. http://www.passages.it/Passages8/Poesia_Rooke.pdf
-
Pubbblicazione: silloge ‘Maggio inquieto di desideri’ sul sito della rivista Passages, 2004. http://www.passages.it/Passages7/maggio_solitario.pdf
Una prosa inedita
a Trotula che dispensò bellezza e cura - frammenti di un culto misterico
Si occupava del corpo delle donne Trotula de’ Ruggiero che fu filosofa e medico nei pressi del 1050 a Salerno, terra di tante lingue erossi frutti, di chiaroveggenti pietre lucide e di un astuto mare che domina e istruisce. Curava Trotula, attingendo a quello stesso uterosempre gravido che fin dall’incanto del primo sguardo, pose nelle mani delle donne il dominio degli elementi. Ancora prima che fosseimpressa la parola alle pietre e la tradizione orale si potesse srotolare nel tempo della memoria. Il principio di cura prevedeva un corpobello a vedersi tanto da poterlo confondere con l’incidere maestoso delle divinità che con lui si intrattenevano. Bello di una bellezzaarborea, capace di competere con la perfezione di animali e piante e di carpirne i segreti. E alla tradizione orale attinge Trotula,iniziata all’arte medica da una donna di cui lei tenne sempre segreta l’identità. Sappiamo di un boschetto di limoni e olivi doveTrotula, ancora bambina, trascorse una lunga notte di luna nera al solstizio d’inverno. Ne uscì al mattino, ormai fattasi donna. Dellasconosciuta sappiamo solo le parole recitate durante i riti misterici che si svolgono nei boschetti di limoni e olivi, dalle donne chedisegnano le costellazioni.
senza volontà esco dal bosco c’è il minimo indispensabile odore di polvere di terra smossa poca umidità echi di suoni lunghi e acuti cigolìo di materia dolorante spira un leggero vento secco che screpola quel che resta della notte mi distendo sull’altare di tufo e pietra tra i ramoscelli di alloro davanti alla luna nera e chiedo comprensione sorgo e tramonto senza posa Trotula lo sai che gli uccelli si addormentano con il timore che il sole torni? e il chiarore della luna non li conforta ma li fa tremare ancora di più con la sua mutevolezza e in queste notti di luna nera di buio denso pregano che non si provochi lo stupore
l’inverno uniforma gli odori li rende meno attraenti avvicinati stenditi su questo giaciglio lascia che riconosca il calore di un corpo sono nata e già questo era sbagliato Trotula c’è un rimedio all’esser figlia non voluta dall’utero che l’ha partorita? ho desiderato carne umana volevo divorare una vittima sacrificale un mio trofeo e mi ritrovo carcassa putrescente scansata anche dalle iene trasformami in leggera umidità notturna in scarna rugiada mattutina e senza riflettere lascia che mi immerga nella prima sagoma incontrata mi faccia refrigerio per una mucosa di larva che cresce in velocità nevrotica scavando cunicoli
di giorno sosto in un luogo scuro con le ginocchia immerse in una fanghiglia impalpabile tra le mani i miei capelli sono diventati radi e grigi senza il nutrimento della luce non so se sto invecchiando o se lo scorrere non consuma tempo in questi cunicoli in fondo potrei essere ancora bambina odorami Trotula so di buono? sono con me gli antenati intenti a scavare e seppellire vite vissute le donne si fanno scheletro piùlentamente e hanno il tempo di destreggiarsi con i resti dei loro uomini ne nascondono le ossa sotto un terriccio umido e profumato per non doverle più ricomporre Trotula gli antenati urlano e reclamano vendetta e mi chiedono di aiutarli a scavare perché ho dimestichezza con il sottobosco ma le mie mani sono stanche e necessitano di cure
ascolta sono gravida ecco affonda le mani nel mio utero e ascolta ho il ventre colmo di una vita sconosciuta ascolta Trotula non senti questo rumore di foglie e arbusti? non era forse un tempo solo eros? e tutte lecreature si univano in amplessi prolungando il balenìo della venuta della storia e gli amplessi generavano costellazioni il senso apparteneva agli alberi fino a quando decisero di disporre fioriture e frutti dicondividere discernimento e inquietudine e gli esseri umani sono rimasti intrappolati nel dolore di un Narciso scomposto che lascia annegare il proprio riflesso e volge lo sguardo al cielo che ascende e discendementre la polvere resta l’unica semenza
Trotula mi curi con aloe miele e zenzero pensi che io abbia ricordi tatuati che sia figlia di una terra contesa dalla luce caparbia dagli aromi esuberanti i colori riccamente disposti ma io sono figlia delladimenticanza della dismissione di ciò che non svolge per essere visto ma ascoltato io sono sorella delle sagome non mi inseguire
hai compiti importanti Trotula prendi tutto il mio sapere e fanne luce e calore permetti le nascite rinvigorisci gli uteri lenisci cospargi di unguenti e ammorbidisci le carni delle donne permetti il fluire del mestruo distribuisci bellezza rendi loro ciò che a me tolgono poni le vergini a tua difesa e di questo nostro amplesso ai margini giorno taci non porgere mai le spalle a levante di notte volgi lo sguardo alle costellazioni danza e canta dimentica il buio nel momento stesso in cui lo vedi ché non sia per te d’inganno
Si narrava delle migliaia di donne uccise perché detenevano conoscenze di cura. Ma alla Scuola Medica Salernitana arrivavano dalmare uomini e donne dalle mille lingue. E le parole nuove si sa, generano alchimie e la conoscenza che ne discende si muove in libertàper molto tempo. Dall’alto di un dirupo Trotula una sera volle trasgredire, volse le spalle al mare e posò lo sguardo sulla vasta pianuraoltre le colline che accoglievano la cittadina proteggendola. Vide sparsi bagliori di roghi e lunghi fumi neri che coprivano lecostellazioni. È vero, pensò, le donne si fanno scheletro lentamente. I suoni di flauti e danze la riportarono con lo sguardo verso il maree la sua Salerno dove trascorse una vita lunga e feconda. Dispensò cure e bellezza fino all’ultimo dei suoi giorni. Mai più volse le spallea levante.
Carmen Gallo, da "Paura degli occhi", L'Arcolaio 2014, nota di Rosa Pierno
Il tema dello sguardo, del distinguere con gli occhi per conoscere, presente nella maggior parte delle poesie di questo volume è intrecciato indissolubilmente con un altro tema: quello della separazione e della fine che è poi quello dell'impossibilità di vedere. Vedere è dunque avere una relazione con un altro essere. Perdere una persona è come perdere gli occhi. Ma vi è anche un vedere con la sola mente, modo che si attiva quando nella perdita si ritrovano tute le immagini accumulate in precedenza. È solo a questo punto che la scrittura trova dichiarata necessità: "individuare uno ad uno / ogni grado di necessità / assegnare come un nome / una mappa affidabile di ogni tua / minuscola escoriazione". La scrittura ricostruisce l'immagine. Ne ricompone le fattezze con la sua tecnica restitutoria/restaurativa. Certo, appena consolatoria, ma necessaria. Essa consente di avere a disposizione un ulteriore spazio progettuale "abitare i soffitti cavi delle parole / e tendersi a raccogliere / solo i tempi imprecisi delle cose". La scrittura consente di allargare le maglie della visione, tessere relazioni tra i corpi del quotidiano e i corpi della storia mantenendo tutti gli avvenimenti sul piatto di un presente che, miracolosamente, è di nuovo sotto il nostro sguardo.
***
Come abitare in un paese straniero
ogni notizia che giunga da te
abbatte aerei, rovina raccolti
costruisce mura intorno
a un cielo bucato
***
Quanto basta a specchiarsi e riaversi
senza più attendere il nome delle cose
legare al letto ciò che non ci sopravvive
con la bocca sulla bocca difendere
ciò che non detto pure esiste
ma poi arriva
l’elenco necessario delle cose che hai
e non t’importa più di perdere
ciò che muto non ti somiglia
***
Non restare buchi neri
fondi fedeli al vuoto
affilare la lama che separa
i lati bianchi della strada
nel paese che nasconde
il cielo nelle cave
essere terra non chiamata
invocazione senza nome
distanza da percorrere sottovoce
***
Stringersi la gola e attendere
prima di respirare ancora
il tempo di cancellarsi la faccia,
il fiato, le rughe sulla fronte
***
Nella gravità delle cose
che non cadono
sostenere lo sguardo
del disastro
Carmen Gallo è nata a Napoli dove insegna Letteratura inglese all’Università L’Orientale. Si occupa di poesia metafisica inglese, teatro elisabettiano, teoria del romanzo e critica angloamericana. È stata finalista due volte al premio Mazzacurati-Russo (2009-2010; 2011-2012), e ha ricevuto una menzione speciale al Premio Montano nel 2011. Alcuni suoi testi sono stati pubblicati su blog (Poetarum Silva, Poesia di Luigia Sorrentino, Transiti Poetici, Carteggi letterari, Formavera, Interno Poesia, Nazione Indiana, Nuovi Argomenti), in antologie (Registro di Poesia #3, 2010 e Registro di Poesia #5, 2012, Edizioni D’If, Napoli), e su rivista (Smerilliana, Argo, e a breve L’Ulisse). Nel dicembre 2014 è uscito il suo primo libro di poesia: Paura degli occhi, per L’Arcolaio, Forlì. Alcuni testi sono stati tradotti in francese da Clement Levy per la rivista online Remue.net.
Dal 2015 cura, con altri colleghi, il Seminario di poesia comparata presso l’Università Federico II, e da quest’anno partecipa al Laboratorio di poesia in carcere della Fondazione Premio Napoli.
Patrizia Dughero, da “Canto del sale”, qudulibri 2016, nota di Davide Campi
Possiamo definire “Il canto del sale” di Patrizia Dughero come “poesia della terra”.
In questo “canto del sale”, infatti, si scorge tutto lo spessore di una cultura contadina complessa, articolata e antica.
È una narrazione a volte dura, di tagliente precisione. In essa i luoghi determinano gli avvenimenti, e i famigliari diventano gli eroi di un’epica privata.
La cesura dei versi riproduce in tanti casi un respiro rotto dal pianto.
Altre volte i versi hanno ritmo più dolce e compiuto, in aperto contrasto con la forza delle parole scritte e con il dramma che ne emerge.
La scrittura si articola in prima persona: il soggetto prova sul proprio corpo gli effetti degli eventi illuminati dai versi.
Soggetto che non è veramente solo “io”, ma piuttosto una sua forma “collettivizzata”.
Soggetto che in sé somma tutti i soggetti che hanno fornito la materia prima di questi scritti, generandone la cultura.
Il percorso del sangue
Quando la terra è di nessuno allora non ha confine.
Muro.
Senza confine in un tempo preciso
quando il blu diventa rosso,
il typus di circolazione sanguigna è determinato dal sangue
che entra negli organi come sangue arterioso
rosso
e li lascia come sangue venoso
blu.
Nell’apparato scheletrico da lì sgorga il sangue.
Il polmone sembra un albero rovesciato
il tronco e le radici dell’albero respiratorio
sono rappresentati da trachea e da laringe dirette in alto.
Attraverso la laringe si può dimostrare
una relazione del polmone con la parola
e del pensiero collegato alla parola.
La postazione esterna del polmone diventa il naso
che assume affnità con la funzione del pensiero.
Mancanza.
Nel corpo ogni organo presenta una duplice natura
e il fegato dà all’uomo il coraggio
di mettere in atto un proposito.
Sale.
L’asimmetria, processo della volontà,
è nesso riscontrabile anche in architettura.
Così la circolazione, il suo typus, genera
un rimodellamento continuo
come le correnti in un’isola di sabbia: nell’isola,
che ha pianta a forma di rene, Spiekeroog,
il moto ondoso, il calore solare e il vento in continuazione
muovono la sabbia, ricreano in continuazione
la forma aggiungendo o togliendo sabbia.
Non è dunque il cuore che muove il sangue
bensì la corrente sanguigna che muove il cuore,
la forza che muove il sangue sta nei sentimenti,
la limpidezza risulta sempre una caratteristica
della morte e dell’elemento minerale.
Guardiana.
La tendenza eccessiva alla limpidezza
potrebbe causare
l’insorgenza di rappresentazioni ossessive.
L’occhio si svuota di vita e di sangue
e perciò diviene trasparente.
Sguardo.
Patrizia Dughero, di origine friulana, è nata a Trento nel 1960. Si è laureata in Arti Visive a Bologna, dove vive e lavora. Dopo svariate occupazioni, tra cui quella più significativa come restauratrice muraria, si dedica completamente alla scrittura, ricevendo riconoscimenti e alcuni premi letterari, inizialmente in concorsi per racconti brevi e in seguito in quelli di poesia. Considera di aver trovato una sorta di appartenenza inserendosi nel contesto dei poeti del Nord-Est, in particolare del goriziano. È presente in numerose antologie, di racconti, di poesie e con testi di prosa poetica. Attualmente la sua attività si concentra su articoli e progetti editoriali. Recensioni sui suoi scritti sono inserite in riviste letterarie, in Italia e in Slovenia. Da qualche anno sta svolgendo studi sul linguaggio poetico dello haiku, culminati nella sua ultima raccolta, Filare i versi /Presti verze, tradotta da Jolka Milič. È stata capo redattrice della rivista “Le voci della Luna”, per cui ha svolto approfondimenti sul tema della scrittura poetica legata al mito, in relazione al disagio femminile.
Coinvolta nel progetto editoriale di Francesca Matteoni, e del suo Blog “Fiabe”, ha realizzato articoli sul tema delle mitiche figure denominate “agane” e del fiabesco, con la partecipazione al volume Di là dal bosco, Edizioni Le Voci della Luna e con l’imminente uscita di un’altra antologia su figure legate all’acqua nei miti europei.
È curatrice dei volumi e responsabile di redazione di “24marzo Onlus”, associazione non governativa che svolge attività culturali e di formazione giuridica sul tema della tutela dei diritti umani e in particolare sulle questioni legate ai desaparecidos argentini di origine italiana.
Ha partecipato a eventi e festival letterari e artistici a Bologna, in Friuli, e in altre regioni in Italia, oltre agli eventi legati alle attività della Rete per l’Identità Italia (di cui fa parte 24marzo Onlus) con ruolo attivo nell’organizzazione. Suoi articoli sono apparsi, tra gli altri, su “le Monde diplomatique” e “Leggere Donna”.
Nel 2013, insieme a Simone Cuva, ha fondato qudulibri, (qudulibri.wordpress.com). Crede nella trasmissione editoriale di una “poesia agita”.
Sono sei le sillogi poetiche pubblicate: Luci di Ljubljana, Ibiskos Editrice Risolo 2010; Le Stanze del Sale, Edizioni Le Voci della Luna (Premio Giorgi) 2010; Canto di Sonno, in tre tempi, Edizioni Smasher (Premio Ulteriora Mirari) 2011; Reaparecidas, qudulibri 2013; Filare i versi /Presti verze, qudulibri 2015; Canto del sale, qudulibri, 2016.
Le sue poesie sono tradotte in spagnolo e sloveno.
Roberto Valentini, dalla raccolta inedita “Vangelo meneghino”, nota di Laura Caccia
Cosa si sente
Quale buona novella ci narra Roberto Valentini con la descrizione, in “Vangelo meneghino”, di una città naufraga e randagia, con la sua umanità dolente e smarrita?
Milano è raccontata attraverso dodici quadri in cui si intrecciano crepe di ombre sotto i portici, cieli sfatti e stanchi, acque sepolte e canali, selciati e luoghi urbani, in un affresco che predilige i toni della sofferenza, ma che lascia anche trapelare squarci di luminosità.
“Infedele / al suo dubbio divaga sui selciati / la città come un flutto dentro il fiele / dell’alba”, ritrae da un lato, nei suoi affreschi dolenti, l’autore e dall’altro, nelle sue aperture di acque e chiarori, “Sì, è una storia / di borri e navigli Milano, d’acque / risorte da altri ipogei di memoria, / ai fontanili sospinte in cui nacque / il riso”.
Anche la gente che la popola viene narrata in stazioni di fatica e solitudine, emarginazione e agonie, dove “croci accolgono di consunte braccia, / e barbe bisunte che come i tigli / nei volti nascondono una faccia / d’aurore”, ma anche attraverso barlumi di speranza: “È la fatica d’una gioia intatta, / proclamata sin dentro la sua pena, / sola maniera rimasta adatta / a essere vivi.”
Quasi metafore delle tante vie crucis, che accomunano popoli e persone, e insieme epifanie di una possibile redenzione, che si rivela come qualcosa di simile alla letizia, appena percepibile, sommessa, commossa.
I testi, connotati da una forte struttura che fa da cornice al racconto, con strofe di venti versi endecasillabi e chiusura di ciascuna con la stessa voce verbale “sente”, ne assecondano il contrasto: quasi, da un lato, a mostrare la necessità di una tenuta, un confine al dolore, e, dall’altro, ad aprire all’ascolto, alla possibilità di un annuncio.
Dalle prime chiusure “solo randagi quaggiù ci si sente”, “quando un pianto si sente”, “se nulla si sente” è un crescendo con cui Roberto Valentini ci conduce verso una promessa, una speranza di salvezza, dove “più salvi qui ci si sente” e “una gioia si sente”, per concludere infine con una, benché ancora in fasce, lieta novella: “se più in solitudine / qualcosa che è nato adesso si sente”.
***
La città non è né l’una né l’altra:
non nella cerchia di periferie,
non in quella che logora ormai scaltra
la luce sopra i bastioni. Eresie
di graffiti ne supplicano il luogo,
il limine cui urge e abroga, che segnano
sui vecchi androni come d’uno sfogo
d’urla colmati o in tinte che consegnano
a intonaci muti tra i falansteri.
Ma una burla di vernici soverchia
il tempo che iscrive senza criteri,
il crimine imprudente che scoperchia
l’assenza e vi rintraccia gli isolati
dall’una all’altra frontiera. Infedele
al suo dubbio divaga sui selciati
la città come un flutto dentro il fiele
dell’alba, si propaga su uno stagno
di nebbie, lutti e utopie, sulle lente
circonferenze d’insonnie, vivagno
di quartieri cui stretti ci si sente.
***
Ma altre circolari d’auto ed abbagli
toccano merlature e feritoie
di torri, languono in fianco a spiragli,
a neon appariscenti come noie
carpite alle finestre d’ospedali;
la volta infrangono che qua divora
le logge, antichità penitenziali
sulla pietra mostruosa che dell’ora
più serena riveste Sant’Ambrogio,
quando sopra un patibolo di stelle
anche l’immensità aspetta il suo mogio
sospiro e un vestibolo di cappelle
attinge al nostro incurante deporre.
Sono i tragitti allora che ne ammassano
i sovrappassi, le piazze cui incorre
perduto un destino, che vi oltrepassano
i silenzi dei parchi e alla Ghisolfa
fruscii di pilastri. Quando veggente
attraversa i suoi varchi una solfa
di piogge, qui ove un lastrico la sente.
Roberto Valentini, nato a Milano, dal 1999 lavora come insegnante nella scuola secondaria superiore e sopra(v)vive a Bernate Ticino, al confine occiduo della provincia milanese. Laureatosi in filosofia all’Università degli Studi di Milano, ha collaborato con la cattedra di Storia della filosofia contemporanea II quale redattore della rivista “Magazzino di filosofia” diretta dal Prof. A. Marini; attualmente, oltre a proseguire tale attività, è fra i curatori del relativo sito web di filosofia contemporanea (www.filosofiacontemporanea.it). Si è interessato in modo particolare della filosofia francese post-strutturalista, della Nietzsche-renaissance e del pensiero di autori quali Blanchot, Derrida, Deleuze, Bataille; in questi anni ha pubblicato, fra gli altri contributi (recensioni e florilegi), saggi sull’insegnamento della filosofia, sul cinema di Kubrick e Il gesto di Alcesti (“Magazzino di filosofia” n. 19/2012), una interpretazione letteraria di alcune tematiche della riflessione di Maurice Blanchot. Ha presentato un proprio lavoro nell’opera collettiva Vita, concettualizzazione, libertà (Mimesis, Milano, 2008).
Sue liriche inedite, articoli, escursioni di carattere saggistico-espressivo ed un racconto sono presenti sul sito web della rivista letteraria “Lunarionuovo”, diretta dallo scrittore e saggista Mario Grasso, sulla rivista “L’EstroVerso” e, diffusamente, sul sito personale (www.robertovalentini.org). Ha pubblicato il volume Dante a rovescio. Il XXXIV canto dell’Inferno capovolto (selfpublishing, Lecce, 2012), le raccolte poetiche Il peso dell'ombra (Prova d’Autore, Catania, 2013), Fra terra e luce. Antipodi dell’uomo (selfpublishing, Lecce, 2014) e Il male degli occhi (Puntoacapo Editrice, Pasturana 2014). Per i tipi di Puntoacapo Editrice è in corso di stampa la raccolta Il beneficio delle brume. Sue liriche sono presenti nelle antologie Enciclopedia di Poesia contemporanea (Fondazione Mario Luzi Editore, 2015), Atti della XVII Biennale di Poesia di Alessandria (a c. di Aldino Leoni e Mauro Ferrari, Puntoacapo Editrice, Pasturana 2015) e sul numero XXVIII di Carte nel Vento, periodico on-line del Premio “Lorenzo Montano”.
Ha ricevuto riconoscimenti al Premio “Lorenzo Montano” (2013, 2015), al Premio Internazionale “Cinque Terre” e la Menzione d’onore per l’opera Il male degli occhi al Premio Casentino 2015. Scontando come tutti la “nera foga della vita” di sabiana memoria, continua a coltivare l’impaziente passione delle lettere, preservando epistole, esercizi di stile, prose rapsodiche e innocenti endecasillabi – né pretenziosi né insinceri – dalla (nella) loro lieve agonia dentro uno stipo.
Ambra Simeone, una prosa inedita, “Un partigiano leopardiano”, nota di Flavio Ermini
Ambra Simeone ci parla di un “uomo del sottosuolo”. Ci parla di un Altro, di una persona che non vuole omologarsi. Una persona che non chiede di essere accolta dalla comunità, perché non vuole condividerne il conformismo.
Stare fuori dalla società comporta dolore e sofferenza, sì, ma consente anche di mantenere la propria identità.
La figura della quale ci parla Ambra Simeone ha bisogno di essere se stessa, di trasformarsi e modificarsi senza condizionamenti, utilizzando per la costruzione di sé solo il “materiale” che proviene dalla propria interiorità.
Ha bisogno di conquistare la propria autonomia intellettuale: un’impresa che richiede spietatezza. E soprattutto il coraggio di mettere in gioco se stessi. Richiede di trarsi fuori dal contingente e spingerci fino al limite del fare esperienza, sottraendosi al conformismo e vivendo il proprio disagio esistenziale fino a rivelare agli altri la propria insofferenza.
L’“uomo del sottosuolo” del quale ci parla Ambra Simeone non si riconosce più nelle rappresentazioni comuni dell’esistente che l’abitudine e il potere offrono a piene mani. Ci impone, in ultima analisi, di essere partigiani e di esserlo attraverso la scrittura, magari in un leopardiano “zibaldone di pensieri”. E ci impone di essere dissidenti contro tutto ciò che ci fa ostaggi e ci rende prigionieri.
Nota biografica
Ambra Simeone è nata a Gaeta (LT) il 28-12-1982 e attualmente vive a Brugherio (MB) dove lavora. Laureata in Lettere Moderne, ha conseguito la specializzazione in Filologia Moderna con il linguista Giuseppe Antonelli e una tesi sul poeta Stefano Dal Bianco. La sua prima raccolta di poesie “Lingue Cattive” esce a gennaio del 2010 per Giulio Perrone Editore (Roma). Del 2013 è la raccolta di racconti “Come John Fante... prima di addormentarmi” deComporre Edizioni. La sua ultima raccolta di quasi-poesie esce nel 2014 per deComporre Edizioni con il titolo “Ho qualcosa da dirti - quasi poesie”. È co- curatore de “Il Gustatore - quaderni Neon-Avanguardisti” che hanno ospitato gli autori: Aldo Nove, Giampiero Neri, Peppe Lanzetta, Paolo Nori e molti altri. Ha curato un progetto multi-antologico attorno al tema della scrittura dal titolo “Scrivere un punto interrogativo” edito da deComporre Edizioni. Alcuni suoi testi sono apparsi su riviste letterarie nazionali e internazionali tra le quali: l’albanese Kuq e Zi, la belga Il caffè e l’americana Italian Poetry Review. Sue poesie sono apparse su diverse antologie tra le quali: Il Quadernario Blu per Lietocolle a cura di Giampiero Neri e Il rumore della parole per EditLet a cura di Giorgio Linguaglossa. Ha organizzato diversi incontri poetici collettivi, fa parte del gruppo dei “Pentagrammatici” attivo nella provincia milanese. Sulla sua scrittura si sono espressi: Gian Ruggero Manzoni, Franca Alaimo, Giampiero Neri, Giorgio Linguaglossa, Claudio Damiani, Nazario Pardini, Marzio Pieri, Stefano Guglielmin. Nel 2015 ha vinto il Premio italo-russo “Raduga” come giovane narratore italiano, per l’occasione un suo racconto è stato tradotto in russo.
Un partigiano leopardiano di Ambra Simeone
sto resistendo a questa cosa che consiste nel mettersi l’orologio al polso sbagliato, visto che il destro non è quello dove si dovrebbe mettere di solito, invece dovrebbe essere il sinistro, a intonarsi con l’eventuale fede e/o anello di fidanzamento, che si tratti di una donna oppure di un uomo, la regola non cambia, rimane quella, così più che trasgredire mi sono imposto di resistere, perché più che di una regola si tratta di un modo di fare, di vestirsi, di farsi vedere, di farsi uguale a chi l’orologio proprio deve portarlo sul polso sini- stro e non su quello destro
che diranno gli altri di questa strana mania?
vedi come fa? pare lo faccia apposta a mettere quella lingua così e quella bocca così, sembra che abbia la gobba persino, con quell’accento poi che si sente che è proprio del sud Italia, mi dice l’amica di facebook del gruppo amiamo la lingua italiana, allora sto resistendo, anche adesso, ora che mi sono trasferito, ma piuttosto che perderlo sto resistendo per farlo rimanere lì quell’accento, preservarlo, che gli accademici della Crusca potrebbero ri- prendermi, se dico ho sceso la valigia, che se lo scrivo me lo sottolineano con la matita rossa di sicuro, possibile che ad avere più paura di quell’amica che non ricordo che faccia abbia, forse non l’ho mai vista neppure in faccia, mi sembra che io ho più paura degli accademici della Crusca?
il piacere di fare il solitario appaga le sue voglie di artista incompreso?
ho visto tanti film sui grandi geni della storia, tutti perfettamente incom- presi, sarà che ai registi la cosa piace, la gente i libri non li vuole leggere, i film invece, non ho mai visto un film in cui loro, i geni, erano perfettamente compresi da qualcuno, che a pensarci su, nessuno è davvero compreso nep- pure i perfetti imbecilli, comunque non era di questo che volevo parlare, ma del fatto che resisto anche quelle volte che mi dicono che c’è della gente che si compra le macchine da quarantamila euro, mentre io vado sul colle di casa mia guardo e rimiro interminati spazi, ma come loro al di là di quelli ce ne sono davvero tanti, non immaginavo neppure così tanti, però non è per i sol- di che se pagati a rate non sono poi così pesanti, ma vorrei resistere alla vo- glia che ha la mia collega di sedersi su una macchina alta un metro e cin-
quanta da terra, invece che sull’erba di un colle, se per sentirsi così dovrà farlo fino all’ultima rata, tra tre anni a duecentocinquanta euro al mese, men- tre di stipendio ne prende solo ottocento, così preferisco parcheggiare la macchina tra le fronde per guardare la luna, e sul cofano prenderci tanti graf- fi dai rami che scendono giù, così posso dire che la mia macchina è bella e vissuta
ma il suo diario?
sì, lo scrivo sotto forma di poesie che sembrano prose, qualcuno mi ha detto meglio lasciar stare che quella lì non è poesia, è uno zibaldone e allora mi sono bloccato per un po’, ma fatevi i fatti vostri, gli ho detto, è solo un compito che mi ha dato lo psicanalista, anche se non era vero, andate a dirlo a lui se non vi piace, allora ho chiesto senza pretesa alcuna, ma voi cosa scrivo, lo avete letto davvero? mi viene il dubbio, perché se resisto a tutte queste cose, che possono sembrare stupide soprattutto da quando settant’anni fa ci siamo liberati di qualcuno che ci imponeva delle idee, adesso resistere servirà pur a qualcosa, mi chiedo? allora provo anche a non andare la dome- nica al centro commerciale quello enorme in centro, solo per andare a passa- re il tempo, a fare una passeggiata tra i negozi, quando fuori piove o nevica e fa freddo, invece dentro mi faccio un giro tra le borse, le scarpe, gli elettro- domestici, i mobili dal design innovativo, che mi tengono al caldo, e quando esco con le borse vuote, era solo perché volevo incontrare qualcuno e non camminare da solo in mezzo a tutta quella roba, maledetta roba
non sarà mica un po’ di vittimista?
no, sarà che mentre faccio questi ragionamenti in realtà, alla fine, sembra che non sia più neppure una mia scelta, ma mi sono abituato, mi pare più una questione di rassegnazione, per esempio mi fa questa impressione quando penso alla tempesta, quella che prima mi dicevano che non c’è la crisi, ora invece la vedo sempre in giro, ora che lo ammettono, non lo so mi sembra una cazzata a vedere tutta quella gente al supermercato, ma in fondo mentre faccio questi ragionamenti che dopo scrivo su quella specie di diario, la crisi magari c’è davvero, anche se c’è molta gente che si comprano le macchine per sedersi a un metro e cinquanta da terra, anche se girano per i supermerca- ti con le borse piene, anche se pagare a rate è diventato divertente che quasi non te ne accorgi, è così facile e veloce, e ti viene d’obbligo farlo, perché se
non lo fai sei veramente avventato e irresponsabile, invece se mi compro una macchina da quarantamila euro non lo sono affatto
e in questi giorni di festa?
ah, sì il 25 aprile non l’ho festeggiato, ma il sabato invece sempre a guar- dare la tv a casa mia e giù al villaggio non ci sono andato, era rosso sul ca- lendario e di solito rosso vuol dire festa, ma anche sangue alle volte, allora ho guardato un po’ di documentari in tv e mi sono sembrati bellissimi, per- ché quando leggo i libri di storia sembra tutto più noioso, le cose sembrano diverse in tv, a leggerle invece, che sudate carte che sono, così pesanti, che anche il giorno della liberazione si è versato tanto rosso da tutte le parti, an- che quelle innocenti, anche quelle presunte colpevoli, però alla fine resisto, ogni tanto penso che un’idea, anche se diversa, dovrei farmela.
a questo punto possiamo cambiare un po’ la terapia, mi prenda solo qualcosa per l’ansia
10 gocce al mattino di En
25 gocce alla sera di diazepam e venga qui 3 volte a settimana
grazie dottore, ora mi sento meglio, lo chiederò a mio padre se mi fa ve- nire qui tre volte a settimana, sa anche lui è un po’ ansioso, e anche se c’è la voglia di non prendere le medicine, potrei riuscirci, magari potrei anche non venire più qui, c’ho la resistenza nel sangue io, e ogni giorno ci provo a far- lo, per non essere schiavo, ma a me partigiano non mi c’hanno mai chiama- no, hanno deciso in tv che non mi ci chiameranno mai, magari in un libro, forse un giorno, in un libro, lo faranno, che in fondo è giusto che guerra ho vinto io? nessuna, nessuna.
Enzo Campi, una poesia inedita, “Andirivieni”, nota di Ranieri Teti
Il paradigma drammatico, l’accumulazione espansiva, l’inserto, la ridondanza, il controcanto, il piacere, anche visivo, offerto dagli scarti di ritmo tra poesia e prosa poetica, gli innesti, l’horror vacui, le sequenze, l’andamento esaustivo e mutante, il discorso poetante quando si trasforma in storia, le domande irridenti e sospese, le assonanze interne ai versi, l’assenza lirica, il mistilinguismo, un’idea centrale che genera la gravità che contiene tutto il corpo del poema, e altri, moltissimi altri sono gli elementi che strutturano il testo lavico di Enzo Campi.
Tra il titolo del brano e la citazione, tra andirivieni ed eterno ritorno, tra segno e simbolo, si realizza l’incastro di filigrane che compone la trama di un grande arazzo pulsante, che raffigura un universo dove vengono interrogate, scomposte e ricomposte, le difese dalla storia e dal reale.
Andirivieni
Getta il tuo peso nel profondo!
Uomo! Dimentica! Uomo dimentica!
Divina è l’arte del dimenticare!
Se vuoi volare,
se vuoi essere di casa nelle altezze,
getta in mare ciò che in te è più pesante!
(Friedrich Nietzsche)
lavora tumido il tamburo
si permea abiurando il piede
in cui forcludersi e sopravvivere
tekua aukèn
nekù keùn
ekuàn ketua
pneuma sordo risuona
compatto a spaziare spartire
tumer ora
rem rume
temur metèm
si spinge battendo e modula
nel ritmo l’idea di un connubio
thumos soma
thauma aumàt
masoch muthos
Così cantò la sirena. Si cantò verace e vorace
riproponendo la solita interrogazione:
quale senso?
quale sesso?
C’è una ruota che gira, caracolla dal pendio fino a valle.
E poi risale. Scandisce il ritmo dell’inesausto andirivieni.
Ditemi, Voi che tutto sapete: la tigre che vive nel cuore
del leone è l’anima al femminile del viandante?
lavora livido il tamburo
si percuote mortificando la pelle
in cui conclamarsi e svanire
Dalle tombe si levano tuoni. Per ogni tuono un ruggito,
un artiglio che raspa nel limo fino a sradicare il midollo
della madre terra. È questa la sua voce? Un tuono?
Dagli abissi si levano in volo uccelli rapaci. Per ogni
colpo d’ala uno stridio lancinante che perfora i timpani.
Questa cosa che chiamiamo profondo, che si forgia nel
male, che sale come luminanza in una nube di vapore,
questa cosa è la nostra casa, la nostra gabbia. Ed è qui
che vive la danza, la piuma che ancora rischia il volo
radente sui corpi degli astanti, la schiuma in cui la vulva
della sirena cerca il collo del serpente in un crogiolo di
scaglie e di squame, il trauma del ruggito che inaugura il
pasto sacrificale in cui ciò che viene meno è proprio il sacro.
C’è chi dice che Aracne fosse nata Sirena e che la
sua ragnatela fosse un circuito di onde sonore.
Melodia e ritmo, sono questi gli strumenti della
cattura, della fattura, della tortura. Ma la Sirena
parla la sua lingua che è eterna e incomprensibile.
epi thumìa thymo
res aimù pithe
ahum uma pié
pneùm ipo thepì
Così cantò e chiamò. Chiamò a sé l’ignoranza e
l’inettitudine del comune mortale annunciando
l’avvento della beatitudine e dell’appagamento.
lavora atavico il tamburo
si trascende graffiando la vena
da cui dissanguarsi e gioire
Ma non vedo chiodi d’intorno. Dov’è il palo incrociato?
Non vorrete negarmi il supplizio? Dov’è il coro delle
prefiche? Siamo tutti invitati alla sacra guerra tra bestia e
bestia. Umano troppo umano: è questa la sentenza del coro!
E il viandante, vorace di fame e di fama, esplose il suo
sdegno: chiedete e vi sarà dato, chiedete e vi sarà negato!
Quale scarto tra la gloria inevasa e le ceneri di un passo
abortito? C’è qualcuno così folle da permettersi il lusso
di rispondere? Quale discrasia tra una piuma incenerita
e la gabbia che preserva il maltolto? Ditemi, Voi che vi
illudete di sapere: la ruota gira sempre a favore delle ore?
Se cerco nel cuore del leone l’anima della tigre sarò
tacciato come servo o come sovrano? Tra sovranità e
servitù un filo sottile di rame propaga la scossa, il fremito
che inaugura lo sguardo d’intesa e la stretta di mano.
Fu così che il re si rese plebeo, fu così che il viandante
santificò la complicità coi suoi amici animali e chiese
al serpente la chiave d’accesso al cielo delle sette solitudini
e delle sette eternità smarrite nelle biforcazioni dei sentieri.
Perché è sempre una questione di scelta. Ed ecco che si
procede, in circolo e sempre a ritroso, per giochi d’impronte
lasciate a commiato, come per dire ho impresso la marca ma
ho inteso trasferire il calco altrove per rendermi prossimo
al trauma del pasto selvaggio. Ci si illude, se pure ridendo,
che il pianto non venga versato a caso su questo o quel rudere,
sulle carcasse dilaniate esposte in bellavista sui coacervi di
letame. Vittima ed insieme carnefice? È questo il destino del
viandante? Malato ed insieme guaritore? È questo il supplizio
da rinnovare in eterno? Se così fosse, e mai lo è,
non ci sarebbero alti né bassi come parametri di
riferimento all’incauto transito di quest’inutile verbo
votato alla dissoluzione, se così fosse, e mai lo sarà,
non ci si dovrebbe sfinire nel creare laviche parabole
a suon d’iperboli e anacoluti, se così fosse, e non lo
è mai stato, potremmo sederci in riva al fiume sul
masso più liscio per meglio scivolare e abbandonarci
al docile flusso in cui rischiare l’estasi dello stallo dinamico.
Tendere la mano alla bestia? Perché? Per consegnarsi
al sacrificio? Se nel mare non riesco ad inabissarmi, se
nel volo non riesco a precipitare, se nel farmi sbranare
non riesco a donare le mie viscere si può dunque parlare
di sacrificio? Silenzio! Ciò che qui parla è il mio fallimento!
jo tona auri
thoma tem urìah
ja kem ri-ti-ki tom
to tarà kiti
methèm to them
oj aton aurì
Non è importante comprendere le parole se sono le bestie
a condurci sull’orlo del precipizio. Ma la pietà che il viandante
ostenta è falsa. Egli non offre la chiave d’accesso e il coro si
manca nell’effrazione mancata. E le bestie lo sanno, lo hanno
sempre saputo, per questo si prendono gioco del coro e si
industriano ad allestire l’impalcatura del giogo. È sempre
questione di sottomissione. Il serpente lo sa, per questo
finge di strisciare. Anche il baccanale puzza di stantio.
Il vino è edulcorato con acqua di palude. Dalla selvaggina
fuoriescono frotte di vermi in parata. Perfino i satiri e le ninfe
abbandonano, mesti, il palcoscenico ove ogni verità è bandita.
Nulla di
nuovo, tutto
normale e
normato,
e scontato.
Così il
tronfio volatile
disegna l’iperbole
castrata del suo
volo coatto e
sogna di
smussare la
serie delle
bordature che
ancora circuiscono
l’andirivieni in
cui ci si
esercita a
saggiare, di
testa, il metallo.
Enzo Campi è nato a Caserta nel 1961. Vive e lavora a Reggio Emilia dal 1990.
Autore e regista teatrale con le compagnie Myosotis e Metateatro dal 1982 al 1990. Videomaker indipendente, ha realizzato svariati cortometraggi e un lungometraggio: Un Amleto in più. Suoi scritti letterari e critici sono reperibili in rete su svariati siti e blog di scrittura, su riviste e antologie. Ha curato numerose prefazioni e note in volumi di poesia. Ha pubblicato Donne - (don)o e (ne)mesi (Genova, 2007), Gesti d’aria e incombenze di luce (Genova, 2008), L’inestinguibile lucore dell’ombra (Parma, 2009), Ipotesi Corpo (Messina, 2010), Dei malnati fiori (Messina, 2011), Ligature (Sondrio, 2013), Il Verbaio (Milano – Sasso Marconi, 2014), Phénoménologie (Bologna, 2015). Principali curatele Poetarum Silva (Parma, 2010), Parabol(ich)e dell’ultimo giorno – Per Emilio Villa (Milano – Sasso Marconi, 2013), Pasolini, la diversità consapevole (Milano, 2015). Ha diretto, per Smasher Edizioni, la collana di letteratura contemporanea Ulteriora Mirari e coordinato le prime due edizioni dell’omonimo Premio Letterario. È stato ideatore e curatore del progetto di aggregazione letteraria “Letteratura Necessaria”. È direttore artistico del Festival “Bologna in Lettere”.
Francesco Bellomi, scrivere musica per il Premio “Montano”. Immagine di Marina Busoni, Forum Anterem 2016
«parlare di musica è come ballare di architettura»
(frase attribuita a Frank Zappa
o a Elvis Costello o a Martin Mull)
Si, effettivamente, spiegare la musica usando le parole è piuttosto complicato e spesso totalmente inutile e fuorviante, specie quando a farlo sono proprio i musicisti.
I critici se la cavano molto meglio, anche se barano tutti alla grande fingendo di capirci qualcosa.
Gli scienziati sono quelli che si avvicinano di più alla sostanza dei fatti musicali, forse perché il lavoro scientifico utilizza alla fin fine gli stessi identici mezzi e procedimenti del lavoro artistico: è un lavoro creativo esattamente come l’arte, la danza, la musica, la poesia, ecc.
Detto questo ci sono validi ripieghi: parlare del contesto storico, delle strutture musicali, delle forme, dei trucchi del mestiere, e così via. Ma alla fin fine, in qualunque modo la si metta, si finisce per raccontare una storia. In fondo anche le leggi fisiche o i teoremi matematici raccontano delle storie: le raccontano con formule numeri ed equazioni, ma sono storie. Una legge fisica che tutti conoscono racconta che se metti dell’acqua in una pentola sul fuoco, dopo un po’ comincia a bollire. Poi arriva uno più bravo a raccontare le storie della fisica, o che ha strumenti più precisi di misurazione, e dice: «L’acqua bolle a 100°». Ma si può raccontarla anche meglio di così. Ad es. «L’acqua bolle a 100° a livello del mare» o, ancora più pignolo: «L’acqua bolle a 100° se è pura (distillata) e se la pressione atmosferica è di 1 atm.»
La proprietà transitiva degli insiemi: «se A = B e B = C, allora A = C» è un’altra storia di queste.
Per i musicisti le storie tipo sono: “Tema di 8 battute, composto di due semifrasi positive di 4 battute. Tonalità di Fa# minore, con modulazione alla dominate alla fine della prima semifrase (batt. 4) e ritorno alla tonica nelle battute 7 e 8. Struttura melodica ad arco con punto culminante tra batt. 6 e 7 (sezione aurea), e armonie così distribuite: | I | IV - II | V IV# | V6/4 - V 3/5 | ecc.»
Ci sono “storie” sulla musica che sono molto peggio di così, lunghe anche centinaia di pagine e che sono una lettura veramente irrinunciabile prima di andare a dormire.
L’idea di vivisezionare la mia musica con questi raffinati strumenti di tortura mi rivolta semplicemente le budella, quindi racconterò si una storia, ma non quella, forse impossibile da dire, di come é la musica. Racconterò invece come io, partendo dai testi dei poeti vincitori del Premio Montano, cerco e trovo le procedure per scrivere i miei pezzi. Come se, invece di portare una bella torta (o almeno i suoi ingredienti), io mi presentassi ad un invito a cena con la sua ricetta: buon appetito!
VIVIANA SCARINCI - AMANDA FIORE O TARTARUGA - PREMIO MONTANO 2016
Nelle 24 righe del testo che ho avuto a disposizione ho sottolineato subito la frase finale: «quella carezza che ti fa orrore». Questo ossimoro è stata per me la chiave di tutti gli ossimori e le contrapposizioni precedenti. Quello che ha innescato il mio procedimento di invenzione.
Ora, in questo testo come in tutti gli altri, c’è ben di più di un ossimoro o simili, ma io avevo bisogno di una chiave di lettura abbastanza astratta da poter essere trasposta in musica e abbastanza semplice da essere comprensibile a chi ascolta la musica. In pratica ho immaginato che questa contrapposizione potesse essere il filo rosso che tiene insieme le centinaia di altre cose che l’analisi di questo testo può rivelare e ho provato a scrivere una musica infarcita di “carezze” e di “orrore”. A cominciare dai materiali di base. Si può mimare musicalmente una carezza in molti modi (e ho provato a usarne qualcuno di quelli usabili sulla tastiera di un pianoforte) ma io non volevo fare il Pierino e il lupo del premio Montano (con i suoi temini-personaggi da asilo infantile: “senti? il tema cullante della carezza? adesso arriva il cluster dell’orrore...”). Io volevo che l’ossimoro “carezza-orrore” fosse strutturale, fosse scritto nel DNA del pezzo.
Così sono partito da un materiale, una scelta di altezze, che potesse già di per se suggerire l’ambiguità di questa orrenda carezza. Il materiale migliore che ho trovato è un accordo ben conosciuto dai musicisti: la triade aumentata o eccedente. Un accordo accuratamente classificato ed etichettato in tutti i manuali di armonia, ma che musicisti come Debussy, Berg (Sonata op.1) e Scriabine hanno usato in modo intensivo e magistrale.

Questo accordo si porta dentro tutta una serie di ambiguità:
- è dissonate (poco) ma è costruito con due intervalli consonanti (due terze maggiori);
- può appartenere a varie tonalità e quindi risolvere in molto modi, basta cambiare il modo con cui si scrivono i suoi suoni (enarmonia);
- mettendo in fila almeno tre triadi aumentate si ottiene una scala “esatonale” o “di Debussy” che ha la singolare caratteristica, essendo composta solo di intervalli di tono, di non avere delle tensioni orientate verso qualche nota di risoluzione della tensione; come succede in tutte le scale tonali che si adoperano nel 97% della musica che ascoltiamo. Nella scale esatonale la tensione è bassa e diffusa, come una nebbia impalpabile e priva di punti di appoggio; non a caso Debussy adorava questa scala.

La triae aumentata è un accordo dolce e morbido come una carezza ma appena lo adoperi per più di due secondi diventa (se non sei un genio come Debussy) veramente nauseante e insopportabile.
Così ho messo sulla mia tavolozza un insieme di altezze (un “impasto”, una scala, un arpeggio, insomma chiamatelo come che vi pare) che contiene questo accordo. Per gli amici possiamo chiamarlo insieme x:

L’insieme y è dato invece da tutte le altre altezze (fra le 12 che usiamo in occidente) che non appartengono all’insieme x.

La somma; x + y = z

dove z è l’insieme di tutte le altezze possibili nel nostro sistema musicale e sulla tastiera di un pianoforte (se è accordato correttamente, cosa che non succede quasi mai, ma questo è un’altra storia).
Il brano oscilla continuamente fra questi due insiemi che costituiscono i due poli di attrazione di tutto il materiale melodico e armonico. In pratica: dopo un po’ di tempo che si lavora con l’insieme x l’ascoltatore comincia a sentire il bisogno di qualcosa, non sa bene cosa, una specie di cambiamento, ma non sa bene quale cambiamento. Cambiamenti di ritmo, di intensità, di testura sono solo palliativi, e servono solo a tirarla in lunga ancora un po’ (prolungamento nell’analisi Schenkeriana) ma alla fine, il desiderio di un cambiamento di “tavolozza armonica” è così forte che non c’è acrobazia che tenga: bisogna cambiare le altezze adoperate altrimenti l’ascoltatore “esplode” o, meno clamorosamente, distoglie l’attenzione.
Nel mondo modale e tonale questa tecnica era chiamata modulazione ed è basata su uno dei meccanismi percettivi più forti (e forse innati) del nostro efficientissimo orecchio tonale.
Nel brano ho poi utilizzato gesti strumentali tipici della morbidezza: sonorità tenui, una certa lentezza, indugio su formule ritmico melodiche ripetitive, arpeggi, pedali, ecc.
Il pezzo finisce con tre accordi: l’insieme x, l’insieme y, e l’insieme z. Una sorta di cadenza riepilogativa di tutta la storia e, casualmente, l’ultimo accordo, l’insieme z, composto di tutte e 12 le altezze di un’ottava del pianoforte può essere suonato solo come un doppio cluster (tasti bianchi + tasti neri) mettendo le mani distese trasversalmente come per accarezzare la tastiera: è l’ultima orribile carezza del pezzo.
MICHELE CAPPETTA ROVESCIO - PREMIO MONTANO 2016
La prima idea, ovviamente, è stata quella di scrivere un pezzo al contrario.
Precedenti illustri non mancano nella musica: l’operina Andata e ritorno di Paul Hindemith, dove a metà del percorso narrativo comincia il viaggio di ritorno e la musica “torna indietro”; il famoso brano medievale Sumer is icomen in dove alcune parti musicali sono “cancrizanti” si possono cioè leggere da sinistra a desta o viceversa: in pratica il palindromo applicato alla musica;
i ritmi “non retrogradabili” di Olivier Messiaen: ancora una volta dei palindromi ritmici;
La musica suonata al contrario, suona molto diversa, e da questa osservazione nasce la celebre storiella di quel dilettante che, pur di scrivere una sinfonia senza averne le capacità, ricopiò al contrario una sinfonia del poco noto compositore A.S. capendo, solo al momento della prima prova, che in realtà aveva così riscritto interamente la quinta sinfonia di Beethoven. Se qualcuno vi ha preceduto nel copiare al contrario, siete fregati.
Ma il testo di Cappetta non è un semplice procedimento retrogrado: se voi provate a leggere il testo frase per frase dalla fine all’inizio, vi accorgete subito che qualcosa non funziona. Il testo di Cappetta è una storia che “torna indietro” ma non è il rovescio di niente. Come fare?
Il concerto per due pianoforti soli di Stravinsky ha la soluzione: c’è un tema con variazioni. Solitamente nei temi con variazioni si fa sentire il tema all’inizio e poi, variazione dopo variazione, ci si allontana progressivamente dal tema arricchendolo, deformandolo, trasformandolo, ecc. Stravinsky fa esattamente il contrario, ed è l’unico caso noto nella storia della musica: parte dall’ultima variazione, quella più lontana dal tema e, variazione dopo variazione, si avvicina al tema spogliandolo progressivamente di tutti i fronzoli e gli ornamenti. Alla fine appare il tema. Nudo. Un vero e proprio striptease sonoro.
Quindi la struttura del mio pezzo è: variazione 4, variazione 3, variazione 2, variazione 1, tema.
Il tema, il lapidario «L’inchiostro è nero» finale, dal quale nasce tutto, è costituito nel mio brano da due semplici accordi formati dall’ insieme x e dall’insieme y. Disposti però ritmicamente in modo non retrogradabile (palindromo).

Questi due insiemi hanno una nota in comune; il re che è una sorta di ponte o legame tra uno e l’altro. Nel gergo insiemistico questo re sarebbe chiamato l’insieme intersezione fra x e y.
La somma di x + y quindi non è z ma un insieme z mancante di un suono (il fa) = z (-1).

Questo suono “fantasma” (il fa) appare di tanto in tanto nel brano, ma non a caso: la sua fugace apparizione segnala la fine di una variazione e il passaggio a quella successiva. E’ come il sospetto di qualcosa che non arriva mai a concretizzarsi ma che con il suo punto di domanda e la sua mancanza apparente di motivazione spinge in avanti la nostra curiosità.
Fino alla terribile frase finale («L’inchiostro è nero») che di per se non ha niente di terribile ma diventa terribile quando si capisce che è stata l’origine di tutta la storia precedente. Questi due accordi e il ritmo con il quale vengono suonati sono per questo quanto di più amorfo e neutro si possa fare in musica. Suonati da soli non dicono praticamente nulla di interessante: sono la cruda essenzialità del tema finale.
PIERA OPPEZZO - VIVENTE STENDE LA MAPPA - PREMIO MONTANO 2016
Il dato strutturale che mi ha colpito subito nella poesia di Piera Oppezzo è la presenza in un certo modo ossessiva di “vivente” quasi in ogni quartina della poesia.
E’ come un maniacale ritorno al punto base, al perno della narrazione, al punto di partenza. Attorno le situazioni cambiano ma noi siamo come prigionieri nel cranio di vivente e assistiamo alle sua azioni e al mutare della scena senza mai cambiare punto di vista.
In musica esiste una forma perfetta per raccontare questo: la Passacaglia, ovvero Ciaccona, ovvero Ground (in Inghilterra).
Un tema si ripete in modo sempre uguale e ossessivo mentre attorno a lui si sviluppa ogni sorta di variazione. I musicisti barocchi erano in genere così abili nell’arte della variazione che riuscivano a “distrarre” l’ascoltatore dalla ripetizione ossessiva del tema facendogli sopportare questa ripetizione continua. Per fare questo usavano dei temi di passacaglia molto semplici e banali e poi si buttavano a capofitto nelle ricchissime variazioni.
Brahms, nel finale della quarta sinfonia, riesce a spingere questo procedimento così a fondo che nessuno, al primo ascolto, si accorge che è una passacaglia. Solo dopo averlo fatto notare ci si rende conto di questa ripetizione ossessiva ma “sotterranea”. Stessa cosa nel brano per organo Le jardin suspendu di Jehan Alain.
Ma esiste un altro modo di usare la passacaglia: quello che si può sentire nelle innumerevoli Ciaccone, bassi ostinati, Ground di Henry Purcel (1658?-1695). In Purcel prevale l’attrazione magnetica e ipnotica per la ripetizione poco mascherata, quasi esplicita, che funziona come un gorgo da quale non si riesce più ad uscire.
Ho usato questo secondo procedimento per raccontare l’onnipresenza di “Vivente” e quindi il tema che ho scelto è molto ben caratterizzato e riconoscibile, privo di respiri e quasi ansioso, e la sua ossessiva ripetizione finisce a poco a poco per fagocitare tutto il resto: non si può che continuare a ripeterlo fino allo sfinimento.

LUIGI SEVERI - SINOPIA - PREMIO MONTANO 2016
Per Sinopia di Luigi Severi ho saputo subito cosa volevo: volevo un colore solo, quell’unico colore con il quale sono dipinte le sinopie: Terra di Siena per gli antichi maestri frescanti ma anche una meravigliosa Terra di Sardegna per la sinopia di 240 mq che mio padre dipinse nella chiesa di Lugagnano, dal 1990 al 2005, e che si trova ora sotto lo strato della successiva pittura a tempera di caseina lattica intitolata Arbor Redemptionis. (Ma molte foto della sinopia, oggi non più visibile, si possono vedere al seguente link: https://get.google.com/u/0/albumarchive/113329101060291120240
Con quest’unico colore volevo, come fa Luigi Severi, raccontare il mondo.
Quindi ho utilizzato un unico insieme di altezze;

e su questo ho costruito tutto il brano evitando il più possibile di uscire da questo monocromo.
L’insieme y ovvero l’insieme non x

non viene mai utilizzato nel corso del brano e questo si trasforma in un tono costante che, pur oscillando fra caratteri diversi, mantiene una colorazione tendenzialmente cupa.
L’insieme y appare solo alla fine del brano, come una nuvola di suoni armonici in dissolvenza, come a ricordare che esisterebbe un altro mondo e un altro modo, complementare e speculare, di raccontare le stesse cose.
I temi musicali che attraversano il brano suonano come frammenti visti attraverso un unico filtro, un unico codice coloristico, un’unica tonalità di fondo. Una sorta di viaggio per il mondo con occhiali color sinopia.
Questo testo, così infarcito di termini tecnici dell’affresco, non poteva non sedurre il figlio di un frescante. Soprattutto quando è forte la consapevolezza che assai spesso le sinopie sono molto più belle, riuscite e stupefacenti dell’opera finita.

Gennaio 2017, anno XIV, numero 33

Una corsa sui versanti della poesia, edita e inedita, e della prosa inedita.
Versanti che rappresentano molte e varie realtà poetiche in atto in questi anni. Il nuovo numero di “Carte nel vento” raccoglie, oltre a quelle già pubblicate, altre note critiche su segnalati e finalisti della 29^ edizione del Premio Lorenzo Montano, prodotte dalla redazione di “Anterem” al completo.
A questo proposito citiamo due considerazioni sul lavoro svolto.
Afferma Laura Caccia: “Offrono possibilità di numerose riflessioni queste opere poetiche, ma soprattutto lasciano intuire, nei loro percorsi che intrecciano temi, lingue e linguaggi diversi, il vibrare sullo sfondo di una tensione comune. Con un punto fermo sull’esser-ci, attraverso un pensiero poetico in dialogo tra il linguaggio e l’esistere”.
Aggiunge Flavio Ermini, parlando della prosa: “Caratteristica di questa sezione è la sua grande libertà stilistica e di genere. Infatti la prosa inviata può essere costituita da una narrazione, un saggio breve, una prosa poetica… Diciamo che è una sezione che va oltre le categorie, oltre le classificazioni. Lo dimostrano le prose pervenute nel corso degli anni. Il nostro tempo è assillato dal culto della categorizzazione, della misurazione. E invece noi diciamo che l’esistenza è sempre una deviazione dal canone e che è necessario diffidare di ogni generalizzazione.
Insomma, si parla tanto di andare oltre i generi. Qui ne facciamo pratica”.
Consapevoli che molto debba ancora accadere, ripartiamo alla ricerca di nuovi paesaggi con la XXXI edizione del “Montano”
In copertina: Fausta Squatriti, Memento mori, grafite e pastello su carta, 2013
Scarica il bando della 31^ edizione del Premio Lorenzo Montano
Flavio Ermini su Frammenti di un discorso poetico di Rosa Salvia
Saggio narrativo
La poesia è una specie di strumento ottico che ci consente di vedere in noi stessi quello che – senza poesia – non avremmo mai visto. In altri termini: la parola poetica ci consente di accostarci alle nostre istanze più profonde, fino ad aprirci alla nostra essenza.
Rosa Salvia mette in evidenza con questo saggio proprio il manifestarsi dell’essere nella poesia, rilevando come la parola poetica sia qualcosa che cade al di là della calcolabilità dei saperi, al di là delle prescrizioni estetiche codificate. Insomma, Rosa Salvia ci induce a riconoscere che il linguaggio poetico costituisce una sfera privilegiata quando si tratta di dare voce all’essenza delle cose.
Poesia è pensiero che interroga e come tale porta il mondo alla sua dimensione più autentica, al suo destino. Il cogliere della poesia, ci conferma Rosa Salvia, non è un disporre “prepotente”, come accade nel “discorso”, bensì l’abbracciare una disposizione che lo precede, ovvero originaria. Il cogliere della poesia assume l’aspetto di un pensiero che vuole trasformarsi in esperienza del destino dell’essere. In questo processo, si può riconoscere senza fatica che l’esperienza linguistica della poesia si chiama, per così dire, “fuori” dal consueto concetto di esperienza, annullandolo, per indicare qualcosa d’altro. Un qualcosa, registra Rosa Salvia, «che possiede la forza di preservarsi dal disfacimento per diventare “preghiera”».
Flavio Ermini su Tra consonanze e alterità di Rossella Cerniglia
Recensione
Il Cesare è un poemetto del poeta spagnolo Luis Cernuda (1902-63). L’opera si ispira alla figura dell’imperatore Tiberio e ne registra il volontario esilio su un’isola. Nell’articolarsi dei versi prende corpo «l’ultimo respiro, l’ultimo pensiero, l’ultimo sentimento, l’ultimo amore» di una grandezza che va esalando. Rossella Cerniglia coglie nel suo commento critico la «lenta estenuazione» e l’«inesorabile fine» di una vita. Come non riandare con il pensiero alla fine di Napoleone così come la celebra Manzoni nella sua ode Il cinque maggio? Comune è infatti il sentimento «tragico e fatale» della condizione umana, protesa nel tentativo di cogliere un senso che presto si rivela irraggiungibile, tanto da essere condannata sempre al fallimento.
I grandi testi, come le grandi vette, ci segnala Rossella Cerniglia, si scambiano tra loro, in alto, cenni d’intesa e di antica consuetudine. Una voce parla e si apre l’essenza: l’impossibilità di realizzare un sogno. Un’altra voce risponde, ma non fa che segnalarci che la vita è il frutto di un’ingannevole illusione, dove tanto simili sono il vagito del neonato e il gemito del morente. Tremiamo alla fine della nostra vita come il primo giorno. Vacilliamo in preda all’incertezza.
Quelle che si levano dal testo critico di Rossella Cerniglia sono voci spesso disincarnate, lontane, ingannevoli, ossessive. Attorno a loro, nell’esilio, un insensato turbinio decreta che non si cessa mai di cadere, non si finisce mai di finire.
Flavio Ermini su L’innamorante restituzione di Stefania Simeoni
Saggistica poetica
Stefania Simeoni ci parla del principio: un principio che non smette di originarsi nel nudo disvelamento del vero, un vero lapidario e sapienziale. Dal puro essere alla presenza; dall’albale manifestazione al vivente nelle sue molteplici forme; dal respiro alla parola; dalla poesia alla verità dell’essere. Stefania Simeoni ci parla dell’inizialità come di una sensazione. Non c’è un luogo in cui si nasce o si muore. C’è solo l’evento del nascere e del morire. Un evento caratterizzato solo da suoni e silenzi; luci e ombre.
«Imparare il ritorno al respiro viscerale»: ecco quanto ci viene richiesto. È compito della parola poetica non sottrarsi alla difficoltà di tale questione per indagare e scoprire i propri fondamenti. Dire l’origine, dunque, per dare forma all’origine e mettere in opera la verità. Dire l’origine, dunque, non per cercare la regola e l’armonia, ma per dare spazio all’irruzione imprevedibile della potenza creatrice, dove riecheggiano voci diverse, difficilmente distinguibili l’una dall’altra. Il fine è raggiungere l’unità nel caos di un’esistenza che è destinata alla lacerazione. Con questo lavoro, Stefania Simeoni ci offre l’occasione di ripensare la parola in tutto il suo spessore teoretico, come serbatoio di un senso possibile.
Flavio Ermini su Del Limite di Giuseppe Armani
Saggio tematico
Giuseppe Armani ci avverte: «L’occhio non è mai innocente». E ci invita ad avere maggiore sensibilità per i fenomeni più ordinari, pulviscolari dell’esistenza. Come dire: diffidiamo delle apparenze, non lasciamoci ingannare dai lampi fuggitivi, dalle tracce inafferrabili, dalle stelle cadenti che scompaiono nel momento stesso in cui si accendono. Come dire: diffidiamo delle illusioni, non lasciamoci ingannare dalle soglie. L’esodo, ci conferma Armani, è «un viaggio solo invocato». L’intera realtà è un flusso temporale in continuo mutamento; esclude che si possa accedere all’essenza delle cose, essenza che risulta così imperscrutabile e inaffidabile…
Questo saggio indica che essendo la realtà stessa costituita da un tessuto mobile, sfrangiato e plurale, anche il nostro atteggiamento non potrà che aderire alle infinite pieghe della vita così come la vita di volta in volta a noi si presenta; a noi, impegnati in quella che Armani definisce una vera e propria «avventura spaziale» finalizzata a «dare forma».
Va liberata la sintassi dal logoro dispotismo della logica lineare. Va prestata attenzione agli spazi bianchi del limite, ovvero a quelle soglie che possono costituire più o meno evidentemente l’occasione per il dispiegarsi del pensiero.
Mara Cini su Donne: le differenze di una crisi di Silvia Del Vecchio
L’analisi di Silvia del Vecchio riguarda il ruolo delle donne nella sfera economica e pubblica e rimarca come la cesura fra le “ragazze 2.0” e le giovani con le gonne a fiori…è un fossato che s’inscrive dentro una lacerazione storica più vasta.
Sarebbe interessante, in un ambito più approfondito, mettere a confronto anche il lavoro di scrittura di queste diverse generazioni femminili così prossime e così diverse.
Nella letteratura il “privato” non ha infatti connotati “conservatori” o “deboli” anzi, se scelto consapevolmente come cifra stilistica, come certa écriture de soi, aderisce efficacemente al reale.
Nelle generazioni più giovani il timore di ricadere in un “vecchio” intimismo, in una dimensione domestica, muove verso modalità letterarie “di mestiere” , forse poco incisive, alla fine.
Le ragazze sono colte e informate, professionalmente preparate, libere di fare ma immerse in una crisi economica e lavorativa così pervasiva da rendere difficile continuità e innovazione progettuale.
E’ il segnale, come indica Del Vecchio, di uno scadimento culturale, istituzionale e ambientale che necessita senz’altro di una rifondazione delle relazioni alla luce delle nuove dinamiche sociali e culturali.
Mara Cini su Incipit di Paola Zallio
Numerosi interessanti elementi si intravedono in Incipit, prosa poetica di Paola Zallio:
indagine sulla nascita del linguaggio tra ricerca di ordine “razionale” e ascolto delle pulsioni archetipiche, indagine sul germogliare e il fiorire della lingua nel formarsi dei nomi.
…il respiro apre il varco del nome “parlato” attraverso il corpo-voce, la mano apre il varco del nome “scritto” , tracciato, sedimentato, il respiro apre il varco del nome a partire dal balbettio infantile, un sillabare che tenta di riconoscere, inseguire, e infine precisare l’identità personale nella realtà circostante.
La cosmogonia delle lettere privilegia le vocali, amate, come è noto da artisti e poeti, tra esse la protagonista Paola, in Incipit, fa della O il suo grembo.
La O che già era la lettera preferita della Thérèse di Canetti in Auto da fé, Thérèse che faceva le migliori O della classe: “Se un titolo conteneva molte O, per prima cosa lei contava quante erano, poi le scriveva tutte alla svelta in fondo alla riga e utilizzava lo spazio rimasto al principio per scrivere il titolo, che mutilava convenientemente”.
Prima di ogni leggibilità c’è infatti il nascere sillaba dopo sillaba di una lingua madre che resta luogo dell’imprinting, dell’apprendimento, dell’esprimersi e del ricordare.
Laura Caccia su Pedagogia del volto di Nicola Contegreco
Nel sangue del dire
Cosa ci insegna un viso, o, come si chiede Nicola Contegreco in “Pedagogia del volto”, quante leggi vi sono scritte?
Se, da un lato, l’autore vorrebbe poter dire “attraverso la linea / curva delle labbra”, dall’altro non può che registrare “i resti vivi del volto in itinere quella sua / trasmutazione di gorghi e di espressioni // distanti quanto l’incapacità di una lingua / sempre più lontana dalla via che deborda”.
Come se le linee del viso evidenziassero lo stesso destino del linguaggio e insieme della vita nella sua complessità, nel lasciare ombre e disafferrare parole, i versi ritmano il loro doloroso interrogare, a partire dalla perdita di una lingua in grado di identificarci, come leggiamo: “Piccoli mesi ci lasciano siepi / davanti agli occhi e alfabeti morti / dietro la bocca".
In un dire che è fortemente impregnato insieme di fisicità e di buio, che registra la “suddivisione atroce tra io e mondo”, assenze e ferite, i versi pulsano come nello scorrere nel sangue e trovano sincopi nel grido, richiamato anche dalla citazione di alcuni versi di “Crow” di T.Hughes.
Non restano, come scrive Nicola Contegreco, che “parole gheriglio masticate con troppo sangue / troppe cifre la cui somma non determina totale / ma i poeti hanno cadute impercorribili pure lo sai / adesso è vero bruciano la verità tra dita di calce”.
Laura Caccia su Inventario dei gesti di Enea Roversi
Il senso dell’umano
“Ci sono gesti che / possiedono la grazia”, scrive Enea Roversi in “Inventario dei gesti” dove si declinano, nella tripartizione della raccolta, azioni “Di disperazione e rabbia”, “D’amore” e “Di vita quotidiana”.
E la gratitudine e la riconoscenza pervadono i gesti, nella ricerca del senso dell’umano, tra differenti azioni e stati emotivi.
A partire da quelli connotati da angoscia e disperazione, solitudine e atti estremi, in una tensione, benché impossibile, a “dimenticare il male”.
Nei gesti d’affetto la grazia è connotata dall’assenza di parole, non come sofferta afasia, ma, come leggiamo, “eloquenza del non dire”, espressione silenziosa “di quelle incertezze / docili e sublimi” attraverso le quali percepire “il rumore / come di senso compiuto / estraniazione nuova”.
Nei gesti quotidiani, tra prepotenze e abusi, emerge, con i ricordi familiari, la gratitudine, come registra l’autore, del “condividere il sorriso / la stretta di mano”, “azioni che / partono da lontano”, che “hanno qualcosa in comune”.
Un catalogo del patrimonio umano che è mosso dalla ricerca di dare significato alle azioni e alle relazioni: “Dare un senso / alle cose che si fanno / a quelle che non / si fanno”, riflette Enea Roversi, così come “pensare: è troppo presto / riconoscere che ormai è tardi / per trovare il senso / eppure lo cercherai / domani, ancora”.
Laura Caccia su Poema dell’Inizio di Pietro Antonio Bernabei
La poesia del principio vitale
Nel racconto biologico dell’origine, che Pietro Antonio Bernabei declina in “Poema dell’Inizio”, è tutta compresa la sfida posta dalla poesia rispetto alla materia del suo dire: l’origine di cui si tratta non è l’inizio indagato dalla riflessione filosofica, ma è ugualmente l’oggetto di un pensiero che affronta la “genesi della vita sulla terra” attraverso una narrazione scientifica che assume lo sguardo dell’arte e la parola della poesia.
Tra trasformazioni filogenetiche, evoluzioni ed estinzioni si susseguono sequenze di immagini messe a fuoco come quadri e insieme attraversate dal senso vitale, insieme oggetto e modo del dire: come annota Pietro Antonio Bernabei, il “principio vitale, / questa fortunata / sequenza di eventi / marca l'innesco / dei processi biologici / in forza dei quali / sono qui a scriverne”.
Ed ecco improvvisa prendere forza la sfida dei versi che passano repentinamente dalla memoria della materia al decisivo ruolo per la specie umana svolto dalle emozioni, dalle cellule staminali alla nascita del pensiero simbolico, dall’evoluzione biologica all’esplosione che culmina nel riso, fondamentale per la parola, nel suo sviluppo dai progenitori alla famiglia Hominidae che, come ci ricorda l’autore, “ride a lungo espirando / ridendo controlla il respiro / ponendo le basi / per la fonazione / e l’evoluzione / dell’eloquenza oratoria”.
Laura Caccia su Codici di Gregorio Muzzì
Le radici delle percezioni
Cosa resta inciso nel pensiero poetico tra le generazioni e quali radici trova il dire che Gregorio Muzzì dispiega in “Codici”, nel convocare così tanti scrittori, poeti, musicisti, artisti da Campana a Cardarelli, da Rilke a Mann, da Dante a Hegel, da Bach a Dürer, da Caravaggio a Giacometti, “Stili poetici lontani”, come scrive l’autore, “comuni / assai lontani / nuovamente / radice”?
Con il prevalere delle percezioni, nel coinvolgimento dei citati autori tra immagini, punti di vista e apparizioni, la parola incide con forza i suoi codici: i contrasti amore-morte, vita-nulla, enigmi-conoscenza, limiti-verità.
Il contrasto è evidente tra i segni della negazione e dell’affermazione di senso, tra quanto appartiene all’area semantica dello sfocare e dello scolorire e quanto invece a quella del dare significato e colore: a tutta una serie di vuoti, precisati dall’autore, “Come mentire / trama incolore”, “Non indico / non voglio dire”, fanno da contrappunto i pieni del “Eppure amori vedono chiaro / osano come navi disperse”, “Rispondono colori”, “palpitano nuovi significanti”.
Dall’oscillazione dei contrasti, sorretta dalle intrusioni degli autori richiamati, prende forma una grande fiducia, da parte di Gregorio Muzzì, nella conoscenza, nel pensiero e soprattutto nel dire, poiché, come ci indica, “Invocando mai pronunciate parole / rivivono alberi” e, ancora, “Addentrando ulteriorità indicibili / parole infinite / plasmeranno umanità”.
Laura Caccia su Frammenti, 2012-2014 di Chetro De Carolis
Nel battito del buio
Il dire a brandelli che Chetro De Carolis adotta in “Frammenti”, nella concisione che potrebbe far pensare ala forma dell’haiku, rovescia le immagini nella loro assenza, le parole nel loro silenzio.
Dove l’haiku si fa soprattutto parola stupefatta e pensosa dello sguardo, l’autrice fa dei suoi frantumi parola del suono e del buio, come fosse ogni brandello poetico uno squarcio nel silenzio, un rintocco, un battito, in un breve risuonare di accenti di lingue diverse e di richiami musicali.
Il senso di smarrimento e dispersione, che trapela anche dalla diversità dei luoghi e degli artisti evocati, attraversa tutta la silloge, evidenziando, nel mutare delle cose e dei segni e nell’ammutolire dei suoni, come resti solo “il brandello, irrimediabilmente perso”.
E restano anche, come figure, il buio, le immagini cimiteriali, le griglie e le cancellate: “Nubi di ferro. / E doppio è il cancello / che serra / il giardino della memoria”, scrive Chetro De Carolis, “E quando è buio pure il suono / Neanche si vede quel giardino”.
E quando il suono si fa buio e la parola silenzio, cosa resta del senso e del dire? Dolente è l’assenza che emerge di segni e figure, anche solo dei loro brandelli o riflessi, come evoca l’autrice: "L’ombra di quel racimolo / di immagine, / anelata, / non appare. / Né l’orma”.
Laura Caccia su Carrube di Vittorino Curci
I doni assenti e presenti della vita
Sono “doni terrestri” quelli che Vittorino Curci sgrana in “Carrube”, con una pluralità di immagini e di ritmi che orchestrano la pulsazione della vita, le cronache dei vivi e dei morti, le sincopate domande di senso.
Sono i frutti che la vita porta con sé, nutrimento particolare, come i baccelli della carrube, e ricchezza, come i semi, utilizzati in passato come misura dell’oro: così “sei sulla buona strada / perché anche i morti sono semi / che patteggiano con la terra / un modo per tornare”, scrive l’autore, convinto che “se siamo strumenti della vita / siamo in buone mani”.
È però una voce dolorosa, tra “la sofferenza più predace”, memorie da scarnificare e disamori, quella che racconta storie di vita, come leggiamo: “ho messo il vestito nuovo / per sentirmi altrove come uno / che viene fuori dal niente e prega / in una lingua sconosciuta”
Nel fluire della musica della vita, tra “onda o risacca”, giungono allora i ritmi sincopati che rovesciano il senso vitale nel “dono assente dei quasiversi” e che interrompono il narrare con la riflessione dolente sul tempo e con la forma interrogante della ricerca di senso.
Così l’assenza prende voce, si fa “canto sperduto nell’aria”, come, ci mostra Vittorino Curci: “l’erba dei tetti / nella strofa che invoca / l’ultima stesura. / se ci fosse un fiume lo canterei. / l’ho anche fatto, e il fiume / non c’era”.
Laura Caccia su Α & ω di Francesco Fedele
L’alfabeto dell’etica
Tra inizio e fine, assecondando possibilità e vincoli offerti dal tautogramma, Francesco Fedele declina in “Α & ω” tutto l’alfabeto dell’esistere.
Dalla denuncia di mercificazioni e genocidi alla desolazione di “generazioni al giogo”, attraverso l’“uguaglianza usurata”, la “kontrokultura”, le disillusioni del “vagare vacuo” e delle “voci a vanvera”, l’autore dispiega l’intero repertorio dell’inciviltà e degli abusi, per prendere chiaramente posizione, come scrive, per “contrastare la carenza con civiltà”, affermando la necessità di superare egoismi e narcisismi, scegliere l’empatia, mettere in primo piano le ragioni dell’etica sociale.
I limiti posti dall’ordine alfabetico e dalla forma linguistica del tautogramma, vengono rovesciati dall’autore con una fuoriuscita dai vincoli linguistici e sociali, come evidenzia: “vorrei venisse una verità, // vis per virare e volare via”, “per navigare oltre il nulla”, “osare oltre l’ovvio”.
Tenendo comunque sempre ferma la barra dell’etica: poiché, leggiamo, anche “la fame di feroci fiere / fomenterà forme di futuro”, per cui l’alfabeto delle miserie potrà generare nuovi inizi: come scrive Francesco Fedele, “Attraversiamo questi acquitrini / di asociale assenza di altruismo / accendiamo altro avvenire” che sarà irrorato “di idee innovatrici” e in cui si gioirà “delle gemme / che germinano nel gelo”.
Giorgio Bonacini su Mise en abîme di Paolo Donini
Quando lo sguardo del poeta sceglie un segno o anche solo un suo visibile ritaglio, muovendosi lentamente in una direzione prospettica che coglie quel particolare dell’ immagine, con nitidezza leggera e, nello stesso tempo, con attenta percezione visiva dello scrivere, allora reale e sogno si uniscono in una visione in cui la certezza di ciò che si vede non si disgiunge mai dalla parola che, con lo stesso andamento immaginifico, ne dice la forma sostanziale e significante.
Così in questo poemetto Paolo Donini vede scrivendo, con un pensiero poetante che si fa voce e figura. Ma in ciò non c’è nulla che assomigli a certa poesia descrittiva che ingenuamente si limita a descrivere il veduto. Qui la ricerca di lampi di trasposizione in continua immersione ed emersione sta nella verosimiglianza interiore alla percezione e al senso di conoscenza. La consapevolezza dell’autore (il titolo ne è testimone) si evidenzia nel mettere al centro della formazione dell’opera, più che l’osservazione, la conformazione di un accadimento reale anche nella misteriosità della sua esistenza.
Il mondo indagato che Mise en abime ci propone è un vortice lento di manifestazioni concrete, ma viste, e ancor più dette, come guardate in ascolto dalla parte ombrosa, sfumata, un po' sfuggente e sfrangiata , come “una cosuggia nera” che “passa sullo sfondo”. E allora sarà perché la percezione di ciò che si legge affonda e riaffiora nell'esempio accolto, intorno a cui ruota l'architettura intima del canto, e cioè un quadro di Bruegel il Vecchio; o forse perché da questo pullulare di vita in movimento statico, fissato ma non bloccato, non muto sulla tavola dipinta, emana una pensosità interrogante sulla totalità dell'immagine e, non disgiunte, su minime particolarità considerate, con inventiva esattezza, lì “dove niente resta uguale”; sarà per l'impressione e il sentimento di lento fluire verso un “unico niente”, in ogni caso, e per ogni considerazione, la scena che noi leggiamo manifesta l'ondulazione continua di un'opera che, attraverso l'autore, tenta di assorbire l'inquietudine di una perdita e la stupefazione che un paesaggio reale, proprio perché, mentale e poetico ci presenta. Un paesaggio dove l’inverno, rappresentato dal quadro, è metafora costruttiva di un biancore che attraversa il sintagma luminosamente oscuro di un panorama velato, ma dove basta un bagliore per, se non disvelare, almeno rivelare la meraviglia di un segreto che tale rimane: la dimensione particolare, in punta di pennino, del luogo. Ma è ciò che non si sa che continua a girare dentro la pagina, a infiltrarsi tra le parole, nel loro andamento errante e a non permettere, apparentemente, lo sviluppo di un vero inizio e una reale continuità. Ma il senso è proprio in questa ricorsività, sempre diversa nel suo ritornare e stare sulla “soglia non della voce/ma del silenzio”, dove forse ogni suono cadrà, svuotato, senza che se ne possa avere coscienza; o forse rimarrà solo un fugace sentire: quello che permetterà ancora la vita della poesia, nonostante l’autore ci dica che “le nostre lettere sono tutte incipit/del poema che mai venne”.
Marco Furia su Palpiti, sontuosi sacrari di un cupo artificio di Vittorio Ricci
Una poetica enumerazione
Vittorio Ricci presenta un componimento (la cui prima parola, non a caso, è “palpiti”) che mostra un susseguirsi di pronunce poetiche sinuose e coinvolgenti.
Quale il senso di simile versificazione?
Siamo forse in presenza, per citare l’autore, di un
“Emblema, bersaglio di un segreto sproposito …”?
In effetti, un sospetto del genere può sorgere nel leggere questa fitta sequenza di versi e vocaboli uniti da cadenze assidue, collegate le une alle altre come onde del mare che si susseguono.
Un oggetto, tuttavia, a mio avviso emerge: è il tutto.
Il tutto dell’umano esistere, terrestre, cosmico, reale, astratto, emotivo, sentimentale, perpetuo, effimero: potrei continuare la serie degli aggettivi fino a esaurire il dizionario.
E, forse, proprio di un tentativo di esaurimento consapevole del suo impossibile perfezionarsi, in questo caso, si tratta: l’immensità non si può dire come tale e nemmeno nei suoi singoli componenti.
Siamo, insomma, di fronte a una sorta di poetica enumerazione conscia di non poter giungere alla fine e, nondimeno, risolutamente decisa a mostrarsi senza esitare.
Non importa esaurire, importa dire.
Si legge, verso la fine della poesia:
“fuggitivo il delitto di uno squadernio di scintille
abbacinanti nel mar dell’essere che essere tace
insu trasfigurati orli o opere del tremore perpetuo,
senza febico responso, senza vaticinio”.
Direi che proprio in quel “fuggitivo” è racchiuso il senso di un articolato e denso dire in perenne movimento, sempre consapevole, tuttavia, di come le immagini e le parole costituiscano brevi ma durevoli soste la cui persistenza è misura della stessa umana vita.
Un’umana vita non certo esaurita ma poeticamente ben rappresentata.
Marco Furia su In-morte di Laura G.V. di Paolo Ferrari
Inusuali traguardi
Con “In – morte di Laura G.V.”, Paolo Ferrari presenta una raccolta dalla fitta persistenza verbale, accompagnata da intense immagini astratte.
Il primo verso è esplicito:
“Insidiosa realtà capziosa”.
Il poeta avverte la “realtà” come insidia: la realtà o il linguaggio degli uomini?
Ambedue, perché, per il Nostro, il dire e il vivere sono inscindibilmente congiunti in un idioma ricco di luci e ombre, di pieni e vuoti, di gioie e dolori, di visioni e cecità.
Paolo non si preoccupa di distinguere e, consapevole di come ogni parola implichi già di per sé una differenza, s’impegna nell’accostare pronunce e singoli vocaboli al fine di produrre un vivido senso.
Le sue cadenze sono precise e le sue immagini, nella loro policroma astrattezza, rimandano a uno sfingeo quid.
Il tempo, in particolare, è oggetto del suo interesse, come emerge dai versi:
“sotto la corolla e la zampa
del tempo”
e
“Arrotolandosi la storia sopra se stessa”.
L’esistenza, senza dubbio, è scandita dal tempo, ma quest’ultimo non è sempre uguale: ogni istante ha una sua irripetibile fisionomia immersa nelle dimensioni individuali e collettive del genere umano.
Un genere umano al quale il poeta si rivolge in maniera appassionata, conscio dell’enigmatica compresenza del perché e del come: per lui, il nesso causale e l’affiorare di aspetti, lungi dall’essere rigidamente separati, si combinano in una dimensione idiomatico – esistenziale che, non pretendendo di spiegare la vita, cerca di renderla maggiormente conoscibile con l’atto del mostrarla in poesia.
Arduo compito che implica il raggiungimento di mete mai definitive, aperte su ulteriori itinerari e anche sull’assenza e sul nulla, ossia su
“quel traguardo
al quale mai fummo abituati”.
Marco Furia su Olio santo II di Fausta Squatriti
Una poesia civile
Con da “Olio santo”, Fausta Squatriti presenta un’agile e pregnante composizione in cui il secondo e il terzo verso
“profilo contorto sfinito
paesaggio senza pena terso”
gettano una sorta di assertiva luce sull’intera poesia.
Siamo al cospetto di un “paesaggio” evidentemente deturpato eppure “senza pena terso”, ossia di un’ “ultima frontiera” che induce a riflettere sulle condizioni di una natura violentata ma ancora capace di mostrare se stessa.
Volendo interpretare la suddetta pronuncia in maniera differente, si potrebbe pensare a una sorta di provocazione secondo la quale il “profilo contorto e sfinito” si mostrerebbe, ormai, come dimensione ambientale tout court, forse non accettabile ma, purtroppo, usuale: siffatta lettura annullerebbe ogni possibilità di fiducia, sicché non resterebbe altro da fare che attendere l’inevitabile catastrofe.
Il tono di denuncia civile del componimento, però, invita a una presa d’atto la cui conseguenza non può certo essere una pessimistica attesa: qualcosa, nonostante tutto, si può fare, anzi si deve fare.
Il mondo c’è ed è com’è e da qui, soltanto da qui, occorre ripartire: le responsabilità sono evidenti, ma proprio perché tali mostrano in maniera chiara, a tutti, la via che occorre intraprendere.
È da notare come il testo non propenda verso facili toni di protesta sociale e politica, ma si svolga secondo efficaci pronunce descrittive che tendono all’equilibrio piuttosto che alla scompostezza: un equilibrio non solo formale ma, vorrei dire, anche sostanziale, poiché, per risolvere un grave problema, occorre, innanzi tutto, accorta fermezza.
E la pregnante agilità di cui parlavo all’inizio riflette, a mio avviso, proprio un’esigenza di assidua, equilibrata perseveranza: questa poesia, insomma, non si limita a rappresentare un grave problema ma mostra anche l’atteggiamento utile a risolverlo.
I versi in esame si possono definire propriamente civili, poiché il loro parlare è già, anche, indispensabile qualità del fare.
La parola di Fausta, insomma, esiste davvero.
Marco Furia su Le ceneri di Adriano di Maurizio Solimine
Il tempo del sempre
All’inizio di “Le ceneri di Adriano”, articolato ma agile poemetto di Maurizio Solimine, si leggono i versi:
“d’Adriano accennano e numi
delle fronde stordiscono l’argilla
della campagna. È l’ora che assorta”.
L’efficace immagine centrale, quella delle “fronde” che “stordiscono l’argilla”, è come compresa tra due pronunce che ne delimitano l’aspetto linguistico e, vorrei dire, narrativo: tale andamento poetico, che procede per raffigurazioni collegate secondo una grammatica del racconto, è proprio di una versificazione che nel richiamo ai poemi classici trova la sua ragione di essere oggi, all’inizio del XXI secolo.
L’antico non diventa più moderno, ma attuale, poiché il ricordo è presenza che si mostra e persiste.
Due versi, a questo proposito, paiono significativi:
“a vincere l’abisso sulle membra
sparse nei mille secoli a venire”.
La poesia vince l’abisso del tempo?
Direi, piuttosto, che ne attraversa, noncurante, le trame.
Da qui, un tono che ha, nello stesso tempo, il sapore di allora e di ora, consapevole di esserci stato e di esserci.
Sorprendente ed enigmatico è dunque questo componimento che sembra raccogliere, con naturalezza, quello che in poesia è stato fatto da più di duemila anni a questa parte.
D’altronde
“il mondo passa, quale crudo nome
è quello del presagio che non torna?”.
La predizione che “non torna” ha un nome “crudo”, quasi l’incuranza del tempo nei confronti delle azioni e dei pensieri umani fosse crudele e non del tutto naturale, ovvia. Viene, perciò, da chiedersi: la sabbia che scorre nella clessidra è del tutto estranea alle nostre vicende? Non è essa stessa una nostra invenzione?
Abbiamo dunque inventato qualcosa che non tiene conto di noi?
Domanda sottesa a un intenso poemetto la cui chiara leggibilità fa emergere in maniera implicita, ma non nascosta, un misterioso quid che riguarda tanti aspetti della nostra vita.
Conoscere, talvolta, è prendere atto di un enigma senza tentare di risolverlo: il nostro poeta lo sa bene.
Ranieri Teti su Appunti d’iperestetica di Anna Maria Dall’Olio
Anna Maria Dall’Olio introduce il lettore alla sintesi di un metatesto, posto al confine, al quadrivio, tra esperienza estetica, etica, arte, forma poetica.
Quattro angoli che sommati generano una sorta di grado ultimo delle possibilità espressive.
In questo frangente di vita estetica l’arte penetra l’etere del mondo / il pianeta s’annuvola di bello.
Il mezzo testuale usato consente gli scarti semantici che caratterizzano la poesia, quando “libera” diventa al verso successivo “libra”, oppure dove una diagnosi è anestesia da estasi.
E’ presente nel testo una sorta di discontinua continuità tra quello che l’arte è e quello che l’esperienza artistica dovrebbe rappresentare; sono evidenti sia il contrasto alle riflessioni critiche autorefenziali, sia la proposta di un rapporto diretto con l’opera.
C’è infatti, espresso con la tensione generata con l’andare a capo della poesia, il grande tema della fruizione dell’arte che per l’autrice dovrebbe avere destinatari interagenti; questo stesso tema si propaga e si allarga anche a chi la produce, fino al monito “di fronte al frutto del lavoro estetico / l’arte non fugga non s’apparti”.
Ranieri Teti su Nel riflesso d’una luce di Renzo Piccoli
La poesia di Renzo Piccoli, innestata nel clima di una lunghissima norma poetica, si sviluppa per accrescimento continuo attraverso un incessante aumento del senso.
L’autore agisce con sempre nuove stratificazioni, quasi come in un crescendo musicale; a differenza di questo, il crescere non è dei toni ma del senso complessivo dell’opera che sempre più si approfondisce e scandisce, come il flusso di un lungo assolo, una complessa sinestesia.
Questo accumulo costante di materiali nello stesso tempo allarga le prospettive, le percezioni e lo spazio vitale della poesia.
“l’attinenza d’un fare / nell’estensione delle complessità” sono due versi esemplari del procedere.
Dalla “nudità delle cose”, attraverso “l’ubiquità dell’assoluto”, Piccoli ci guida presso la “versatilità affabulata d’una mimesi”, ci tratteggia un iter poetico che si radica, per i materiali trattati, nei nostri strati più profondi.
C’è una velleità morale in questo testo, una tensione che si accentua, una paziente ricerca del filo del discorso, “d’un senso dell’agire”.
Ranieri Teti su “In un punto” di Roberto Perotti
La poesia di Roberto Perotti porta con sé il senso dell’infinito, la trama del continuo ritorno.
Si pone come l’oggetto espressivo di una prossemica spaziale.
Ci induce a far di conto con il dubbio, ci conduce a immaginare un destino di domande senza risposte.
E’ come se l’autore si fosse posizionato in un punto indeterminato del cosmo e da questo punto osservasse il ritornare della storia, il passare delle epoche, l’incommensurabilmente grande e i minimi accadimenti quando diventano scintilla.
Più precisamente, “una scintilla che dipana / una storia”.
In questo testo si offre un fermo-immagine dell’evoluzione, una personale meccanica celeste, una luce dentro una prospettiva, un respiro o, per citare Perotti, “una favola di frammenti continuamente ricomposti”.
Il poeta, quando cerca, trova alleati dappertutto; incontra cose e situazioni talmente vere che accadono solo in un testo poetico.
Ranieri Teti su “Accolgo distratto” di Stefano Iori
Il mondo emozionale di Stefano Iori restituisce frammenti di vita poetica, dubbi, certezze, incertezze.
In questa poesia c’è un modo dello scrivere che parte dall’ordinario per trasfigurarlo, che cerca di superarne la barriera.
La rimozione della punteggiatura e degli spazi tra i versi, pur mimati dalle riprese in maiuscolo, testimonia la ricerca di un flusso ininterrotto anche se all’interno franto.
Lo spazio poetico che l’autore rappresenta è distribuito tra l’osservazione della realtà e l’aspirazione a un reale strutturato dal pensiero.
C’è inoltre la volontà di compiere uno dei più importanti lavori del poeta: liberare la parola dalle incrostazioni che derivano dall’uso quotidiano e utilitaristico che ne fa la comunicazione di massa, tentare di salvare la lingua sotto costante attacco: “Trascrivo parole / di seguito / sole / ... / pulite infine” ci dice Iori.
Rosa Pierno su I Compianti di Maria Pia Quintavalla, effigie, 2015
L’impeto a raccontare la propria infanzia non può che avere un unico senso in Maria Pia Quintavalla: ricrearla con la preziosità dell’ideato, con l’impalpabilità che solo la poesia consente, con la lacunosità che riserva alla concretezza dell’esistenza, creando un magazzino eterno, da utilizzare come miniera. Ciò che avanza, dunque, per il presente e i futuri anni, è il tessuto del ricreato, che viene ulteriormente arricchito dalla descrizione delle opere d’arte di Parma, teatro dell’esistenza e della rappresentazione.
La figura del padre, centrale in tutta la silloge, è restituita tracciando i suoi gesti quotidiani contro uno sfondo d’eternità tramite il marchingegno dell’alone misterioso, che rende vaghi, non ancorati, i concetti, anche tramite l’accostamento con un tempo storico altrettanto inaccessibile all’analisi: “Spazzava ogni giorno la cantina, / poi non la spazzava più; / non le cose rimaste deflagrava, ma / era sangue rappreso, era la polvere”. Il tempo del ricordo diluisce la cronologia e tende a rendere simbolici gesti, azioni, oggetti, periodi. In questa sorta di sospensione, risalta il solo elemento spaziale, che anzi diviene vera e propria macchina rappresentativa. Riassunto il tempo in una dimensione indifferenziata, nel contenitore parmense, si accende il faro sull’invenzione dell’interiorità, che si snoda quasi come un film muto.
D’altronde, lo stesso futuro, seppur soventemente citato, non può avere più valore di un desiderata. Il greve pondo dei ricordi trascina in basso, verso le sedimentazioni e le registrate cose, non quelle a venire: “come se fosse intatto il tempo, / l’eterno tutto qui insepolto, / fresco di mondi / / indelebili futuri”. Vivere le storie, che tramite le opere d’arte sacre sono percepite come fossero il più vivido presente, rende sacre anche le vicende personali, ma non sarà ancora che a causa di un uso indifferenziato del tempo, il quale non influisce per similitudine, quanto innescando un prosciugamento interno. Il tempo dell’individuo collassato sul tempo cosmico rende accettabile anche la morte delle persone più care, e soprattutto scolpisce nella retina la turpe vicenda dei campi di sterminio, accadimento anch’esso privato del suo scorrere temporale, che stende un’ombra lunga sull’intero genere umano.
Rosa Pierno su La gioia è un turbine di quiete di Lorenzo Gobbi, ATì Editore, 2014
La fitta, irrinunciabile conversazione, istituita dalla voce di Lorenzo Gobbi, nel suo La gioia è un turbine di quiete è rivolta a più interlocutori: che siano Layla, un amico o Dio, non importa quanto la messa a punto di una parola polimorfica e metamorfica, poiché se le poesie iniziano col nominare un interlocutore, finiscono – e nel passaggio si fanno figure, ritornano suoni, si materializzano si desostanziano – col parlare anche a tutti gli altri, pubblico compreso. La parola, in questo processo di allargamento della platea, se in tal guisa si diparte da una situazione confidenziale, spesso generata da semplici osservazioni, quali possono essere la visione di steli d’erba o di un volo di rondini, tende a coinvolgere aspetti più generali, fino ad assumere una valenza che tende all’universale: “Testimoniano per me / le tue promesse – la sostanza / d’ogni cosa è questa Pasqua / questo mare aperto, questi / fiori di bianchissima speranza”. Se le domande sono rivolte all’Altissimo, il tessuto che le sostiene è nella vita, nel contatto delle mani, nel sostegno degli sguardi, nel profumo dei fiori. La delicatezza con cui Lorenzo Gobbi rilancia la posta non deve far credere a una sorta di flebile posizione, poiché forte e tenace è la volontà di perseguire il cammino poetico ed esistenziale. La ricerca ha come scopo l’obiettivo di meglio conoscere per meglio abbattere i limiti tra il sé e l’altro, tra il corporeo, il mentale e lo spirituale, tra ciò che appare e la sua essenza. La natura si configura come un al di qua che simboleggia l’al di là. Nella pace avvertita nella fertile pianura estiva, “questa pace, là: nell’alto, / negli eccelsi luoghi dove tutto / è un’opera di vita”. Eppure, non è colloquio che procuri pace, se ne sente il rovello, lo scavo inesausto, preghiera recitata senza sosta, quasi supplica, di cui tanta letteratura mistica ci ha mostrato la difficoltosa registrazione. Il ruolo della fede s’individua nel porsi ogni giorno domande, anche sul nome di dio, come avviene nella riflessione ebraica: “io vorrei di lui, non so / da dove scenda il Nome”. I misteri rimangono misteri e la morte, il dolore, lo scorrere inesorabile del tempo, intessono i dialoghi, che vedono già solo nel loro istituirsi la somiglianza di ogni cosa con ogni cosa, disegno unitario che se la poesia non può esaurire, può però movimentare.
Rosa Pierno su Il non potere di Davide Nota, Sigismundus editrice, 2014
In Davide Nota il rapporto con la storia che illumina i comportamenti umani, i suoi strumenti, i suoi limiti è centrale, quanto impietoso: la critica viene indirizzata verso se stesso, ma sta per la società tutta. Dopo aver riconosciuto che la ragione può quasi nulla rispetto alla forza della storia, l’azione è ricondotta verso un ripiegarsi su se stessa, “dove solo l’incoscienza, immune / da ogni nuovo strategico diniego / di scienza, riconquista la sovrana / vitalità dell’atto, oscuro lume… “. Il balzo al sesso è immediato, e immediato il suo legame con la prostituzione, a ciò che, comunque, riconduce ad animale stato: “in cui s’accorge di fuggire al senso / spaventoso di sua vita ignora / il tutto e oggetto fattosi onora / in implacabile banchetto carnale / l’anale suo destino d’animale”. Sarà poi alla madre, che Nota destina l’appellativo di santa. Nei nitidissimi quadretti di quattro versi che sanno delineare immagini che hanno l’icasticità di simboli del vivere attuale, è ancora la ragione, seppure in controluce, ciò a cui Nota attribuisce soluzione, costruzione di senso, valorizzazione: “Ma no, non è la produzione industriale che mi terrorizza / ma le finalità mancanti!”. E la ragione è appunto l’antidoto, l’unico possibile. E, d’altronde, se “No, non sono le occasioni ma le finalità / che mancano, le ragioni...” non si vede come esse possano nascere da occasioni di vita spesso marginali o compromesse. Assediato dal vuoto, enuclea situazioni del male di vivere, di cui il corpo si fa immolato messaggero: “mostrando seni da ormoni / gonfiati, siliconati, calze in nylon sopra mascoline gambe e labbra dure, / brasiliane, pronte al male”. Forse la critica è sufficiente, ma d’altronde la promiscuità che il corpo ha con la mente, mette in dubbio l’intero progetto: “l’oggi / è quanto resta, scoria / che la fuga della storia elude: un perizoma”. Tuttavia Davide Nota rilancia, disegna scenari che a questo vilipendio subìto/prodotto dalla carne si sottraggono, tratteggiando, appunto, situazioni di ribellione al degrado e all’ingiustizia e rimarcando che finché c’è coscienza critica, c’è opposizione. La silloge, che raccoglie poesie che vanno dal 2002 al 2013 si fa nel prosieguo più sonora, lieve, quasi che il peso delle cose nel fluire della storia sia, non maggiormente sopportabile, ma rimembrante. Nota, interrogando il passato con mesta cura, sia il proprio io sia la dimensione collettiva, si fa portavoce di messaggi che ritiene importante non vadano perduti, cerca nella morte dei soldati e nelle figure parentali una voce intorno a cui sia possibile l’agglutinarsi del vero: “Di fronte a questa storia / anche il sole si incrina”.
Rosa Pierno su Gamete di Osvaldo Coluccino, Coup d’idée, 2014
Leggiamo la prima sezione della silloge Gamete, intitolata Eliaco, come se fossimo immessi, dalla voce autoriale di Osvaldo Coluccino, nell’atmosfera dei quadri di Poussin. Il lessico ricercato, aulico, introduce in un’atmosfera rarefatta, dove la particolare consistenza della luce, dorata e senza tempo, sembra essere il personaggio principale e i convocati - personaggi mitici - paiono avere la medesima aerea consistenza: “Bevuti in un soffio, di parca reale / Fattezza, al lago tranquillo velati, / Fili opimi al limitare del bianco.” Sonore reminescenze, le definiremmo, visioni suscitate dal registro linguistico anacronistico (dove anacronistico ha necessariamente funzione strumentale) atte a dipingere una scena, a creare un’ambientazione. A partire da questo evocativo fondale, si può risiedere atemporalmente sulle due opposte sponde di un medesimo fiume, e vivere nella cultura, riattualizzandone le opere: si può vivere, dunque, in un’altra epoca, farla propria. Nella sezione che dà il nome al libro, la narrazione sembra avere uno svolgimento solo al fine di ottenere un immoto quadro. Scrivere come se si dipingesse, scrivere per dipingere, in realtà: “La nave è assente ma le spume / Più ardue paiono di gemma”. Tuttavia, con un gusto particolare: quello che scorge nelle analogie, quasi una prova dell’identità comune: “La salvia si conosce nel corallo. Sposalizio”. Quale sarebbe, infatti, il discrimine? La soglia che consenta di affermare: qui c’è una cesura, la differenza tra mitico e reale. Oppure che consenta di chiedersi: vivo in quest’epoca? Se la propria interiorità può assumere persino cangianti forme mitiche, è possibile! E l’autore trascina con sé, inevitabilmente, il capovolgimento come figura principe a cui sottoporre il senso per attivare l’intero arco semantico: “È un’apparizione strana, di me stesso, qui / Più che in altre balde epoche, direi / Se non fosse improprio, capovolto”. In tal maniera, l’io appare immerso in una congerie d’immagini classiche e rinascimentali, in cui alcune parole, nel flusso testuale rullante, appaiono come intoppi temporali: “Slancio di cui la famiglia si fregiava / Fu scolato umore a non fargliene fregare. O acque mute, ove l’abito da eroe / Che lo tramutò in subacqueo, erodeste?”. Così forse non crediamo all’uso dei simboli profusi nel testo: la torre, il leone, la fenice, le ali, la coppa, la nave, il vento. Non crediamo siano da decifrare, ma lemmi che al pari di navicelle, ci possano dislocare altrove, da cui lasciarsi trasportare.
Rosa Pierno su Serie fossile di Maria Grazia Calandrone, Crocetti, 2015
In Maria Grazia Calandrone, il linguaggio si fa simbolico, o frammentato specchio in cui parole si accumulano per un’urgenza interiore a cui non si deve chiedere logica sequenza, mentre fermo e integro risulta, invece, un contemporaneo accorato rivolgersi che tiene le redini del discorso poetico e guida il lettore per selve visionarie, pure quinte teatrali le vorremmo definire: ma questo filo non è nemmeno esso lineare, pur mutandosi, in un solo tornante, nel suo opposto, lucidamente disegnando le sponde di vorticanti descrizioni. Così, la Calandrone individua, nel suo Serie fossile, due livelli di espressione delineanti mondi irriducibili: il corpo della poesia, la descrizione vera e propria che articola sensazioni, percezioni, sinestesie, innesti tra l’io e il dato empirico e il contrapposto mondo interiore tenuto distinto, appunto, da quel filo rosso – in realtà avente la marcatura del corsivo sulla pagina – in cui ci pare quasi di riconoscere la voce dell’autrice, nel senso di una vera e propria messa in scena, quasi in una sorta di supplica, affinché si svolga un dialogo, che abbia valore di condivisione, che assomigli a un placebo, qualcosa che plachi il desiderio, che esaudisca la conoscenza, che serva da fondamento per tutti i piani dell’espressione. E dicevamo che questo filo esprime qualcosa e, contemporaneamente, il suo contrario: “metti il dito nel solco del tuo cuore, indicami” e “ per favore non dirlo, chiudi la bocca)”, mentre il corpo della poesia accumula definizioni: “hai una debolezza di spiga, / muscoli di cavalla, un’arsura / di sabbia calpestata / nella spina dorsale / e un solco di aratura”.
Preleviamo dalla poesia Fossile, un altro esempio di filo rosso: “– sarebbe riduttivo dire amore / questa necessità della natura –” incistato nel seguente tessuto: “usa la bocca, sfilami dal cuore / il pungiglione d’oro, / la memoria di un lampo che ha bruciato la mia forma umana / in una qualche preistoria”.
Se logica non s’innesta con visione, se percetto non s’accorda con immaginazione, la spola che tesse la poesia di Maria Grazia Calandrone, inesausta, dipinge un mondo fantasmagorico e ferreo ove il linguaggio non ammette vie di fuga, né consente vie di salvezza, se non appunto l’incessante percorrenza.
Rosa Pierno su Piano Argento di Angela Passarello, edizioni del verri, 2014
Una delicatezza che nasce dalla semplicità e dalla sintesi, dal parco uso delle parole, dalla calibrata aggettivazione con cui ogni lirica ci dispiega dinanzi agli occhi il racconto di memorie e percezioni. La parte che sta per il tutto, grazie alla capacità di individuare un’immagine che riassuma in sé una tramatura d’essere con le sue lacune e il suo senso alleggerito o latente, ma che valga come un simbolo dell’intero e che, dunque, sappia anche sostenere il peso delle cose concretissime, arse, assetate, o infitte come oasi nel mare dell’inconsistenza. Se tali immagini risalgono ai ricordi d’infanzia, esse però sono restituite come fossero l’unica dimensione riconosciuta e individuante della propria personalità: “quando imbastivi i vestiti per la festa / spezzavi il filo con i denti davanti / nel medio indossavi sempre il ditale / appariva regale la tua mano vestita”. E regale resta per sempre, senza che sia fissato il metro di confronto in una realtà esterna, radicalmente altra. C’è dell’assolutezza in questa poesia: un valore che sembra risiedere in un marchio, anche qui legato al dato geografico e climatico, dove oltretutto la cultura, in terra siciliana, è questione di mescidazioni tra quella greca e quella araba e, dunque, subito deponente il concetto dell’ideale incorrotto. Ciò che pertanto sembra facile, per la sua peculiare freschezza, si mostra nella sua veste barocca di dato complicato, da decifrare, anche solo col fine di voltarlo per vedere quale sorpresa riservi il verso. Il recto, fisso e come scolpito in una luce meridiana, assolata, è scavato da una sintassi quasi avara, scabra, ove si sente che il poeta incide, rastrema, filtra: “lo mantiene dritto un bastone / come certe viti invecchiate / sollevate da terra a fatica”. Ma sovvengono anche certe prove di scuola francese, (si pensi alla prosa di un Ponge) ove si tenta di liberare le cose da un linguaggio che inevitabilmente le incrosta: “il cane la precedeva marcando il territorio / la vecchia sovrastata da un fagotto di stoffa sbiadita / entrambi ritornavano poi verso la casa diroccata”, anche se qui più potente risulta essere lo scavo: quasi da graffito su rupe, in assolato deserto.
Rosa Pierno su boxing day di Pasquale Della Ragione, Edizioni Riccardi, 2013
Il testo sembra sembrerebbe una sorta di wunderkammer, se non raccontasse di un viaggio esistenziale. O la scena di un luogo appena abbandonato, ove al suolo, in maniera disordinata, siano restati piccoli insignificanti oggetti: piume, corde, ragnatele, fili, foglie, corolle, pietre, i quali richiamano alla mente concetti legati all’organico e al geometrico: distanza, nascita, crescita, perimetro, figura, equilibrio, ritmo. Il meccanismo d’innalzamento della struttura testuale sembra essere ottenuto tramite l’accostamento di tre o più nastri a velocità differenziata, per cui parole che facciano parte di un nastro vengono a trovarsi allineate a quelle di altri nastri. Potremmo pensare a una sorta di slot machine. Ecco, dunque, che vediamo scorrere sulla pagina aggettivo, sostantivo, verbo, i quali pertengono a diversi contesti semantici: naturale o astratto o antropologico: “ nella ruga / convessa lo strumento / di tramonto” o ancora “del ginepro / dura / lo smalto d’occhio”. E non è un caso che verbi o aggettivi concordino soltanto se appartengono al medesimo nastro. In questo modo, solo apparentemente si libera il linguaggio, aprendolo alla casualità degli allineamenti: l’operazione, benché liberata da certe costrizioni, è tuttavia imbrigliata in altre: si pensi qui alla ricchezza di certi limiti imposti alla pagina dal movimento dell’OuLiPo (che utilizzava, appunto, tecniche di scrittura vincolata detta anche a restrizione). Ma va anche aggiunto che tale scelta riguarda non solo il guadagno di una maggiore mobilità rispetto alle regole linguistiche e sintattiche (si pensi all’assenza, nella totalità del testo, di apostrofi e punteggiatura) ma anche la libertà d’azione rispetto alla congruenza delle associazioni semantiche: “ crivellando lo scolorire / dello / sgranarsi” oppure “l’acquisto che sfibra / le colonne del / perdurare”. Siffatti accostamenti concernono anche i significati contraddittori, nel senso in cui, ad esempio, ciò che non ha sostanza viene crivellato e ciò che non ha fibra viene sfibrato a testimonianza del fatto che, per Pasquale Della Ragione, l’attacco al sistema è possibile grazie all’utilizzo di paradossi con cui se il linguaggio ci intrappola, il linguaggio ci libera.
Davide Campi su La stanza nella stanza di Lia Rossi, Edizioni Tecnograf, 2014
Nelle scritture di Lia Rossi le parole emergono -come boe salvifiche, da un ipotetico caos- prepotentemente misurate all’interno delle geometrie di ogni pagina.
Sono parole del quotidiano che qui si liberano del tono dimesso a loro solitamente proprio per ridefinire usi e spazi: “una camera chiara il sogno/in segreto il segreto inonda l’acqua/crescono sui tetti le stanze…”.
Accuratamente posizionate nello spazio della pagina, sintatticamente asciugate fino all’essenziale, nella perdita di ogni narrazione, le parole “stanza”, “tetto”, “strada” si slegano dei loro confini fisici strutturali per assurgere ad altre mete: “ il tetto sul tetto la terra in terra la notte/nella notte iridescente strada sulla strada/la casa in casa”.
C’è una profonda fisicità negli spazi generati da queste scritture, pareti friabili di parole con all’interno spazi candidi di silenzio. Ed altrettanta fisicità nei ritmi che le parole generano specie quando ripetute in una cantilena telescopica: “..in una torre nella torre tra parentesi/converge) va l’infinito lentamente”; i tempi sono quelli del respiro, del battito del cuore, a ricordare che ogni ambiente è tale solo se abitato.
Davide Campi su Le città antiche e altre poesie di Miro Gabriele, GB EditoriA, 2014
Miro Gabriele scrive in forme regolari, con molta attenzione alle metriche, ai ritmi interni, agli equilibri sonori. Ci sono spesso rime, non sempre esplicite, allitterazioni e assonanze (“Altra difficile dolcezza invernale/amore al buio, luce insostanziale…”) ma anche, talvolta, un uso assai disinvolto dell’enjamblement; il tutto totalmente asservito ad evidenziare il senso.
Ed è chiaramente merito di una rigorosa formazione classica, proficuamente applicata alle traduzioni del classici latini, ma anche ampiamente digerita e consolidata, se tutti questi aspetti formali nulla tolgono al piacere della lettura dei suoi testi.
Al di là degli aspetti strutturali, è interessante la prospettiva percettiva che emerge da questi versi. Che si parli di città antiche o moderne, di paesaggi umani o esperienza interiore, ciò che viene descritto in poesia si trova all’interno di uno spazio totalmente soggettivo o, al massimo, in quella zona di confine subito prima della totale, oggettiva e aliena presenza del mondo esterno: “La riconosciamo è un’abitudine/in quest’ora sottile in riva al mare/la stessa ansia in me e in te d’una misura…”.
Davide Campi su Musa fitta nell’azzurro di Davide Argnani, Di Felice Editore, 2014
Davide Argnani è poeta di lungo corso e di grande esperienza.
La lingua della sua poesia è caratterizzata da rigore e coerenza, e questo libro ne è testimonianza diretta.
Spesso le scritture hanno un inizio leggero, quasi colloquiale, sviluppandosi in seguito in potenza evocativa, nella forma e nel lessico, “Cammino a moscacieca lungo le sponde del tunnel/qui la farfalla sventola ali agli intrecci degli angoli/s’incunea il rettile nei labirinti del sottosuolo…”. Ritmi lunghi, metriche decise e regolari, con pochi, meditati squilibri ad accentuare il senso, ma anche a sottolineare la frequentazione quotidiana ad una poetica delle grandi emozioni del vissuto umano (nostalgia, dolore, abbandono, amore).
È una scrittura che spesso ricorda le forme delle arti figurative (paesaggio e ritratto), dove lo sguardo cristallizza la scena fermandone uno specifico istante, per poi subirne l’inevitabile assalto: “ora ho voglia di piangere sulla terra secca dei miei occhi/… sulla sabbia un segno dov’è stato il corpo…”. Così i versi, più che restituire la specifica scena, danno conto della sua naturale, violenta risposta a qualsiasi osservazione.
Davide Campi su Previsioni e lapsus di Luciano Mazziotta, Editrice Zona, 2014
La poetica di Luciano Mazziotta si esprime con successo in questo libro sia in poesia che in prosa poetica.
Accomuna i due moduli espressivi il ritmo volutamente incostante e a tratti convulso, un linguaggio lucido e di estrema concretezza e una narrazione vagamente teatrale, con spazi scenici ben delimitati: “Succede che qualcosa si rompe/che si sgretola il soffitto sul sofà/appena intravisto nell’atto/di cedere, di essere cenere/bianca: crepa.” o anche, in prosa:” e lo dicevo infine. e lo ripetevo a me stesso di essere qui. E, chiudendo la porta, ero in un’altra città”.
Tratto distintivo dell’operazione poetica è la misurazione di una data realtà, ben identificata e ordinata, scendendo progressivamente e metodicamente al minimo particolare, con un accanimento da “osservatore seriale”: “e lei continuava, dicendo, che berlino era un balocco e che tutto sarebbe rimasto in quella città, che non avremmo potuto dirlo a nessuno se non agli specchi e un riflesso che parla non fa una realtà.” o anche : “Preni ad esempio la Karl-Marx-Allee:/compatta, compatto è l’asfalto:/non ci sono buche né vuoti/gli edifici non ammettono fughe/né pause, se pausa è un salto tra i tempi…”.
Operazione riuscita, con grande coerenza espressiva e senza cedimenti.
Davide Campi su Tagli di Marco Sonzogni, La Vita Felice, 2014
Marco Sonzogni pratica la poesia in modo consapevole e tutto, in questo libro, testimonia della profondità dei suoi studi e delle sue frequentazioni letterarie.
Nella sua scrittura troviamo poesia in metriche di vario tipo, a volte in rima classica: “Non temo la notte ma l’indifferenza/ho sempre perseguito i miei sogni./Mi ha sempre sostenuto la pazienza./Ho sempre ascoltato i miei bisogni.” e piccole prose ma anche brevi omaggi e brani “alla maniera di…”, spudoratamente segnalati dalle citazioni: “E viene e va e torna e si resta/in balia della terra che trema…”.
Segnali certi di una meditata ricerca da cui risulta anche un elevato grado di dominio della materia linguistica.
L’oggetto principale della sua poesia è una narrazione dell’esistenza vista esclusivamente dall’interno del proprio essere in una sorta di egocentrismo poetico: “Basterà quando non ci sarai/più il tuo nome tra le litanie/a riparare ogni mio misfatto?”: non solo i fatti straordinari e i luoghi esotici, ma anche il quotidiano, i gesti dell’abitudine, nel loro rapporto viscerale col corpo fisico del poeta, diventano un’epica senza compromessi: “Per lavarmi la faccia/sopporto sì/queste mie mani/così piccole sono/scusa perfetta di pianista fallito.”.
Davide Campi su Testa rasata di Maddalena Capalbi, Moretti & Vitali, 2015
La poesia di Maddalena Capalbi parla lucidamente e sapientemente di violenza.
Si tratta di una violenza a prescindere, storicamente documentata, ingiustificabile, con un unico e inevitabile bersaglio. In essa non c’è niente di spirituale o teoricamente collocabile; è solo cieca e fisica. È contro il corpo della donna, e vi si accanisce fino al più definitivo epilogo: “…per questo hai abbracciato/i seni con rabbia/e pazzo d’amore/li hai riempiti di fori.”.
Ogni poesia è rappresentazione e narrazione di una storia e di un personaggio, svelando ognuna una diversa declinazione della stessa ingiuria.
La lingua che la svela ha sintassi essenziale: “…La bambina si difende dal terrore di essere snidata…”, ritmi a volte incalzanti: “Non serve la croce che ciondola/per leggere i desideri volgari”, ma più spesso distesi e musicali, a dispetto della crudezza delle parole: “Aveva le mani nel fango/e i capelli attorcigliati,/ancora vestita…”.
Ma l’abilità poetica della Capalbi si dimostra soprattutto nella capacità di usare e gestire un lessico necessariamente molto duro e aspro mantenendo nei versi una potente ed evocativa coerenza sonora.
Ultima pagina: “Memento mori” di Fausta Squatriti, particolari e nota dell’Autrice

Memento mori, 2014
Memento mori sta ad una fase di ricerca degli ultimi anni, nella quale mi sento libera di fare quello che mi piace fare, e il disegno è tornato tra le mie mani sempre più come una necessità.
Fiori, belli per eccellenza, ma da me "ritratti" con maggior piacere quando sono secchi, contorti, quando le loro venature, una volta perduto il turgore della vita, diventano precise come una radiografia, rivelando l'intima struttura dei loro fragili corpi. I colori virano verso inedite sfumature, i gambi si contorcono asciugandosi per diventare secchi, ed ecco che al mio sguardo tutta quella bellezza si è ben presto trasformata in un campo di battaglia, coperto di morti, feriti, ritrovati, riesumati, magari ancora ricoperti dalla calce delle fosse comuni.
L’estetica del dolore, della trasformazione, dalla carne allo scheletro, si serve della bellezza come facevano i barocchi per i loro Memento mori, raffinati promemoria della fine ultima del corpo come strumento della vita. Le ossa degli esseri animali ci attraggono e respingono, grandi composizioni estetiche sono state fatte con le ossa, e ancora ornavano chiese e cappelle, sarcofagi e capitelli. Al mondo vegetale si è riservata più leggerezza, diventando la mela bacata, la foglia secca, con il loro portato simbolico, un accenno meno drammatico alla malattia e alla morte, ma proprio perché nel mondo vegetale il dolore della malattia non è, se c’è, appariscente come quello del mondo animale. Ritornare a questi antichi inganni, per dire il vero più crudo, drammatico in modo intrinseco, senza il dramma aggiunto delle umane vicende, è la ragione di questi disegni di grandi dimensioni, dove la matita, impugnata come fosse uno stiletto tagliente, asseconda ogni piega, arricciatura o vena del fiore a modello.
Biografia di Fausta Squatriti (a cura di Ornella Mignone)
pubblicata nel catalogo edito da MANDRAGORA in occasione della mostra
SE IL MONDO FOSSE QUADRO, SAPREI DOVE ANDARE…
a cura di Elisabetta Longari
Gallerie d’Italia – Triennale – Nuova Galleria Morone
Fausta Squatriti nasce nel 1941 a Milano, dove vive e lavora. Alla mostra di Picasso a Palazzo Reale di Milano, nel 1953, ancora bimba, decide che diventerà un’artista cubista. Lo stesso anno all’Arengario di Milano alla mostra dedicata al disegno infantile c’è anche un suo disegno: La pezzente. Il suo professore di disegno Gianni Monnet, aderente al MAC, la incoraggia a iscriversi alla X Triennale Socota, Concorso internazionale per disegni di tessuti per arredamento. Sua madre, la scrittrice Lina Angioletti, giocherà un ruolo importante: introduce Fausta nel mondo dei suoi amici, da Quasimodo a Lucio Fontana.
Nel 1959 si iscrive all’accademia di Brera, dove si diploma nel 1963 con una tesi su Il metodo nella ricerca di Paul Klee; nell’estate del 1961 frequenta l’International Sommerakademie di Salisburgo, dove impara a usare l’acquarello sotto la guida di Kokoshka. La sua prima mostra milanese è del 1960, alla Galleria del Disegno, dove espone una serie di disegni astratti presentati da Roberto Sanesi.
Il suo coinvolgimento per l’arte è sempre più totale e con Sergio Tosi inizia a occuparsi di edizioni numerate, attività che porterà la giovane coppia a essere conosciuta internazionalmente per il loro lavoro tanto con grandi maestri quanto con i giovani emergenti. Sposa, quasi per scherzo, Sergio Tosi a New York in occasione della personale da Barbara Koz, è il 1969. Il libretto “The coud eye” pubblicato all’occasione da Sergio Tosi, con testo di Gillo Dorfles, è posto in vendita nei bookshop del MOMA e del Berkeley Museum of Art. Nello spazio dell’Art Lending Service del MOMA, sono esposti gli –intaglio- di alluminio. Fausta e Sergio, che andavano spesso a trovare Antonio Calderara a Vacciago, si innamorano del luogo e decidono di trasferirsi sul lago d’Orta. Man Ray regala loro il disegno per una fontana purtroppo mai realizzata. Come editori Squatriti e Tosi sono attivi dal 1964 al 1974, data che segna sia la fine del matrimonio che del legame lavorativo. Fausta Squatriti riorganizza la propria vita da sola, è il 1980 quando riprende a proprio nome l’attività editoriale. 1
Tra il 1964 e il 1965 nascono i primi cicli tematici: Bagno d’aria e La passeggiata di Buster Keaton. Sono dipinti ispirati alla spazialità tiepolesca in chiave pop, fanno parte delle opere le cornici di legno intagliato, un connubio buffo e solenne. Ripresi nel 1966, diventano teatrini tridimensionali, nel nero si muovono figure colorate. La strada verso la scultura è annunciata e si concretizza con le Sculture colorate. La severità delle forme geometriche è contaminata da elementi vicini al cartoon. Per realizzarli Squatriti usa tecniche e materiali industriali: acciaio speculare, plexiglass, ferro laccato.
Si interessa a queste sculture il mercante d’arte Pierre Lundholm che le presenta nella sua galleria di Stoccolma e ne vende una al Moderna Museet. Questi lavori sono presentati da Gillo Dorfles in occasione della prima mostra americana di Squatriti alla galleria Kozmopolitan di New York (1969), in seguito portata alla The Courteney Gallery a Houston e alla Jack Mizrachi Gallery a Città del Messico.
Gli oggetti inquietanti che Fausta Squatriti viene ideando e realizzando da un paio di anni sembrano usciti da un fascicolo di science fiction dove si cerchi di descrivere le suppellettili che dei cosmonauti terrestri scoprono nelle abitazioni di un’altra galassia. 2
Le Sculture colorate sono proposte anche in Israele alla Mabat Art Gallery di Tel Aviv nel 1970, da Alexander Iolas a Ginevra; e fanno una tournée anche in America Latina, a Caracas nelle gallerie Estudio Actual (1970) e Artecontacto (1975) e al Museo de Arte Contemporáneo Jesus Soto di Ciudad Bolivar (1975).
A partire dal 1972 Fausta Squatriti elimina il colore, tutto diventa rigoroso, essenziale, per un decennio la sua ricerca verte attorno alla geometria astratto-geometrica espressa con le Sculture nere, in ferro e acciaio, presentate alla galleria del Naviglio a Milano nel 1979. L’anno successivo il Centro Iniziative Culturali Concordia 7, Pordenone pubblica la monografia che correda la mostra di cui la seconda tappa è allo studio Marconi a Milano. In questa occasione Squatriti inizia un fitto carteggio con Giulio Carlo Argan, con il quale condivide riflessioni sull’arte; l’epistolario è ora depositato presso il “Fondo manoscritti” di Pavia. Argan firma i testi della prima mostra parigina da Denise Renè nel 1982 e della prima personale a Düsseldorf, da Karin Fesel, nel 1987. Dall’incontro con la gallerista tedesca nascono diverse occasioni espositive, personali e collettive nei suoi spazi di Düsseldorf e Sonsbeck ma anche in importanti spazi pubblici in Germania.
Con la metà degli anni ’80 l’artista imprime al suo percorso creativo una svolta decisa, si avvale di un linguaggio che ha bisogno della superficie e del volume. Squatriti si ritiene soddisfatta del suo lavoro con il ciclo Fisiologia del quadrato (1985), installazioni che mettono insieme pittura, grafica e scultura, triade che si consoliderà ulteriormente con il ciclo In segno di Natura. Nel 1991 inizia il ciclo: I segni del conflitto, cui segue I ferri del mestiere, un’indagine sugli strumenti di tortura. Sono dittici o trittici sempre più crudi, violenti. Utilizza foto di scimmie urlanti: nasce Nel regno animale e prosegue con gli spasmi dei frutti e dei fiori deformati, malati: Nel regno vegetale. Nel 1995 approfondisce il tema dei Legami di sangue, congiunzioni improprie, tragiche, tra esseri diversi, elementi che generano violenza e sofferenza. In Sed libera non a malo, dello stesso anno, Squatriti inverte i termini percettivi, visivi e di valore, lo scopo è rendere attraente la bruttezza delle cose e viceversa. Vicine a questa serie sono le stazioni della Via Crucis realizzata nel 1996 ed esposta a Bergamo nell’Ex Teatro Sociale. Pierluigi Lia ne scrive: non come un’opera fatta per piacere, ma a un discorso fatto per urtare fin nelle viscere3. I pesci rappresentano il simbolo del dolore nella serie Strage degli innocenti, 1997, dolore e sofferenza anche con Un Requiem per la specie e per la macchina, con brandelli di corpi umani accostati a parti di macchine logore, ciclo presentato all’ex essiccatoio a San Vito al Tagliamento (Pordenone) nel 2000.
Il Museum am Ostwall di Dortmund nel 2001 dedica a Fausta Squatriti un’antologica a cura di Ingo Bartsch; egli sostiene che I ferri del mestiere è il ciclo che indica più chiaramente quale è la questione principale dell’artista: il male fa parte del mondo e, poiché esso tende a nascondersi, deve essere smascherato per poter essere combattuto.4 In questa occasione Mazzotta pubblica una ricca monografia curata da Claudio Cerritelli.
I particolari ritratti di intellettuali che compongono La Commedia Umana, sono raccolti per la prima volta in Italia all’interno dell’antologica alla Fondazione Mudima a Milano nel 2001.
Beata solitudo sola beatitudo, serie non ancora conclusa, inizia nel 2002 e viene proposta a Bologna, alla nt gallery da Valerio Dehò. Per il Giorno della Memoria 2006, all’interno dell’ex Sinagoga, a Monte Savino (Arezzo) Fausta Squatriti progetta l’installazione intitolata Zachor – In memoria (Ricordare per essere liberi), che sarà poi esposta a Torino al Museo delle ex carceri Le Nuove nel 2013.
Ecce homo è invece la retrospettiva che le dedica nel 2009 il Moscow Museum of Modern Art di Mosca, a cura di Evelina Schatz. Il ciclo omonimo, iniziato nel 2005, ha come fulcro un insieme di immagini di un reportage di denuncia sulle condizioni degli internati negli ospedali psichiatrici dei paesi dell’Est.
Jaqueline Ceresoli introduce la mostra da Assab One a Milano nel 2011, concentrandosi soprattutto sui trittici che compongono il ciclo Ascolta il tuo cuore città, titolo preso a prestito dal romanzo che Alberto Savinio pubblica nel 1944. Un viaggio onirico nello spazio e nel tempo, surreale, fino al cuore della metropoli, esangue e rantolante dopo un’apocalisse. […] un presupposto poetico scritto con le immagini e gli oggetti che raccontano la solitudine dell’umanità e delle sue bellissime città così genialmente costruite. 5
Sue opere fanno parte della collezione del Centre Pompidou, che ne espone una nella mostra Elles@centrepompidou nel 2010, e del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, che la espone nella saletta dell’arte italiana nel 2015/16.
Fausta Squatriti ha insegnato presso le accademie di Carrara, Venezia e Milano, è stata visiting professor all’Académie des Beaux-Arts di Mons. Nel 1988 è invitata a insegnare e a esporre alla University at Manoa di Honolulu, esperienza che ripeterà nel 1994. Ha tenuto conferenze sul proprio lavoro e su altri argomenti a Honolulu, Tel Aviv, Haifa e Parigi, oltre che in Italia.
Per quanto riguarda il lavoro in ambito letterario, va segnalata la pubblicazione di poesie e saggi. Sue poesie sono state tradotte in ebraico e pubblicate in Israele nel 2012, e nello stesso anno una silloge in inglese è pubblicata sulla rivista internazionale ''Incontri''. La più recente raccolta di poesia è Vietato entrare (La Vita felice, 2013); nel 2016 è pubblica la traduzione francese di una scelta di sue poesie, Une anthologie 1960-2012 (L’Harmattan, Paris 2016). Dal 1992 al 1995 esce la rivista interdisciplinare ''Kiliagono'' fondata dall’artista con Gaetano Delli Santi ed edita per il Pesce d’oro da Scheiwiller. Per quanto riguarda la prosa, due sono i romanzi pubblicati, Crampi (Abramo, 2006) e La Cana (Puntoacapo, 2015). Nel suo percorso vanno infine citate alcune esperienze collaterali, fra cui nel 1997 la fondazione con Francesco Leonetti del Teatro dell’autore in scena, che proponeva brevi testi di artisti e poeti impegnati anche nella recitazione. Il gruppo esordì alla Fondazione Mudima a Milano, con successive prove al Festival Ricercare a Reggio Emilia, a Venezia per il Festival della parola, e a Milano per Teatri ‘90, il Teatro Franco Parenti e ancora Mudima. Nel 2011 è andato in scena alla Fondazione Calderara di Vacciago il monologo Istruzioni per l’uso, recitato da Alberto Lombardo. Nel 2002 Squatriti ha creato le scenografie per The stillest, con la coreografia di Eric Senen, rappresentato al teatro Mains d’oeuvre di Parigi, e nel 2012 ha curato i testi e creato gli oggetti di scena per Ora d’aria, spettacolo rappresentato dal Teatro delle Selve sul Lago d’Orta. Squatriti ha impiegato diversi anni per indagare un oggetto legato alla sua famiglia e del quale nulla si sapeva, l’esito di tale ricerca storica, artistica e narrativa è raccolto in Pollice verso. Storia di un arazzo (Nardini, Firenze 2015).
1 Dal 1980 l’artista riprende l’attività editoriale, realizzando Exacta, la sua più impegnativa edizione dedicata a 27 protagonisti della ricerca costruttivista internazionale.
2 Dorfles Gillo, Oggetti inquetanti, “The Cloud Eye”, Sergio Tosi, Milano 1969
3 Lia Pierluigi, Via Crucis: considerazioni teologiche per un’iconografia, in Recanati M. Grazia (a cura di), “Via Crucis”, Mazzotta, Milano 1999, p.12.
4 Bartsch Ingo, trascrizione del discorso tenuto all’inaugurazione della mostra Per una poetica della tortura ovvero: insorgere contro la permanenza del male, Museum am Ostwall, Dormunt, 23 maggio 2001
5 Ceresoli Jaqueline, Fausta&Squatriti, in Nano Stefania (a cura di), “Conosci te stesso”, Quinta Arte, 2012
Luglio 2016, anno XIII, numero 32

La giuria del Premio Lorenzo Montano, composta da Giorgio Bonacini - Laura Caccia - Davide Campi - Mara Cini - Flavio Ermini - Marco Furia - Rosa Pierno - Ranieri Teti, è lieta di presentare i risultati finali della 30^ edizione del "Montano".
Le premiazioni di segnalati, finalisti e vincitori si terranno a Verona sabato 12 e sabato 19 novembre p.v., nell’ambito del “Forum Anterem 2016”.
Aprile 2016, anno XIII, numero 31

Un ulteriore sguardo sulla poesia italiana contemporanea, ideale seguito dei tre numeri precedenti: ancora una volta, nel nuovo “Carte nel vento”, tutta la redazione di “Anterem” è impegnata a presentare le opere, sia segnalate che finaliste, premiate nell’edizione 2015 del “Montano”.
Gli autori ospitati sono: Antonio Bux, Enzo Campi, Lia Cucconi, Chiara De Luca, Adelio Fusé, Paolo Gentiluomo, Giuseppe Gorlani, Francesca Monnetti, Alberto Mori, Giuseppina Rando, Marco Saya, Liliana Ugolini & Vincenzo Lauria.
L’occasione ci permette di rivivere l’esperienza del Forum 2015, che proseguirà quest’anno con simili modalità ma anche nuovi contenuti legati al trentennale del Premio.
Ricordiamo che il 15 aprile scadono i termini per partecipare alla 30^ edizione scarica il bando.
In copertina, Forum Anterem 2015, immagini di Armando Bertollo
Antonio Bux, da “Sistemi di disordine quotidiano”, Achille e la Tartaruga 2015, nota di Davide Campi
Antonio Bux, in questa come in altre precedenti opere, sviluppa i suoi testi in forme diverse, fisicamente avvicinate per area concettuale, che risultano tra loro complementari e convergenti ad illuminare in suoi sistemi caotici della percezione.
I versi in corsivo, alti, evocativi, potenti per introdurre o, a volte anche per chiudere un campo di indagine, quasi a misurarne valore e universalità, come scrive proprio all’inizio: “La memoria/si genera/per ombre,/e solo conserva/il suo lato/retrostante”.
Le prose poetiche, il cui inizio colloca e definisce con un ritmo da cantilena breve che poi mano a mano si allarga e si riempie di strappi e crepe seguendo l’articolarsi e deteriorarsi nei suoi stadi più disgregati di un qualsiasi sistema complesso sottoposto a percezione.
Le poesie, in cui avviene la vera narrazione del corpo del soggetto, a volte in versi lunghi e inaciditi, altre con verso breve e più lirico, sempre e comunque musicali, concettualmente quasi –e ribadisco “quasi”- circolari, spesso con una piccola “fuga” finale priva di redenzione.
Una scelta precisa e obbligata dalla complessità e irriducibilità dell’oggetto dell’indagine poetica.
Dalla sezione “Scotomi”
Da Smistamento dell’invisibile
***
“Sono le vecchie pose
che rimangono accese
come a contrastare l’ombra,
la forza oscura arrugginendo
l’origine nell’ossidazione
di una fiamma primitiva”
Di tutto un fascio che avvolge
vi è sempre un filamento più teso
che avanza per sé, e da solo riprende
il peso che unisce – ma poi si ferma
a piegare le entrate, le distende sui lati
e si spezza da sé, come la memoria:
continua il ritaglio per stringersi ancora.
Dalla sezione “L’inversa voce del respiro”
***
“Dell’acqua su più strati, curva anomala
o solo onda senza ritiro, una marea
che già è furia prima di erigersi,
rovescio del luogo nel luogo riflesso”
Se un dipinto muove i luoghi,
li contiene in un acquerello,
allora l’effimero vive il disegno,
non la base reale, né la sostanza
dove prevale l’affanno invisibile,
come fluttuando nel pastello lucente
quando un dito ripercorre l’universo
- e dentro un confine d’ombra lo cancella –
nell’introspezione visiva custodisce l’addio.
***
“Dunque: somigliarsi allo specchio
prima ancora che il vuoto disegni
la forma a svanire, l’immagine
più ostile, quell’altro che rimane”
Nel bianco sporco della pagina
smacchia la lavanda del pensiero:
si stende invano sul dorso del foglio
e all’inverso produce
il chiarore, la luce insicura
nel tramonto della parola.
Antonio Bux (Foggia, 1982). Vive tra la Spagna e l’Italia. Suoi lavori e recensioni sono apparse in numerose antologie (tra le quali piace citare A sud del sud dei santi – Sinopsi, Immagini e Forme della Puglia Poetica. Cento Anni di Storia Letteraria (a cura di Michelangelo Zizzi, LietoColle Editore, Faloppio, 2013); InVerse 2014/15 - Italian poets in translation (a cura di Brunella Antomarini, Berenice Cocciolillo e Rosa Filardi, John Cabot University Press, Roma, 2014/2015); Poeti della lontananza (a cura di Sonia Caporossi e Antonella Pierangeli, Marco Saya Edizioni, Milano, 2014), e sulle pagine culturali dei maggiori quotidiani nazionali (come Corriere della sera e L’Unità) oltre che in diverse riviste (tra le quali Italian Poetry Review, Poesia, L’Ulisse, La Manzana Poética, Hyperion) e lit-blog (come La dimora del tempo sospeso, Nazione Indiana, Poesia 2.0, Otra iglesia es imposible) sia nazionali che internazionali, dato che molti suoi testi sono stati tradotti in spagnolo, francese, inglese, catalano, tedesco, rumeno e serbo. Ha curato la traduzione del libro Ventanas a ninguna parte (Gattomerlino Superstripes, Roma, 2015) dell’autore spagnolo Javier Vicedo Alós, oltre che la traduzione di testi scelti di autori tra i quali Leopoldo María Panero, Julio Cortázar, Dário Jaramillo, Álvaro García, Antonio Cabrera, Jaime Saenz, Pere Gimferrer, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Samanta Schweblin e tanti altri ancora. È autore dei libri Disgrafie (Poesie 2000-2007 e altre poesie) (Edizioni Oèdipus, Salerno-Milano, 2013; libro vincitore della XXXVII Edizione del Premio Minturnae Poesia Giovane “Ornella Valerio”); Trilogia dello zero (Marco Saya Edizioni, Milano, 2012; libro finalista per l’opera edita alla XXVII Edizione del Premio Lorenzo Montano); Turritopsis (Di Felice Edizioni, Martinsicuro 2014); 23 - fragmentos de alguien (libro scritto direttamente in spagnolo, edizione bilingue; Ediciones Ruinas Circulares, Buenos Aires, 2014); Sistemi di disordine quotidiano (Achille e la tartaruga edizioni, Torino, 2015). È risultato vincitore del premio Iris di Firenze nel 2014, e finalista al premio Poesia di strada, sempre nello stesso anno. Collabora con diversi editori e scrive per alcune pagine culturali sul web. Gestisce il blog Disgrafie (antoniobux.wordpress.com) e, per le Marco Saya Edizioni, la collana Sottotraccia.
Liliana Ugolini & Vincenzo Lauria, dalla raccolta inedita “Le stanze della mente”, nota di Laura Caccia
Perdi/Menti
È una suonata a quattro mani quella che Liliana Ugolini e Vincenzo Lauria eseguono sullo spartito della silloge “Le stanze della mente”, stanze musicate con uno strumento le cui corde vibrano in una tensione che chiama in causa, nei loro controcanti reciproci, il pensiero e la parola, come introducono gli autori: “Linguaggio miriade / che percuote tam tam soffia di tromba / corda di violino e richiama / dialettiche e allusioni di doppi. / La verità del perdersi”.
Il perdersi, personale e della parola, muove dalle difficoltà di dire, quando per Liliana Ugolini “Il conoscere incontra la fatica verbale / e si fanno versi silenzi e balbettii”, e dai limiti posti dal finito nel controcanto di Vincenzo Lauria, per il quale “Ultima è la meraviglia / la parola morta / in fremer di labbra / morta in gola / per aver saggiato il suo confine”.
Attraversando le varie stanze e declinazioni della mente, come leggiamo, “A porte chiuse / l’avversa mente / è la tua stessa mente /… accosta/Menti / in strania/Menti da strapiombo”, in un serio e sofferto gioco linguistico, gli autori mettono in scena misure e dismisure, abissi e silenzi, assenze e non esistenze, finito e infinito, nell’erranza della mente e della parola: “Facil/Mente / errerò nell’in/errabile”, riflette Vincenzo Lauria, trovando nel controcanto di Liliana Ugolini, la misura dell’oltre, “Ora so che basta saper d’aver visto / con occhi innocenti / un che d’infinito una volta”.
Cervello
L’enigma verticizza
l’evolversi complesso.
Milletrecento grammi
d’encefalo complesso
esploso in due emisferi
(m/isterocosmo) in divenire
dell’attimo successo telegrafico filo
d’un messaggio. Linguaggio miriade
che percuote tam tam soffia di tromba
corda di violino e richiama
dialettiche e allusioni di doppi.
La verità del perdersi.
Sostanza grigia (Liliana Ugolini)
Piacersi porre la propria immagine
ai larghi luoghi di velato comando
sicuri delle strade percorribili
guidare verso assolate speranze sicurezze
farsi seguire da sorrisi donati
per conoscere il ciclo e arrivare al coraggio
del granello perduto nelle storie.
Segreta IV (Vincenzo Lauria)
Le coincidenze,
le sovrapposizioni di spazi
ci ricongiungono al dunque
mentre il non sapersi ci riduce
di dose in dose
all’alchimia vivente,
memori d’immemore
funamboli su funi dentellate.
A tratti un meccanismo interno
ci sbalza nel fuori/dentro
e in immersione
ci si arrende alla crudità delle nostre carni.
Liliana Ugolini ha pubblicato 19 libri di poesia, 4 in prosa e 4 di teatro. Da questi sono stati prodotti 12 spettacoli teatrali e 2 opere/concerto. Ha curato per 16 anni in “Pianeta Poesia” la poesia performativa e multimediale documentata in tre libri.Collabora con l’Associazione Multimedia91 all’Archivio Voce dei Poeti e fa parte del gruppo performativo “Cerimonie Crudeli”. E’ stata redattrice della rivista “L’Area di Broca”.
Vincenzo Lauria, dopo un primo percorso nella poesia lineare, ha portato le coordinate del proprio orientamento nella dimensione poetica verso l’intermedialità e la performance. Dal 2010 collabora con Liliana Ugolini ai progetti poetici multimediali Oltre Infinito, Oltre Infinito 2.0, O13 Infinito. Dal 2012 collabora con l’Associazione Multimedia91 – Archivio Voce dei Poeti.
Paolo Gentiluomo, da “L’onnivoro digiuno”, Oèdipus 2014, nota di Rosa Pierno
La carne, in Paolo Gentiluomo, è non solo la predella da cui erigere lo sguardo verso l’altro, ma è l’orizzonte speculativo stesso. Come dire: mezzo e scopo della conoscenza. Se nell’intuizione aristotelica, mente e corpo sono indistinguibili, in Gentiluomo, il corpo si percepisce con i sensi, s’interpreta attraverso le sue azioni. Il corpo si apre, così, a un’interpretazione combinatoria pressoché infinita rispetto al dato finito: tant’è che delle donne incontrate nessuna descrizione, benché finita nel tempo, può terminarne esaustivamente la definizione, determinarne l’essenza. E, dunque, per Gentiluomo si deve considerare solo il corpo: “in tutto ciò lo spirito non alberga da nessuna parte, non entra neanche in gioco, è solo soffio e alito pesante”. Anche quando il prelievo da opere appartenenti alla tradizione in qualche modo dirotta il discorso, attraverso consolidati stilemi, inevitabilmente, l’oggetto è sempre il corpo e soprattutto non vi si apre mai un’asola di incertezza o mistero che indichi una prospettiva di tipo metafisico: “quel dente che mi fére ad ora ad ora le tumidule genule, i nigerrimi occhi mi risana ancora il desir troppo ingordo”o ancora “s’io avessi le lingue mille a mille e fussi tutto bocca e labbra e denti”. Come a dire non si esce da questa sfera, non si esce dal corpo se non mentendo. Corpo: gabbia e strumento di saturazione, oggetto limitato, ma permutante, ove quel che varia è la ripetizione, con la diversa collezione che se ne può ottenere. E, in questo senso, particolarmente vicina appare la poetica di Gentiluomo a quella beckettiana, dove la descrizione delle sole azioni è affidata a una descrizione geometrica: “un corpo spostato, rallentato, con omissione di un fumo che offusca, con omissione di una curvatura, e anche gli angoli non sono stati detti”. Come l’autore stesso afferma, tale operazione di ricalco è parallela alla doppia natura umana/divina di Cristo, e, infatti, in molte parti della silloge ritorna spesso il prelievo dai testi evangelici, impegnati come sono nella resa di tale duplicità, quasi un confronto preferito rispetto ad altri per il poeta. Ma vogliamo anche segnalare un’attenzione ai codici artistici, citati nel testo in quanto oggetti, corpi fra altri, e la vena ironica sempre presente, che se non assurge a rovesciamento delle verità veicolate dal potere, vale però come costante segnalazione di campo minato.
Dalla sezione “Il mio cuore è il tuo porcile”
v. il mio cuore è il tuo porcile
...quel porcile del mio cuore
come me lo sono ridotto!, un tumore
strappato coi denti, annusato e ansante,
un tumulto senza più accenti,
cumulo di parole lasciate sole
senza la bocca che le ha scoccate...
vi. caracollo
*
le mani ecco
l’attività febbrile delle mani le mie mani
che piegano gli abiti e li ripongono al loro posto
la questione dello stare al proprio posto
ruoli le mani
hanno il compito di non dare tregua al mondo
una di lavare l’altra senza scampo le mani
meglio averle morbide per petrti carezzare eppure...
*
le mani riportano ferite
in gesti presi da qualche parte
e riportati al volo sul corpo
venti coltellate forse ventuno
le mani sono state loro a infierire
le mani carnefici
hanno confezionato con abilità
il vestito della morte la cassa la tomba
mani diverse hanno preparato tutto come si deve
e le mani hanno posto fine ai battiti
mani incuneate nel cuore
per sottrarne una libbra
a me sembra fossero trenta trentatrè le coltellate
amano vibrante o forse confondo con altri ferimenti letali
eppure...
Paolo Gentiluomo suonò musica industriale coi TamQuamTabulaRasa (tapes-cd). Coordinò con Berisso, Cademartori e Caserza il collettivo di pronto intervento poetico Altri Luoghi. Partecipò al Gruppo 93. Danzò in Danze minute e sTANZe della coreografa-danzatrice Aline Nari. Lesse in feste, festival, gallerie, radio, chiese sconsacrate, monasteri, musei dell'attore, teatri, ex-macelli, varietà patafisici da lui stesso confezionati. Pubblicò Novene irresistibili (Periferia, 1995), Catalogo (Zona, 1998), il manualetto per ragazzi Poemificio (D'If, 2003), Dice con quanti denti quest'amor ti morde (Mazzoli, 2005, finalista al Delfini), La ragion totale (Zona, 2007, finalista al Tassoni 2008, segnalato al Montano 2009), il romanzo Lo smaltimento (Round Robin 2010), Manuale Portatile per la Devozione del Fertile Gaudio (Sartoria Utopia, 2012 e 2015).
Adelio Fusé, poesia inedita “All’epoca le ore mi avevano assegnato”, nota di Ranieri Teti
La perizia metaforica che sostiene il testo lo connota pur nella molto particolare struttura dialogica.
Una delusa attesa di vita concentra e addensa questa poesia, la sua necessità di dire, la sua libertà espressiva.
Nel circuito della significazione, in entrambi i versanti delle voci, il testo di Adelio Fusé è orientato sia al racconto che a una simultanea introspezione. Dice insieme il fatto e il pensiero che ne consegue, come nella chiusa della terza strofa:
“e via franando fino all’irriducibile /
il punto che ci dipana ma mai si tocca / e luce non getta”.
Come cadere nel buco nero di un sé inconcluso, dentro una confusa massa.
Ma tutto, in questa come in molte storie che raccontano deglutite amarezze, si scioglie nella piega finale, a tratti dolorosa, per altri versi ironica, dolcemente meditativa, della voce-pensiero che osserva senza aspettative ma irriducibilmente “qualunque transitare che più non passa”.
***
all 'epoca le ore mi avevano assegnato
alla costa dove il mare sbraitava
a dispetto dei miei gemiti assenti:
nell 'entroterra un altro vento volava
e fustigava e smembrava
"e tu che sei il veterinario si guastano mai
dimmi i denti ai cavalli?"
lui un autografo nella posa consueta
smerciò sorrisi lieti oppure così lunghi
che parevano marci sollevando nuvole
da gran fumatore (sigari dozzinali
a giudicare dall'odore)
"perché ecco vedi" si recitò saggio svagato
e informale "occorre circoscrivere
le domande e la tua nulla da eccepire
è localizzabile nella bocca
di provenienza - la tua -
e nella bocca equina che nomina:
un esempio uno soltanto pari
a incalcoabili altri
oh! io sono confusa massa ma il senso
è che questa piana qui intorno si riduce
per mia volontà alla porzione che io occupo
in definitiva all'effetto e alla causa nel ristretto:
ragiono e m'impunto su scale minimali
e via franando fino all'irriducibile
il punto che ci dipana ma mai si tocca
e luce non getta
(e oggi ti prego di credere non ho bevuto
un goccio forse finalmente dovrei
anche più d'uno in verità
da bagnarsi con gli spiccioli
ultimi: lo si afferra per la coda - ridi perdio
alla coda del goccio! - come il rinomato treno
o medium qualunque transitante che più non passa
insomma accostiamo i bicchieri amico transfuga
noi delicati e inconclusi non ancora spacciati)"
Adelio Fusé è nato in provincia di Varese nel 1958, vive a Milano e lavora nell’editoria. Ha pubblicato saggi su Sade, Kafka, Sartre, Handke, Eno (Cd-Book Auditorium-Materiali Sonori, 1999), un romanzo (North Rocks, Campanotto, 2001) e i libri di poesia Il boomerang non torna, Book Editore 2001; Orizzonti della clessidra distesa, Book Editore 2005; Canti dello specchio bifronte, Book Editore 2009; L’obliqua scacchiera, Book Editore 2012; segnalati al Premio “Lorenzo Montano”, 2004, 2006, 2009, 2013). Testi sono apparsi su riviste ("alfabeta", “Atelier”, "Auditorium", “Il Segnale”, "La Ginestra", "Legenda", "Lengua", "Sonus", “Tratti”) e online (“Carte nel Vento/Anterem”, “Poetarum Silva”, “Vico Acitillo 124 – Poetry Wave”). Ha fatto parte della direzione di "Legenda" (Tranchida, 1988-1995). Collabora con artisti e musicisti (libri d’artista, installazioni, performance). Ha ottenuto un riconoscimento speciale al “Premio Riccione per il teatro" (1981).
Enzo Campi, dalla raccolta inedita “ex tra sistole”, nota di Giorgio Bonacini
La parola che Enzo Campi ci presenta in questo poemetto ha una speciale qualità che travalica la semplice lettura dei suoi testi, compenetrando il lettore con un’azione che cancella il già dato e generando e rigenerando un fluire linguistico senza agganci conosciuti. Per questo il termine “lettura”, così come lo si intende e lo si agisce normalmente, crediamo che in queste poesie sia quantomeno inadeguato, perché va riempito di ulteriori significazioni e ancora più di pratiche interpretative significanti. Per comprendere allora qualcosa di essenziale della visione poetica che l’autore infonde in questi testi, occorre leggere come se fossimo noi a scrivere: per percepire con gli occhi, con la mente pensante e intuiva, con il corpo e, nell’insieme, con il movimento che la voce trasporta in scrittura e riverbera trasformata in suono nuovo. È un’ architettura modulare, fatta di onde e sommovimenti, in cui la circolarità fono-grafica accresce, abbandona, recupera, nel lavorio della lingua, i sensi di una forma gestuale: contemporaneamente fisica e incorporea.
E se questo movimento non viene sentito, o meglio, non ci si dispone a sentirne le ondulazioni generate dal suo pensiero fluente e confluente – mai trattenuto, mai costretto ma sempre lucido e attento a riconoscere che “l’aria che si respira tra il/bianco e il/nero” è un “vuoto.../pieno d’humus vitale” –, se dunque non si fa lo sforzo benefico di aderire a ogni articolazione, anche minima del testo, l’opera di Enzo Campi la si può certamente leggere, ma al minimo delle sue potenzialità semantiche. Il segno di questa sua particolare natura è, fin dal prologo del poema, evidenziato in una duplice specificità: lì dove poetare per voce e corpo non può non trovare, in un andamento che riconosce nel suo cercare le concrete fonie che “sibilano o sibillano”. Quindi il suono che si fa senso multiforme, che attrae e fa attrito tra sé e il mondo, che si struttura plasmando o graffiando, a partire da un soffio o da gutturalità originarie, disarticolate, forse residuali particelle, ma capaci di dare sostanza alla lingua esistenziale che si apre alle evidenze nascoste del segno iniziale.
Enzo Campi è poeta che non si lascia agganciare da una mera interpretazione sperimentale, perché la sua estroversione selettiva coglie e combina ogni materia sensibile che la lingua possiede, sia in atto esplicito sia come annuncio segreto. In ogni caso un segno da scoprire, anche quando questo sembra apparire non chiamato o accadere non destinato. In queste pagine si compie un tumulto fonico che sente e fa sentire – con profonda duplicità del concetto di “udire” in sé e in sé “provare” il senso – come e quanto un dire così prensile non tenda a esprimere suoni che portano un significato concluso, ma prova a incidere nell’aria e sulla carta le “le cose e i silenzi/raschiati dal fondo”. E più ancora negli abissi di una superficie che vede i concetti smembrarsi e il soggetto interiore prendere parte in questa disgregazione dividendo “il primo pronome” IO, tra linearità univoca del significato e circolarità ricorsiva del significante poetico. Ed è qui, in questo conflitto che osserviamo una lotta tra “sillabe laviche” e “sillabe edulcorate”; conflitto che potrebbe annichilire fonemi e grafemi, se non fosse che ogni volta, da ogni disgregazione si forma uno scarto di senso, che muove e preme, in modo indistinto ma deciso, dentro un pensiero alla ricerca del “Lascito Originario da/cui attingere linfa vitale”.
Da ex tra sistole
prologo
disfusi per voce rattratta o
abrasi per gesto di ventre
sibilano o sibillano
tracotanti fonemi camuffati in
note stonate che raschiano che
raspano l’
esile struttura di una stele in-
cosciente chiodata al muro di
turno
ecco
:
non c’
è bisogno di spacciare ulteriori profezie
la palla di
spugna che massaggia il
tamburo non cede alle
lusinghe della mano di
turno e rifiuta l’ovatta
che vorrebbe detergere
le labbra dai residui
tribali di un sapere perduto
parodo
tra collo e colon un
sapido rizoma a
veicolare umori e
spacciare la parola d’
ordine per aggirare i
grumi rappresi
ma il sasso di grasso che garantisce l’
arresto e respinge il contatto è pronto a
sciogliersi e liberare l’
accesso se la chiave viene urlata
masticando chiodi e scalpelli
a fuoco vivo recita il
coro se pavidi o in-
costanti risuonano i
lamenti della prefica-madre e pure
collidono coincidono sull’
asse il grave e l’
inerte il trapano che trivella il supporto il
proiettile che perfora il
corpo allettato di fresco
a fuoco vivo recita il
coro per perpetuare la disseminazione e lo
scarto
Enzo Campi è nato a Caserta nel 1961. Vive e lavora a Reggio Emilia dal 1990.
Autore e regista teatrale con le compagnie Myosotis e Metateatro dal 1982 al 1990. Videomaker indipendente, ha realizzato svariati cortometraggi e un lungometraggio: Un Amleto in più. Suoi scritti letterari e critici sono reperibili in rete su svariati siti e blog di scrittura, su riviste e antologie. Ha curato numerose prefazioni e note in volumi di poesia. Ha pubblicato Donne - (don)o e (ne)mesi (Genova, 2007), Gesti d’aria e incombenze di luce (Genova, 2008), L’inestinguibile lucore dell’ombra (Parma, 2009), Ipotesi Corpo (Messina, 2010), Dei malnati fiori (Messina, 2011), Ligature (Sondrio, 2013), Il Verbaio (Milano – Sasso Marconi, 2014), Phénoménologie (Bologna, 2015). Principali curatele Poetarum Silva (Parma, 2010), Parabol(ich)e dell’ultimo giorno – Per Emilio Villa (Milano – Sasso Marconi, 2013), Pasolini, la diversità consapevole (Milano, 2015). Ha diretto, per Smasher Edizioni, la collana di letteratura contemporanea Ulteriora Mirari e coordinato le prime due edizioni dell’omonimo Premio Letterario. È stato ideatore e curatore del progetto di aggregazione letteraria “Letteratura Necessaria”. È direttore artistico del Festival “Bologna in Lettere”.
Giuseppina Rando, prosa inedita “Vuoto”, nota di Flavio Ermini
Prosa poetica
Giuseppina Rando ci parla di un essere in cammino. Il suo passo muove da una presenza per approssimarsi al vuoto. La presenza è evidente nell’atto della rappresentazione. Ma quella stessa presenza cessa di essere tale nel momento in cui la rappresentazione è conclusa.
A rappresentazione avvenuta subentra l’assenza. Alle molteplici forme si sostitusce il vuoto. L’errante, registra Giuseppina Rando è «in cerca di ragione», ma in realtà incontra l’assenza. Lo straniero anela a un senso, ma in realtà si trova a fare i conti con «parvenze inerti». Persino i nomi non hanno più niente a che fare con il dire.
L’arte rappresenta l’essenza del reale, ne ruba l’anima. Ma così facendo determina che il reale non esista più. Oppure fa sì che si mostri solo come maschera, come «cranio rovesciato». È come se cogliendo l’essenza delle cose l’artista rendesse non solo priva di attrattiva la realtà, ma la spazzasse via, la destituisse di materialità.
Il viandante, ci indica Giuseppina Rando, si muove «da notte a notte», ovvero da tenebra a tenebra. In questo percorso si trova a fare i conti con i silenzi dell’indicibile ogni volta che si attarda ad ascoltare l’appello dell’essere, la sua necessità.
Vuoto
S’intersecano nei solchi della tela le linee interne del quadro
provengono dalla fessura della porta.
Ciò che è rappresentato è assente.
Più in là la scodella di rame del viandante - di tanto in tanto-
brilla nelle sillabe disperse lungo la via - fra notte e notte - .
Sulle foglie oscillare di visioni molteplici forme s’inseguono
nella brezza che spazza frammenti di fatica.
Sul volto rugoso dello straniero si nascondono i segreti
che già un tempo furono le parole del Re da tempo immemorabile
assente.
Vuoto il posto costruito come il precario muro della certezza
sullo svanire di farfuglii bigi . Sovrasta l’ombra del ritmo
che regola la terra semisepolta da parvenze mute inerti, potenti.
I loro nomi non dicono, disperdono.
Nulla si aspetta l’errante . Conosce la propria appartenenza al niente.
Ciò che è rappresentato è assente, attraversato da ombre fugaci.
Sullo sfondo della tela fluiscono da alberi scorticati -come fosse sorgente-
buchi neri - crani rovesciati - macchine assordanti in cerca di ragione.
Attorno s’insinua tra polveri e vapori un’aria cristallina
silenzio che trascina all’altro capo del filamento.
Giuseppina Rando è siciliana. E’ stata docente di Lingua e Letteratura italiana negli istituti superiori.
Impegnata nella ricerca letteraria, si dedica anche a studi di carattere storico e filosofico.
Collabora con diverse riviste ed è presente in numerosi volumi di poesia, antologie e saggi.
Ha pubblicato testi di Poesia tra i quali: Spuma di mare (poesie 1970-1981), Statue di gesso (poesie 1982-1995), Duplice veste (2001), Immane tu (2002), Figura e parola, Cierre Grafica (2005), Vibrazioni (2007) Noubs Chieti, Bioccoli, Anterem Edizioni (2008); saggi: Profili di donne nel Vangelo (2001) Bastogi, Chiara. Una voce dal silenzio (2002) Edizioni San Paolo, Le belle parole, Scrittura Creativa Edizioni (2013).
Nel Segno -Racconti- (2011) Pungitopo, Patti Marina ha ricevuto il Premio di narrativa Joyce Lussu, Offida (Ascoli Piceno).
Finalista e segnalata in diverse edizioni del Premio Lorenzo Montano di Verona.
Francesca Monnetti, poemetto inedito “Antalgie”, nota di Marco Furia
Poetici coinvolgimenti
Con “Antalgie”, Francesca Monnetti propone un componimento davvero intenso nelle sue quasi aforistiche forme.
Già all’inizio, la pronuncia
“esterno uguale interno”
induce a riflettere sulla pregnanza di un senso che non corrisponde al significato logico di termini che nel linguaggio ordinario appaiono contrapposti, ma che
“di specie sinuosa
isomorfa estrosa”
bene convivono in condizione di uguaglianza nella poesia in esame.
Più avanti, la poetessa riesce a sorprenderci con una sequenza in cui il dato esistenziale, richiamato dalla parola “vivilo”, riguarda un vuoto da considerare nel suo integro emergere:
“vivilo … il vuoto
non sfumarlo”.
Più oltre, con
“per un po’ … per combinazione
in variazione … ti riconosco”
Francesca mostra come non sia certo la rigidità fisionomica a consentire il riconoscimento: ossia come, nel suo vedere, l’affiorare d’immagini ed emozioni si combinino per via di una sorta di sinfonico ritmo capace di risvegliare sensi di familiarità.
Suoni, colori, odori, figure, non sono per la poetessa singoli aspetti definibili in maniera risolutiva, bensì veri e propri ingredienti di circostanze non esauribili dalle parole: fino a qual punto possiamo dire la nostra vita?
Questa mi pare la domanda sottesa all’agile versificazione di “Antalgie”.
Domanda che, forse, trova risposta nei versi
“tra caos e caso
un ordine esce”
pur viene a deporsi
… materia e forma
ritornano a sé”.
Versi proposti con l’immediata semplicità di chi considera talmente naturale ciò che dice, da riuscire a farlo avvertire normale anche al lettore.
Siamo al cospetto di un idioma tendenzialmente coinvolgente?
Quello poetico lo è sempre.
Da “Antalgie”
In-compiuta
più netti
vanno resi i contorni
mentre tendono
e flettono ancora
le linee dei corpi
i dintorni
più non dilatano
i volti dentro
non sformano
i pezzi dell’essere
... pur sempre
dimorano in te
or su dunque
sia fatta pulizia
nel mio nido ...
... si diradano
i dettagli
sfocano in ombre
tratti di-visi
risorti ricorrono
altrove si fondono
sedimentano
in me
scarno ... congruo
il quadro
nello specchio
rotondo
tra caos e caso
un ordine esce
pur viene a deporsi
... materia e forma
ritornano a sé.
Francesca Monnetti è nata a Firenze dove ha compiuto studi in ambito filosofico-morale. La sua prima raccolta, “in-solite movenze”, finalista al “Montano” 2008, è stata pubblicata da Cierre Grafica l’anno seguente. Una sua silloge inedita ha vinto la IV edizione del Premio Sergio De Risio nel 2010. La sua poesia è stata presentata nel sito blanc de ta nuque da Stefano Guglielmin. Una selezione di suoi testi poetici inediti è uscita on-line su “Arcipelago Itaca”.
Giuseppe Gorlani, prosa inedita “La parola”, nota di Mara Cini
Illecito è pretendere d’essere creduti quando tracciamo confini inesistenti intorno alla parola.
Tentativo quello di Gorlani di circoscrivere la sostanza inesprimibile che pure spreme un succo stupefacente. E’ la parola nel perimetro del corpo e del respiro, nella geometria di un’apertura, nell’accrescimento botanico, nella litania consolante e ludica dei suoni.
La parola che si fa alternativamente tasca e coltello, che raccoglie e ripara, offende e ferisce, che disegna aree dove seminare, coltivare, raccogliere e ridisseminare.
La parola muove da un suono o da una traccia. Chi ha imparato dal gheppio sa che nel volteggio (un gesto grafico se immaginato con ali intrise d’inchiostro) il rapace scrive il suo grido.
La parola
I
In interiore homine c’è l’erba piegata dal vento. All’esterno, sul calar della sera, c’è l’erba d’oro tinta. In alto l’etere, in basso il cielo. Intorno la madre silente ripete quel che le suggeriamo. Al grido risponde con un grido, al sussurro con un sussurro. Saperlo induce a quiescere. Oppure ancora ci si ostina ad immaginare cornucopie sostenute dal cachinno del secolo?
Difficile pregare, impossibile chiedere. Nell’atarassia emerge la porta diuturnamente aperta, senza battenti, senza cardini. Anzi, nemmeno si può dire che vi sia una porta. In verità un insetto, una nuvola o qualsiasi altra forma suscitano stupore e ammirazione. Eppure si è affini agli estinti: il corpo già andato, l’anima a brandelli, la gola prosciugata. Gli uccelli li si ode distanti.
Non si ha alcuna pretesa di descrivere il modo a-modale dell’Essere in se stesso. Tutti lo vivono in essenza; nessuno lo conosce. Deum nemo vidit umquam.* Piuttosto si vuole correre, immobili sul filo del paradosso, saziare fame e sete, spossare gli eoni. In conseguenza a ciò le ginocchia si piegano, le palpebre si chiudono, le mani asciutte accolgono altre mani, le lettere si associano all’improvviso, le sillabe grondano sangue – o rubini, o pomi imperlati dalla pioggia nel verziere custodito dal serpente? – la neve crea sintassi inaudite.
E allora ci si china sulla parola come su una pianticella, scaturigine dell’intero mondo vegetale. La si contempla, ovvero si penetra in essa, la si lancia qua e là nell’ebbrezza ludica, la si ripone in un panno candido per stanchezza, non la si vende mai. Essa è sì virtù cacuminale, ma nel contempo risulta incomprensibile a qualsiasi mercanteggiare. Parola addormentata, diritta, languida, radiante. Tasca ove riporre gli esigui giorni da trascorrere che in essa producono vapore. Coltello, poeta, rishi: il pensabile in spire raccolto ai margini della foresta. Amica del filosofo e sua mercuriale messaggera, araldo nella battaglia sullo Kurukshetra. Bhagavadgita, Anugita, mandala perpetuati da fiumi. Nascite e morti a milioni, per nulla. Tristezza.
Financo la torre contratta a penna, ormai affatto indifferente alle vicende semantiche, reputa importante prosternarsi ai suoi piedi. La contentezza da questi sprigionata fiorisce nella libertà, mentre i passi errano e danzano tra scacchiere ingannevoli, riflettendosi negli occhioni bovini, nel muschio abbarbicato alle pietre, nella carcassa abbandonata ai necrofagi.
La parola è respiro da centellinare il mattino, è dono elargito con maturata innocenza, è profumo accetto agli dèi discesi nei mantra, è mysterium, filo aureo, ponte nella coincidenza tra catabasi e anabasi, rovina e risurrezione, rintocco che pervade il trimundio, è giumella in cui si porge la postrema offerta ridotta a briciola abbagliante in pasto a una formica.
* Gv I, 18
II
La parola insorge se le si ordina di esaurire la realtà. Divora le falangi ai pennaioli, oggi impegnati con tastiere, e le risputa alle ortiche. La parola è scepsi inesauribile o, tutt’al più, inno all’Ineffabile, proemio al silenzio. Scevra da albagia, percorre tratturi tra i poggi e pregia soste con i rari ortolani sopravvissuti. Sa distinguere il fungo edule da quello esiziale, perciò nutre e protegge. Non teme l’inzaccherarsi nei pantani, purché la farfalla proceda prima che deperisca il calore.
Anche i tetti di certe cappelle cimiteriali sporgenti dai muri perimetrali sono per lei palazzi principeschi o architetture diafane in cui i viatori possano resipiscere, cioè comprendere la natura degli alberi, la meraviglia aleggiante nelle campagne.
Dopo la parola litanica sopraggiunge la quiete, avvolta in dense nebbie percorse da note di pianoforte. I suoni a volte sembrano palloncini colorati, a volte foglie rotanti sulle quali la voce innamorata modula dolenti ebbrezze. Già, poiché l’amato non si lascia mai toccare, forse solo lambire nell’intimo, quasi le ore e gli anni avessero scarso valore.
Tuttavia c’è, in esergo, appagamento: l’intelletto non scorge iniziare o terminare alcunché. Ci si può dunque fermare, estranei ad ogni divenire, indifferenti ai machiavellismi dei saccenti che asseriscono di appetire cose concrete.
È una sostanza inesprimibile quella a cui ci si apre; così la parola, da antichi ceppi liberata, può sorreggere. Il profumo sussiste, il colore celeste riverbera eco persistenti, il grigio culla il bambino, lo stridere dei corvi sale e scende sopra i campi arati. La parola intona stanze a cascata, abbracciando l’attuale e l’inattuale, sbeffeggiando le mode imponenti etichette, appartenenze, maschere. Come se fuori da simili ambizioni vi fosse il niente.
Illecito è pretendere d’essere creduti quando tracciamo confini inesistenti intorno alla parola. Inopportuno pascere ritorni chimerici al passato o sporgersi avventatamente verso il futuro. Basta restare nell’impronta presente, consentendone l’eccesso e la sobrietà, la laconicità. Il che implica abbandonare il frastuono interno.
III
Sta due dita dietro la lingua, la parola. Non si lamenta. Registra declivi profanati da sporcizia, la miseria salita in cattedra, l’idiozia sclerotizzata a dogma, il plagio pervasivo da pochi rifiutato, eppure tace, o emette ultrasuoni sufficienti a tenere in vita la bellezza, senza che sia propizio domandare dove abiti. Gli astri balzano agili oltre il sole. E in tale átopon è proscritto l’accesso a chi abbia smarrito la chiave di passo. È indispensabile recuperare sensibilità, aspirazione, empatia se si gradisce che i cerchi sull’acqua tornino a farsi intelligibili e lo stagno, le rane, le tife, i ponti dissolti nella luce meridiana si rivelino mai scomparsi. Nello specchio persino il re ci sorride; l’azzurro da cui è circonfuso, la porpora, l’argento, il verde ci porgono pazientemente la sapienza capace di saldare attimi, eternità, sfumature. A cagione di quale ottenebrazione avevamo potuto dimenticare i viottoli nelle foreste, le fragole presso la roccia solitaria, l’improvvisa apparizione di Pan, i flauti sulle labbra delle trote? Capitolare al servaggio è proprio un resistere al mare. Quanto travaglio per censurare quel che si è o si potrebbe risvegliare, sostituendovi l’adesione robotica a sogni altrui! Ben altro spirito assiste Offerus quando traghetta il peso del cosmo-bambino, meritandosi il nome Cristoforo.
L’atto coscienziale si impone per necessità: recide lacci, fende veli, scaglia nell’aere frammenti sepolcrali, sdrucisce arti aggrappati a croci stanche, appese in cubi titanici, infernali. E l’oro riemerge, carico di gioia. La parola ne è garante. Addietro si nascondeva tra detriti cementizi, soffocata da liquidi amniotici, ora canta di nuovo, dilata il minuscolo, si sofferma sopra i labirinti calcinati in compagnia del padre Dedalo. Ma non precipita per esuberanza. Ha imparato dal gheppio. Conosce l’integrità, la differenza nell’identità. Sa la plenitudine nel vuoto, la soddisfazione nel deserto, lo strillo aquilino, il gemito nella corda strappata sotto la luna.
La pagina gira. Qualsiasi cosa appaia non ha importanza. Non v’è aritmia: la parola ne estrae il succo stupefacente.
Giuseppe Gorlani è nato a Longhena (Bs) nel 1946. Dai venti ai trent'anni ha viaggiato a lungo in Oriente e nel Sud dell’Italia, soggiornando in Afghanistan, Nepal e alcuni anni in India.
È poeta, grafico, saggista e musicofilo.
Suoi interventi sono apparsi in varie riviste letterarie e di studi tradizionali, tra le quali: Convivium, Paramita, Poiesis, I Quaderni di Avalon, Viàtor, Conoscenza, Atrium, Letteratura-Tradizione, Spiritualità e Letteratura, Quaderni dell’Associazione Eco-Filosofica Trevigiana, Vidya.
Suoi articoli e saggi compaiono in siti online quali: Centro Studi Opifice, La nube e la rupe, Est Ovest, Rassegna Stampa di Arianna, Per una Nuova Oggettività, Corriere Metapolitico, Centro Studi La Runa, Centro Paradesha, Vidya Bharata, Fondazione Julius Evola, Politicainrete, PoliticaMente, ecc.
Presso Il Cerchio Iniziative Editoriali ha pubblicato tre raccolte di poesie e disegni (Radici e Sorgenti, 1989; La Porta del Sole, 1990, Premio Letterario “Città di Roma” 1991; Nel Giardino del Cuore, 1994, con Prefazione di Emilio Servadio), una traduzione dall’inglese dell’opera Nan Yar di Sri Ramana Maharshi col titolo Chi Sono Io? (1995) e la raccolta di saggi Il Segno del Cigno - Sulle Tracce dell’Ineffabile (1999), con Prefazione di Adolfo Morganti. Le sillogi La Porta del Sole e Nel Giardino del Cuore sono illustrate, oltre che da se stesso, da Carla Ricotti, Maura Boldi e Domenico Franchi.
Un suo saggio, Hippie: sadhu d’Occidente, compare nel volume antologico L’immaginazione al podere – Che cosa resta delle eresie psichedeliche, a c. di A. Castronuovo e W. Catalano, Stampa Alternativa, Vt 2005.
Con La Finestra Editrice (Lavis-TN) ha pubblicato: Anatema (2000), una raccolta di prose poetiche; Uomo e Natura (2006), una raccolta di saggi, con una testimonianza di Guido Ceronetti; Visioni del Soma (2010), una raccolta di prose poetiche e disegni; Il Filo Aureo (2012), una raccolta di saggi con Prefazione di Giovanni Sessa.
Su incarico di Guido Ceronetti ha illustrato la vita del Buddha in due tavole comparse su La Stampa nella rubrica La Valigia del Cantastorie (2002).
Tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta ha collaborato con varie radio libere di Brescia e dal 1991 al 1992 ha curato la trasmissione Il Terzo Orecchio per Radio Popolare di Brescia.
Marco Saya, da “Chiacchiericcio”, Marco Saya Edizioni 2012, nota di Davide Campi
Nelle poesie di Marco Saya il ritmo è sostanziale, quasi concreto; la sintassi è misurata ed essenziale.
Poiché nessun inciampo sonoro o difficoltà grammaticale deve intromettersi nello scorrere il testo; la lettura deve scorrere liscia dai primi versi ove la scena viene presentata alla maniera più alta possibile, all’ultimo verso che ne segnala la rovinosa e imprevedibile caduta verso un concreto suolo.
Quindi una modalità di espressione non facile da produrre e riprodurre con coerenza e senza cadute; e nemmeno tanto semplice e popolare da fruire.
Poesie prevalentemente brevi, spesso in forma aforistica, in una felice combinazione tra ironia e sarcasmo, in cui, inizialmente, un linguaggio di grande spessore traduce gli inciampi e i marginali fardelli del vivere quotidiano donando loro tutte le prerogative di un’epica. Salvo poi, nei versi finali, sgonfiare rapidamente il testo e restituire alla scena le sue tristi e abituali qualità.
Esemplare da questo punto di vista il testo intitolato “possibilità”, che inizia da “c’era una verità tramandata/da previi accordi…” e finisce con “…:se cambiare/o meno quella guarnizione”.
Da “Chiacchiericcio”
alfabeto
di tutto fu scritto
e l’alfabeto del mondo
era sempre più povero.
si ricercavano nuove lettere
anche se la precarietà
della parola
lottava per un discorso
a tempo indeterminato.
tempo
il tempo ammonticchia i tempi
pari, dispari, come i giorni
in un’unica partitura
dove accadi tra una misura
e la successiva sorseggiando
un caffé nelle pause
e la melodia della sera
simula quell’ad libitum
che in-tona o s-tona il fischio d’inizio.
there must be some kind of way out of here
Hey Bob, Hey Jimi,
ci deve essere un modo
per uscire da questo posto,
lo chiedo a voi,
lo chiedo a tutti,
lo chiedo al mondo dei posti,
alla natura che non li abita,
alla Highway 61 che tramonta
alla foce del Mississippi,
a King e alla sua Lucy,
al Re Lucertola che ogni cosa poteva fare*,
a qualunque uomo
che rompa il sentiero stabilito
per seguire il sentiero destinato**,
a una macchina veloce,
a un orizzonte lontano
e a una donna da amare alla fine della strada***
there must be some kind of way out of here
ci deve essere un modo
per uscire da questo posto,
lo chiedo a voi,
lo chiedo a tutti,
lo chiedo al mondo dei posti.
* Jim Morrison
** Gregory Corso
*** Jack Kerouac
Marco Saya è nato a Buenos Aires il 3 aprile 1953. Dal 63 risiede a Milano. Musicista jazz, scrittore ed editore. Diverse pubblicazioni, ultime la raccolta poetica dal titolo Filosofia Spicciola (2014) e Chiacchiericcio (2012) edite da Marco Saya Edizioni, Murales edita dall’Arca Felice (2010) e Situazione Temporanea edita da Puntoacapo Editrice (2009). È presente poi in diverse antologie tra cui segnaliamo: L’albero degli aforismi (2004), Il segreto delle fragole (2005) e L’antologia delle stagioni (2006) edite da Lietocolle; Swing in versi (2004) edita da Lampi di Stampa e Vicino alle nubi sulla montagna crollata (2007) edita da Campanotto. Ha condotto una rubrica musicale sul sito della Rizzoli Speaker’s Corner. È presente su tutti i più importanti siti di scrittura, rubriche e riviste letterarie. Raccoglie, poi, importanti risultati nei vari concorsi proposti, segnalato in diverse edizioni del premio “Lorenzo Montano” curato da Anterem, vincitore con la raccolta Situazione Temporanea della XXIV edizione del premio Nuove Lettere a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Napoli (2010) e della X edizione del Premio Carver (2010), infine premiato al Concorso Laurentum 2011 per la poesia online, I° premio della critica, e menzione speciale della giuria per la raccolta edita Murales (L’Arca Felice) finalista tra le prime cinque. Infine giunto nella terna finalista con la raccolta Chiacchiericcio sempre al Concorso Laurentum 2013 e premiato al premio Farina con la raccolta Filosofia Spicciola (2014).
Alberto Mori, da “Davanti alla mancante”, Scrittura Creativa Edizioni 2014, nota di Rosa Pierno
Nati da un dialogo con le immagini fotografiche di Francesca Woodman, i testi poetici che Alberto Mori costruisce, in Davanti alla mancante, sono inevitabilmente tarlati dall’assenza, sia a causa della prematura scomparsa della fotografa, sia perché il suo corpo è presente nelle sue immagini in perenne dissolvenza. Ora, far parlare qualcosa che non è a fuoco, che arretra rispetto a qualcosa in primo piano - e che è nitidamente in primo piano - è già lavorare con un imprendibile al quadrato: è lavorare con la rappresentazione di una rappresentazione. Per dire di questa mancanza di messa a fuoco anche il linguaggio si fa approssimativo, non accorda aggettivi a sostantivi: “Un filo di proiezione fra le dita / I capelli sono scomparsa / Le gambe non vedono /nella dissoluzione seduta”. Di pari passo va la registrazione della difficoltà di distinguere il corpo dal fondo e di rendere conto della sua apparenza fantasmatica. Lo sguardo s’affossa, stancandosi per meglio afferrare, mentre il pensiero si meraviglia per uno spazio che prende ad avere sostanza corporale: “Nella fuggenza stupisce / il vestito a maculi dello spazio accoscia”. Nello sfocamento c’è uno scambio di materie, metafora dello slittamento tra i diversi mezzi e codici artistici messi a confliggere sulla pagina, ma anche la cucitura che Mori tenta degli oggetti in primo piano, i quali sfrontatamente esibiscono la loro cifra contro un corpo che s’allontana fino alla totale perdita di dettaglio sullo sfondo. Il disperato tentativo di dialogo instaurato dall’autoritratto, “l’appello silenzioso”, viene raccolto dal poeta insieme a una serie di parole adagiate intorno al corpo testuale: specchio, riflesso, acqua, davanzale, volto, palpebra, sogno, quasi una strumentazione atta ad afferrare tutto quello che è possibile in una visione. Solo la dissolvenza, l’apparenza, l’incanto restano impigliati in tale tracciatura: “Accanto alle foto / Postuma / Spettro composto del ricordo / Limbo nero profumato”. Ed è, difatti, proprio il passaggio dalla carne a un’identità disincarnata ciò che il fruitore percepisce nelle fotografie e legge nei testi, in una riuscita equivalenza.
***
Chissà dove sarai
lieta e svanita
ad autoritrarti
dissolta fra le nuvole
Passeggera incisa dalla carne nuda nei fiati scomparenti
***
“Non puoi vedermi da dove mi guardo”
Senza focus anche l’accanto
Contatto delle spalle sfumate
La caviglia
Piega del moto concentrato
***
Sdraiata e rialzata
Morte
Immagine rovesciata
Calla e battigia
Simmetria del volto
nell’occhio sospeso dal sogno marino
“Eppure ti vestirò polvere”
Alberto Mori, poeta performer e artista, sperimenta una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando di volta in volta altre forme d’arte e di comunicazione: dalla poesia sonora e visiva, alla performance, dall’installazione al video ed alla fotografia. La produzione video e performativa è consultabile on line sulla pagina YouTube e Vimeo dell’autore e nell’archivio multimediale dell’ Associazione Careof / Organization for Contemporary Art di Milano.Collabora inoltre,con molti fra i più noti poeti contemporanei, italiani e stranieri, per la realizzazione di letture pubbliche, manifestazioni ed eventi dedicati alla poesia.Negli ultimi anni più volte finalista del premio di poesia “ L.Montano” della rivista Anterem di Verona. Dal 1986 ha all’attivo numerose pubblicazioni, tra le quali ricordiamo Iperpoesie (1997), Cellule (2001), Raccordanze (2004), Utópos (2005), Bar (2006), Raccolta (2008), Fashion (2009), Objects (2010), Financial (2011), Performate (2011) Piano (2012), Meteo tempi (2014).
Chiara De Luca, dalla raccolta inedita “La nudità della luce”, nota di Laura Caccia
La vibrazione dell’esistere
In tutta “La nudità della luce” che Chiara De Luca dispiega nel suo spartito colmo “di mondo e silenzio” risuona un continuo intreccio tra il corpo e gli elementi del reale, tra presenza e assenza, bellezza e spesamento, nell’inebriarsi, come scrive, “di sole di vento forte o d’opaco di luce / di canto d’inverno di pianto di freddo / d’eterno d’inferno di sogno e risveglio”.
Nelle immagini che i versi sfiorano a volte come un tocco di luce leggera, a volte con una dolorosa messa a nudo, pare di scorgere l’Ophelia shakespeariana dipinta da J. E. Millais, a partire dalla figura iniziale, che l’autrice presenta come il salice-donna “che piange / la fine delle storie” riflessa nell’acqua e i cui “capelli le si schiudono a raggiera, / sparsi vibrano del brivido dell’onda”.
La vibrazione caratterizza quest’immersione totale nella vita, dove gli elementi corporei e naturali si dissolvono gli uni negli altri, tra il buio della perdita e la luce della bellezza, come fa risuonare Chiara De Luca, da un lato “su spariti senza voce // leggendone le note per vibrarne”, dall’altro “nel canto che ha l’unisono del sangue”, tra il dolore causato dall’assenza e l’affermarsi forte della pienezza vitale, riuscendo, nel suo ampio respiro a tenere insieme gli opposti, a, come ci conferma l’autrice, dire “di quest’aspra fame di silenzio” e insieme dire “dell’esistere semplicemente”.
***
Elegante si china come un giunco,
nebbia la sfiora di una veste da sposa,
i capelli le si schiudono a raggiera,
sparsi vibrano del brivido dell’onda
si giungono e ancora la corrente li separa:
si specchia capovolta finché non la spaventa
un colpo di vento che di colpo la disperde
sulla superficie come una malerba.
Ë una donna il salice che piange
la fine delle storie, stanca del giorno
implora la notte ebbra d'autunno
di baciarle via la luce dal volto.
Testamento
Mentre aprile nasce io vi lascio
le spoglie di quel che fu soltanto
frammento dei chi che avrei potuto
si deve qui colmare tutto il tempo
fino all’orlo più alto e traboccarlo;
perché non tornano gli anni rubati
da quella che per me li ha vissuti.
Vi lascio le sue mani di cartapesta
fruscianti a ogni stretta concessa
vi lascio la sua pelle di trine sottile
fremente al minimo tocco gentile
il suo silenzioso scusarsi per tutti
gli assolti delitti commessi da altri.
la stoffa dei suoi miti giorni perduti
da pagliaccio docilmente indossati
per stracciarli al circo delle stagioni
ma non prima di lasciarvi in rima
il mare di quei disossati perdoni
delle dolci e scarnite assoluzioni
degli arresi e atterriti abbandoni
il breve cenno nel voltarsi di una mano
riportando in poesia le ali di un gabbiano.
Chiara De Luca, laureata in Lingue e Letterature straniere a Pisa, ha frequentato la Scuola europea di traduzione letteraria di Magda Olivetti a Firenze e il master in traduzione letteraria per l’editoria dell’Università di Bologna, dove ha conseguito un dottorato in Letterature europee. Scrive poesia, narrativa e critica, traduce da inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Ha pubblicato con Perdisa la pièce teatrale Duetti, con Fara i romanzi La Collezionista (2005) e La mina (stra)vagante (2006), i poemetti La notte salva (2008) e Il soffio del silenzio (2009) e la silloge Il mondo capovolto (2012), con Kolibris la raccolta poetica La corolla del ricordo (Kolibris 2009, 2010), edita anche in versione bilingue con traduzione in inglese di Eileen Sullivan (The Corolla of Memory, 2010) e l’antologia Animali prima del diluvio. Poesie 2006-2010 e ha in preparazione l’antologia bilingue di testi scelti The Sum of Each Return / La somma di ogni ritorno, con traduzione inglese di Gray Sutherland. Ha pubblicato testi poetici in varie riviste e antologie in Italia e all’estero. Ha curato l’antologia di giovane poesia italiana contemporanea Nella borsa del viandante (Fara, 2009), ha pubblicato la raccolta di saggi, articoli e scritti critici A margine dei versi. Appunti sulla poesia contemporanea (Kolibris, 2015) e traduzioni di oltre cinquanta raccolte poetiche di autori stranieri contemporanei. Sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, tedesco e spagnolo e rumeno.
Nel 2008 ha creato Edizioni Kolibris, casa editrice indipendente consacrata alla traduzione e diffusione della poesia straniera contemporanea (http://edizionikolibris.net). Cura il blog “A margine dei versi”, dedicato alla critica del testo poetico, il progetto europeo “Safe Souls” per la traduzione e pubblicazione di dieci grandi voci della poesia contemporanea (http://safesouls.net) e il sito internazionale Iris di Kolibris, dedicato alla traduzione poetica, al bilinguismo e alla letteratura della migrazione, cui collaborano numerosi poeti, traduttori ed editori di diverse nazionalità (http://irisdikolibris.net). Collabora con il mensile internazionale di cultura poetica “Poesia” (Crocetti Editore), con la rubrica online “Officina Poesia” della rivista “Nuovi Argomenti” e con “Poesia” di Rai News. Per il sito del festival Parco Poesia cura una rubrica dedicata alla giovane poesia internazionale e per la rivista peruviana “Vallejo & Co” una rubrica dedicata alla poesia italiana contemporanea in traduzione spagnola. Con il poeta e traduttore canadese Gray Sutherland si occupa della rubrica “Gray Ink”, dedicata alla traduzione in inglese della poesia italiana contemporanea. Per Samuele Editore è in uscita la sua raccolta poesica Alfabeto dell’invisibile. Il suo sito personale è: http://chiaradeluca.net
Lia Cucconi, poesia inedita “Dell’ Essere”, nota di Ranieri Teti
La nostra condizione terrena ci porta a convivere con un forte senso di vuoto.
Molti provano a colmare questo vuoto in vari modi: con la religione, con la psicanalisi, con la tecnologia e tutti i suoi derivati.
Alcuni, come Lia Cucconi, tentano l’avventura di confrontarsi con esso poeticamente, attraverso un ragionamento in versi sull’Essere.
Ne nasce una discesa nell’interiorità: “una voce d’altro alfabeto mi guida all’ascolto: è l’incompreso inconosciuto altro”, scrive Cucconi che possiamo immaginare in un mare in tempesta battersi come il remo nel suo gorgo. Oppure su una tortuosa strada ricca di sviamenti come può essere l’inconscio, dove l’autrice ambienta e raduna spezzoni di vita, con il senso demandato alla parola dell’”altro”.
Ne nasce una salita nel pensiero: “dove “io sono” siamo la stessa cosa”.
L’altezza raggiunta ci conduce verso la nostra notte oscura. In un laico confondersi del fine della poesia con la fine della nostra vita.
***
Un filo si trascina la mia essenza
nel grembo interno ai segni luminosi
al suono ora inteso ora incerto a cose
che hanno la voce dell’universo.
Nel fragile nucleo di coscienza
passano e si stendono le parole
oltre le ombre del pensiero, vedo
e sento che è l’immenso d’ignoto
battersi come il remo nel suo gorgo
al vento dell’incontro dentro al tempo.
Come un soffuso richiamo su me
passa una traccia di suoni, una voce
d’altro alfabeto mi guida all’ascolto:
è l’incompreso inconosciuto “altro”:
lui m’interagisce al mistero umano
e come tessuti andiamo nel labile
confine posto in nostra carne e c’è
conoscenza d’essere ciò che siamo
come l’alloro, il vento, il fiore, il ramo
e la rondine che si posa, l’ombra
d’ogni richiamo, l’inconscio numero
dei sogni che ci fanno in noi natura
dove “io sono” siamo la stessa cosa
generati dall’imprevedibile
genitrice gelosa di sua impronta.
Lia Cucconi ha pubblicato tredici libri di cui cinque in italiano e otto in dialetto di Carpi. Con i volumi dialettali è sempre stata finalista al Premio Pascoli. Tra gli ultimi editi in italiano ricordiamo “Intrusiva” (2000) e “L’imposta” (2010). È presente in riviste e antologie.
Si sono occupati, tra gli altri, della sua poesia Giorgio Luzzi, Sandro Montalto, Giorgio Barberi Squarotti, Stefano Verdino, Manuel Cohen.
Vive a Torino.
Ultima pagina: Galleria fotografica/2 del Forum 2015, immagini di Maria Grazia Veroni
Marzo 2016, anno XIII, numero 30

La conclusione dell’ultimo Forum Anterem è stata affidata al concerto di Motocontrario Ensemble, eseguito con musiche ispirate alla poetica di Emilio Villa (1914-2003). L’evento ha potuto contare sulla presenza di Bianca Battilocchi a introdurre l’opera villiana. Grazie alla stessa studiosa, oggi possiamo leggere quattro poesie inedite di Emilio Villa, appartenenti al ciclo dei “Tarocchi”, scritte negli anni ’80.
Ancora una volta, in questo nuovo numero di “Carte nel vento”, la redazione di “Anterem” al completo è attiva nel presentare i testi di alcuni tra gli autori segnalati, finalisti e vincitori della 29^ edizione del Premio Lorenzo Montano, esattamente come avviene dal vivo nelle giornate del Forum. La 30^ edizione è ancora in corso, la storia continua... scarica il bando della 30a edizione
Inediti: "I miei Tarocchi in generale" di Emilio Villa, tradotti e presentati da Bianca Battilocchi
I Tarocchi di Emilio Villa. Giocare e sfidare l’Enigma
Il testo che qui riportiamo con l’ausilio di una nostra traduzione fa parte di un gruppo cospicuo di inediti villiani dedicati al tema dei Tarocchi. Questi sono databili agli anni Ottanta ma si consideri che l’interesse per gli arcani si mostra in Villa già molti decenni prima, grazie al contatto soprattutto con pittori come Corrado Cagli e Sebastian Matta. La nostra scelta di presentare questo testo in particolare si lega alla sua natura più didascalica di fronte al progetto stesso che non arrivò mai a una pubblicazione e di cui si conservano il taccuino illustrativo e le poesie in fase di bozza. Si nota fin da subito la preferenza per la lingua francese che dagli anni Cinquanta offre al poeta maggiori possibilità di artifici e giochi linguistici e accanto a questa si mostra qui l’italiano, il latino e, nel resto dell’opera, piccoli frammenti di greco, tedesco, inglese e sumero. La nostra traduzione che appiattisce la plurivocità linguistica dell’originale è quasi del tutto letterale poiché in queste carte di natura più introduttiva non si mostra, se non a tratti, la furia demiurgica che più si confà alla vena matura dell’autore. Nondimeno riconosciamo elementi tipicamente villiani nell’importanza grafica e sonora dell’enunciato che viene spezzato in paragrafi di diverse allineamenti, blocchi associativi, e che rivela un numero fitto di varie altre figure retoriche tra cui le amate omofonie (“revelation” / “rêve élation”). Riguardo i contenuti, Villa ci introduce qui a un ‘sistema di figure, immagini, parole e segni’ come occasione di incontro-scontro (“se retrouver/ se battre”) per il lettore-giocatore (e per il poeta stesso) il quale viene descritto anche come tentatore e istigatore (“inductus”), in quanto violatore dell’enigma. Riteniamo che questo misterioso e periglioso rendez vous equivalga a un percorso di tipo iniziatico come quello nel mondo classico attraverso le trame angosciose del labirinto. Oltre a molteplici tracce di questo archetipo negli arcani di Villa (1), che proprio negli anni Ottanta affrontò diffusamente la tematica in altri testi, sottolineiamo segnatamente l’annotazione “Quante e quali sono le carte con cui si ESCE dall’impasse, dal labirinto?" (2). L’autore sembra voler unire la valenza tragica del mito - per cui ogni carta diventa un oggetto spietato - a quella ludica più vicina al mondo moderno, palesata ad esempio nelle giocose scomposizioni e associazioni verbali oltre che nella “magia” del gioco stesso dei Tarocchi; che fa da cornice e che rende possibile la creazione di una dimensione altra, connessa con l’Enigma e dettata da Villa-medium-sibilla. In linea con il viaggio labirintico dell’antichità, Villa scrive che l’‘avventura’ nei suoi tarocchi porterà a una ‘metamorfosi’, a un “incrinamento [...] della propria esistenza" (3) rappresenta chiaramente il fine apotropaico (in senso per lui neognostico, di aiuto all’uomo e alle sue miserie mondane) negli ultimi versi del testo: “Incontro […] è legare per slegare, slogarsi per logarsi”. Eccoci di fronte a nuovi frammenti di una scrittura poetica unica, che seppur sfiorando il Nulla nella sua cripticità e glossolalia, riesce a farsi evocativa voce sibillina e arte come riproposizione instancabile dell’Enigma relativo al linguaggio e al Futuro(-Eternità).
I MIEI TAROCCHI IN GENERALE
ciascun esito di una figura
o immagine
o parola
o segno
o sistema di
figure/immagini/parole/segni
è un
incontro (casuale)
[come reincontrarsi
ritrovarsi
battersi]
è un appuntamento
segretamente prodotto-ridotto-indotto
[ductus, indutus, inductus reductus]
attraverso l’ap pa ri zione o presenza
o rivelazione
o rêve elazione
o epifania
o presenza
o astanza
del vivente tentatore
ovvero del giocatore
che tocca la (le)
carta (e)
***
l’
appuntamento
spontaneamente si offre
soffre
soffia
l’appuntamento
avviene
è
in una regione
immutabile e trepidante
nasce si sviluppa e si conclude
attraverso un esercizio cieco
e l’impatto tra
segnalazione e tentatore
produce una
metafora - metamorfosi
sono da cogliere nelle sensazioni
attraverso altri bagliori e altri
intervalli
metamitosi
fiduciosa
o in pendenza
***
a ogni incontro
bisogna pentirsi
di essere piombato
di essere magneticamente inghiottita
dall’avventura
dall’avvenire
e dunque bisogna:
determinarsi in
troposfera
dell’essere trombata
ogni incontro o urto
sarà un attentato
o aggressione
nel futuro
sarà un
incrinamento o incrinazione
o incriminazione
della propria esistenza
che si contagia di futuro
sarà un contagio reciproco
il futuro è solo una malattia
dell’enigma
***
ogni incontro con un segnale
è un mutamento nella direzione
dell’enigma
l’incontro è
legare x slegare
e insieme
slogarsi x logarsi
incontro è
violazione
dell’enigma
ciascuna carta
è un oggetto
senza pietà
traduzione di Bianca Battilocchi
© di Francesco e Stefania Villa
chaque issue d’une figure
ou image
ou mot
ou signe
ou système de
est un
rencontre (casuel)
[comme se rencontrer
se retrouver
se battre]
est un rendez-vous
secrètement produit – reduit – induit
[ductus, indutus, inductus reductus]
par l’ap pa ri tion où présence
où revelation
où rêve élation
où epiphanie
où présence
où adstance
du vivant tentateur
c.a.d du joueur
qui touche la (les)
carte (s)
***
le
rendez-vous
spontanément s’offre
spontanément souffre
spontanément souffle
le rendez-vous
vient
est
sans un région
immutable et trépidante
naît vient et s’achève
par un exercice aveugle
et l’impact entre
signalation et tentateur
produit une
métaphore – métamorphose
dans les sensations sont à saisir
par d’autres éclats et d’autres
écarts
métamythose
confiante
ou en pente
***
à chaque rencontre
faut se repentir
d’être tombé
d’être magnétiquement engloutie
par l’aventure
par l’avenir
et donc il faut :
se determiner en
troposphère
de l’être trombée
chaque rencontre ou heurte
sera un attentat
ou aggression
entre le futur
sera un
incrinamento o incrinazione
o incriminazione
della propria esistenza
che si contagia di futuro
sarà un contagio reciproco
il futuro è solo una malattia
dell’enigma
***
ogni incontro con un segnale
è un mutamento nella direzione
dell’enigma
l’incontro è
legare x slegare
e insieme
slogarsi x logarsi
incontro è
violazione
dell’enigma
chaque carte
est un objet
sans pitié
(1) Si veda ad esempio in E.Villa, I miei Tarocchi, materiale inedito, Archivio Villa, Museo della Carale, Ivrea: “Universo snodato”, “aggomitolati” (nb.4), “trasmissione vorticosa” (nb.9), “roteazioni”, “spirali” (nb.11), ecc.,. Sul tema del labirinto si legga Aldo Tagliaferri, Dentro e oltre i labirinti di Emilio Villa, edizioni il verri, Milano, 2013.
(2) Cfr. E. Villa, I miei Tarocchi, 9a.b.
(3) Cfr. E.Villa, I miei Tarocchi, cit., 73a.
Bianca Battilocchi si è laureata all’Università di Parma in Comunicazione letteraria moderna e contemporanea con un anno di studio presso Paris III Sorbonne Nouvelle. Nel 2013 si è diplomata in Magistrale con un’analisi completa delle Diaciassette variazioni di Emilio Villa e da quell'anno si occupa dell'opera del poeta. Oltre a presentazioni della ricerca e conferenze in Italia e Irlanda, ha pubblicato sull'autore in “Griselda online”, “Parole Rubate” e "JOLT" . Attualmente svolge un dottorato di ricerca al Department of Italian Studies del Trinity College di Dublino, concentrandosi sui Tarocchi inediti di Villa. Si interessa di poesia e arte contemporanea, italiana e internazionale, in particolare di avanguardie e sperimentalismi.
Rita R. Florit, dalla raccolta inedita "Nyctalopia", nota di Giorgio Bonacini
Un poesia intitolata in modo diretto con un termine in cui convivono, senza contrasto, due significati che dovrebbero opporsi – vedere nell’oscurità e il suo contrario, questo significa nyctalopia – indica immediatamente una direzione di lettura verso l’esterna formazione di un mondo e, allo stesso tempo, un’idea di scrittura verso l’interiorità del dire poetico. Un fuori e un dentro che nascono e svolgono il loro cammino rivolgendo lo sguardo con reciprocità continua: lì dove il doppio motivo della luce e del buio ingloba e determina la voce e il mutismo, la vista e la cecità. L’autrice, consapevole che il fare poetico assume su di sé, e in sé produce, un dire che non è disvelamento o nascondimento, ma indicazione di uno sguardo mobile, mostra nei suoi testi un pensiero che è ai fondamenti di un reale visionario, che segna la figura profonda di ciò che sente come un vedere. E il punto di congiunzione tra il chiaro e l’oscuro è una zona che ha certamente limiti immaginativi, ma dai bordi indeterminati. Ed è proprio su quella soglia che chi guarda non si fa “sviare dall’ombra”, ma ne perlustra la trasparenza offuscata e la dimensione ondulante: quasi un luogo di deformazioni conoscitive dove le potenzialità del senso risuonando tendono a zittire e viceversa.
Nessuna preoccupazione di evidenza o chiarezza ingenue nel pensiero poetico di Rita Florit, bensì tanta occupazione di lucidità e precisione, pur tumultuosi ma in parola essenziale nel labirinto delle emozioni. Una ricerca sostanziale, stringata ma indirizzata a una multiformità sensoriale che riverbera dal fondo e sgorga nel sentimento di una voce che “è tutte le voci”. E non può essere che così: quando la necessità preme, stringendo i sintagmi e il loro sentire selettivo, la poesia lascia intravedere, e anche prefigurare, un’alternativa all’andamento ordinario delle cose: una ex-temporaneità (per usare un termine dell’autrice) che, in un’apparente contraddizione, continuamente e ricorsivamente fluisce e si consolida. E sono le cose a trasformarsi, sia nella loro apparenza sia nel loro essere, grazie a una percezione che scombina i sensi, espande vuoto e attrito e costringe la notte a rompere la sua ossessione per inalberare i bagliori della cecità che “illumina la tenebra”.
E se a questo aggiungiamo una forma di sgretolamento del corpo che, attraverso una ritmica fisica di sonorità, vibrazioni, fremiti, tremori, che ne scandagliano e ne spezzettano le parti con precisione nominale, producendo spasmi linguistici di elevata tensione, comprendiamo bene come, per l’autrice, quello che può sembrare uno squartamento porta invece a un espansione del non-silenzio (ciò che sta tra la mancanza del suono e il suo cominciamento), anche con il rischio della frantumazione e della dissipazione. Perché è così che la parola abbagliante della poesia, nella fioca luce del mondo, rende il poeta nictalope quasi veggente (precisa in una nota Rita Florit, con evidente richiamo a Rimbaud), in modo tale da far sì che la cecità esterna del momento notturno divenga essenziale per la visione ultravedente, per poter raccogliere e accogliere una nuova conoscenza del reale.
La notte invocata quasi in preghiera è mater riparatrice: presenza di luogo e tempo che riparando protegge, riparando custodisce e riparando aggiusta e ricompone. L’oscurità, allora, non è più irraggiungibile, non è più notte-mancanza,vuoto, nulla, assenza, ma inquietudine e alterazione in sonno e veglia: dove irradiano e si riversano concretezza e trasparenza, deragliamenti e scavi, bruciori e fluorescenze, in sinestesie di musiche di porpora, visceralmente guardate. Il tutto incluso in un sentire poetico proprio dell’immensa notte che qui attraversiamo e che ciecamente intravede e versa vertigine vivifica e vortica.
Dalla sezione “imus”
***
Tu misuri la solitudine ti schernisci devii dagli
specchi l’afflizione azzera i saperi non ti fai
sviare dall’ombra, la perlustri, la porti addosso,
ricevi il suo peso, la consistenza e
l’inafferrabilità. Le bilanci. Poi prudentemente
avanzi da questa distanza inanimata ti sporgi.
***
Sotto parola vibrazione risonante chiama da
porose profondità. Mobile srotola pseudopodi,
copre distanze infinitesimali. Snida la tenebra.
Smuove, sfalda. Detriti. Affondo ai centri
innumerevoli dell’Essere, degli esseri che siamo.
Moltitudine nell’uno.
Dalla sezione “corpus”
***
Ustione interna, centrifuga dalle viscere alla
lingua uncina e stride in sabbia sete livida nel
dormiveglia. Ospitare un deserto dune articolari
in flusso, alzare la loro fiamma, ardere assenze,
allontanare lune. Sospenderne il ricordo. E
l’assetato sceglie il deserto da dove era venuto.
***
Privazione d’amore è deserto - tu vesti di sabbia
trasudi polveri vieni dal deserto. Una
città-silenzio rompe il cristallo notturno. La
reclusione più dura è una distanza, fortezza dalle
mura invalicabili - Die ganze Stadt - ossessione
reiterata percuote-ri-percuote stringe-co-stringe
asfissia, manca l’aria nella stanza. Fuori la notte
inalbera bagliori.
Dalla sezione “Memento”
***
E altre musiche oscure più del rogo sonoro del
corpo armato, più della fosfofluorica inermità di
genere, dell’inclusione della lingua madre, del
brillìo daìmon, più dell’animale attiguo che
rivesti, della bestia silenziosa che covi, più del
bosco di braci che vai a essere.
Nota dell’autrice
Nictalopia dal greco nýx nyktós notte, alaós cieco, ops vista, cecità notturna, mancata o imperfetta visione di notte ed anche buona acuità visiva nelle ore notturne; questa paradossale e affascinante duplicità di significati dal tempo ereditati ora nell’una ora nell’altra accezione, fa della cecità un chiaro vedere, un intravedere, lux in tenebris, fa del nictalope quasi un veggente.
Rita Regina Florit ha pubblicato 'Lezioni inevitabili' (Lietocolle, 2005) e 'Passo nel fuoco' (Edizioni d'if, 2010) che ha vinto il Premio Mazzacurati-Russo IV edizione. E’ presente in varie antologie tra cui Portfolio e Registro di poesia # 2, (Edizioni d’if)‘Paraboliche dell’ultimo giorno per Emilio Villa’ (Dot.comPress-Le Voci della luna, 2013). Ha co-tradotto l'antologia poetica Ghérasim Luca ‘La Fine del mondo' (Joker edizioni, 2012). Ha tradotto Benoît Gréan per l’annuario di poesia “Punto” (Puntoacapoeditrice, 2013). I suoi videopoemi compaiono in eventi e rassegne nazionali ed internazionali. Testi e traduzioni sono pubblicati in vari siti e lit-blog tra cui Anterem, Nazione Indiana,Rebstein, Il porto di Toledo, Poeziebao, Rhuthmos, Terresdesfemmes. Sul web cura il blog di letteratura e traduzione letteraria : sottopelle.wordpress.com
Stefano Della Tommasina, poesia inedita "Global", nota di Marco Furia
Una parola necessaria
Con “Global”, Stefano Della Tommasina presenta un’intensa composizione le cui vivide pronunce si susseguono secondo ritmi capaci di catturare l’attenzione e, nello stesso tempo, di lasciarla libera di proseguire.
“Se cogli al volo un dialogo di nervi l’occhio si riproduce”
dice il poeta sorprendendoci e inducendoci a riflettere.
A riflettere su un “dialogo”, ossia su un parlare, “di nervi” che, a prima vista, appare quasi enfatico nella sua propensione a meravigliare.
Ci si accorge presto, però, di non essere al cospetto di una semplice provocazione linguistica o, peggio, di un formalismo volto a stupire in maniera superficiale, bensì di essere di fronte a un’esigenza espressiva talmente intensa da non poter trovare sbocco che in certe parole.
Parole poetiche, appunto, generate da esigenze stilistiche interne a un discorso necessario la cui urgenza trova in una forma linguistica fitta ma equilibrata il suo vero e proprio modo d’essere.
Di questo, davvero si tratta: di un esserci non con le parole, ma nelle parole.
Il che non significa, ovviamente, trascurare un attento lavoro di composizione, bensì cercare e trovare il giusto tono utile a trasmettere un quid che si rende esplicito non per via di definizioni, bensì nel farsi di una sequenza espressiva.
Stefano si serve di parole di uso comune, ma il risultato al quale tende, lungi dal consistere in rigidi significati, è l’emergere di un senso che suggerisce e implica qualità e aspetti dell’esistenza vissuti in maniera davvero vivida.
Si legge, circa a metà della poesia
“Ora che le edicole si chiudono lungimiranti, i titoli di coda
minimizzano, rendono lo strabismo fatalmente estetico”.
Ecco, credo che proprio in uno “strabismo fatalmente estetico” consista l’attenzione estrema, a tratti forse perfino dolorosa, che si fa poesia in virtù di una volontà espressiva capace di diventare lingua superando, con coraggio, non pochi ostacoli.
Arduo è il lavoro del poeta.
Global
Le frontiere si dissolvono nell'afa
sono miracoli del primo pomeriggio
prima del dolore, dopo il parto
semplici regali della terra incolta,
razze incrociate nei sentieri
dove si perdono le bussole
e il seme troppo fondo si dimentica.
Non si discostano le labbra dalle gemme scure
di uno scomodo frutto. Sfidano l'aria incerta, il modo
che riporta a terra logore maturità, equilibri di colore
che rasentano il giallo e in un secondo tempo liberano
il viale, gli alberi, la neve artificiale di una realtà circense.
Se cogli al volo un dialogo di nervi l'occhio si riproduce,
i capillari rossi, come minuscole dionee, divorano
ogni fantasia possibile; le nari sembrano infette.
Ora che le edicole si chiudono lungimiranti, i titoli di coda
minimizzano, rendono lo strabismo fatalmente estetico.
Il nero dagli occhi bassi è l'unico a vedere abusi
trasversali, prove di segmenti, relazioni in vetro
e nel disgelo i figli fissano le asiatiche sui marciapiedi
tumulati, chini al davanzale come gambi decimati,
non possono implorare la moria delle uniformi bianche
per restituire un sosia al padre, quasi un capo indiano
che neppure si ricorda dove giace la sua America.
Stefano Della Tommasina è nato a Massa il 28 gennaio 1962. Nel 2015 vince il Concorso Opera Prima, iniziativa promossa dal 2012 da Poesia2punto0, con la silloge intitolata “Museo Bianco”.
Alcune sue poesie sono state pubblicate online nel sito http://www.poetastri.com/gennaio-stefano-della-tommasina.html nella rubrica "Per il verso giusto".
Con altri testi è presente in alcune antologie edite da Lietocolle: Il Segreto delle Fragole, Verba Agrestia e L'Amore al tempo della Collera.
Fabio Scotto, da “La Grecia è morta”, Passigli 2013, nota di Rosa Pierno
Se la figura retorica dell’enumerazione è presente fin dalle prime pagine de La Grecia è morta di Fabio Scotto, sarà proprio scartando da tale elenco che il senso defletterà per immettersi dal mondo reale al mondo interiore: ciò consentirà l’apertura di un passaggio fra una Grecia “vittima dei raggiri delle banche” a una Grecia “che dorme fra gli abissi della Caldera / la Grecia a sera / nell’incanto dei fiori rosa / nella brezza che agita il mare”. E in un istante eccoci precipitati nel mondo mitologico, nel sogno, ma, come in una tessitura che riprenda incessantemente il suo ritmo ossessivo, siamo anche nella Grecia dei Colonnelli e delle torture. La tela di Fabio Scotto è la tela degli inestricabili conflitti, ove a poco servirà il tentativo di separare il bene dal male. Grecia, “parola dell’origine” e “assedio della lingua”, Grecia “che uccido per morire in lei / e che uccidendo salvo”. Seppure, ben si veda come persino il rovesciamento delle figure necessiti della presenza, sull’altro piatto della bilancia, del peso del suo opposto. Solo non lasciandoselo alle spalle è raggiunta la totalità, la contemplazione di tutti gli aspetti, stretti nel florilegio del racconto lirico. Il racconto, dicevamo, poiché è sempre da un luogo, da una situazione concreta che Scotto si diparte con una descrizione piana, delicata, aderente (“La vasca è vuota / Qui dov’era il canale / il freddo scheggia il marmo”) per poi, come un provetto pescatore, venuto il pesce ad abboccare, chiudere con l’immagine che si è addensata sulla superficie della mente, frutto, simile a quelli prodotti dal sonno, oracolare. Poesia, in quanto tensione a visualizzare l’inesistente, a rendere concreto ciò che è solo ideato, ma in ogni caso agganciato allo spazio-tempo esistenziale. E anche quando il flusso percettivo si fa più intenso, come nei rapporti umani, è ancora al dato geografico/naturale che il poeta fa riferimento: “Giungono a spasmi come lava / corrodono i tegumenti del cuore”. La strettissima correlazione istituita per questa via da Fabio Scotto rende la realtà esterna il correlato di quella interna, e nessuno dei due aspetti potrà mai sussistere o essere preso in considerazione da solo. L’io lirico è il termine medio, il legante che salda, ove il dato concreto si fa metafora di quello interno: “in bilico sul baratro di me / reclino”, parendo che solo per questa via il cerchio si chiuda e la Grecia ritorni a essere una.
Dalla sezione “Angelus hiroshimae” (Haiku per un film)
1.
scendo alla caccia
senza saperti ancora
preda dell’alba
2.
ruota a ritroso
nell’agonia dei passi
il tempo esploso
3.
cielo ferito
tu non fossi caduto
viso nel fango
4.
musica mia
calda notte del cuore
se apri gli occhi
5.
già olio l’arma
mangia dalle mie mani
al mio richiamo
6.
nel sonno ancora
riprendere la marcia
luna ridesta
7.
più nessuno qui
la notte chiama al volo
ogni suo figlio
8.
le ali nere
sfidavano le nubi
ardono chiare
9.
nudo a terra
ti lecchi le ferite
perduta guerra
10.
brucia la storia
fiamme sui volti arsi
quale vittoria
Fabio Scotto è nato a La Spezia nel 1959. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo, per la saggistica, La voce spezzata. Il frammento poetico nella modernità francese (Donzelli, 2012), Il senso del suono. Traduzione poetica e ritmo (Donzelli, 2013), le curatele e traduzioni dei volumi Rimbaud. Speranza e lucidità (Donzelli, 2010), del Meridiano L’opera poetica (Mondadori, 2010) di Yves Bonnefoy, l’antologia Nuovi poeti francesi (Einaudi, 2011).
In poesia, il suo libro precedente è Bocca segreta (Passigli, 2008 – Premio Selezione “San Vito al Tagliamento”).
Marco Nuzzo, prosa inedita "I luoghi del tuo Permiano", nota di Mara Cini
La prosa brevissima di Nuzzo rivela grande viscosità e densità non tanto nella sintassi ma nel “quadro” che, forse, intende rappresentare . Non un quadro statico, a dire il vero, ma una scena in divenire. Primordiale, biologica, fisica e sacra ad un tempo, cangiante, in continua trasformazione e in continuo rapporto con gli stati precedenti e successivi.
Minima prosa con minime, caleidoscopiche, valanghe di sensazioni visive che colpiscono con il clangore infinitesimale dello sfaldarsi di una crosta di crisalide.
I luoghi del tuo Permiano
In principio era l'isteresi, poi venne l'isteria e la fuga nel dubbio saccente, la mia larva approdava in fossili di mestizia, in vaticinati abituri d'ossa e sacrazioni, nella mirabilia dalle vaste pretese. Ero nel luogo del tuo Permiano, nell'alta stagione delle mie estinzioni, basso quanto bassa è la voracità di una clemenza ventrale; laterale e nudo come l'utopismo nella sua effusione dalla gola di vernice. Cementavo il parto col tuo ordito, ingollando la pece calda, il clangore del nero fin sotto le falangi. Dagli strati ungueali alla proteiformità della voce, fin nella falda infrangibile del verme, cadendo da crisalide come crosta sublimata, piano, come il fortunale scisso nella sentenza delle disarmonie più inquiete, amaro come il danno della peste nel sacello, libero di stare, appena estinto, vuoto nel tempo.
Marco Nuzzo, nato in provincia di Lecce nell’aprile del ’78, è recensore e collaboratore editoriale. La sua bibliografia comprende: “Ultime frontiere” - (Poesia) Aletti Editore, 2011; “Non ti piacerei, vestito dell’inverno appena trascorso” - (Poesia) Rupe Mutevole Edizioni, 2011, prefato da Emanuele Marcuccio; “Anime” – Di Gioia Lomasti e Marco Nuzzo (Poesia), Photocity Edizioni, 2012; Prefazione e revisione della raccolta "L'ora dell'Horror" (Racconti AA.VV.), Edizioni Il Foglio, 2013; “Le falene dalla luce” - Di Alessandra Molteni e Marco Nuzzo (Poesia), Matisklo Edizioni, 2014.
Patrizia Dughero, dalla raccolta inedita "L’ultima foglia", nota di Laura Caccia
Nel giardino dell’esser-ci
Sono molteplici i piani che Patrizia Dughero mette in gioco con “L’ultima foglia/giustificata, interlinea singola” dove viene declinato l’esistere nelle sue dimensioni naturali e corporee, in un costante rapporto con la lingua in cerca di una sua rigenerazione.
Dalla parte dell’esser-ci, anche di “una certa felicità di esistere” raggiunta al termine di una sotterranea battaglia a partire da un lutto personale, l’autrice insegue, come ci indica, una specifica “qualità dell’esserci: il movimento dei volatili…della luce…del fogliame e degli alberi”, da assecondare con il corpo e con le parole, in una tensione onomatopeica suggerita dai versi di J.al-Dīn Rūmī, nello sforzo doloroso di uscire da “silenzio e aridità” .
In un tentativo di allontanamento dall’io, concentrando lo sguardo sul reale e consapevole comunque dello scarto tra linguaggio e realtà, il dire cerca una nuova rinascita nel prendersi cura di un giardino e di una lingua, così come nel seguire, attraverso il canto degli uccelli, la musica dell’esistere.
Tra i confini, naturali e grafici, che impone al giardino e alla scrittura, nella sofferenza sottotraccia in cerca di cura e rinascita, Patrizia Dughero mette in gioco tutto il proprio corpo nel far risorgere, nell’alterità, parole e senso, come precisa: un corpo che “vive e rivive soltanto nella parola” e in cui “le mani si sono infine congiunte / come guardando una battaglia che diventi arte”.
***
dopo la morte del padre le parole
si sono ammantate di bianco
uscendo dal fango dell’ambiguità;
per un certo tempo hanno percorso soltanto
sentieri di silenzio e aridità;
sono state le voci dei volatili, introdotte
l’anno precedente dal gracidare assordante
delle rane e dei ranocchi,
a ricondurre al volo che percepisce parole,
cercando di forare la porta
lavorando con le mani, per prima cosa,
imponendo confini secchi alle bordure:
le mani si sono infine congiunte
come guardando una battaglia che diventi arte.
***
il cancello ha inferriate grandi che si
specchiano sui muri interni, con ri-
flessi a losanghe, texture di ombre; il
bicchiere risplende di luce propria e
un incendio, fuori, avanza crepitando.
come piuma dal sacco il sale si riversa
sul fuoco, disperdendosi a mo’ di pulvi-
scolo, il fuoco s’arresta.
***
se non ci fosse il suono qui sarebbe nulla,
ma c’è una musica diegetica che impedisce
il silenzio: il silenzio del bosco ha il bianco,
essere che mostra niente.
Patrizia Dughero: Di origine friulana, sono nata a Trento il 30 aprile 1960. Mi sono laureata con una tesi in Fenomenologia degli stili (prof. Renato Barilli) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, dove ho anche conseguito un Master, dal momento in cui Bologna diventa la mia città d’azione, avendo precedentemente vissuto in molte città d’Italia: una molteplicità di luoghi che caratterizza anche la mia professionalità. Non lontana l’esperienza come restauratrice muraria, nel campo del restauro di beni artistici e culturali, presso alcuni importanti cantieri bolognesi. Ho sempre coltivato la scrittura e le collaborazioni editoriali, negli ultimi anni ho ricevuto diversi premi letterari, sono attiva nell’organizzazione di eventi e presente in alcune antologie inizialmente di racconti brevi (Premio “Fili di parole III”, per Giulio Perrone Editore) e in seguito esclusivamente poetiche, le ultime a tema civile, Cuore di preda e Il ricatto del pane, entrambe CFR Edizioni e Sotto il cielo di Lampedusa, Rayuela Edizioni. Ho scritto articoli a tema fiabesco inseriti in blog e antologie, come Di là dal bosco, andata e ritorno nel paese delle fiabe, Dot.com Press Edizioni. Sono presente in numerosi blog con i miei articoli e con altrui recensioni sulle mie poesie, inserite in riviste letterarie sia in Italia che in Slovenia, quali “Poesia” e “Novi Glass”. Quattro le sillogi poetiche pubblicate: Luci di Ljubljana (Ibiskos Editrice Risolo - Empoli - 2009), Le Stanze del Sale, vincitrice del “Premio Giorgi” 2010 (Le Voci della Luna - Sasso Marconi - 2010); Contatti, col poemetto Canto di Sonno, in tre tempi, vincitrice del premio “Ulteriora mirari” 2011 (Edizioni Smasher - Messina - 2011); Reaparecidas (Qudulibri - Bologna - 2013). Selezionata al premio “Elsa Buiese 2013” per DARS (Donna Arte Ricerca e Sperimentazione) di Udine, con il poemetto Camera Oscura, inserito nella raccolta Reaparecidas insieme a alcuni dei Disegni sui giornali di Marcello Gentili. Nel 2014 sono stata selezionata al “Premio Montano” per la sezione “Una prosa inedita” con il componimento Dipingere non è tingere. Da qualche anno sto svolgendo studi sul linguaggio poetico dello Haiku, in particolare con tre articoli apparsi su “Le voci della Luna”, rivista d’informazione e cultura letteraria e artistica, di cui sono stata capo redattrice per diversi anni. Ho messo a punto un progetto, dal titolo “Possiamo chiamarla poesia gentile?” che fa seguito al precedente “Haiku: sulla brevità per scoprire in se stessi lo stupore”, inserito in un ampio contesto, adattato a differenti fasce d’età, svolto nelle scuole elementari e presentato ai plessi delle scuole medie della provincia di Bologna e all’Università Primo Levi di Bologna. Sono redattrice di “24marzo Onlus”, associazione che si occupa di iniziative in Italia sui desaparecidos dell’Argentina e dell’America Latina. Dal 2012 ho aperto una casa editrice, Qudulibri, che amo definire fondata sull’ “impegno del linguaggio per una militanza della Memoria”. Tra le collane di Qudulibri, la collana di poesia breve Ku. Non senza titolo di Daniel Gahnerz è uscito per Qudulibri in tre lingue, svedese-inglese-italiano e riportato successivamente nel linguaggio dei segni, con una mia nota dal titolo “Contagio haiku”. “Gli haikai dei rimorsi di Pierpaolo Pasolini” è un mio articolo apparso nel blog Cinquesettecinque a luglio del 2014.
Alessio Alessandrini, da "Somiglia più all’urlo di un animale", Italic 2014, nota di Davide Campi
Alessio Alessandrini costruisce i suoi versi svolgendo la narrazione di attimi di vita vissuta, scenografie minime sviscerate ossessivamente fino al minimo dettaglio, purché strettamente interiorizzate o interiorizzabili.
E non sono riferimenti alla metropoli ma sempre elementi di scenografie interiori gli accenni ai non-luoghi del nostro quotidiano: “Le autostrade agonizzano di gialli fari…” in cui oggetti della vita comune si coagulano in una rete solida cui ancorare il proprio disagio per documentarlo, smontarlo, spiegarlo, senza archiviarlo mai.
Nello stesso modo i paesaggi della consuetudine scivolano in una percezione volutamente incerta, franano nel racconto di paralleli moti dello spirito (“Lungomare disertato, deserto e desueto/solo tiepidi passaggi emozionali…”).
Nessuna pretesa di condivisione o generalità in questa poetica livida, permeata di piccoli e grandi dolori, espressa in forme regolari, dai ritmi lunghi e instabili, con frequenti intrusioni lessicali: “E poi, un incensurato rumore di orme/scalze, scadute sui parati, sul parquet…”.
L’universalità di questo sentire emerge come elemento strutturale di ogni riuscita lingua poetica.
Dalla sezione “Bianco”
Stanze d’albergo
a Remo Pagnanelli (in memoria)
L’indomani, certo, occorrerà
con deferenza e infame zelo
abbandonarla questa vacanza
di pochi metri quadri arredati
dove abbiamo gettato le ancore,
provvisorie, navigato, a volte,
perpetrato il duro inganno
di sconfiggere la sorte che
ci vuole solitari con i nostri
inciampi di pelle morta o sebo.
Dovremmo recuperare i resti umani
le tracce pelviche, il lenzuolo
affebbrato, gli asciugamani
perché nessun passo estraneo osi
sconsacrare quello che ci è stato
concesso mescolare.
Eppure resisterebbero le orme e
un battito soffice che sa di animale,
la consistenza impalpabile,
la consorteria della carne coniugata,
l’impercettibile bigiotteria del vivere
che ci conferma angeli ancora troppo
teneri: con mani e piedi e fiati piombati,
dalle ali impantanate tra il profumo
delle stelle e la moquette alluvionata
di polveri e capelli. Ma che resti
almeno il sudore o il suo alone
bianco: l’aver sfidato il cielo
in queste temporanee celle,
arnie da abitare appena e
dover maledettamente
rendere.
Dalla sezione “La panchina azzurra”
Molo sud
Noi così impudicamente scoperti,
osceni – offerti alla scena:
aperti, squarciati, indifesi
dietro tanta pigrizia:
due nuche ciondolanti
concesse alla bufera.
Inermi.
Il colpo sulla schiena.
***
Questa intramontabile fatica di distruggere ogni giorno:
vivere di scarti, liquami, decomposizioni minori,
per fecondare ventiquattro ore self service e via:
disossare porti, sfarinare templi, sciogliersi.
Alessio Alessandrini, Ascoli Piceno 1974, ha pubblicato “La vasca” (Lietocolle, 2008), vincitrice del XXII Premio Camaiore nella sezione Proposte Opera Prima. Sue poesie possono essere lette in raccolte antologiche o sul web.
Tiziana Colusso, prosa inedita "Nutrimenti. Fusioni. Nascite", nota di Flavio Ermini
Racconto epistolare
Generalmente chi scrive ama il rimando da una parola all’altra, di voce in voce, senza portarsi mai a contatto con i segni arginanti esterni. Non è così per Tiziana Colusso, cosciente com’è che fermarsi a questo reticolato verbale significherebbe aver pensato troppo poco e inadeguatamente il rapporto tra il dire e la cosa.
«Dovremmo trovare il modo di sostenere più a lungo lo sguardo sulle cose» riflette Tiziana Colusso, ed è una riflessione che è segnata da un’insuperabile necessità: cogliere gli avvenimenti, i contesti, gli incontri e le opposizioni della propria vita come una sorta di chiamata da parte dell’essenza nascosta – ma al tempo stesso inevitabile e impellente – del mondo. È un mettersi in gioco nei confronti della scrittura da una parte e rispetto agli accadimenti della vita dall’altra. Ciò determina una scelta radicale riguardo alla percorribilità o meno di certe strade: la forma epistolare della narrazione, il minuzioso racconto dei sogni, la dialettica mai deposta tra materia vivente e materia inerte.
Ciò che Tiziana Colusso scrive riguarda di fatto la nostra condizione e il nostro destino. Dice qualcosa di essenziale per noi. Dice che grande importanza ha il passaggio dallo stato di veglia alla dimensione onirica e che in questo passaggio va prestata grande attenzione al precipitare della parola nel non-detto.
Nutrimenti. Fusioni. Nascite. Ma la scrittura è una creazione o una creatura?
Cara amica, i nostri pensieri non sono mai puri. Dovremmo concentrarci, scolpire le parole ad una ad una, fino a farle vibrare. Ad un certo punto la forma si disfa e tutto eternamente ricomincia. Dovremmo trovare il modo di sostenere più a lungo lo sguardo sulle cose, sulla loro luce. La luce della rabbia è una luce elettrica, di forma netta, trascina con sé onde di detriti, polvere, cellule morte. La guerra è una luce artificiale, non vibra, forte nella sua immobilità. La luce viva la si incontra sui volti, attorno alle rughe, alle smorfie, l’ombra sulla guancia appena rosata. La luce dei volti è generata da soli interiori, che quando si spengono fanno crollare gli zigomi e gli angoli della bocca come impalcature.
A volte mi sembra che scrivere renda simili a quelle stelline fluorescenti che vendono nelle cartolerie, che durante il giorno assorbono luce solare e poi di notte la cedono a poco a poco sotto forma di una luminescenza fredda, come quella un minuscolo neon, e priva di ombra.
Ho generato bambini solo nei sogni. Una volta ho sognato di avere una bambina appena nata, attaccata al seno. Insieme a me c’erano F. - il quale non era soddisfatto di questa figlia perché eravamo poveri ed inseguiti dalla polizia e diceva che la bambina mi succhiava tutto il nutrimento - e M.T ed S., i quali mi davano consigli sull’orario delle poppate. Io credevo che la bambina dovesse mangiare solo una volta al giorno. Ricordo la sensazione piacevole di mia figlia attaccata al seno: un’impressione molto vivida, nonostante la situazione del sogno fosse tutt’altro che tranquilla.
Un’altra volta ho sognato di avere una bambina piccola e di fuggire con lei e mia suocera da mio marito che ci inseguiva, chissà perché. Io ero una madre distratta, che spesso si scordava dell’esistenza di questa figlia ma poi rimediava con slanci di affetto. Finivamo per rifugiarci in uno strano bar sotterraneo che poi scoprivamo essere un bordello. Atmosfera calda e ovattata, con camere disordinate ingombre di biancheria. Ci sedevamo nel salone della casa indossando solo la biancheria intima e la vestaglia, di fronte a noi alcuni ragazzi esaminavano le donne in offerta, io non sapevo dove tenere la bambina, non volevo lasciarla nelle stanze ma non potevo nemmeno tenerla con me in quella vetrina, che però era confortevole, un rifugio nella notte fredda. La suocera aveva preso la situazione con ironia e stava lì sul divano sotto gli sguardi degli uomini, dicendomi sottovoce "Però guarda che se lui ci trova qui ci ammazza sul serio!"
Di nuovo un sogno con un bambino piccolo, un neonato, che io dimenticavo di nutrire. Le circostanze del sogno sono svanite, ma ricordo che mi trovavo con altra gente e tornavamo a casa di corsa perché io mi accorgevo di non avere dato da mangiare al bambino per troppo tempo. Ricordo che entrando in camera da letto trovavo sul letto grande, sfatto, dei gatti addormentati e poi, su una coperta, il bambino, che nutrivo a seno. La paura mangia l’anima, diceva Fassbinder. E l’anima, cosa mangia?
Sogno di Aurelia. Voci, pesci affamati intorno al pane, si avvicinano ad un nucleo di luce che vibra appena sotto il pelo dell’acqua: quella luce è lei. Le voci-pesci discutono intorno a lei, le voci vicine si sporgono a guardare e si allontanano con uno scatto pauroso della coda quando lei muove la testa o digrigna i denti in risposta a voci cupe come ombre, che salgono dal fondo e si distinguono dalle altre per certi pungiglioni urticanti e la persistenza della loro ombra.
Mi risveglio da un sogno con un’orribile sensazione di soffocamento. Il luogo del sogno è una piscina affollata. Un uomo fa nuotare con infinito amore e con pazienza una sorta di fantoccetto alto non più di un palmo, senza braccia né gambe e con due alucce atrofiche sulle spalle. E’ sua figlia, con l’evidenza folgorante del sogno. La appoggia sul pelo dell’acqua e la bambola - che è in realtà è un pupazzo di forma indefinibile - scende verso il fondo della piscina. Lui si tuffa e la riporta a galla. Intanto una persona nuota da un bordo all’altro della piscina, e ad un certo punto una bambina cerca per scherzo di soffocarla, mettendole la mano sulla testa in modo da farla restare sotto il pelo dell’acqua. Lei le morde un dito, con forza. Si sente
scricchiolare l’osso sotto i denti. Poi il ricordo torna ancora al bagnetto del fantoccio e di suo padre. Molte persone assistono alla scena, intenerite da tanto amore nei confronti di un esserino così deforme. Il padre la deposita sull’acqua e le chiede se ha paura di andare giù. La bambina-fantoccio, con una voce saggia e pacata, risponde "no se scendi pure tu". Il padre ricomincia a tuffarsi, a prenderla e riportarla su. Fino a che in una discesa il fantoccio si incastra nella vegetazione corallina del fondale. Il padre, facendo attenzione a non rovinare le alucce, la riprende: niente panico. Il panico comincia quando si dà la spinta per risalire ed è troppo corta. Scende nuovamente sul fondo per darsi un’altra spinta, più forte, ma l’aria nei suoi polmoni si sta esaurendo. La vedo dal basso risalire a siluro, uscendo dall’acqua sotto la spinta del panico, questo stesso panico che mi fa svegliare di colpo.
In una mostra sulla Cina a Venezia, ho sostato a lungo di fronte ai corredi funebri antichi, che riproponevano una riproduzione perfetta del mondo reale, compresa una moneta coniata appositamente, una moneta in bronzo o ceramica destinata alla "circolazione nel mondo sotterraneo". Questo simulacro di realtà è insieme angosciante e consolatorio: proprio come la scrittura. Nella mia scrittura, ricorrenza quasi ossessiva della dialettica tra materia vivente e materia inerte.
La luce va via a causa del temporale, rimane acceso solo lo schermo del mio computer, che risalta nel buio come un oggetto totemico. Accendo una candela, per bilanciare le luce azzurrognola e fredda con una fiammella calda. La gatta, terrorizzata dal fuoco, scappa dietro alla cassapanca. Il ragazzo che me l’ha regalata mi ha raccontato che la gatta ha avuto una vita travagliata, tra le varie disavventure è anche scampata ad un incendio. Gattina, ti dedico un verso bellissimo di Ingeborg Bachmann. Ora al buio sarebbe complicato ritrovare il libro nel soppalco. Ti dovrai accontentare di una citazione a memoria: "Vedo la salamandra attraversare tutti i fuochi, e tuttavia...". E tuttavia?
Sequenze di parole dotate di alto tasso di informazione, come quelle dei giornali. Oppure le parole anodine della comunicazione quotidiana, familiare, che hanno il loro vero significato in un’eterna partita a scacchi emotiva che si gioca sotto e attraverso le parole. Per avere ancora voglia di scrivere si devono trovare parole dense, che salgono alla superficie da una riserva situata in un altro tempo, in un altro luogo. Altrove, altrimenti. Parole magiche: nel senso proprio del termine, dotate cioè di potere evocativo e non informativo. Parole-miracolo, nel senso in cui Wittgenstein usa questa espressione in "Lezioni e conversazioni": "E ora descriverò l’esperienza di meravigliarsi per l’esistenza del mondo, dicendo: è l’esperienza di vedere il mondo come un miracolo"
Ospite in una casa con camino, passo molte ore ad accendere e ravvivare il fuoco. Quest’attività è diventata la scansione della scrittura, anche per la somiglianza tra questi due gesti. C’è da un lato tutta la simbologia di purificazione delle scorie tramite il fuoco, di trasmutazione alchemica di una ganga di materiali disparati in una quintessenza fondata in sé stessa. C’è anche una similitudine più semplice, manuale, tra lo scrivere e il tenere acceso il fuoco con equilibrio di legna, di soffio, di carta, a volte di alcool. A volte la fiamma stenta per ore, a volte la legna è poca o poco stagionata, a volte dopo molti tentativi, quando si è già rinunciato, c’è una fiammella sotterranea che si propaga in un attimo a tutta la catasta.
Un tempo ero convinta che il salto tra la lingua d’uso e la lingua letteraria fosse in una sorta di preziosità inusuale del lessico e della situazione. In realtà è piuttosto una questione di tono, di un ritmo che sin dalle prime battute si percepisce diverso: ed anche frasi che pronunciate in altro modo scivolerebbero via senza lasciare traccia, acquistano in questo tono e ritmo una risonanza particolare, inconfondibile. La mia scrittura è stata forse originata da questo bisogno coatto di ripulire, mettere a punto, precisare, un discorso che mi sfugge dalla bocca senza alcun controllo.
Alla stazione di Nervi, appena dopo il calar del sole, nella luminosità diffusa, un treno con i finestrini accesi sfreccia rapido di fronte alla balaustra affacciata sul mare, e una volta che è passato lo sguardo scopre dietro di lui il mare immerso nella luce grigia, e davanti alla linea dell’orizzonte un traghetto con gli oblò illuminati. Lo sguardo pensa a tutte le storie che sfrecciano via dietro i finestrini del treno e gli oblò della nave e si rende conto con tristezza di non avere nessuno da rimpiangere: nessuno è partito, nessuno sta per sparire
all’orizzonte. Lo sguardo deve allora forse inventare una storia per collocarla tra quegli abitatori di luci fuggitive: inventare qualcuno che è partito, per poterlo rimpiangere.
Lo spazio è tutto, lì dove non c’è il tempo. E se non c’è il tempo non c’è neanche la fine del tempo. Lo spazio solido e immobile invade tutto di sé, e la stessa esistenza non è che una posizione in quello spazio, il quale si modella intorno all’esistenza come una presenza gelatinosa. C’è un silenzio intessuto di battiti attutiti, sciacquettii, aria smossa, fiumi sotterranei lenti e continui. Da qui, da questa dialettica tra spazio-conchiglia e spazio-infinito, ha origine il racconto
Una serie di immagini che rimandano in forme e modi diversi al binomio materia vivente/materia inerte, con i relativi passaggi di trasmutazione. Ad un certo punto avevo appuntato su uno dei quaderni una frase di Wittgenstein "Ogni mattino dobbiamo penetrare di nuovo attraverso cumuli di pietre morte per arrivare al vivo, caldo nucleo".
Questi miei quaderni, luogo insieme mobile e tangibile della scrittura, che ho trasportato in tutti i luoghi del mio pellegrinaggio di anima in pena - case, quartieri, città, bar, aeroporti, ospedali - sono stati il mio luogo privilegiato per la tessitura complessa e discontinua del mio mondo. La loro presenza mi consola, lenisce il sentimento di dispersione di me, di smarrimento. Le loro copertine lise, variegate, familiari, sono in qualche modo la conchiglia del mio mondo e del mio discorso sul mondo
E se la pietra di Sisifo fosse un’immagine della pietra filosofale? In tal caso non si tratterebbe di cercare tanto lontano, ma solo di riuscire a vedere veramente ciò a cui si aderisce con tutto il corpo e la fatica - la vita? In un libro sull’alchimia di cui ho dimenticato l’autore, si dice che "lavorando il corporeo e trasmutandolo, l’alchimista trova l’uomo autentico che non c’è ancora".
Tuttavia, mi preme dirlo: questa storia è dedicata a chi sa che le storie non si costruiscono come una casa - con una griglia di cemento armato preliminare e poi le rifiniture, gli impianti, gli infissi - ma come una tela di ragno. Costruzione paziente del discorso che filando e filando, secrezione infinita, si dispone in una forma compiuta, luccicante di geometria e di saliva.
Tiziana Colusso:
Sito internet: www.tizianacolusso.it
Autrice di narrativa, poesia, testi teatrali, fiabe, saggistica. Ha fondato nel 2009 e dirige il trimestrale telematico FORMAFLUENS - International Literary Magazine (www.formafluens.net).
Dopo la laurea in Letteratura Comparata a Roma ha vissuto a Parigi, specializzandosi all’Université Paris-Sorbonne e collaborando con “La Republique Internationale des Lettres”. È stata dal 2004 Responsabile Esteri del Sindacato Nazionale Scrittori e tra i promotori della nuova Sezione Nazionale Scrittori SLC-CGIL, creata nel 2014. Dall 2005 al 2011 è stata eletta nel Direttivo (Board) dello European Writers’ Council, Federazione delle Associazioni di autori dei paesi europei, con sede a Bruxelles.
Tra le sue pubblicazioni: La manutenzione della meraviglia. Diari e scritture di viaggio, 2013 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri; Ecofrasie, audiolibro con CD allegato. Testi di Tiziana Colusso e musiche originali di Natale Romolo e Federico Scalas. Edizioni Terre Sommerse 2012; La lingua langue (traduzioni di suoi testi poetici in dodici lingue: Arabo, Bengalese, Bulgaro, Danese, Francese, Giapponese, Lèttone, Inglese, Romeno, Slovacco, Spagnolo, Ucraino, prefazione del Prof. Jean Charles Vegliante - Université Sorbonne Nouvelle) Ed. Eurolinguistica 2010; Il sanscrito del corpo, Fermenti 2007; Italiano per straniati, Fabio D’Ambrosio Editore, 2004; La criminale sono io – ciò che è stato torna a scorrere Arlem 2002, riedizione in eBook 2011, sito letterario “La recherche.it”; La terza riva del fiume, Ed. Impronte degli Uccelli 2003; Né lisci né impeccabili, Arlem 2000, Il Paese delle Orme, Edizioni Interculturali 1999; Le avventure di Gismondo, mago trasformamondo, Edizioni Musicali, 1998. Ha partecipato a numerose antologie di prosa e poesia (tra le ultime L’amore è un topo strabico, (racconti), Robin Edizioni 2010; Poesia a comizio, Empiria 2008; Cattivissimi, racconti neonoir Stampa Alternativa 2012) e a vari Festival Letterari in Italia e all’estero. Collabora riviste, enti e istituzioni culturali.
Pratica dal 2006 il Tai Chi, e da molti anni la meditazione Vipassana.
Antonino Contiliano, poesia inedita "Amour événementiel", nota di Ranieri Teti
Poesia della piena presenza, scritta da posizioni che non arretrano.
Antonino Contiliano vi instilla a piene mani tutto il sentire e insieme tutto il vedere. Al termine di ogni strofa porta il testo fino al limite del possibile, fino all’ultimo metro di terra, fino alla sporgenza che salva dal crepaccio.
Quanto del climax determina l’ascolto e la lettura, quanto della visione diventa parola che con-fonde e porta lontano, si risolve in una ridda di metafore additive proposte con ritmo serrato, per spaesamenti improvvisi, verso una gioia fra le oscillazioni in fuga e altre connotazioni tanto orientate al senso e alla sorpresa linguistica quanto al mondo emozionale.
Dal momento che morire è il futuro che ci viene incontro, Contiliano conduce tutti, noi lettori e se stesso, senza dolore, verso il fatale esilio o l’ultima stazione.
Nel buio incrollabile nessuna notte promette complicità e ripari.
Nella vita figurata dall’autore non c’è consolazione né retorica ma solo, al più, un vago rimpianto d’amore. Tutte le gioie sono passeggere.
Amour événementiel
all’ironia di un amico
incendiaria una marea questi fiori cardiaci
questi fotoni sognanti e le foglie di neve
un naviglio di onde nello spazio profumato
questo attracco di notti rotte all’addiaccio
delle mani i doni giuramenti inanellano
e le vibrazioni dei desideri ventosi e rasi
aggrappati sono carezze dell’azzurro arso
una gioia fra le oscillazioni in fuga, ça va...
svuotati del vuoto e dell’ora gli orli e in volo
ora che d’essere ventagli si posano scuciti
svelata con-tingenza di miele una scia sugli anni
un bagno événementiel di danze virali l’amour
la notte è una farfalla dai colori nucleari
e nessun infinito turba così tempestoso
una veglia dell’udito così tastiera criminale
che ogni ferita è gelo addosso al silenzio
poche sono le cose da dire e non disdire
questo nodo di primavera fuori stagione
è così sorgente emergente senza passato
che in cascata corre ragione scalarne i sorsi
nessuna notte promette complicità e ripari
o angoli occupati dal risveglio avvenire
non c’è palpebra che rosa s’abbassi e passi
se non per pazzire sì ... bruci ogni gola
ogni futuro è senza intervalli a monte
a valle per-per-tuo impulso urti e flutti
un nulla solido sbattuto dai sognatori
gli istanti radioattivi dell’amore durante
amico lascia l’ironia a chi già sa dove
morire è il futuro che gli viene incontro
e un carico d’anni gravato solo da un peso
quello degli amori non vissuti e sans dire salut!
Antonino Contiliano è nato a Marsala nel 1942. Tra gli anni ’70 e ’80 ha fatto parte dell’Antigruppo, movimento poetico e culturale siciliano, diventando anche redattore di “Impegno 80”, la rivista del gruppo. Tra le sue moltissime opere poetiche ricordiamo Il flauto del fauno (1981), L’utopia di Hanna Arendt (1991), La soglia dell’esilio (2000), ‘Elmotell blues (2007), Il tempo del poeta (2009).
Alcune sue poesie sono state tradotte in varie lingue, nonché accolte in varie antologie e riviste dagli anno Settanta a oggi. Vasta anche la sua produzione critica.
Francesco Lorusso, dalla raccolta inedita "Il Secchio e lo Specchio", nota di Laura Caccia
Tra le assenze e i riflessi
Sta nel gioco di specchi, la cui superficie statica riflette “quel che resta sulla faccia / inflesso dalla lunga minaccia”, e di secchi, dove il tremolio dell’acqua moltiplica le facce, la trama di maschere e riflessi che Francesco Lorusso fa vibrare in “Il Secchio e Lo Specchio” .
Sono riflessi insidiosi del tempo, poiché, scrive l’autore, “da sempre è l’imminenza che ci minaccia”, evidenziando un desiderio ribadito più volte e sempre insoddisfatto di permanere nel cuore della temporalità.
E sono riverberi dello spazio, di quello esterno che riflette inquietudini “nello specchio amaro della via”, di quello interiore messo in luce da perdite e separazioni e di un altrove che si affaccia nell’alitare di un battito, quando “ti fissa tra gli occhi l’assenza”.
E sono insieme rispecchiamenti dell’io e delle cose, dove le grinze, le fessure, le crepe disegnano i riflessi, come mette in luce Francesco Lorusso, sia dei volti, “dentro gli specchi doppi oramai grigi di luce / che sono simili alle grinze che ci cuce la sorte”, sia del mondo, poiché “dentro la grinza / ti parlano alcune cose / con un riflesso freddo / che ne sciacqua le crepe”.
E anche il dire trova i suoi riverberi, come precisa l’autore, tra le screpolature di “parole marchiate / da una balbuzie digiuna e diversa” e un suono a volte “lontano senza più luce”, a volte che “insiste… che cerca ragione”.
Dalla sezione “Il secchio e lo specchio”
***
Rapsodie diffuse silenziano la notte
ti trascinano fuori dalle acque aperte
da questo fiato inceppato nell’onda
Sono i corpi che muovono la paura
sul mare delle parole marchiate
da una balbuzie digiuna e diversa.
***
Sei aperto da fessure al vento
frutto del lavoro di chi paga
di colui che consuma il nome
sul segno certo di suole sconosciute
le voci di una prigione indistinguibile
nervo montante di finestre troppo simili
a forme fatte lunghe di luce già mozza
mantenuta meticolosamente nascosta
all’ascolto di quella parte comune di bocca.
***
Così ritorno nella stanza nuda
fra l’umore immutato dei mobili,
la sedia sperduta che non mi aspetta
e un suono lontano senza più luce.
Dalla sezione “Sette interpunzioni strette”
2.
e ci stava solo un frammento finito fra le fessure
un luogo comune che ci costava fatica e respiro
il fianco sciupato dalla piega sana del camice
e la narice sottesa sui movimenti senza suono
ad accogliere il rigore composto del nuovo corpo
il foglio buono delle figure fitte ora affastellate
3.
la festa oramai finisce nella forza fiera dei tuoi giorni
attraverso il braccio sotteso sulla tua parola perduta
ma sai che da sempre è l’imminenza che ci minaccia
ora che sono i fili oltre le finestre a gesticolare per te
sfiniti sulle vesti che non arrestano il tuo ultimo salto
ma l’istante si aggrappa al lento movimento della mano
Francesco Lorusso (Bari, 1968), dopo aver ottenuto diverse menzioni e un premio nel 2003 con una sua lirica al concorso “Città di Bari”, pubblica una corposa silloge sulla rivista “incroci” di Bari, dal titolo “Nelle nove lune e altre poesie” (2005). Esce in volume per la Cierregrafica di Verona, nella collana Opera Prima, prefato da Flavio Ermini, con la raccolta “Decodifiche” (2007). Il suo ultimo lavoro è per l’editore La Vita Felice di Milano con una prefazione di Daniele M. Pegorari e una nota critica del poeta Vittorino Curci, dal titolo “L’Ufficio del Personale” (2014).
Angela Greco, da "Personale Eden", La Vita Felice 2015, nota di Davide Campi
Angela Greco sviluppa il tema con poesie dal respiro ampio e dal ritmo veloce, concitato, a tratti accanito: “ho un sospetto di sentimento che s’accorda al tuo nome/e vocali e voragini aperte nell’attesa di averti addosso…”.
Il tema è l’amore, non certo teorico, ma reale e specifico per un “altro” non generico.
Il ritmo segnala il corpo, necessariamente fisico, solido e presente, in tutte le declinazioni
che riguardano il desiderio, nello stesso modo fisico e solido, sia in assenza che in presenza dell’amato: “mi soffermo come se ancora non fossi ma già sento/diventa vero il distacco dal rumore intorno e anche tu”. La tensione verso l’oggetto d’amore, anzi, risulta essere vera sia in assenza che in presenza dell’amato.
Come afferma acutamente Rita Pacilio in premessa, “bisogna formulare in modo precisissimo gli itinerari del sublime e della sua luminescenza per rintracciare i segni del fenomeno lirico europeo nella poesia di Angela Greco: versi lunghi, arditi e dotti dall’atmosfera emotivo/sensoriale, dai toni suggestivi...”.
Così Angela Greco restituisce in versi coerenti una profonda modificazione percettiva, consentendo alla lingua poetica di superare l’aspetto particolare del sentimento per tendere verso una visione universale.
***
ho bisogno d’un passo d’apertura
da tralasciare altrove la quiete d’una notte sola
di stelle scucite di desiderio: apro mani
in contraltare al quotidiano in canto stonati
rivolti ad una terra senza fini che restituirà
il legame che riporti al di qua del silenzio
mentre muta m’accordo all’azzurro in crescendo
strappato al momento in cui si dovrebbe altro
eppure necessario a riprendere strada e incontro
ritrovando quiete e quanto sappiamo essere
e che non possiamo:
avanza allora il dire sottile e lento precipita
verso palpebre chiuse anzitempo e prima di essere
voce che ha già detto meravigliando altri scenari
volo a comporre linea testa-cardio-strada ferrata
che in punto di fuga sbiadisce impossibile contro città
in lontananza striscia d’altro colore sul foglio del sé
senza giusta ragione se non l’incomprensione
guardo immobile lo svolgersi delle ore antimeridiane
***
riprendimi esattamente da questo punto
quello in cui coloravamo il ritrovarci stretti
precisi nello sbottonare voglia e labbra:
tra le tue dita il mio dettaglio nascosto alza la voce
e fughiamo chiaroscuri di silenzi ormai altrove da qui
ché sappiamo adesso dove posare l’istinto incrollabile
ad afferrare e restituire duplicate ipotesi di paradiso:
ritrovami ancora umida meraviglia
che ho atteso leccando una ad una piaghe d’assenza
mancanza oggi risolta dalla conoscenza delle tue rughe
varchi di tempo narrato ai miei occhi e sapienza
di sapermi nell’intimo di un ancoradadire:
siamo distanti solo un bacio non di più
e questa attesa è solo il nostro abbraccio più lungo
Angela Greco è nata nel 1976 a Massafra, dove vive; occupata in poesia, con la famiglia e con il suo collettivo di poesia, arte e dintorni Il sasso nello stagno di AnGre (http://ilsassonellostagno.wordpress.com/).
Ha pubblicato:
- in prosa, Ritratto di ragazza allo specchio (racconti, Lupo Editore, 2008, con prefazione di Michelangelo Zizzi);
- in poesia: A sensi congiunti (Edizioni Smasher, 2012, con una nota di Roberto Ranieri); Arabeschi incisi dal sole (Terra d’ulivi, 2013); Personale Eden (La Vita Felice, 2015, con prefazione di Rita Pacilio); in uscita: Attraversandomi (Limina Mentis Editore, 2015, con una nota di Nunzio Tria); Elaborazione parentale (Edizioni Smasher, 2015, con prefazione di Giorgio Chiantini);
- in formato elettronico, suoi testi sono stati inclusi ne I Quaderni di Èrato (2014) ed in alcuni numeri della fanzine Versante Ripido (2014).
Primerio Bellomo, poesia inedita "Alba", nota di Ranieri Teti
Primerio Bellomo ci avvicina allo stupore di un sortilegio.
Al “murmure diffuso delle cose non vedute”.
L’autore si muove nell’inestricabile connubio tra pensieri e osservazioni: la natura dell’alba diventa, nello scorrere del testo, sentimento dell’alba.
Bellomo ci rende partecipi della sua visione e del suo procedere: siamo su un crinale, sospesi tra una tesa capacità di linguaggio e la sua proprietà di originaria sorgente polisemica.
Le espansioni del senso offrono la possibilità di rendere evocativo ogni sintagma, ogni singolo attimo descritto, ogni singolo frammento della vasta scena.
L’intimità indocile e vivida del cielo offre il set naturale a una tenace e insieme tenue portata poetica, misurata nelle connotazioni che scandiscono gli intervalli del tempo.
Nella “corsa senza freni delle ore”, Bellomo descrive sfumature e arabeschi, trafitture, bassorilievi d’aria, cangianti e vive risonanze in cui
“resta vera e indifferente / l’innocente durezza della pietra”.
Alba
S'attorcono i pensieri nella mente
e non slarga il giorno all'alba.
Resta basso il cielo e il murmure
diffuso delle cose non vedute
s'arresta al gelo scialbo del mattino
che la prima luce rade.
Si assottiglia silenziosa
l'onda lunga della notte
e precipita in un giorno vuoto
la corsa senza freni delle ore.
Si alza solitario
il volo non pensato di un gabbiano.
La gioia del suo arco
è abbagliante purezza e senza scopo
abbraccia intera l'etra.
Cambia il colore delle case
ma resta vera e indifferente
l'innocente durezza della pietra.
Primerio Bellomo è nato nel 1958 a Palestrina (Rm), dove risiede. E' laureato in Architettura. Volumi pubblicati:
L'ombra del dire (Cierre Grafica, 2005) )
Chorale e Al fuoco dell’origine (Manni, 2009)
Primo vere (Josef Weiss Edizioni, 2011)
Notte siriana (Ed. Il Bulino, 2013).
Suoi testi poetici in:
Roberto Almagno - non solo carte (Gangemi Editore, 2007 ), catalogo della mostra di disegni e sculture dell’artista Roberto Almagno, tenutasi a Roma, presso la Galleria Mara Coccia
Attività 2009-10 dell'Archivio Afro
Segni e parole (Ed. Il Bulino, 2011)
Yasude (Premio Haiku 2013 - Empiria).
Nel 2009 ha partecipato con testi poetici inediti alla mostra Urban Necessity dell'artista Marco Milia presso la Estile Gallery, Roma.
Finalista al Premio Haiku 2013.
Più volte finalista al Premio Montano, nel 2014 è stato finalista nella sezione “ Una poesia singola”, con il testo La rosa dell'assenza .
Recensioni:
Giorgio Bonacini, Una collana dedicata in Il Segnale, n° 72, Ottobre 2005.
Rosa Pierno, Primerio Bellomo “ Primo Vere” in Carte nel Vento, settembre 2013, n° 20. Marco Furia, “Le forme del poema” in Carte nel Vento, aprile 2015, n° 27.
Ultima pagina: Galleria fotografica/1 del Forum Anterem 2015, immagini di Franco Falasca
Forum Anterem 2015, immagini di Franco Falasca
Febbraio 2016, anno XIII, numero 29

La capacità di dare un senso nuovo alle cose e superarle, creando una dimensione estranea alla sfera personale, posiziona la poesia lontano da ogni forma di privata recitazione.
Quando l’autore si dissimula nell’opera, celandosi tra le sue parole, consente al testo di acquisire un valore comune, diventare un bene di tutti.
Questa caratteristica può essere uno dei tratti che accomuna le scritture ospitate nel nuovo numero di “Carte nel vento”, che nasce dai testi presentati alla precedente edizione del Premio Lorenzo Montano.
Gli autori scelti sono tutti introdotti dalla redazione di “Anterem”, come è accaduto in diretta durante il Forum 2015.
Ricordando che è ancora in corso la nuova edizione del Premio, giunto ai 30 anni di attività, auguriamo buona lettura.
In copertina, Laura Cingolani, “Sonnambula n. 7” (acquerello di caffé su carta da disegno stampata)
scarica il bando della 30a edizione
Laura Cingolani, poesia inedita "Sonnambula n. 7", nota di Ranieri Teti
La sostanza della forma.
Epifania per diversa agnizione.
La parola racchiusa nei suoi dintorni.
Codice di visione in assonanza simbolica.
Mimesi grafica del sonnambulismo e azioni.
Veglia a occhi chiusi oppure sonno a occhi aperti?
La figura è ritta, in leggero ritmo, costante movimento.
Contemporaneamente ricorda, pensa, vive, crea astrazioni.
Con moto accorto, andante non prolisso, produce riflessioni.
Si riflette nello spostamento lieve. Il pensiero è interiore.
Porta consueti smarrimenti e volontari nuovi inciampi.
Come fa un uccello “poco incline all’orizzonte”.
Viene assalita da altri spaesamenti temporali:
“mai più capii se c’eri veramente”. Un
segreto donato dal vento notturno.
Consumato dal sogno il destino
quale nuova tregua offerta.

Nota biografica di Laura Cingolani
Angelo Andreotti, da "Dell’ombra la luce", L'arcolaio 2014, nota di Davide Campi
Angelo Andreotti è un poeta colto.
Si avvertono, nelle sue scritture, oltre alla passione per il dire poetico, anche tutte quelle capacità che derivano da un lungo e paziente esercizio di studio del mezzo espressivo.
E dunque, all’interno di forme classiche, con linguaggio alto, si può facilmente notare l’esito di un meditato lavoro di equilibratura degli esiti sonori e ritmici in una interessante convergenza fra scelte lessicali e appropriate cesure dei versi: “così come di notte dell’ombra/si perde notizia/e della luce/si cerca ovunque traccia…”.
Ma si avverte anche l’urgenza di completare l’approccio puramente estetico con modalità espressive che diano conto di un diverso e meno scontato spessore di pensiero (proseguendo la citazione dello stesso testo): “…(benché entrambe si stiano abbracciando/a parole spogliate nel buio)…”.
Un enigma, come avverte Duccio Demetrio nella postfazione, lirico e filosofico insieme.
Da un lato la luce come fattrice della visibilità del mondo e del suo racconto e dall’altro l’ombra come misterica fonte di comprensione, insieme composte nelle loro declinazioni naturali, narrate sotto lo stesso cielo e mai completamente separate.
Anzi, propriamente, rese inscindibili dallo stesso pensiero che prova a definirle.
Prologo
Come nascosta nel verbo di un àugure
non ebbe fine la luce al suo inizio,
fu dopo,
fu quando si vide occultata,
a se stessa negata
scivolando
nel vuoto dietro a un corpoaccarezzato.
Sentì mancarsi
e si mancò,
volse in ombra
ecco:
si fece mondo
e per sempre incarnata fu anche spazio.
Poi in alternante sovrapposizione
fu forma delle cose,
mentre l’ombra
che luce non guarda
l’andava amando.
1, I
E man mano che arriva
la luce riordina il mondo, allude,
imbevendosi d’aria
fa largo alle cose.
Le accoglie in colori appropriati,
ne annuncia i luoghi con semplice gesto,
pienamente tutto amando
nell’ospitale offerta di orizzonte.
Ciò che di oscuro resta
è reso dallo sguardo dei veggenti
nella parola imparata da capo,
benché nulla sia prescritto,
benché nulla venga aggiunto.
Angelo Andreotti vive a Ferrara dove dirige i Musei d’Arte Antica e Storico-Scientifici. Nell’ambito della scrittura creativa ha pubblicato: Porto Palos, Book 2006; La faretra di Zenone, Corbo 2008; Nel verso della vita, Este Edition 2010; Parole come dita, Mobydick 2011.
Sue poesie sono state pubblicate in antologie e riviste, sia cartacee che on-line.
Fa parte del gruppo fondatore dell’Accademia del Silenzio di Anghiari.
Emanuele Canzaniello, prosa inedita “Patmos”, nota di Flavio Ermini
Recensione immaginaria di un film immaginario di Emmanuel Carrère (2014)
Emanuele Canzaniello ci parla di Patmos di Emmanuel Carrère e ci indica per prima cosa che si tratta di un film girato «come un documentario». «Di questo film si è ospiti» precisa Canzaniello. Gli crediamo e leggiamo il suo testo come una recensione cinematografica. Ma dobbiamo ri-crederci. Mano a mano che procediamo nella lettura, infatti, ci rendiamo conto che questo testo che abbiamo iniziato a leggere “come una recensione” va letto «come un documentario», proprio come il film. Non solo. Ci rendiamo conto che si tratta di un film immaginario, che Carrère non ha mai girato… Un gioco di specchi si svolge su uno schermo immaginario, lo stesso che si articola nella scrittura che Canzaniello, in una studiata divaricazione tra la vita mondana del turismo e le preghiere dei monaci scuri.
Si avverte nel testo di Canzaniello un’estrema cautela nel parlare di questi movimenti, una profonda vigilanza critica e in qualche punto anche l’insoddisfazione nei confronti di quanto va scrivendo, perché provvisorio, così com’è provvisoria l’immaginazione. Lo rivela nel finale, quando, abbandonando ogni finzione, Canzaniello si rivolge senza mediazione direttamente a noi lettori invitandoci a trovare la chiave di interpretazione di questo immaginario film.
In un estenuante corpo a corpo, noi lettori impariamo a esasperare la pratica del dubbio, un dubbio che fende come una crepa la comprensione della realtà, soprattutto quando l’immaginario prende il sopravvento.
Nota biografica di Emanuele Canzaniello
Patmos (2014) – Emmanuel Carrère
Un’ascesi mondana, e un’ascesa a Patmos, al monastero di San Giovanni Teologo. Una sequenza iniziale sul mare intorno all’isola, in traghetto, prima di arrivarvi. Celebrità monastiche, cocktail di anziane dame policrome che hanno conosciuto i ricordi di Dalmazio, dell’Impero mentre moriva. I signori possono accomodarsi, le mura sono bianche, la vista è splendida. Di questo film si è ospiti naturali. Stabilisce per noi parentele e filigrane di Albertine, fa di noi una fuga ed è lui stesso a fuggire da noi. A pochi fotogrammi di distanza, una festa, luci sul mare, qualcuno lascia suonare La Pianista, una signora impeccabile e guantata che entra in un peep-show e raccoglie e annusa un fazzoletto inseminato.
Girato come un documentario, Patmos, di Emmanuel Carrère è un movimento centrifugo di elementi biografici manipolati con grande abilità. Proprietario di una casa sull’isola, lo scrittore francese dirige la propria architetturale visione del promontorio e della vita eremitica. Vara un documentario di finzione, dove lui stesso più che recitare è in scena, abita il film, perché lui abita lì, in quella casa così simile all’omaggio di pietra che arrossa la punta del Massullo, la villa caprese di Malaparte. Ed è intorno alla sua casa greca e dentro le ville povere abitate dal mondo in un preciso momento di agosto, che scopriamo Dio. Nato dai materiali accumulati per un documentario sul monastero dell’isola, sull’ortodossia di croci e d’oro dell’estremo Egeo, il film conserva innumerevoli tracce di mosaico, tessere magnifiche, di quell’intento iniziale. Conosce i luoghi di preghiera e li percorre, ma è indifferente al gusto apocalittico che vende bene l’isola. Una severità piena di sole ne intaglia la fotografia. Per quella via in lamina d’oro si veste e celebra nel film una storia eccentrica, un elemento che altera il profilo del documentario spoglio. Ma del documentario conserva il mondo e in quelle pieghe si diverte a modellare abiti di taglio perfetto. Il coniugio è presto celebrato tra le feste liturgiche e la mondanità sacra, ma non è invadente, non è manifesto, è piuttosto casto. Ci si accorge appena che dall’ora del lavoro in monastero, si scenda la sera in giardini che ospitano il turismo celebre. Una conduttrice della televisione italiana o il re di Grecia, legittimo per sola discendenza, in legami di parentela con l’ultimo Luigi decapitato di Francia. Un lontano parente di cui parlare con affettuosa apprensione. Michel de Grece recitato par lui même, sodomizza il pubblico con la sua scatologia universale. Narra di come il mondo sia diviso e divisibile in tre ordini distinti, e di Patmos ne fa il modello miniato. Al vertice dei pudori e di tutti gli onori vivono les gens, incastonate nella grazia delle dimore di Chora, sotto le mura monastiche. Essi sono re e ricordi dei re, alcuni sono indicati invece come discendenze di lontane divinità, familiari al turchese delle mura di Babilonia. Poi vengono gli inglesi, subito dopo dio. Patrimoni non intaccati dalla perdita della schiavitù, i cui figli vivono di spiagge, chiari come la sabbia. Subito dopo gl’inglesi viene il pop, le celebrità inattuali, vecchie copertine, artisti e galleristi. Non digradanti ecco poi le mansioni del sesso d’alto lignaggio, la prostituzione museale e monumentale di gens raccolta lì da tutto il mondo. Riciclaggio e redenzione, liquidi indiscutibili e sempre accolti della finanza giovane. Su tutti il vero privilegio è la genealogia. Il secondo ordine è già gleba, costituito com’è da non-gens, da chi sostiene tutte le attività del creato. Michel de Grece dice di averla vista all’opera in un libro d’ore di stupenda fattura. Come tra la nobiltà e il popolo vi è il nulla, così il n’y a rien tra questi primi due ordini estivi, e in questo nulla solo il turista sopravvive, senza nascita, senza nome. La cosa più preoccupante, avverte il principe, è che tra i turisti ci sia chi aspiri a far parte della gens, una devianza che meriterebbe il carcere.
Al centro di questa come di tutte le conversazioni c’è Carrère, si parla con lui, e attraverso lui godiamo di una catabasi mondana, divertente, altera, perfettamente falsa, impassibilmente vera. Tra gli invitati, senza distrarci troppo, un giovane uomo dichiara di essere un rifugiato politico, di aver ucciso Berlusconi; non ha nemmeno trent’anni. Parla di un colpo di pistola, di azalee. Poi ci sono le bellezze, i più giovani sono ungheresi, armeni, così perfetti da sembrare appartenere a razze estinte, a ordini di templi mai riportati alla luce. Si prostituiscono, probabilmente. La tonalità dei gesti, il ballo quasi immobile e l’accoglienza dimostrata alle parole di alcuni anziani, e in alcuni casi, la posizione inginocchiata o semidistesa si fanno notare in mezzo agli alberi. Pisanello, una sant’Anastasia, qualcuno sta per partire, castelli traforati su in alto.
E in alto la vita dei monaci scuri, il sandalo e la preghiera. Non stupitevi di questa difficile amalgama, il film non soffre schizofrenie, anzi gode di questa studiata divaricazione e si dimostra molto prensile in entrambe le ricostruzioni, archeologica l’una quanto l’altra. Carrère prega con loro e si fa tramite dei due set, presiede alle duplici cerimonie, confonde i suoi ospiti e non impressiona gli eremiti, che lo lasciano stare tra loro come si fa con le mosche. E lui ricambia, per lo più non inventando storie; finge di ricordare quello che gli è stato riferito, di mettere insieme dei fatti sparsi, di circostanziarli in una forma che ha il gusto della conversazione, opposta e affine al silenzio suggerito dalla regola. Ma quello che conta è altro, il vero centro di tutto è il cuore di un uomo solo, il cuore dell’igumeno. Non uno sconvolgimento ma costantemente una meditazione, una meditazione su qualcosa d’invisibile al cinema. Una casistica minuta e una vasta teologia dell’amore; il profilo di un uomo invecchiato ma imponente, dalla barba in cui nidificano le Scritture, dalle labbra di vino. Il monaco igumeno dell’isola monastica ama e ama una donna, risorsa e ispirazione carnale. Non conosciamo il monaco, né ci viene presentato bene da Carrère, ma conosciamo lentamente il suo tormento. Non importa che egli ami, non è la tentazione il suo cardine, non il discrimine della carne e dei corpi, il tremore del film è la febbre ferma dell’amore che non può riaversi, non può riavere se stesso e non può cibarsi d’altro. L’abate ortodosso sa che nemmeno in confessione potrà rivelare ad altri il suo segreto. Sa che cedervi al pensiero è già colpa, eppure l’incessante grazia del film vuole altro, allude ad altro. In immagini e gradienti di silenzio è in questa natura di confessione impossibile dell’amore che è ospitato il materiale ottico ispezionato, allocato in quello scarto come nella vera cava dell’Apocalisse. Un incesto dell’animo con se stesso. Il monaco può accettare di amare, ma fuori di sé non può rendere nulla di quest’amore, può aspettare che passi. Restituire quest’attesa in pochi gesti, pochi volumi di corpi nello spazio, restituire la pace che può esserci sulla pelle segnata di una mano, sondare la preghiera come esorcismo contro l’amore, vedere quella condizione di sudore, questo conta nella singolarità dello sforzo filmato.
Conta meno che l’igumeno venga ritrovato morto tra le mura della sua cella, morto appena prima o appena dopo aver ricevuto la sua donna in confessione. Lascerò che seguiate da voi il finale, dopo la visione, a voi la scelta tra le due ipotesi che resteranno ancora in piedi: il suicidio prima che avvenisse la confessione o l’omicidio successivo.
Mario Campanino, dalla raccolta inedita "Vendesi uomo", nota di Laura Caccia
La dissoluzione dell’io
Nell’orchestrazione seriale, con cui Mario Campanino organizza l’impianto narrativo di “Vendesi uomo”, viene messo in scena lo smembramento dell’io, frammentato, fatto a pezzi, messo in vendita.
Dopo la premessa “Vendesi uomo / senza rima e senza uscita / del resto completo / e opportunamente disassemblato”, quasi un controcanto laico della silloge “L’angelo morto”, si assiste all’esposizione della merce corporea e umana, con annunci che alternano, con apparente distaccata ironia, mercificazioni e affetti, denuncia e tenerezza.
Solo l’anima non subisce lo stesso destino, forse perché irriducibile all’io o forse solo non a disposizione: “Non vendo anima / smarrita”, scrive l’autore.
Il procedere disincantato per negazioni e affermazioni, per rifiuti e adesioni non esclude però alla fine un atto di fiducia, anche se solo in un possibile amatore, poiché scrive Mario Campanino, al termine delle offerte di tutto quanto è stato smembrato: “Vendo istruzioni / di possibile riassemblaggio”.
Una fiducia nell’uomo, nel pensiero, nella parola? Una speranza che la premura possa riportare all’integrazione delle parti?
E cosa conta: ridare corpo e unità all’io, all’esser-ci di cui prendersi cura oppure stare dalla parte dell’anima, di ciò che non si vende e non si può frammentare, dell’essere irriducibile e smarrito?
***
Vendesi uomo
senza rima e senza uscita
del resto completo
e opportunamente disassemblato
sì segni di usura
no malfunzionamenti
causa cambio fede
e riduzione spazio
in relativo disimpegno
con realizzo di vuoto.
***
Vendo cervello
in buono stato apparente
uso pensieri buoni e cattivi
completo di subconscio e super io
controllo movimenti e linguaggio
gestione riflessi e semicoscienze
anadato qualche volta in sovraccarico
poi opportunamente svuotato
e ricondizionato per nuovo utilizzo
confezione in scatola cranica.
***
Vendo capelli
tonalità iniziale nero
sviluppo in variazioni castano
e cadenza finale bianco
salvo perdita componenti
in spazi tra righe in mezzo
per debolezza d’attacco
in contrasto con le cose fisse
come i motivi classici
e le vecchie paure.
Nota biografica di Mario Campanino
Giancarlo Stoccoro, poesia inedita "Non hanno scuse", nota di Marco Furia
Un illuminante dire
Con “Non hanno scuse”, Giancarlo Stoccoro presenta un calibrato componimento le cui chiare pronunce sono semplici eppure infinitamente complesse.
Si veda ad esempio:
“le derive fragili del paesaggio
luoghi assoluti sottratti alle radiografie”.
Qui si crea un’immagine poetica il cui immediato emergere tende a continui arricchimenti: si tratta di una raffigurazione dai profili definiti eppure aperti a complessità capaci di crescere con il procedere della nostra riflessione.
Non siamo al cospetto di un gioco di specchi né di un colpo di zoom o di un’osservazione al microscopio, bensì d’intense sequenze tali da mostrare innumerevoli implicazioni nel cui àmbito il lineamento linguistico si offre e, nello stesso tempo, promuove un divenire.
La poesia si conclude con i versi:
“quando la notte spezza le catene
e si fa per tutti sogno luminoso”,
ossia con un’immagine che dal gusto per il paradosso sembra estrarre un’intima esistenza che il lettore riconosce come propria.
Non è facile proporre connessioni di parole suscitando negli altri un’immediata adesione che non consiste nel mero significato, bensì in un’emozione condivisa.
Quella “notte”, ora, è la nostra notte e quel “sogno luminoso” è il nostro sogno luminoso: ci ritroviamo in un territorio linguistico in cui abitavamo da sempre senza saperlo.
Una persistenza esistenziale si è illuminata e noi l’abbiamo immediatamente riconosciuta: qualcosa, che c’era già, si è aggiunto.
Il lavoro dei poeti consiste nel rendere gli uomini maggiormente consapevoli, conducendoli lungo una via di conoscenza che si serve, anziché d’inflessibili nessi
causali, d’immagini e di suggerimenti, d’emozioni e di grumi di senso: lungo tale via ci accompagna la semplice complessità di Giancarlo.
Non hanno scuse
invitano a gesti plateali
le derive fragili del paesaggio
luoghi assoluti sottratti alle radiografie
ai parenti stretti alle memorie
in epigrafe sui muri
Fino a ieri contavano
ancora le appartenenze gli sguardi
rubati dietro al cancello le ombre
più prossime al sacrificio dei corpi
quando la notte spezza le catene
e si fa per tutti sogno luminoso
Giancarlo Stoccoro, nato a Milano nel 1963, è psichiatra e psicoterapeuta. Studioso di Georg Groddeck, ne ha curato e introdotto l’edizione italiana della biografia: Georg Groddeck Una vita, di W. Martynkewicz (IL Saggiatore, Milano, 2005), attualmente in traduzione in lingua spagnola. Da parecchi anni, oltre all’attività clinica, si occupa di formazione e conduce incontri sulla relazione medico-paziente secondo la metodica dei Gruppi Balint e ha pubblicato diversi lavori su riviste scientifiche.
Suo è il primo saggio che esplora il cinema associato al Social Dreaming (sognare sociale/ sognare assieme) che ha applicato in ambito sanitario, scolastico, nelle carceri e direttamente nei cinema: Occhi del sogno. Cinema e Social Dreaming (Giovanni Fioriti editore, Roma, 2012).
Ha frequentato intorno ai vent’anni il circolo letterario comasco Acarya e sue poesie sono presenti nell’antologia “Voci e immagini poetiche 3”. Ha partecipato al premio Lerici Pea 1988, vincendo la medaglia nati dopo il 1958, con la poesia L’ombra dell’aquilone premiata da Giorgio Caproni.
Sono state segnalate poesie sullo Specchio della Stampa (2/12/06) nella rubrica “Scuola di Poesia” e in “Dialoghi in versi” (17/08/2007) da Maurizio Cucchi.
Per le edizioni Gattomerlino/Superstripes è uscita nel giugno 2014 la silloge di poesie Il negozio degli affetti e in ebook presso Morellini Note di sguardo, tra le opere vincitrici del concorso internazionale Lago Gerundo 2014- 12° edizione, (presidente di sezione Giancarlo Pontiggia). È in corso di stampa per l’editore ticinese Alla chiara fonte la raccolta breve Benché non si sappia entrambi che vivere. Per Nomos editore è in attesa di pubblicazione la raccolta poetica Consulente del buio, con la prefazione di Giovanni Tesio.
Daniele Bellomi, da "Dove mente il fiume", Ed. Prufrock spa 2015, nota di Rosa Pierno
Un singolare pedinamento quello di Daniele Bellomi, in dove mente il fiume, condotto osservando l’evoluzione di un organismo e quella del linguaggio che, a sua volta, lo segue dappresso: “anche la fonte risultasse, fosse riconosciuta, prima / vede il primer, l’enzima, aspetta la ligàsi, legarsi, /leggasi”. Se nel linguaggio l’assonanza funge da similitudine, ma in maniera non fondata, che cosa avviene nello sviluppo dell’embrione “fino a quando la materia si compatta, diventa gelatina”? L’istituzione di questo binario d’indagine viene estesa a tal punto da far dubitare che esista contatto, tangenza, somiglianza tra materia (genericamente intesa) e linguaggio. Solo certi passaggi, fulminanti, che avvengono (“vediate, deviate”) consentono di coniugare le sponde altrimenti inaccostabili. Ma anche certe raffinate contrapposizioni colte sulla soglia del visibile: “si vede contro luce mentre ora, content, ancora contro, lei resta muta”. Ciò rende più complesso il quadro, pur tuttavia non se ne traggono concettualizzazioni esaustive: si disegna però la situazione di fatto, si rende visibile il modo in cui formuliamo il pensiero, ciò che creiamo con la famiglia delle somiglianze: il che è già un’enormità. Allo stesso modo, la traduzione tra idiomi differenti convoca un ulteriore problematico piano: quanto hanno di simile due concetti espressi in due lingue differenti “pleurer, è come pioggia”? Il corpo onnipresente, invasivo, tra il proprio e la protesi sul tavolo anatomico, diviene piano dove viene analizzata, auscultata, la propria identità. Sul banco degli imputati, è sistemata una società di massa deprimente e impoverente, che scambia make-up ed extention per valori. Ed è anche una ricerca dei valori quella che si dipana sulla pagina e che corrode come acido quando il genio poetico è in azione! Passaggi sorprendenti dalla sala operatoria alla sala cinematografica. Dall’organico al meccanico. Dove malattia del corpo umano è per estensione malattia del corpo sociale, assunto nella forma dell’immaginario collettivo o anche forma prescrittiva delle sue regole e dei suoi divieti: “ non riesco ancora a capire i divieti sulle sponde dei laghi” e “compio leggere deviazioni dalla norma”. Da questo deposito d’immagini che si forma sulla pagina, se sono rese esplicite le modalità di collegamento tra le varie forme di conoscenza prodotte dal pensiero, dalle percezioni e dalle immagini, resta peraltro altrettanto evidente il piano non omologabile, falsamente relato, almeno relato arbitrariamente, che introduce alla libertà, operando il passaggio tra un soffocante io, una soffocante collettività, e l’apertura stessa, tutta da sentire e pensare e vedere, fosse pure in assenza!
lftb
nonostante le ore spese provano a trovare lemmi,
captatio, ulne che macchiano le dita, materia per discorrere
di apparenze, fill in the blanks. urla: sono meduse e sono
dentro ai demos, poi soltanto filo, spinano l’urna, la carcassa
che conosceranno: escono dal tempo speso, tagliano filler
nella cartilagine, risulteranno come scarti da ciò che resta
nel vano della bestia, tirati via dal ventre, trasmessi dentro
ai tubuli, rimasti freddi nel contatto: carne bleu
perchè vediate, deviate dalla nuda consistenza, usando
il vostro fuoco se riuscite a credere sia giusto, se rimane
traccia sulla pelle, rash per cui qualcuno addenta roba
erosa dallo sfondo: che lo crediate giusto perchè si deve,
si vede controluce mentre ora, content, ancora contro,
lei resta muta, è assente, non può sentirvi.
dispose
parte la guerra dentro un margine di fuga, per dove manca,
sarà forse il marker del sangue che non c'era prima, preso
dentro a fare sfogo di se stesso. prendono a non guardare
più nel primer dello specchio: quello che resta è solo guerra
quando se ne andranno, pregando che tutto sia finzione,
disposti al ritiro degli assalti laterali. hanno una funzione:
arrivano diretti alle sorgenti radio, al solo prezzo reso
ormai possibile. passerà, dalla capienza al taglio netto
col presente; passerà, se dai terreni di coltura provano
il rilascio dei batteri, battery, catalizzando i resti dove
niente potrà essere di nuovo; passerà: circonderanno
le pianure per emettere un segnale, conosceranno
meglio la condensa dei campi, la frequenza dei carri,
ed archi, arches, protesi a fare voti irradieranno punti
vitali e non dissimili da gabbie, gathering. passerà, come
una spiegazione a caro prezzo, verrà per liberarci
di ogni cosa. funziona, per impulso, in ogni storia.
Daniele Bellomi (1988). Suoi testi, online, su “GAMMM”, “Nazione Indiana” e altri; in rivista, su “il verri” e “Trivio”. Vincitore del Premio “Opera Prima 2013”, pubblica il suo primo libro “Ripartizione della volta” coedito da Anterem edizioni e Cierre grafica.
Gian Paolo Guerini, dalla raccolta inedita "Un attimo prima di desiderare", nota di Giorgio Bonacini
Gian Paolo Guerini ci presenta una raccolta di duecento paragrafi, apparentemente in prosa, chiedendoci espressamente di considerare l’opera come un poema, dove ogni paragrafo, di diversa lunghezza per numero di righe, è un verso. Dunque un’architettura unitaria, non per visibilità, ma per composizione. Certo, non è cosa infrequente, oggi, nel panorama poetico che si apre a nuove sperimentazioni formali e sostanziali, proporre testi che si staccano dalla tradizione formale e sostanziale, comprese quelle d’avanguardia, e così anche in questo caso, l’intitolazione a “poema”, ha le sue specifiche implicazioni. Intanto non ne ha la struttura, né tradizionale né in variazione codificata o anarchicamente variabile, mentre si presenta con un sottotitolo, verificabile e vero, ma fortemente ironico.
Dunque l’intenzione dell’autore sembra appartenere a una sperimentazione complessiva della struttura e del senso pensante, incarnata in un’opera che deforma la significazione, ma senza toccare la grammatica o rompere la sintassi o il lessico. Sposta invece, in direzioni inedite, il sommovimento del dire nella sua comprensione intersoggettiva. E in merito al dire – in sé, come qualità fondante il sentire della scrittura poeta, e nelle specifiche modalità in cui si snoda questa raccolta – Guerini scrive:”...a volte è come una malattia...un’ossessione che non ti lascia mai la mente libera...”. Siamo, come si vede, dentro l’ascolto profondo di ciò che la scrittura sente; quindi all’interno della percezione propria del segno poetico. Un segno, inciso e corporeo, particolarmente speciale, che disorienta e ammutolisce un lettore che vi cerchi agganci semantici nominalmente riconoscibili. E ciò perché in questa raccolta tutto il discorso è su un piano di significazione altamente dislocato e disorientante, sia nei confronti dell’ordinaria misura del discorso sia rispetto a una lingua sensitivamente mossa come quella di ogni forma di poesia.
Ogni verso-paragrafo è una particella di concretezza surreale, che dà all’insieme l’aspetto interiore di una figura deformata, senza che questo impedisca però di proiettarsi all’esterno con naturalezza. L’ordine sequenziale propone e spesso imbriglia una selettività di motivi interni di ardua lettura. Un’oscurità necessaria però: perché dal suo interno lascia filtrare una luminescente nebulosa di sensi, che punteggiano un percorso, lampeggiando in direzioni inusitate ma percorribili.
E un’indicazione precisa della poetica di Guerini ci viene dal titolo di questa raccolta: Un attimo prima di desiderare, dove la mente poetica si trova in uno stato di coscienza e di presenza autoriflessiva, ma orientata verso il bordo e in procinto di un passo ulteriore. Un avvicinamento al baratro dove la parola perde suono, ma anche un avvicinamento al vuoto, che risucchia scombina e riporta a nuova vita i tratti distintivi significanti. Guerini ci dice che la scrittura è certamente un atto desiderante, ma che, mostrando la sua incompletezza, non può risolversi nel gesto desiderato: pur non raggiunto, ma sempre in tensione congiunta. Anche là dove affronta la contraddizione, o la nevrosi, che intimamente scombina la normale, prefigurata e comunemente sentita, come vitale alla poesia, realizzazione della pagina scritta. E infatti al quindicesimo verso scrive: ”Nell’attimo in cui le parole si sentono svanire, quale disdetta per loro, incarnarsi nel testo”. Ma nonostante questo, il poema, con estrema allucinata lucidità, continua. Vi si trovano motivi parabolici, vicini all’illuminazione zen, di de-significazione, sottrazione, diluizione, dissuasione del senso; momenti che sfiorano una lirica malinconia (...una nuvola in corsa sa sempre dove vanno i corpi nudi a chiudere gli occhi); elencazioni: motti, detti, quasi proverbi epifanici e cerebrali, che contengono, per inciso, frasi che inutilmente tentano di raddrizzarne il senso (nel languore, (le mattine a letto, senza rumori per strada, solo il ricordo della risacca mentre contemplo la neve che scende) l’ordito sopito polverizza l’insolenza); la lista dei venti che in scrittura soffiano con allitterazioni e rime, fonosimbolismi assonanti, consonanti, risonanti, che improvvisamente diventa bottoni, asole, isole e relitti che dialogano fino a diradare il loro dire, “eterni con la paura di non durare e immediati con il desiderio di svanire.">
***
Si prova sempre a limitare l’imitare. Per esempio, parlando del tempo: “Come
l’arsura che chiede d’essere placata, un sorso è la cucitura d’una camicia
annodata ai fianchi, d’una stesa tra il bucato in fiamme all’incrocio dei
venti: quello che si dice e quello che si tace fanno i giorni, e come i giorni
fanno la vita, gli istanti persi sono ritrovati, nei giorni andati e in quelli a
venire; qui, ora, può essere il passo che faccio verso di me; perché ogni
passo avanti è un passo in meno”. Ma ci si casca sempre: data per
definitiva la speranza, ci si arrabatta con le parole, come se potessero
parlarci.
O parlando di naufragi: “Nell’attimo in cui le parole si sentono svanire, quale
disdetta, per loro, incarnarsi testo. La parola scandaglia la sua cavità, in
bilico tra afasia e alienazione. Interrompe un passo e irrompe in un
sentiero inaffrontabile, gode prima di desiderare”.
Eppure, non posso dire di non avergli creduto, solo che ho ceduto alle lusinghe
dei libri, credendo di poterci trovare qualcosa che fosse qualcosa in più al
qualcosa che si incontra ad esempio nel tamponamento di un furgone
portavalori o a una pedalata tra la neve.
Per una lettura integrale dell'opera: http://www.gianpaologuerini.it/20_un_attimo_prima/pdf/un_attimo_prima_di_desiderare.pdf
Nota biografica di Gian Paolo Guerini
Giovanni Campi, prosa inedita "Tetr'agone m'usi che musica non m'usa", nota di Mara Cini
Maurits Cornelis Escher “con elevato virtuosismo tecnico” realizza le sue note illusioni spaziali, Giovanni Campi, almeno nella prima parte di Tetragone m’usi che musica non m’usa propone analoghe illusioni (non compiute illusioni verbali, però): Man mano che varcava la soglia, da cui n’era varcato, non sapeva più dire fosse dentro o fuori, ecc.
Insieme ad Escher arrivano sulla pagina tutti gli altri “indiziati”: Alice nello specchio, Le città invisibili e I destini incrociati, Samuel B. con il suo guscio pieno di vuoto, gli Angeli Sterminatori, la Tempesta, e Allen/Urlo...tutti insieme Padreterno e Figuranti a dire, sopra le righe, una geometrica celeste preghiera senza soluzione di continuità di notte il giorno…un quadro d’insieme ma senza insieme…
tetr’agone m’usi che musica non m’usa
Il Signore era ai quattro lati d’una figura che potremmo definire come un teatro da burattini, ma senza piú burattini né burattinajo, o come uno scacchiere, o scacchiera, ma senza piú pezzi: le torri, cadute, e no, né re né regine, né manco nel c’era una volta; del cavallo nulla, se non la mossa, ma no, nessuna mossa né altro da fare.
Agli angoli, avanti a sé, o dietro di, i pezzi di quella grantorre e di questa, la minuta. Come se la partita finita da sempre non fosse per altro mai stata giocata, erano pezzi del resto delle torri cadute, pezzi fatti a pezzi, rovine. Tra i resti di nulla ne immaginava alcuni come porte. Man mano che varcava la soglia, da cui n’era varcato, non sapeva piú ove fosse: se dentro o fuori. Qualora dentro, gli si diceva d’uscire. Qualora fuori, d’entrare. Talora si pensava dentro e fuori insieme, o fuor di sé e ritornato in sé; talaltra, riuscitone fuori senza per altro riuscire ad alcun ché. C’erano, ora li vedeva, gli occhi volti indietro, avanti, il passato da venire, avvenuto, e cosí il futuro, c’erano, ora li vedeva, altri resti, altre rovine: pezzi di scale, non tutti i gradini, no, solo alcuni, solo parti. Man mano che d’un grado saliva, man mano che d’un grado scendeva, non sapeva piú ove fosse: se sopra o sotto. Qualora sotto, gli si diceva di salire. Qualora sopra, di scendere. Talora si pensava sopra e sotto insieme. Senza soluzione di continuità di notte il giorno del, di giorno la notte del: si destava al sogno d’un quadro d’insieme ma senza insieme, luogo & tempo ora mai comuni, quasi la memoria, non facendosi storia, fosse disfatta in storie senza storia. Nel corpo a corpo d’anime animate in agoni d’agonía, forse già morte, forse mai nate, si destava al destarsi d’esse, anime dal corpus esangue che langue al presente dell’assenza; anime di ricomposte lame che, fredde, fredda d’un colpo d’una e tutte le colpe; animelame che, diacce, diaccia di tutte e una colpa, d’un colpo ferite, d’inferire nel conto alla rovescia: tre, due, uno, zero prima della fine, prima dell’inizio nel diritto del rovescio, nel diritto a uno, due, tre.
L’ultimo desiderio, prima della fine. Prima della fine del desiderio, non desiderare alcunché, che non possa finire, né possa finire di desiderare ancora. Ancora.
L’ultima parola, prima della fine. Prima della fine delle parole, non dire alcunché, che non possa finire, né possa finire di dire ancora. Ancora.
Ancora, prima dell’inizio. Prima dell’inizio del desiderio, non desiderare alcunché, che non possa iniziare, né possa iniziare a finire il desiderio. Prima dell’inizio delle parole, non dire alcunché, che non possa iniziare, né possa iniziare a finire di dire, di nuovo. Di nuovo.
Di nuovo si destò al sogno d’una rivelazione, ma senza averne memoria, se non come d’una profezia da inverarsi ancora o non piú, senza averne percezione, se non come d’un’oscura chiaroveggenza: ai quattro angoli della terra, questo guscio pieno di vuoto, quattro angeli o custodi. Forse, da un lato, gli angeli custodi, uno per ogni torre assegnata non si sa da chi, da custodire, e, dall’altro, gli angeli sterminatori, uno per ogni torre assegnata si sa da chi, da sterminare; forse i custodi della porta cui chiedere d’entrare, cui chiedere d’uscire, forse i custodi della scala, cui chiedere di salire, cui chiedere di scendere. Eventi rilasciavano e venti trattenevano, o, al contrario, il granvento del destino avanti ventava ad essi adesso, o ad uno soltanto; forse l’uno non era affatto uno d’essi, non era uno di nessuno, o sí, era uno di nessuno. Era ora il tempo ch’era stato: una tempesta, tradotta parola tradita dall’accento diviso, acuto senz’acuzie, grave senza gravità, suonosilenzio; una tempesta, tradita parola tradotta dall’accento gravido d’ogni ordine & significato, sí, ma avvolto nella volta del cielo in ogni disordine & gradus ad, in una e piú strofe all’ingiú volte, volte all’insú: una catastrofe, e piú. Nel cielo, la volta e i veli penduli nella volta di bocche spalancate dall’urgenza posteriore all’ultima preghiera erano sono e urlo, da disvelare e rivelare; saranno il nomade nome dell’ade, la monade d’abitare, da cui essere abitati, nella spiega da spiegare, dispiegare, ripiegare, a ché il significato sia solo sfiorato, sia solo tocco e toccato: a ché mani lievi suonino, d’uno strumento fatto di vento, una musica di gratia per ogni disgrazia. Era ora il tempo ch’era stato futuro: una tempesta, detta progresso. Era ora il tempo che sarà passato: una tempesta, detta regresso a infinito. Intanto che nel dolore implacabile ci si senta sentiti e che nel male incurabile ci si sappia saputi: per tutti i popoli oppressi, per tutti i morti, era ora il tempo che sarà per essere. (Pausa).
E che sarà? E che sarà mai? Sarà mai? Sarà ora? (Pausa). Sarà, ora, tempo? (Pausa).
(Tempo).
Giovanni Campi: suoi testi sono in rete (La dimora del tempo sospeso, Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, Carte Sensibili, Poetarum Silva, Versante Ripido, etc.) e in varie antologie; vincitore della settima edizione del premio MAZZACURATI-RUSSO, il suo libro d’esordio è il dialogo "l'irragionevole prova del nove" per i tipi della Smasher Edizioni nella collana "orme di teatro".
Annamaria Ferramosca, da “Ciclica”, La Vita Felice 2014, nota di Davide Campi
La lingua poetica di Annamaria Ferramosca è complessa e poco prevedibile, fondata sulle intrusioni, di forma e di senso: “…forme disperse disperate da deportare/in fili d’aria files” ma anche: “nascita che ritarda ancora/grido che non erompe/eppure ogni istante si rompono le acque/e terre dilavano in diluvio”.
C’è in molti dei testi un solido principio di necessità, posizionato all’inizio delle strofe, da cui la strofa stessa si sviluppa, allontanandosene a spirale, aumentando mano a mano lo spessore evocativo, per poi chiudere con un repentino riavvicinamento verso il mondo reale: “neve parola bianca/delicato peso che dice/l’usura della terra e preme/piano preme sui rami/per infinite lentezze da vendicare/-tonfi sulle auto lasciate sotto i pini-“.
E c’è un gentile e misuratissimo senso del dramma, mentre descrive di questo assalto caotico della vita, di questo di allarme perenne di cui siamo tutti oggetto, configurando perfino una qualche forma plausibile di redenzione: “…forse soltanto allora potremo raccontare/di atlantidi affiorate/di infiniti modi per sprofondare/uno per riemergere”.
Dalla sezione “Urti gentili”
***
mai più riproducibile o seriale
questa lingua vorrebbe solo arti-colare
bellezza tornare alla prima neve
all’origine sillabica del fiume
puro occhio
con la lingua vorrei solo esultare
soffrire delle cose sulle cose far luce
anche feroce - sventagliando laser -
o velarle le cose di compassione
coprirle scoprirle interrogarle
romperle corromperle
ammalarle infettandomi guarire
restandomi nella voce – irrimediabili –
i segni del contagio e della cura
Dalla sezione “Ciclica”
***
scavo a mani nude negli angoli
avida dietro vite minuscole
sul fondo la finitezza che disàncora
ci sarà un punto segreto su cui far leva
dove affondano le radici
si assestano le fondamenta
termine di terracielo confine limpido
dove culmina la vertigine ammicca il démone
da cui spiccare il volo
nella chiarità o nell’abisso?
Annamaria Ferramosca, salentina di origine, da molti anni vive e lavora a Roma. E’stata per alcuni anni cultrice di Letteratura italiana all’Università Roma3. Fa parte della redazione del portalepoesia2punto0.com, dove da alcuni anni è curatrice della rubrica non autoreferenzialePoesia Condivisa da lei ideata>. Ha presieduto il Premio di Poesia De Palchi- Raiziss e fatto parte della giuria del Premio Davide Maria Turoldo e del Premio Don Milani.
Ha pubblicato in poesia:Il versante vero, Fermenti, 1999;Porte di terra dormo, Dialogo Libri, 2001;Porte / Doors, Edizioni del Leone, 2002, traduzione inglese di Anamaría Crowe Serrano e Riccardo Duranti; Curve di livello, Marsilio, collana elleffe a cura di Cesare Ruffato, 2006;Paso Doble, Empiria, 2006, raccolta di “dual poems”> (poesie bilingui a quattro mani), coautrice Anamaría Crowe Serrano, con traduzione inglese di Riccardo Duranti ;> Canti della prossimità, silloge contenuta in La Poesia Anima Mundi, monografia a cura di Gianmario Lucini,
punto acapo editrice, 2011(con cd audio); Other Signs Other Circles (Altri Segni, Altri Cerchi ), raccolta antologica di poesie 1990-2009, Chelsea Editions,New York, collana Poeti Italiani Contemporanei Tradotti, 2009, Introduzione e Traduzione di A. Crowe Serrano.
Loredana Lacroix-Prete, dalla raccolta inedita "Aeriforme", nota di Laura Caccia
Nell’evaporazione dei sensi
È alla ricerca di una forma che non abbia forma, nella decomposizione della materia e nella dispersione dei sensi, la versificazione rarefatta di Loredana Lacroix-Prete in “Aeriforme”.
Come l’evaporazione di una sostanza allo stato gassoso o di vapore, tutta la vasta gamma di sensi e sentimenti che l’autrice mette in gioco, nel loro tendere alla rarefazione, parte da un punto di ebollizione sottostante.
I sensi hanno attraversato la terra e stati si direbbe di ebbrezza e ora l’udito si esprime, come leggiamo, attraverso “sfiniti / gemiti”, “sordi / battiti”, “suono / vacuo”, la vista in “rifrazioni // occhi / dilatati”, l’odorato in “incogniti / odori” e “sazie narici”, così come “evaporano / emozioni / di / scintille / vacue”.
La ricchezza delle percezioni sensoriali è scarnificata da Loredana Lacroix-Prete con aggettivazioni che spostano la terrestrità dei sensi all’assenza di forma propria dell’aria, l’eliminazione formale di articoli e preposizioni e la disposizione del testo contribuiscono a denotare la disidratazione del senso.
Senza, però, dimenticare che l’aria non è solo informe rarefazione ma anche principio vitale: se da un lato l’autrice evidenzia la “necessità di dissolversi”, dall’altro non può fare a meno di richiamare, pur nel mutismo della voce, ciò che “espande / di / infinite / forme / passione / morde / debordante / fiamma / cerca / respiro”.
1.
sazie narici
smembrano
coralli
invadono
nuclei
rotola
aria
mesce
vapore
6.
c o n t r a p p e s i
finzioni
irrigidiscono
membra
disseccata
e s s e n z a
imporpora
fluttuazioni
scarnite
10.
come onda
informe/sdrucciola
su
timpano
sigillo
gravidi
posticci
inverni
infervora
aria
insani umori
Loredana Lacroix-Prete è nata a Brindisi.
Le sue poesie sono decomposizione, immagini, frammenti, ricordi che s’inseguono in battere e levare, in un tempo monotono. La staticità di questo quattro quarti scandisce la dinamicità.
Aeriforme fa parte di un progetto di scrittura sugli stati della materia.
La sua prima raccolta pubblicata è Liquido (2014).
Gregorio Tenti, poesia inedita "Dell’immensa disfatta", nota di Ranieri Teti
Blanchot in esergo ci ammonisce, ammonisce tutti gli umani che “non sanno nulla dell’immensa disfatta verso cui vanno, ignari di se stessi”.
Gregorio Tenti, mediante la scrittura severamente controllata di questo poemetto tripartito, partendo da molto lontano, dove tutto è interno a tutto, ci porta poco a poco, attraverso quelle terre trapassate nel profondo e proseguendo il viaggio verso le bianche carcasse di eterno, a condividere il nostro destino prefigurato da Blanchot.
Fino alla stazione ultima, nel terzo tempo del poema, quello della risalita. Qui infatti partiremo di buon’ora e arriveremo / senza che il sole cali, sicuramente verso i luoghi di nuove superfici per la parola, probabilmente dentro l’ultima incertezza o verso l’inaspettato.
Qui il poetico sovverte le convenzioni. L’atto del poeta ancora una volta esprime la sua unicità, rivendica il diritto di innalzare alte difese contro il rapido decadimento di ogni cosa.
Quanto circonda un poeta può essere abisso oppure incanto: ovvero, ripensando al testo di Tenti, incanto dell’abisso.
Nota biografica di Gregorio Tenti
Gregorio Tenti, "Dell’immensa disfatta"
Non sanno nulla dell'immensa disfatta verso cui vanno, ignari di se stessi, nel brusio monotono dei loro passi sempre più rapidi che li portano impersonalmente con un grande movimento immobile. (…) Ma la caduta è forse questo, il non poter più essere un destino personale, ma la sorte di ciascuno in tutti.
Maurice Blanchot
I.
dalle intestina ci stringiamo al sole, noi lo siamo tutto è interno a tutto
verosimilmente una solarità invernale che resiste nuda a occhio umano, l’alleanza o ancora quel calore
che si vede concrescere al sole ampio delle sue grinze. le costole partoriscono alle folle
le tribù dai polmoni pieni di carne tengono l’estinto stretto per le sue resine - e noi generosi e scoscesi restiamo assolti ad altro intendere, interni ad altro parlare: uno stesso fiato dice di noi, vicini; di sé, della voce.
quella tessitura quel perlaceo digitare sarà materia di queste terre, le strade e le occasioni, quando sarà finito, diranno solo della nostra sparizione ne saremo portati come acque
per le parti quiete e le altre gravità
che causano persone - e riposate corna imbiancate -
il corallo sordo lappa ogni precauzione
e tu la veneri in saggi frammenti
non sia però questo riflesso impugnato non sia nulla, nonostante tu sia
mosso nel sole, da quando
sai di essere cieco, non visto altrove.
la città ha dieci ali di meshnet su cui far correre altri desideri. la chela dell’aria ci dissemina.
i senza vento gridano dai territori giunturali il canto immobile delle api immobili.
II.
Spinoza ebbe un figlio dalle viscere del mondo dai suoi
piedi luminosi - quelle terre trapassate nel profondo
dalle navi senza ventre; punisci ora te ne prego
i fiumi che il silenzio ha fatto cosa sola con le loro
cuciture. potremo, come dolci navigazioni allora
essere della pelle del mare
potremo rendere al sole le nostre schiene arcuate
ad ogni messa in acqua mattutina. ora non
abbiamo mani per proseguire
i fili delle nostre dita, la cruda terra che occorre
alle narici, la Qasba il favo aberrante
siamo gusci che vivono. ma ad ogni poro
una pista senza destinazione, il calibro
di tutta una vita.
andiamo lungo le bianche
carcasse di eterno - e loro cantano all’unisono
della cecità sottratta
che l’amicizia prenda le condotte
che maceri gli antichi minatori, dicono. ora
il soccorso invade e non passa.
III.
un giorno saremo in superficie, lì le cose
vanno meglio. incontreremo
tutti i vicini assieme, il loro torace immenso
che si articola e non saremo soli
un giorno dovremo andare.
partiremo di buon’ora e arriveremo
senza che il sole cali. lasceremo le stanze
aperte e le pareti dei nostri bunker piovosi; ci sarà chiesto di
dimenticare, lo faremo… in macchina
mi chiederai di cosa vivremo.
potremo anche morire, lo sai,
ma sarà facile. resteremo.
Ultima pagina, “Sonnambule” di Laura Cingolani, nota dell’autrice e una variante
Là dove tutto dorme sgorga come latte un getto sincero di coscienza, là dove è veglia affiora come automa il flusso misterioso di un canto. Le sonnambule sono creature che abitano l’interstizio profondo tra questi due stati. Vanno tentoni, cieche e visionarie, ricercano cenni e segmenti nell’ignoto, mentre con lento movimento il passo incede. Trasportano energia estetica necessaria alla propria esperienza, veicolano corpo e verso, il loro stato di trance decifra e genera enigmi.
L’arte, come forma di sonnambulismo consapevole, libera e trasmette un flusso guida, una voce fuori campo sempre in bilico che attraversa e che attraversiamo: per causa di, grazie a, nonostante, malgrado, al di là di. Tutto.

Opere esposte alla mostra Fragili guerriere:
SONNAMBULA
Poesia visiva - Acquerello su carta da disegno stampata – 2015
SONNAMBULA
Poesia tridimensionale - Uniposca su Lego - 2015
SONNAMBULA
Intervento su quadro recuperato - 2015
Gennaio 2016, anno XIII, numero 28

Trent’anni fa nasceva il Premio Lorenzo Montano.
Il passare delle epoche porta con sé mutazioni, smarrimenti, nuove possibilità. Anche per la scrittura. La vita letteraria, nelle sue varie manifestazioni, in questo trentennio è molto cambiata.
Piacevole è riconoscere che anche nel nostro tempo, proprio quello di adesso, la qualità della poesia rimane intatta: questo testimoniano poeti e prosatori presenti nel nuovo numero di “Carte nel Vento”, tutti introdotti dalla redazione di “Anterem”, selezionati dalla scorsa edizione del Premio.
Nel mutamento delle epoche restano intatte molte questioni legate alla poesia: riesce a raggiungere la meta che indica, riesce a colmare il vuoto che racconta, riesce a seguire i richiami che capta?
Nel cambiamento dei mezzi comunicativi rimane intatta la densità delle opere: forse il miglior viatico per il 30° “Montano”, a cui invitiamo poeti e prosatori per proseguire questa lunga storia.
scarica il bando della 30^ edizione
Giuseppe Nava, dalla raccolta inedita “Nemontemi”, nota di Giorgio Bonacini
Il filo che lega queste testi in un poemetto che, fin dalle prime parole, evidenzia una sua lenta e dolente osservazione e interrogazione, inizia da una notazione storica: il calendario azteco che chiudeva l’anno con una coda di cinque giorni, detti nemontemi, da cui il titolo dell’opera, che oscuravano e quasi bloccavano la vita e le attività umane fino al nuovo e rassicurante inizio d’anno. Questo è il luogo metaforico, ma concreto e denso di sostanza, in cui l’autore immerge il suo soliloquio: fatto di parole che sembrano un mormorio di precisazioni malinconiche, un percorso ondulante, morbido, una lenta marea dove la tensione di una tristezza chiusa si avverte sia nelle notazioni esteriori sia nei passaggi interni, lì dove la misura del vedere, del pensare e del sentire “vibra e trema a ogni passo”. E scegliere un luogo temporale di sospensione e paura come centro propulsore della propria scrittura è già di per sé una scelta poetica, perché va ad immergersi e alimentarsi nelle passioni umane che faticano ad uscire e si intorbidano, e spingono prima ancora di aver detto ciò che si incaricherà la poesia di dire. Il lavoro della lingua poetica, con le sue proprietà di espansione e compressione, è l’unico in grado di crescere, imprimersi e liberarsi come forma di vita. E lo fa con un andamento continuo, come se scivolasse in un magma, ma senza cercare agganci per fermarsi.
Nel poemetto c’è un tu, c’è un io e c’è un noi, ma si ha la sensazione che questa intersoggettività sia soltanto un’illusione: quella di chi vuole e sa di interloquire con il mondo, ma questo, invece, altro non è se non il riverbero di un vuoto un “immaginarci senza”. Ed è in questa zona ancora indefinita che Giuseppe Nava entra: tra inquietudini che sembrano non avere né principio né fine, ma un incessante movimento centrale: un gorgo in cui i sentimenti, le emozioni, le visioni, le domande e le frasi stesse che scrivono questo affondano, e risalgono senza boccheggiare, come se respirassero anche sotto o non respirassero affatto. Oppure sembrano svolgersi da una matassa di suoni, di voci dove qualcosa si prende e si accoglie, ma anche qualcosa si lascia e si perde.
Qualcosa nel ricordo del perché si è qui: da quale segno, gesto o senso si arriva; “da quale testo mai scritto”, chiede il poema “abbiamo preso le parole” che ci conducono. Un perturbante insaputo avvolge quest’opera; e involge il lettore dentro l’assillo di un’oscurità senza riflesso alcuno; e nello stesso tempo lo coinvolge senza possibilità di sottrarsi. Perché questa poesia non vuole restrizioni intellettive, blocchi concettuali, ma solo pensosità: pulsazioni significanti che, nel fluire dei versi, prendono distanza come “particelle irrimediabili” stelle lontano che pulsano.
Un universo poetico il cui centro irradia le significazioni visive di un corpo di corpi attorcigliati: uno spazio guardato come si guarda un oggetto vivo ma quasi non umano. Infatti, se si osservano le parti che si intrecciano in linee rette o spezzate, in curve ripiegate o stese, il tutto appare percepito con una strana lontananza, taciuta o in atto di estinguersi “a ogni sonno”.
E’ questo che fa il poeta: scopre nell’esistente ordinario un disordine creativo che non combacia e sborda, rimodulando il segno emozionale e conoscitivo. E lo fa con la consapevolezza (a volte inspiegabilmente incosciente) che la frantumazione del visibile e il suo scivolamento in anfratti invisibili, non ancora detti ma temuti, serve a “sorreggere il passo verso il nulla” : dove le cose emergono in forma e senso indistinti. Lì, in quel luogo di timore e in quel tempo di vacuità, Giuseppe Nava trova e ci esorta a trovare la parola giusta: quella che chiama piano e quasi viene inghiottita prima di essere detta, eppure dice e parla “oltre le ombre che noi siamo”.
***
se ne va il veleno a poco a poco
da quei cinque giorni innominabili
si sposta l’asse delle cose amate e dà vertigine
per noi che ci vediamo nello specchio che fuma
si raggrumano risposte, si staccano le croste
dalla pelle tatuata, si incide la ferita
e si succhia via il veleno, a poco a poco,
non fa male dici, ma l’anno nuovo
deve ancora incominciare
***
cose, mi hai detto, che ho colto tra le spugne del sonno,
cose mai dette, infilate a forza in una ragione,
circoscritte allo schema, ridotte all’etichetta consueta
delle stagioni e le loro promesse, cose, che scivolano via
se l’incoscienza delle forme dona grucce o stampelle
a sorreggere il passo verso il nulla, cose,
che l’inciampo lascia a terra a sanguinare,
e con il sangue disegnarne la memoria che ogni volta
mi scuote la testa in una smorfia, un tic, un no
detto ad alta voce
***
abbi cura di cancellare ogni traccia
i nomi le firme i numeri, confondere le prove e i residui
senza spezzare i rami, camminando all’indietro come gli indiani
sugli stessi passi, sulle impronte, fino a sparire
nel folto dell’ombra
Giuseppe Nava è nato a Lecco nel 1981 e vive a Trieste. Ha pubblicato Un passo indietro (LietoColle 2009) e Esecuzioni (Edizioni d'If 2013, Premio Mazzacurati-Russo). Tra il 2010 e il 2013 suoi testi sono stati pubblicati sulla rivista «Inpensiero» e, in rete, su Absoluteville, Poetarum Silva, Nazione Indiana. Ha curato (con M. Cohen, V. Cuccaroni, R. Renzi, C. Sinicco) l'antologia di poesia dialettale L’Italia a pezzi (Gwynplaine 2014). È redattore delle riviste «Bollettino ‘900» e «Argo». Dal 2012 collabora all’organizzazione del Trieste International Poetry Slam.
Franco Falasca, poesia inedita “Tu che non esisti”, nota di Marco Furia
Un indicibile bersaglio
Con “Tu che non esisti”, Franco Falasca propone un componimento il cui evidente espressionismo sembra quasi sconfinare nella vera e propria invettiva.
La parola è uno strumento e, usata in una certa maniera, può assumere l’aspetto di un’arma o, comunque, di un proiettile lanciato contro qualcosa o qualcuno.
Verrebbe da pensare contro quel “Tu che non esisti” con cui si apre la poesia, ma, a dire il vero, l’individuare con precisione il bersaglio non pare l’intento del poeta e, dunque, non deve essere quello del lettore.
Tre versi, in particolare, hanno suscitato il mio interesse:
“immerso nelle viscere delle distanze
lontane come l’infinito misurato da un metro
da sartoria”.
Pronuncia non estranea a un surrealismo che definirei esistenziale per il bagaglio di difficoltà del vivere che porta con sé: il poeta si sente sprofondato entro “viscere delle distanze” lontane e non assoggettabili ad alcun tipo di misurazione.
O meglio, di misurazione comunemente accettata, poiché, se al “metro da sartoria” si sostituisse un altro strumento, forse potrebbero emergere alcune connessioni utili a far uscire il Nostro dallo stato d’inquietudine in cui si trova.
Anche la misura è un linguaggio e, a volte, occorre saper costruire modelli maggiormente adatti alla bisogna? Sì ma, in questo caso, quali?
Domanda che non può trovare risposta in un componimento il cui intento evidente è quello di porre un’assillante questione e non di risolverla.
Siamo dinanzi alla sincera testimonianza di un’umana trepidazione che, forse, proprio nel trovare uno sbocco nel dire poetico, trova la possibilità di non diventare assiduo (insopportabile) tormento.
Al penultimo verso, non a caso, Franco parla di una sua provocazione “da artista” che, a mio avviso, illumina un’insofferenza patita ma anche desiderosa di essere condivisa, nella convinzione che il comunicare le proprie sensazioni ed emozioni sia, più che un desiderio, un destino.
E all’umano destino il Nostro è certamente molto interessato.
Franco Falasca, poesia inedita “Tu che non esisti”
Tu che non esisti
Tu che non esisti
che non hai voglie
che non hai spessore
che non hai luce
che non hai vigore
che non hai occhi
che sei questa luce assente
questa voglia di niente
che mi hai gettato in questa esperienza
di nulla
condito come un’insalata
credendo che io lo credessi
ma non l’ho creduto
non l’ho digerito
non l’ho vissuto
e ne chiedo il conto
di questa imbecillità responsabile
in questo nulla di fronte a te
che sei il nulla ed il buio assoluto
in questo tentativo di far nascere
qualcosa da qualcosa
che io non ho creduto e che tu non credi
e non vedi
e non annusi
in un turbine di fumo carbone ed ossa
immerso nelle viscere delle distanze
lontane come l’infinito misurato da un metro
da sartoria
ossessionato da sentimenti inesistenti
da inesistenti palpebre
da inesistenti voglie
imbecillità pulsante
restituiscimi altra luce ed altra ragione
o genio vigliacco ed
imbroglione cosmico
che ridi alle spalle
seduto al bordo di immense materie
su cuscini di morbidi atomi
vomitando teorie di questa cloaca
che la coscienza sbrinata
smembra come cellulosa umida
di cui so godere
ma lontano
che so scrutare senza sguardo
che vedo con nitidezza
assente
che adoro inesistente
che assumo da imbecille
che derido da genio
che aspiro da spaurito
che temo da ignorante
che venero da retore
che denigro da uomo
che calpesto da animale
che inseguo da giovane
che annuso da filosofo
che descrivo da poeta
che aggiro da amante
che soppeso da venditore
che spremo alla pari
che disprezzo da vendicatore
che imito da religioso
che mimo da malato
che introietto da attore
che ignoro da figlio
che provoco da artista
che esalto da scienziato.
Franco FALASCA
Nato a Civita Castellana (VT), vive a Roma. Ha prodotto, oltre a poesie e racconti, anche poesie visive, films super 8, video, fotografie, performances. Ha organizzato rassegne e manifestazioni.
Nel 1973 fonda (con Carlo Maurizio Benveduti e Tullio Catalano) l’Ufficio per la Immaginazione Preventiva con cui collabora fino al 1979; partecipa come artista alla Biennale di Venezia 1976. Suoi testi e materiali vari sono stati pubblicati, oltre che nei cataloghi delle mostre alle quali ha partecipato, anche su varie riviste ed antologie e nei volumi:
UFFICIO PER LA IMMAGINAZIONE PREVENTIVA <file:///F:\web\francofalasca\uip\uip.htm> (con Tullio Catalano e Carlo Maurizio Benveduti) - a cura di Filiberto Menna, Massimo Marani Editore, Roma, 1976
"UNA CASA NEL BOSCO - Prose e racconti", Edizioni Latium/Ouasar, Roma, 1990, vincitore del Premio Letterario Orient-Express 1990“NATURE IMPROPRIE (poesie 1976-2000)”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2004, vincitore del Premio di Poesia Lorenzo Montano XIX edizione (2004-2005) della Provincia di Verona
“LA FELICITA E LE ABERRAZIONI (poesie 2001-2010)”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2011
Stefania Negro, prosa inedita “Il pittore dei colori”, nota di Flavio Ermini
Il protagonista del racconto di Stefania Negro è un pittore. È un artista che si affida alla molteplicità dei colori per interpretare il mondo. Ma la vita gli riserva una sorpresa. A causa di un danno cerebrale la visione del mondo diventa improvvisamente in bianco e nero. Le foglie che cadono si sono trasformate in leggeri fiocchi di neve. Il mondo sembra sfuggire a ogni definizione. Ma a questa sorpresa se ne aggiunge un’altra. Pur essendo la realtà priva di colori, il “sentire” non è mutato. Non è cambiata la percezione delle cose.
La lezione qual è? La lezione è che non sono necessari i colori per immergersi nella realtà, per riunirsi con l’arché, per confondersi con la matrice originaria, per transitare nell’essenza delle cose. Non importano gli strumenti, non importano le modalità della vista, così come non contano le qualità del tatto e degli altri sensi. Ciò che conta è il “sentire”. E le modalità del sentire sono immutabili.
Brandelli spaziali, frammenti temporali del mondo li possiamo cogliere indipendentemente dalla qualità dei sensi. Nella loro complessità li possiamo percepire sempre e comunque nel fondo dello specchio mentale. È ciò che fa registrare a Kafka: «Sono grigio come la cenere. Desidero scomparire tra le pietre». Insomma, è necessario prendere coscienza dell’inutilità degli “strumenti” nella percezione. È come vedere dopo aver cercato semplicemente di scorgere.
Guai all’abbandonarsi alla cieca fiducia dei dati forniti dalla qualità dei sensi. All’origine del rapporto di scambio fra soggetto e mondo c’è l’alleanza fra sentimento e pensiero. Stefania Negro ci dimostra che è proprio a questo punto che i colori perdono la parola e la lasciano al sentimento.
IL PITTORE DEI COLORI
La luce anima il mio sguardo. C’è una fierezza nei colori che si diffondono come miele , è vita dissipata nelle forme ed è una grande energia di trasformazione e di divenire che non ha una precisa definizione. Ora vedo l’albeggiare, la luce che si confonde e si conchiude nella brina e il volo di questo mirabile uccello, con le piume striate, che si libra in alto. Questo è nettare, nettare di vita, questa vita che si consuma nella dissipazione, odio, certezza, incertezza, trama, voluttà, mistificazione, bisogno, necessità, tolleranza, comunione … vorrei essere proprio quel dispiegamento d’ali, provare la vertigine … ordire l’impossibile, significare l’essere … eppure se sono qui è già realizzata la mia piccola infinita partecipazione al mondo. Voglio che questa cifra d’essere si rappresenti nella tela, voglio che sia significato, voglio che sia colore che scivoli ad oltranza sul margine infinito della forma, della radice ultima dei numeri concreti che si fanno astratti in arte sebbene tutto alla fine si riassume in un meraviglioso congegno di energie che prende origine dal caos e dal firmamento e si applica alla molecola e al quanto. Ora voglio essere io e far parte del tutto, ora voglio sentirmi il colore stesso dei miei dipinti. Rosso, rosso vermiglio perché così è la vita, il sangue, dono mirabile che ci scorre nelle vene, blu e nero come la notte e poi qualsiasi elemento cromatico che mi faccia partecipare all’essere. Esse est percipi diceva Berkeley. E non solo percepire ma soprattutto sentire, sentire, sentire ogni brivido sulla pelle. Ora voglio provare il brivido naturale dell’esserci e comprendere che ogni cosa ha una sua natura e una sua matrice, sentirmi come un fiume che scorre e nulla d’altro, come un fiume di colore per poterlo rappresentare. Voglio delineare il volo, l’istinto intimo di ogni creatura ad essere oltre eppure parte del tutto come una nota in una composizione musicale. I pennelli accarezzano la tela, i pennelli col colore imprimono l’esserci, lo spazio, il tempo, i pennelli danno la forma , i pennelli sono prolungamenti della mia esistenza, del mio sentire, dicono il mio sguardo sul mondo , rappresentano le mie emozioni forti, intense, insopportabili per il cuore e per la mente , insopportabili perché cariche di vita, talmente cariche da procurarmi dolori al petto e tachicardia, io sento e perché sento dipingo e i colori sono la manifestazione del mio esserci. Amo la vita, temo la vita, amo la vita ad oltranza nonostante il carico di delusioni e di amarezze infinite. I miei compagni di viaggio sono tutti coloro che sentono come me, oltraggiati dalle vicende umane ma difensori dei valori, nessuno respira e talvolta ansima la vita come coloro che più ne sono partecipi: artisti, folli, sognatori … ecco sognatori. Ebbene la vita è ciò che sogniamo o ciò che viviamo? Il nostro mondo interiore o l’esterno in cui siamo proiettati, a volte gettati come palle di un cannone. La tela non è che lo spazio bianco su cui si diffonde il mio sentire, sentire l’horror vacui a volte ma anche la pienezza d’esistere, la pienezza dell’esserci che alcune volte mordiamo con troppa forza come in attesa che il nostro spasimo diventi energia e l’energia evento, attimo in cui si produce la nostra vita.
Si rappresenta così il mio esserci: sulla tela.
Organizziamo le nostre vite ma l’imponderabile ci richiama continuamente al sentire che tutto è imperscrutabile.
Il colore è tutto, è la mia matrice d’essere.
Guardo la tela mentre penso e dipingo e vedo il diluvio del colore che straripa, che dirompe…
Lascio i pennelli. Prendo un caffè bollente ed esco in macchina per raggiungere il supermercato fuori città. La tangenziale è dritta e stranamente poco trafficata. Guido a velocità regolare vedendo l’asfalto scorrere innanzi a me senza sosta poi improvvisamente mi appare un’esplosione, sembra un fungo atomico. Non riesco a capire cosa stia accadendo. La testa mi fa male, è un male acutissimo. Accosto in un’area di servizio. Mi guardo intorno…….cosa accade? Tutto è così strano, strano veramente, tutto è senza colore. Solo bianco, nero e maledettissimo grigio.
Scendo dalla macchina e chiedo al benzinaio : “Ha visto l’esplosione?” “Quale esplosione?” risponde guardandomi stranito.
“ Quello strano fungo atomico…non vede non c’è più colore”.
“Guardi credo che lei non stia bene, non è accaduto nulla…”
Sono inferocito, mi sento preso in giro, mi guardo intorno e chiedo ad un passante, ad una donna che esce dal bar dell’area di servizio, ad un uomo grasso che sta fagocitando un panino. Tutti sono perplessi. Nulla, proprio nulla è accaduto. Qualcuno chiama un’ambulanza che non tarda ad arrivare.
Sono impietrito, sconvolto, incredulo, non ho spiegazioni. Non sono in grado di spiegare bene l’accaduto neanche ai medici del pronto soccorso.
Accertamenti, risonanze, tac, elettroencefalogramma.
La diagnosi. Un medico mi guarda e con voce calma e ferma mi dice che ho subito un danno nelle aree cerebrali corticali visive, le aree legate alla visione del colore. Altri danni cerebrali gravi non ce ne sono mi rassicura. Ci sono stati altri casi al mondo.
Una vita senza colore? Un realtà percepita solo attraverso sfumature di grigio? La legge del contrappasso? Il mio eccessivo amore per il colore…
E’ tutto così assurdo. Anche il silenzio è assordante. Cosa dipingerò ora? Uno spazio grigio, a volte nero, a volte bianco? Un’assenza? Un vuoto?
Una trappola enorme mi ha teso il destino. Ho sempre creduto di poter affrontare tutto, di sconfiggere la malasorte, basta volerlo dicevo a me stesso. Basta volerlo.
Mia moglie mi guarda dritto negli occhi, mi stringe le mani fra le sue senza dire nulla, non servono parole. La radio trasmette la mia musica preferita. La legna nel camino arde e fuori oltre la finestra cadono le foglie, sembrano neve, leggeri fiocchi di neve di un bianco accecante.
Chiudo gli occhi e provo a capire il senso di questo accadere.
Schiudo le ciglia, scopro che tutto è diverso, diverso da prima, senza colore, eguale invece è il mio sentire.
Stefania Negro (Lecce, 1965) è autrice di testi poetici, saggistici e critici. Incoraggiata nella sua ricerca poetica da Edmond Jabès, Andrea Zanzotto, Edoardo e Vera Cacciatore, esordisce nel 2007 con Fili di luce compresi negli archi del divenire (Cierre Grafica), con una riflessione critica di Bruno Moroncini. A Roma collabora con Empiria, tenendo conferenze e seguendo il lavoro redazionale della casa editrice. Si occupa di giornalismo e sceneggiatura. Un suo cortometraggio, realizzato con Corrado Franco e Sofia Volpe, giunge finalista al premio internazionale indetto da Cinecittà Internet Film Festival. Collabora con riviste specializzate, tra cui, in particolare, “l’immaginazione”. Un suo contributo teorico, Tutor nei corsi di formazione, è presente nel libro Le remore e il Titanic, vite precarie a scuola, a cura di Luca Antoccia, con prefazione di Tullio De Mauro. Nel 2009 pubblica il saggio filosofico-letterario Erranze nel divenire nella collana “Pensare la letteratura” di Anterem Edizioni. Sempre per Anterem, nello stesso anno esce la sua raccolta poetica La geometria della luce, nella collana “Limina”. La sua terza raccolta poetica appare nel 2011 con Manni Editori, raccolta con la quale partecipa a un reading di Italia Wave Festival, rilasciando un’intervista presente sul sito Rai (edizione Risonanze). Nel mese di luglio 2014 è uscita con Anterem Edizioni nella collana “Limina” la sua ultima raccolta di versi dal titolo “Oscillazioni”.
Marco Pacioni, da “Il bollettino dei mari alla radio”, Aguaplano 2014, nota di Rosa Pierno
Che sia quasi esclusivamente una scrittura che abbia come suo orizzonte la meta- poesia, lo dimostra il fatto che in Il bollettino dei mari alla radio, di Marco Pacioni, qualsiasi dato empirico viene riportato alla sua rappresentazione sia letteraria sia visiva, e lo stesso titolo in qualche modo ne rappresenta la cifra: “e naviganti e pescherecci arrugginiti / lungo le coste italiche / e putti soffianti i nomi dei vènti / sulla carta geografica immaginata”. Una riflessione sulla poesia fatta con le vive voci dei poeti (i quali sono invitati a comparire sulla pagina con citazioni o intere poesie), la quale disegna una costellazione di riferimento. L’interesse è forte, dunque, anche verso una poesia polifonica, poiché, come afferma lo stesso Pacioni, il tu esiste prima dell’io. Ma è anche una riflessione che s’incarica di fare il punto sul medium, ancorché poi la poesia venga messa costantemente a confronto con l’opera d’arte. Si veda il richiamo al Pontormo: “stinge il colore / che a tratti / barbaglia / e sembra ridere nella figura / che scontorna”. Se “poesia è fatta per andare / non per restare / disperata allucinazione / paradiso artificiale”, alle immagini artistiche, nella silloge, è affidato un ruolo di puntello, di sostegno. La cartografia culturale che segna, tramite citazioni, i gangli di molteplici percorsi, definisce contemporaneamente, con puntualizzazioni concettuali una sorta di legenda, di memento, quasi una precettistica del ruolo dell’intellettuale (“schiarire il senso il vero”) da tenere a mente: “e la paura di sembrare loro / solo prima contro coro”, ma da sottoporre, anch’essa, a dubbio. Sebbene ci siano delle soglie, le quali, come in ogni vero sistema morale, non bisogna oltrepassare: “e no / non imparare mai / mai la lezione / l’eccezione il male minore / l’autorità necessaria / e il mercato che decide”. Il che, inevitabilmente, trascina con sé anche una critica della cultura, come quando Pacioni segna il baratro tra l’abolizione del limbo ”per gli infanti non battezzati” e il discrimine reale operato dai centri di accoglienza. La critica alla cultura è inevitabilmente critica al sistema sociale che la produce: “kit e brochure / di villaggio tour e colonia penale / per la vacanza / al tempo sospeso nell’evo capitale”. E, quando è presente la natura, lo è già in forma mediata, poiché anche la natura è dato culturale.
***
mar làmina
la spiaggia una legnaia abbandonata
che il moto rode
non guardare solo avanti
la battigia non ha limiti
ma elementi
mare e terra a latere
acqua che s’insabbia e spuma
altr’acqua che sduna
la secca e s’impolla
lasciando biche d’alghe
che i passi sfasciano e rifanno
vedi
né chiama né
così ogni origine si disperde
così l’inizio
addossato ad ogni appresso
scatenata catena
ondata
è il ritmo
***
da una parte all’altra della foto
tu sforbicia
lungo il filo spinato
e ricongiungi i lembi del taglio
sì, rimargina
sì, la cicatrice rimane
***
in treno
nel dopo
guardato su un vetro
viso alberato a viso
caseggiati e passanti
e tutto
in fuga per stare
tra la ferrovia e la statale
la riva e là oltremare
Marco Pacioni (1974) è dottore di ricerca in Italianistica e ha insegnato Lingua italiana, Letteratura, Storia medievale e rinascimentale presso diversi istituti universitari fra Italia e Stati Uniti. Autore di numerosi saggi accademici, ha curato l'edizione de La condanna a morte di Pietro Paolo Boscoli di Luca Della Robbia (Quodlibet 2012), delle «Poesie scelte» di Michele Ranchetti (Anterem 2008), è fra gli autori del volume «Dante, Petrarca, Boccaccio e il paratesto. Le edizioni rinascimentali delle tre corone» (Edizioni dell'Ateneo 2006) e del libro su Proust Dalla parte di Marcel (Clichy, 2013). Ha in preparazione uno studio sulle neuroscienze in rapporto all'estetica e un saggio sul filosofo Giorgio Agamben. Attualmente collabora con «il manifesto» e con i periodici «Lo Straniero» e «Alfabeta2». Ha pubblicato poesie in lingua inglese su riviste americane e libri d’arte. Il bollettino dei mari alla radio (Aguaplano 2014) è il suo primo libro di poesie.
Roberto Valentini, poesia inedita “Anche il ricordo del tuo bel vestito”, nota di Ranieri Teti
Con la poesia di Roberto Valentini entriamo nella precisa fusione tra suono e senso; qui la forma del sonetto non è una rigida gabbia, il guscio entro cui abitare sopravvivendo poeticamente.
Nella capacità generativa della lingua convivono termini classici rivisitati e inedite aperture al senso.
Due sono i registri che Valentini ci apre: la portata emozionale del testo e, sullo stesso piano, la sua trasposizione al reale.
Così si procede da “un vago requisito degli occhi”, attraverso le “orchestre dei sensi”, fino all’“euforia che sequestra il pensiero”.
C’è in questa poesia una costruzione che, parola dopo parola, porta a una continua sospensione che diventa, verso dopo verso, tensione.
Nella tensione che anche grazie agli enjambements viene creata, si prepara un terreno fertile per far risuonare le parole secondo i canoni della loro più vera espressività. Nella loro verità che, attraverso la sonorità del verso, genera un senso nuovo e ulteriore.
Qui infatti il ricordo non procura dolore, viene sigillato per sempre, per sempre cristallizzato in un tempo determinato.
***
Anche il ricordo del tuo bel vestito
color cinabro come la parete
di questa mia stanza, induce la sete
di cercarti in un vago requisito
degli occhi. Dal lampadario un tinnito
segnala i tuoi rintocchi. Quali mete
diranno dove le nostre incomplete
speranze troveranno lo spartito,
gli attimi più giusti, una melodia
di tumulti, diffusi fatalmente
da orchestre dei sensi? Nell’euforia
che sequestra il pensiero e più irriverente
dei nostri animi fiuta l’anarchia,
forse sapremo che anche il mondo è niente.
Roberto Valentini, nato a Milano, dal 1999 lavora come insegnante nella scuola secondaria superiore e sopra(v)vive a Bernate Ticino, al confine occiduo della provincia milanese. Laureatosi in filosofia all’Università degli Studi di Milano, ha collaborato con la cattedra di Storia della filosofia contemporanea II quale redattore della rivista “Magazzino di filosofia” diretta dal Prof. A. Marini; attualmente, oltre a proseguire tale attività, è fra i curatori del relativo sito web di filosofia contemporanea (www.filosofiacontemporanea.it). In questi anni ha pubblicato, fra gli altri contributi (recensioni e florilegi), saggi sull’insegnamento della filosofia, sul cinema di Kubrick e Il gesto di Alcesti (“Magazzino di filosofia” n. 19/2012), una interpretazione letteraria di alcune tematiche della riflessione di Maurice Blanchot (nell’ambito di una collana della rivista è in corso di stampa il testo ampliato, unitamente ad un altro poemetto). Ha presentato un proprio lavoro nell’opera collettiva Vita, concettualizzazione, libertà (Mimesis, Milano, 2008).
Sue liriche inedite, articoli, escursioni di carattere saggistico-espressivo ed un racconto sono presenti sul sito web della rivista letteraria “Lunarionuovo”, diretta dallo scrittore e saggista Mario Grasso, e sulla rivista “L’EstroVerso”.
Ha pubblicato le seguenti monografie: Dante a rovescio. Il XXXIV canto dell’Inferno capovolto (Tricase, 2012) ‒ un esercizio di stile da porsi in un’ideale contiguità, si parva licet, con quelli proposti da Umberto Eco; le raccolte poetiche: Il peso dell'ombra (Prova d’Autore, Catania, 2013); Il male degli occhi, (Puntoacapo Editrice, Alessandria 2014); Fra Terra e Luce, antipodi dell’Uomo (c.s.).
Giovanni Guanti, prosa inedita “Big fog”, nota di Mara Cini
Grande Nebbia. Palude. Crisi.
Giovanni Guanti sembra registrare una generale sfiducia nelle righe oziose di linguaggi sdrucciolevoli come pioli infangati che s’inabissano nell’insignificanza .
Eppure disseminati nel testo non mancano vocaboli che esprimono una residua positività del dire, una versione potabile della parola che, dunque, risulta elemento/alimento capace di ricatturare (…) riflessi di oro sporco e altri colori/sapori.
E’ un’alternanza di voci che ammettono un intatto fascino della discesa fino alla riva di un fiume (un fiume di parole?), che si autosospendono perché la scena o lo schermo non erano più visibili al pubblico (dunque niente era più rappresentato), che vivono e rivivono di molteplici interessi ( inverni messicani compresi ), che, forse malate, respirano arie fetide chiazzate con giallo.
Grande Nebbia come una complessa partitura immaginaria ( altra diversa aliena estranea ), per chitarra e strumenti vari, che, dopo ogni esecuzione, chiede di essere suonata ancora.
BIG FOG
prosimetro trilingue n. 13 per voce recitante e chitarra anche immaginaria
non pubblicabili? grazie per l'invito a stamparmeli in proprio
visto che oggi è così economico
resta intatto il fascino della discesa fino alla riva di un fiume qualsiasi che non irrìga giardini tagliati in quattro spicchi né abbraccia come il Pishon l'edenica terra di Havila ricca di philosophicum aurum
e resta inspiegabile l'incanto del ricongiungermi ai mucchi d'erba putrida protesi sull'acqua avanzando tra le ombre delle chiatte da ghiaia tratte a riva se ce ne sono
catabasi tra i relitti della Rivoluzione industriale
smog = nebbia + fuliggine sive Laborintus
quasi laborem habens intus boreali zuppe di fumo e anidride solforosa eruttati da ciminiere e marmitte finché l'oro autentico non si riaccumulerà in versione potabile
vede lo ammette anche lei sono righe oziose e poeti ce ne saranno sempre troppi
ma con la crisi incombente l'editore piccolo e virtuoso è a rischio d'estinzione
seppure immerso a bagnomaria cautelare nella prosa dickensiana: “At such times almost all the senses have their share of trouble. Not only does a strange and worse than Cimmerian darkness hide familiar landmarks from the sight, but the taste and sense of smell are offended by an unhallowed compound of flavours, and all things become greasy and clammy to the touch”
venerdì e giorni ancora più neri a raffica collassi ulteriori mai
definitivi quanto durerà questa crisi? amico ha mai sentito parlare
della Guerra dei Cent'anni? non c'è più trippa per gatti
tranquillo non me ne cruccio sono un po' certosino
vesto fumo di Londra a prescindere
God save our souls e se può anche queste croste di vita sul fiume deprezzate dagli intenditori miraggi di pittori della domenica risarcitori di più buie giornate viavai sull'acqua di fascine pecore sacchi di iuta anche gondole all'attracco di fondamenta sotto piazze rischiarate da fiaccole e paludi costiere a difesa di indecifrabili città – sarde? maremmane? – in primo piano scortecciatori di sughero e carbonai (non bruciatori di carbone ossia falsi alchimisti)
ci vorrebbe Lucrezio che cantò la peste di Atene del 430 avanti Cristo per condensare la Killer Fog del 1952 in versi degni delle – chi dice 4000 chi 12000 – vittime
days of toxic darkness
days of choking cloud
da comporci una ballata country ecologicamente impegnata
Lei non è uno sprovveduto lo vedo dal curriculum
Vede male bene vedeva invece carloemilio
distinguendo povero Cristo dal poverocristo
in ciascuno di noi poeta o meno
secondo i più recenti studi
ma statistiche e bilanci non sono adamantini
bensì sdrucciolevoli come pioli infangati che s'inabissano nell'insignificanza
a Londra tra il 5 e il 9 dicembre 1952 colarono a picco nella bruma legioni di povericristi poi risarciti dal Clear Air Act del 1956 con restrizioni severissime all'altezza dei camini e la deportazione forzata degli impianti industriali più inquinanti extra moenia
nulla salus eppure sono contento d'averli visti quegli sgorbi da quattro soldi e anche il Tevere itterico per il troppo fango che serpeggia sempre amabile per quanti danni abbia fatto dai tempi di Lucrezio a oggi
CE MANCA TUTTO NUN CE SERVE NIENTE OKKIO!
mirabilmente loquaci mura di Roma anche contemporanea
Si usa ma non si getta se non nella mischia maschia
delle cose profonde penetra il fondo e alle più superficiali
accarezza il pelo traslucido
nel caso probabile di nuove crisi ne uscirà
diversa altra aliena estranea e più forte la poesia che sa
imporsi necessità e priorità: ricatturare i flussi e riflussi incontrollati di oro sporco e stroncarne gli scambi transnazionali malavitosi anche se
non mi lascia una flussione le parole proferir
si giustifica sempre così il servo furbo ingozzandosi spudoratamente
Leporello (mangiando e bevendo di nascosto)
(Questo pezzo di fagiano,
Piano piano vo’inghiottir)
Don Giovanni
(Sta mangiando, quel marrano!
Fingerò di non capir)
e poi mi scusi professore a chi vuole interessi (soprattutto se legge
preferibilmente poesia) quanto segue per esempio nel prosimetro
quindicesimo dopo il crack dell'inverno 1994-95
metà dei messicani precipitò sotto la soglia della povertà? Sbaglia.
Ci interessiamo proprio di tutto. Inverni messicani compresi
inversions are frequent on winter nights
soffiai il naso il fazzoletto si riempì di fiocchi di neve nera
after the ground has cooled down
respiravo aria fetida chiazzata di giallo
so much that it begins to chill the air closest to it
aspiravo una condensa di particelle di catrame
causing mist to form as water vapour precipitates on dust particles
avanzavamo a tentoni rasente ai muri
breathing in acid aerosol irritated the bronchial tubes
le Autorità intimarono bambini a casa per non smarrirli
acid aerosol produced large amounts of mucus
concerti rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche furono sospesi
perché la scena o lo schermo non erano più visibili al pubblico
lo sai anche se non lo ammetterai
mai e poi mai anche se non stamperai assonanze
da poco come queste che disciplinatamente restano
al loro posto per mia scelta e mia massima colpa
costi quel che costi nell'altrui giudizio
che non mi costa poi nulla sì sì che lo sai
se gli architetti del sistema finanziario avessero costruito una casa sarebbero stati trascinati in giudizio per negligenza e gravi vizi di progettazione le strutture portanti crollano e come sempre avviene le macerie travolgono i povericristi che hanno l'unico torto di trovarsi là sotto
me ne resto dunque dabasso al mio posto
che chiaro non è ma chiara mente
mira al cuore di tutto mirando anche a Te
Giovanni Guanti, (Roma 1952) dopo gli studi classici si è laureato in Filosofia teoretica con il massimo dei voti e la lode all'Università di Torino nel 1976 sotto la guida di Sergio Givone; parallelamente ha svolto studi musicali nei conservatori di Alessandria Milano Perugia e Firenze, diplomandosi in musica corale e direzione di coro (1978) e in composizione (1982).
Titolare della cattedra di Elementi di Composizione per Didattica al Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria dal 1980 al 2005 e professore a contratto di Estetica musicale e varie altre discipline musicologiche presso le Università di Perugia e Pavia (sede di Cremona), dal 2005 è professore associato di Storia della musica all'Università di Roma3, idoneo dal 2014 all'ordinariato.
Nei suoi scritti si è occupato prevalentemente di filosofia della musica, di rapporti tra quest'ultima e le altre arti, di autori quali Tartini Beethoven Schumann Busoni e Cage.
Mara Mattoscio, dalla raccolta inedita “Inesprimere l’esprimibile”, nota di Laura Caccia
Tra afasie e nuovi mondi
Rovesciato il classico interrogarsi sulla possibilità o meno di “esprimere l’inesprimibile”, di cui si sono occupati vari autori, Mara Mattoscio con “Inesprimere l’esprimibile” mette in luce il senso di disorientamento per la perdita delle parole che, come evidenzia, da “essenza del possibile” sono diventate “sfasate fuori centro, fuori respiro”, all’interno di un più generale smarrirsi come condizione individuale e intellettuale a partire da un persistente senso di vuoto e dalla perdita di sé.
Tuttavia quello che l’autrice definisce, nella sua biografia, come “un irrimediabile amore per le parole” rovescia l’assunto dichiarato dal titolo in una possibile fiducia nel pensiero e nel dire, in quello che ci indica come “salto in lungo dell’anima / di parola / in parola”, lungo cartografie insieme visibili e ignote, immaginate e segrete.
E, con il recupero delle potenzialità della parola, il muoversi di Mara Mattoscio, in un incedere tremante come “corda / di violino solitaria” tra l’inesprimere e la meraviglia, trova un suo dire anche corale, a partire dal richiamo a “Howl” di A.Ginsberg e dalle dispersioni delle “migliori menti”, nell’afasia di una generazione in cerca di sé, lungo le mappe di un’esplorazione sofferta e inappagata in cui però, come ci indica l’autrice, “la scoscesa incompletezza // che sempre avanza, / pensa nuovi mondi”:
Durare
Sono difficile
come un passo di montagna.
Sola nel nulla
da cui si vedono altipiani
densi di luci brulicanti.
Scoscesa
Scomoda
Scivolosa a me stessa
In perenne arginare
la tensione
che chiama vita nelle viscere,
il movimento incompreso
che mi sale dalla terra,
troppo in fondo.
Il profilo mi trema
mi suda
ma non cambia,
se non per qualche cespuglio
distante
e qualche piccolo fiore
di montagna
che nessuno vedrà.
O per qualche dura
roccia
che mi si spezza addosso
e scivola di vita
e chiama piano l’attenzione.
Buona speranza.
Cartografia per un viaggio
Capo dello spirito
Capo
del magnete
del mio disegno
Capo della
vista
degli ultimi orizzonti
Capo delle mani
Capo dell’energia
di chi vive
da parte
In rosso
dalla mia mappa a scomparsa
occhieggia
-a tratti-
il capo segreto.
Mara Mattoscio è nata a Pescara nel 1983. Vittima di un irrimediabile amore per le parole, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere e specializzata in Lingue, Letterature e Culture Moderne, sempre privilegiando l’intreccio tra letteratura, teoria filosofica e arti visive, in particolar modo il cinema. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Anglistica con una tesi sulla rappresentazione del corpo di genere in autori sudafricani di lingua inglese (Nadine Gordimer e J. M. Coeztee) e nei relativi adattamenti cinematografici. Da questa tesi e da altro materiale ha tratto alcune pubblicazioni accademiche e un'ininterrotta passione per la teoria e la scrittura postcoloniali. La sua scrittura creativa, invece, è rimasta fino a questo momento una questione privata – ad eccezione del racconto La sintesi, incluso nel 2007 nell’antologia a cura di Massimo Avenali Entrata d’emergenza. Dodici nuovi accessi all’Abruzzo (Giulio Perroni Editore). Inesprimere l’esprimibile è la sua prima raccolta di poesie.
Antonella Taravella, da “La cromatica carne”, Libro Aperto 2013, nota di Davide Campi
I testi di questo libro si risolvono in forme prevalentemente brevi, quasi liquide, solo all’apparenza pacificate nella sintassi.
Al contrario, il lessico risulta improntato alla pura e semplice potenza: “rovine screpolate come dita”.
In questa prospettiva, nel tono piano dell’articolazione, le minime fratture e i piccoli spasmi di questa scrittura acquistano grande forza e potere disgregante e, soprattutto, sottolineante: “…una saliva di cose non dette/- ordinare le stoffe per dolore…”.
Parallelamente, nel mondo che le poesie portano alla luce, non esiste un rumore di fondo che alzi in modo consolatorio l’asticella della percezione rendendo sopportabili i normali eccessi dell’esistere.
Sono vuoto e silenzio i punti di riferimento, lo zero strumentale necessario ad ogni misura. Cosicché, con uno sguardo quasi didascalico, all’interno dei minimi e strettamente controllati paesaggi oggetto dei versi, questa scrittura acquista l’energia e universalità della vera constatazione.
***
il doppio ritratto si appende a creatura
pasto ceruleo di miniature affrescate
zampettano le gocce in pozze di fango
a capestro sulla strada di casa
***
dis-velarsi mature
quando la saliva gocciola
sul punto più oscuro del verso
e stringersi addosso
ogni punteggiatura anomala
per sradicare minuti di silenzio
dalle braccia stanche
spezzarsi nella caparbietà di un pozzo
nel nervo gonfio di spigoli
la vittima dei sacrifici
e del pensiero che ritrae luce
***
vegliavo sull’ombra come una madre sconfitta
dedicavo alla voce l’occasione del rimpianto
e resta ancora – e ancora
una sapienza giustificata ad est
nel simbolico darmi come una pietra liquida
contro i fianchi della mia stessa natura
Antonella Taravella nel 2012 ha creato “Words Social Forum”, sito di cultura artistica che comprende varie tipologie di arte.
In poesia ha pubblicato, con le Edizioni Smasher, Vertigini scomposte (2009), Sbocciata nelle viscere (2011), Aderenza (2012).
Silvia Comoglio, da “Il vogatore”, Anterem 2015, nota di Giorgio Bonacini

Come ogni anno, il Forum Anterem si terrà presso la Biblioteca Civica di Verona. Gli appuntamenti saranno ben tredici e si svolgeranno dal 7 novembre al 14 novembre 2015. Nel corso della manifestazione saranno premiati i vincitori del Premio Lorenzo Montano, XXIX edizione.
Nell’attesa, segnaliamo che vincitrice della sezione “Raccolta inedita” è Silvia Comoglio. La sua opera è stata pubblicata nella collana La ricerca letteraria delle Edizioni Anterem.
Il libro – di cui anticipiamo le poesie di apertura e la postfazione di Giorgio Bonacini – ha per titolo Il vogatore.
Ultima pagina: Paolo Donini, “Noterella liquida”, su Silvia Comoglio
Noterella liquida per “Il vogatore”
a Silvia Comoglio
Questo libro è un guado a fior di labbra. Il solco-solcato dalla voga procede a ritroso.
Ritroso (e ritrosia) di cui occorrerà dar conto.
Il solco intanto è il tratto-fratto, il taglio delle labbra aperte al mormorare e subito chiuse, la scia di chiglia mai definitiva
ma sempre aperta/chiusa: dietro di noi? Forse.
La paginetta attinge, in un secchiello forato, quella che il buon borghese chiamerà (liquidandola) una melodia fluviale: noi sentiamo invece
dal colabrodo sillabico ogni fonema quando cerca (e trova) un suo rimbalzo.
La voga del resto non può che essere percussiva,
ma certo non perduta, come parrebbe, nella malia del flutto, il corpo
però non esce sulla rena mai: perché?
Forse perché non è di corpo che si vuol trattare, qui – ecco la ritrosia –
ma del lungo palo intinto (ah scrittura!) , del lavorio di braccia sul canale (verbale) senza gondoliere e, naturalmente, della sua scia labiale (ah moto delle labbra e non-parola!)
Nessun naufragio del resto incombe, il rischio in queste onde è tornaconto dei segni issati dall’accento senza però sortire
dalla lingua, essendo questa l’acqua che monta nel tratto-fratto, alle labbra marea inclusa.
Avanti, dite? Ma no: indietro. Ecco il ritroso a cui il filo di una voce si addipana: il flutto
del tempo si ricapitola perché qui, signori, si va alla fonte, spolpando la lingua del suo scoglio, pesce che si delisca e splende in tras-lucenza (o: licenza, che dir si voglia).
Per questo l’isola è ancora e sempre là davanti, non fosse che si scava navigando la voce
se la terra del nome sull’onda a specchio, tremula e vibrante, si scolpisce.
13 ottobre 2015 Paolo Donini
Aprile 2015, anno XII, numero 27

Dalla carta, attraverso la voce, alla rete. La poesia declinata al presente. Il presente (quello nascosto, quello assente, quello vero) detto in poesia. Senza stereotipi, nella libertà delle differenze. Come nei pressi di un confine. “Al di qua c’è lo scacco, la morte del soggetto, al di là c’è il Nomos, la Necessità. La poiesis si fa nella miseria e nella caducità dell’esserci, per portarsi nel regno intermedio, oltre il quale c’è il nulla” ci ricorda Aldo Trione.
Primerio Bellomo, Martina Campi, Mauro Caselli, Alessandro Catà, Rita Florit & Alfredo Riponi, Carlo Invernizzi, Michele Porsia, Viviana Scarinci, Italo Testa, Silvia Tripodi, Paola Zallio ci conducono in questo luogo sorvegliato dal silenzio, in cui è possibile prolungare il sentire.
Molti dei poeti di questo nuovo numero di “Carte nel vento”, tutti finalisti e vincitori del “Montano 2014”, sono stati presenti al “Forum di Anterem” del novembre scorso. Tutti sono introdotti dai redattori della rivista. In attesa degli autori del 2015, ricordando che fino al 15 aprile è possibile inviare i materiali al Premio (scarica il bando della 29^ edizione), auguriamo buona lettura.
In copertina: Laura Fortin, L’absence
Primerio Bellomo, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
Le forme del poema
“La rosa dell’assenza”, di Primerio Bellomo, è un elegante componimento la cui agilità espressiva non va a scapito di una pregnante intensità.
I tre versi
“ultimo esilio
di un fragile e sorgivo
unico dire”
rivelano, in modo non ambiguo, l’atteggiamento assunto dal poeta nei confronti del linguaggio.
Un linguaggio ritenuto “fragile”, “sorgivo” e “unico”, ossia delicato, di continuo nascente e, perciò, appunto, unico.
Usando quest’ultimo aggettivo, Primerio non ha certo inteso negare l’ampia gamma delle possibili umane maniere di esprimersi, ma ha voluto porre l’accento sull’attitudine al dire propria della specie umana.
Un dire che proviene da silenziose assenze e che di queste ultime reca indelebili tracce.
Costruito volta per volta, parola per parola, il discorso - quello poetico in particolare -pone in essere, assieme a sé, la vita medesima, consentendo (o, almeno, potendo consentire) una continua rinascita.
Siamo dunque al cospetto di una fragilità sorgiva davvero feconda, tale da promuovere ulteriori passi avanti sulla via della conoscenza.
Il poeta propone ritmi alternati di tre e di due versi ciascuno, creando così una musicalità visiva in grado di concedere anche all’occhio che ancora non ha letto la possibilità di accostarsi alla forma poetica.
Potrebbe apparire un aspetto secondario ma non lo è, poiché l’impronta del primo sguardo persiste in una lettura che riesce in tal modo a coniugare gli aspetti specificatamente linguistici con l’immagine complessiva degli stessi.
A coniugare?
Meglio, a fondere in un’organicità in cui l’elemento iconico e quello letterale si riflettono l’uno nell’altro promuovendo una feconda riflessione sulla natura del segno verbale e del suo non univoco uso. (m. f.)
La rosa dell’assenza
non più effimero
di una roccia l’immenso
vuoto dell’ora
si china e affida all’ombra
la sostanza del cielo
ultimo esilio
di un fragile e sorgivo
unico dire
albale e vacuo altrove
è respiro e radura
di spazi evasi
l’alta marea del tempo
e oscura vita
tra trame cune e cigli
d’acque e remote terre
priva di nomi
e fulgida di abissi
s’apre alla notte
rada nube ed oblìo
la rosa dell’assenza
Primerio Bellomo, laureato in Architettura, è nato nel 1958 a Palestrina (Rm) dove risiede. Ha pubblicato L’ombra del dire (2005), Chorale e Al fuoco dell’origine (2009), Primo vere (2011), Notte siriana (2013).
Martina Campi, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
In poesia distinguere tra voce e scrittura è un’operazione ardua, sia dal punto di vista concettuale sia da quello materiale. Si dice ciò che si scrive o viceversa? Probabilmente non è la distinzione nella manifestazione esterna che apre al fare poetico, ma forse, e più sottilmente, è riuscire a togliere, a nascondere, o ancor meglio a far scomparire la differenza, che nel procedere di un linguaggio così teso come quello della poesia, fa sostanza e conduce il senso. Martina Campi ha una scrittura vocale che assume l’esperienza del dire incuneandola direttamente nel corpo percettivo della lingua, svuotandola da ogni “intenzione premeditata”e arricchendola di trasformazioni e sovversioni istintive. Manuale d’estinzione si muove proprio intorno a ciò che fa assenza – di luce, di suono, di movimento, di struttura – cercando, nell’immersione in ciò che viene meno, di recuperare almeno dei frammenti presi dalla “densità del buio” o dal “moto del respiro”, e con questi provare a ridare forma, visibilità, ricordanza a ciò che per esistere deve imparare a sottrarre e a sottrarsi. E lo fa con un disporsi, spezzato in parole, che sembrano scorrere sulla pagina con un moto intimo, a volte lineare, a volte a salti e a scatti, a volte quasi inciampando, come per distrazione, contro una realtà (spigoli, oggetti, rimorsi) che frena la materialità dell’essere e dello stare lì, in concomitanza con il mondo. Ma questo trovarsi non può non frantumarsi quando il senso del mondo ordinario viene sparpagliato e rivissuto al centro della solitudine poetica. Allora bisogna rendere visibile ciò che per l’autrice è una scelta di forma: e in quanto scelta è fisicamente udibile nel “vibrare della gola”. Lì dove la parola cercano di trasformarsi in ciò che esiste fuori, nel turbinio delle trasmutazioni che la lingua attua. Ma questo referente esterno è solo apparenza. Ciò che è effettivamente reale viene invece sprigionato da una significazione sorgiva che rende metaforico, e dunque più vero, anche un cuore fantasmatico ma vivente. Un cuore che traspare in esistenza tra le sillabe, che accadono e conseguono verso una qualità speciale della conoscenza che ci è ignota, eppure sentita come un attrito nuovo, come all’origine dei suoni e dei segni, nella sintesi dei sensi. E Martina Campi è capace, in queste pagine, di versi semplicemente luminosi, come cenni sfuggiti ai primordi di una leggerezza rara e chiara. Versi che hanno l’andamento di un haiku, che puoi trovare dispersi nei testi e quasi incogniti, ma quando si incontrano manifestano immediatamente la loro disposizione, il loro”guizzo di luce” dove “la gazza/ladra del sonno/ubriaca il chiarore”. Ma ciò che sta al centro di questo poema, aperto a flussi di propagazione ma anche a necessari cedimenti, è far sì che la parola possa posarsi e smuovere il vuoto e il bianco della pagina, disarticolando la struttura rigida di quel pensiero arido, falsamente veritiero che blocca la vicinanza al dire che rischia e che brucia in poesia. Lì, e solo lì, la voce può perdersi in un pulviscolo di significazioni che diramano dal corpo presente, teso al limite del sentirsi. Perché presenza e assenza, articolate in combinazioni lucidamente emotive, hanno regole che si manifestano solo dopo gli accadimenti. Ma la poesia impara, e l’alfabeto imprime le sue connessioni fino al punto in cui “finisci per credere al movimento/ degli alberi” e a ciò che dev’essere: dare voce e consistenza alle cose e insieme ricevere da loro sostanza e parola. Una risonanza che è vita, con la sua dedizione al gesto di consegnarsi al luogo dove può capitare che le cose pronuncino da sole la loro lingua coscientemente folle. L’autrice indaga con precisione questa buona anomalia, che rende la parola poetica - né veritiera né verosimile né verità – ma semplicemente vera. Perché il suono delle cose è voce che prende dal silenzio il suo ascolto, in attesa del senso inaspettato, lì dove “forse basterebbe lasciarsi/pensare”. (g. b.)
Da Manuale d’estinzione
2.22
aframmento pop del centellinante-
alle 2.22 speri in un futuro non troppo futuro show dei cure e speri di trovare in rete proprio la mail di robert smith per scrivergli qualcosa d’importante tipo di dormire senza paura o che gli vuoi bene e non solo immaginare di volergliene ma davvero come le parole che non si perdono e si scrivono sempre e ci scrivono come l’andare del sogno e ti sembrava d’aver trovato qualcosa di davvero davvero importante da dirgli che non poteva aspettare di dimenticarsi come i tanti pensieri e le idee che diventano millimetri o meno di millimetri tra i chilometri delle strade di tutte le città messe insieme tutte in un posto le luci che sequestrano gli occhi le luci t’incasinano tutto perché era spontaneo e non l’avevi preparato e intorno quando c’è il buio le luci sono indicazioni a frammento e sono richiamo per tutto quello che non hai mai raccolto prima o se hai fame ti dicono qui puoi venire e qui è dentro e le 2.22 continuano a saperlo come allungarsi e distrarsi da quello che volevi dire quello che avevi capito
di tanto importante proprio allora
ascoltando
che ti fa pensare sempre a come risolvere il problema cure che se ci pensi è un controsenso ma neanche tanto se invece entro in scena anche io e mi metto a pensare alle gocce che poi quello delle gocce che scendono è il mio pensiero notturno più centellinato
Da “Estinzione 02”
***
Eravamo luce di corvo
in volo: la vista sfuoca
la distanza in gocce
che ci separa
e la mancanza
che fa sentire
se pare un volo nero
a svanire.
***
Quel bussare era ieri
un cuore fantasma
sperduto senza memoria
cosa potremmo dire
che non sia verità
è il vuoto che si prende le stanze
e ogni parola dagli scaffali.
Da “Estinzione 05”
Dire:
sì.
Può salvare la vita.
Fare voce
fare destino
accettare la natura
persino quando tramonta.
Mauro Caselli, da “è VERAMENTE COSA BUONA E GIUSTA”, Battello Stampatore, 2014, nota critica di Rosa Pierno
Emerge, fin dalle prime pagine, la questione che Caselli intende affrontare: la verità definita in sede logica non è adeguata in sede esistenziale. Con un richiamo subitaneo al potere incontrollabile della parola: “ C’è solo la parola, che tradisce / anche se stessa e, crudele, richiama / alla maternità della bellezza”. Ma contemporaneamente si deve aggiungere a tale impianto la percezione di una nota molto insistente di rassegnata adesione, sorta di mancanza di illusione denunciata dalla serie aggettivale: ‘ irrilevanti’, ‘vani’, ‘secondari’, in questo caso a carico dei particolari che non formerebbero mai una figura finita. Quasi una nostalgia dell’intero e un dispregio per il frammento a cui vengono invece associate “le cose volgari”. Ciò che è ideale non si adatta a ciò che è reale e questo causa all’autore un profondo disagio che gli fa perdere anche la positiva energia del momento iniziale di ogni esperienza: “E poi, al di là di ogni immaginazione, / non rimane che un po’ di malumore / per avere tentato il sentimento / con parole importune e idee buone”. Ogni tentativo di alimentare il presente con la forza della verità pare destinato a inabissarsi nella menzogna. Nella relazione con un altro essere non ci sarà spazio per “un consenso che perdona / ai contenuti di verità il danno / e la beffa”. L’impossibilità di conciliare il bene con il bello, secondo platonico intendimento, dissolve persino l’amore, annegandolo nel nulla. Che Caselli intenda non cedere e che si ponga incessantemente il problema del modo con cui ricollocare sul binario giusto la traiettoria delle proprie aspettative determina la formulazione di un testo che ha il rovello come nucleo propulsivo dello sviluppo testuale. “E se alle volte sembra differente / poi dopo è sempre la solita storia, / la variazione diviene un momento / di ritorno alle forme del presente / e un cenno appena fatto è già memoria”. Le pratiche strategiche che consentono di non rigettare completamente la relazione con gli altri sono tutte esaminate: viene stilato il regesto del dare e dall’avere con cinica precisione. Ne è causa un mondo senza scopo ove il linguaggio invece persegue motivi e valori, e di questa frattura l’autore denuncia la non ricomponibilità. Adottare modelli assoluti rispetto a un mondo frammentato è un errore che genera confusione e la variazione incessante ne è la conseguenza anche testuale. In ogni caso, forse l’amore è ancora “una figura di risposta, / perciò non ama far troppe domande”. Seppure, Caselli individui due vie percorribili: “si decide di stare con le cose / o, diversamente, con le parole”, l’ultima poesia, inevitabilmente, lo vede rilanciare la posta sperando in una terza via. (r. p.)
***
Nelle parole si cerca il segreto,
la completa risposta alla domanda
sull’inizio, perché la verità
è certamente cosa buona e giusta,
e non ci può essere niente di meglio.
Se il risultato ogni volta è una fine,
la tappa conclusiva di un percorso,
accade tuttavia che il conto non torni,
in quanto un compimento senza resto
è solamente se stesso, il rifiuto
dell’idea che esista un’occasione
per il presente, per il tempo dato.
No, tutta questa faccenda è il ricatto
d’un calcolo, necessario ed esatto.
***
Le cose che non si possono dire
rimangono in attesa, e poi dissolvono
in vicinanza. Lasciano frangenti
di viva assenza e l’indicazione
d’un movimento nelle oscurità
della memoria, in quello spazio
dove ciò che esiste torna e nasconde.
Ed ecco allora la solita storia,
quella dei tentativi di partenza
tra le insistenze della novità
ed il continuo imbarazzo del vero.
C’è solo la parola, che tradisce
anche se stessa e, crudele, richiama
alla maternità della bellezza.
Mauro Caselli, oltre che poeta, è critico letterario.
Ha scritto saggi su Marin, Saba, Svevo, Penna, Dickinson, Shakespeare. I suoi ultimi libri sono Il giogo (2004), Per un caso o per allegra vendetta (2007), Il banderaro importuno (2013).
Alessandro Catà, da “Continenti persi”, Moretti & Vitali, 2013, nota critica di Rosa Pierno
I testi di Alessandro Catà sono caratterizzati in maniera preponderante dalle marche temporali e dai luoghi. Naturalmente lo spazio implica il tempo e anch’esso è definito dalle direzioni: avanti e indietro, eppure, una spola mentale tenta di tessere fra gli oggetti una continuità che resta in ogni caso difficile a reperirsi. “Sei troppo avanti / o indietro, ma non ricordi / più, strana lingua di frasi / dette al contrario, cerchio / sull’acqua che non viene da / un sasso, ma si restringe”. L’andare e il venire riguarda oggetti concreti e astratti: la lingua, gli stati interiori, la posizione nello spazio, la variazione della forma. Dunque, non lo spazio e il tempo in quanto essenze, ma entità registrate nel vissuto dell’io lirico, impregnate di sé, formulate in un linguaggio polito e come disossato. Ed è in questo senso che il moto denuncia immediatamente la sua prossimità con l’immobile. Da tutti questi movimenti si evince che nulla al fine cambia: “Invoco il punto più lontano dall’acqua / ma scopro le imperfezioni / della desolazione, quel rivelarsi / in fondo solo un intreccio / di frenesie”. Il mondo è affetto da frenetico, disordinato moto, si vive per vedere le cose cambiare e allo stesso tempo che mai nulla cambi, in un insensato gioco che però viene comunque compitamente registrato dall’autore. Gli oggetti vengono assunti come simboli e dunque se gli alberi sono grandi come fiammiferi, ciò comporterà una variazione in qualche altro oggetto o stato (nessun senso essendo univocamente isolabile se non in ambito scientifico). L’autore non può non esserne il testimone e non certo un testimone che non alteri la scena percepita! La consapevolezza che la scena si modifichi senza che comunque ciò comporti un diverso esito nella vicenda non ferma l’autore (e qui apriremmo un inciso sulla ricerca di un senso locale anche in mancanza di un senso finale). La coppia senso / non senso è lo spazio di libertà entro cui il testo viene giocato, ciò con cui si costruisce lessicalmente una rete che ha lo scopo di catturare l’io. Tale cattura non potrebbe darsi se ogni oggetto non trascinasse con sé anche il corrispettivo astratto: “l’estetica di un lamento”, “la scultura del peccato, “il significato notturno dell’oro”. La caccia al corrispettivo prosegue fino a sfidare l’accostabilità, ma in fondo non è ancora e sempre che un muoversi all’interno del linguaggio. Persino la funzione mnemonica non consiste che in un riportare alla mente parole. E la memoria, è per Catà, forse, la sola la macchina che tutto muove e che nondimeno produce anche il nulla: “La verità / fuori mano / lontana dalle voci dove / finisce un paese”. (r. p.)
Dalla sezione “Il punto più lontano dall’acqua”
***
Ti parlo dal carbonio,
da uno scempio di me
che ha decapitato serpenti
e binari e la mia voce
ha un’estensione di polvere
e macchine senza volere.
Per la tua lealtà
soldato io mi avvicino
al linguaggio di ferro:
le travi... la carne lassù
ovale dei piccioni.
Dieci ore dopo.
Cento anni dopo.
Dalla sezione “L’aria che tu chiamavi cielo”
Giant steps
Cosa vai a pensare
le pietre parlanti
il giovane mercurio
che salta
appare e scompare nei
boschi
se avesse un suono sarebbe
di campanelli
un agitarsi di metalli minimi
che lasciano le ombre
indietro
ferma la stanza delle
voci pallide
e sopra i giorni sta
la domenica
acuta è la mattina
il latte rotondo di una perla
si è perso tra le pieghe
è rotolato nella sintassi
delle cose sparse
sembra un’allegoria
e invece
è la pressione
di tutta la casa
un forte getto d’acqua
perpendicolare al disordine.
Alessandro Catà (1951), è autore dei libri di poesia Blocco riassunto (1991) e L’ordine del respiro (2007). Ha pubblicato la prosa Ascoli nel 2008, con foto di Mario Dondero.
Rita Florit & Alfredo Riponi, una prosa inedita, premessa di Mara Cini
Come in Un homme qui dort di Georges Perec, troviamo in Agrimensure una sorta di sfocatura, di dissoluzione percettiva .
La scrittura allora dimentica il suo essere atto comunicativo e diventa meccanismo e segnale di presenza, un’ossessione tattile e olfattiva indispensabile a delimitare memorie e stagioni, paesaggi e desideri.
Quando le mani strofinano parole sulla pelle si attiva la misura delle cose che, tra luce e ombra, permette di accennare a qualcosa della nostra realtà imperfetta. (m. c.)
Rita R. Florit ha pubblicato “Lezioni inevitabili” (Lietocolle, 2005), “Passo nel fuoco” (Edizioni d'if, 2010 - Premio Mazzacurati-Russo, IV edizione). E’ presente in varie antologie tra cui “Registro di Poesia n.2” (Edizioni d’if, 2009) e “Parabol(ich)e dell’ultimo giorno. Per Emilio Villa” (Dot.com Press-Le voci della Luna 2013). Ha co-tradotto l'antologia poetica “Ghérasim Luca, La Fine del mondo” (Joker edizioni, 2012). Ha tradotto Benoît Gréan per l'annuario di poesia “Punto” (Puntoacapo editrice, 2013).
Alfredo Riponi ha curato e co-tradotto “Ghérasim Luca, La Fine del mondo” (Joker edizioni,2012). Ha tradotto Benoît Gréan per l'annuario di poesia “Punto” (Puntoacapo editrice, 2013). Sue poesie sono contenute nel “Registro di poesia n.2” (Edizioni d'if, 2009). È presente nel libro in uscita per Manifesto Libri “Louis Wolfson, Cronache da un pianeta infernale”.
Carlo Invernizzi, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
Uno degli aspetti più straordinari di questa raccolta di poesie è la compattezza e totale coerenza di un uso della lingua che cerca non solo una significazione generativa di meraviglia, ma tenta la trasformazione di sé in ciò che dice. E lo dice con una parola che vuole essere vista per essere ascoltata, in una visione sonora che attraversa il lessico per vedere ciò che il linguaggio comunemente non dice e dire ciò che la percezione ordinaria non vede. Lucentizie è un poema della luce che percorre le ombre di una natura che sembra apparire in trasparenza e dileguarsi, per venire però raggiunta da una poesia sempre al limite, che si muove sul suo stesso bordo e contemporaneamente sul limite concettuale che pensa il mondo. Le figure che si incontrano – siano esse minerali, vegetali, animali; palpabili o impalpabili; evidenti o nascoste – sono figure d’aria sfuggenti, che “irrompono nei cunicoli/sfrecciano imprevedibili”e che si rendono fisicamente presenti solo nella tensione che le parole intrecciano tra loro. L’autore non descrive la luminosità o l’oscurità, ma lascia che scintillii fonici scrivano se stessi, che germi di buio crescano fisicamente tra gli interstizi delle lettere. E nessuna ingenua raffigurazione prende il sopravvento, ma sempre e solo un’adesione alle figure luminescenti che dissipano la loro presenza per riformarsi in angoli e scorci visti di sbieco, ma sentiti come ciò che sono: parolecose che solo la scrittura poetica (o almeno questa scrittura) può immaginare. Una tensione che, pur nascendo dal fondo di un’ immersione impossibile, emerge al margine reale di una natura vera. Le parole si intrecciano fra loro, e si fondono a dar vita alla significazione che si prova nel toccare fisicamente la materia, nel sentire l’energia costitutiva di ciò che è e in cui siamo. E ciò che esiste e vive può manifestarsi anche in semplici “prati d’altura/cianoscurilucenti/arsi/tra impicchi di muri/nudi/”a cui Invernizzi dà questa speciale voce che li concretizza.
Ma ecco allora quanti germi d’arte, vita e sostanza sprigiona la semplicità polimorfa che naturalmente ci circonda; e quanto la trasformazione interna e, diremmo anche intima, che il poema opera sulla struttura linguistica, condensando grafemi e fonemi, può portare a una deflagrazione della normale conoscenza mediata, in direzione di nuove, multiformi ma precise definizioni. Così questi testi sono la prova che lo stupore generato dalla formazione di parole non abusate, non guastate, non compromesse, ma che aderiscono (perché devono necessariamente farlo se vogliono parlare nuovamente) agli elementi che la natura ci offre, possono portare la visione ad altezze vertiginose dove ”s’infulgono ioniluce/verdeplendenti”; ma possono andare anche verso voragini abissali dove “tutto è riverbero di stenti”, “urgenti catastrofi/ in entropia del niente”. Due percezioni apparentemente opposte si presentano, allora, nitide ai nostri occhi di lettori: una trascendente, che pensa un mistero oscuro e lo sente dileguarsi indestinabile nel tempo; l’altra immanente che ode nel mattino cantare monotono ma prodigioso il cuculo. Ma è la poesia a farsi carico di non disgiungere le contrapposizioni: e lo fa oltrepassando in scrittura forse la sua stessa consapevolezza, lì dove intravede un’ alternativa alla lingua ordinaria che solo descrive la natura, mentre lei la scrive. Ecco allora dare visione al volo in luce di uccellilucentineri: dove è ambivalente il nero che prende la sua lucentezza dal brillio del sole (uccelli lucenti neri) e la luminescenza che il nero in sé produce (uccelli lucentìneri). Un esempio per dire come, questo poema, raggiunge il suo scopo di dire e dare vita. (g. b.)
Da Lucentizie
***
Sui muri della mente
offuschi scuri
scivolano riverberi
oblique trasparenze
ombre vacue che vacillano
disperse parvenze.
***
Lucentizie sempre apparenti
mai non recessive
come sempre gl’innevi d’inverno
sono altitanti e vallivi.
Lucentizie elitranti
eppure impercettibili
che pulsano nel ventale diafano
e dileguano invisibili.
Lucentizie di fulgidi albori
che di colle in colle rifrangono
e nella chiarità vibrando
lucciolano.
***
Addentro
sempre invano più addentro
senza fine il disintegro
del vuotoinfolto del niente.
Dove senza vita
s’incede
il misterio della vita
e senza luce
s’ingermina nell’oscurità
il canto
del ventoluce.
Carlo Invernizzi è nato nel 1932, vive e lavora a Milano e Morterone.
Il suo ultimo volume pubblicato è Secretizie, Mimesis 2009.
Michele Porsia, da “Bianchi girari”, Giulio Perrone Editore, 2011, nota critica di Rosa Pierno
Scegliere come antagonista della parola la morte è una scelta di campo che lascia all’interno dell’insieme scelto l’esistenza tutta. D’altronde, già Epicuro aveva detto che se c’era lui non c’era la morte e viceversa. Questa sorta di limite, di alterità, serve più a valorizzare l’esistente che il nulla. Porsia accosta ogni oggetto e persona con una delicatezza che diviene raffinata già solo perché rara: le briciole, i posacenere, i cucchiaini valgono in quanto segni disseminati nello spazio domestico e condividono o simboleggiano il destino umano. Nonostante il linguaggio sia sempre in campo, incessantemente nominato il suo potere, non è esso a dominare con la sua legislazione. Solo a sprazzi. La questione sembra essere aperta e tale rimanere. La lotta ingaggiata con la parola per trascinare la morte fra le cose vive né è come l’emblema: “- io con la morte ci faccio l’amore - // l’amore con la morte in allitterazione”. Ma la parola sembra avere anche una sua materialità: funzionare come residuo: qualcosa che resta dell’uomo pur dopo che è sparito. Un’archeologia della parola che fa rinvenire, ma per un istante solo: “bocca a bocca respira / per spirare”.
Dapprima, pare che non si attui nessuna sostituzione tra le parole e gli oggetti o eventi dell’esistenza, pare che scorrano su binari paralleli, non intersecantisi nemmeno all’infinito: strana geometria non-euclidea che vuole infilzare un’unica meta, di volta in volta differita o perduta: “E mentre il significato sfugge, appare chiaro / l’alone della luce / l’ostensione di questa sindrome interna”. Il senso viene equiparato a una slavina: “ - le parole e le rocce contengono un linguaggio / che segue una sintassi di sfaldamenti e di fratture”. Se ogni parola “contiene il proprio vuoto”, in ogni caso l’equivalenza con la morte non è congettura da doversi accettare in maniera dogmatica. L’autore sembra ricercare ciò che renda inconfrontabili i due oggetti che ha posto in opposizione: nello svolgimento della sua ricerca assistiamo, a volta, anche a tentativi di paludamento, di mimesi (si pensi ad alcune poesie visive all’interno del volume, ove la parola gingko biloba, ad esempio, si trova in un testo che ha la forma di tale foglia). Persino la voce viene coinvolta in questa sorta di confronti, di ricerca di somiglianze formali o sostanziali: “dei segni contorti sul bloc-notes, / un viluppo di bianchi girari, figure fitomorfe / della voce”. Ma, viene alfine raggiunta una sorta di ricomposizione tramite visioni in cui collassano forme vegetali, culturali, esistenziali, materiali di risulta, reperti archeologici, epidermici proliferando uno dall’altro incessantemente: “ Parola / esci come parola / dalla radice / o dall’osso, la costola del libro”…. (r. p.)
Dalla sezione Bocca a bocca
(è un prestito di voce
questa cauzione da lasciare tra le pagine.
Un palmo dallo sterno, il torace scoperto,
il corpo morto
sotto il massaggio cardiaco.
E riprende vita per un istante solo,
bocca a bocca respira
per spirare)
Dalla sezione Il niente che è
ecco la scomparsa diurna,
un diluvio sceso come in ogni poema nelle cavità terrene,
una restituzione
del suono tenuto tra le costole.
Fiato
lasciato sulla mano, la sinistra, la pietra fredda
e un battito d’acqua a riempire le lacune.
E’ stato un rito di passaggio
Dalla sezione Muschi
X.
(...)
Parola
esci come parola
dalla radice
o dall’osso,
la costola
del libro,
cresci
lo stesso
sottopelle,
se non puoi salire
esci e cresci in sotto
cresci comunque cresci
Altri testi da questa raccolta, allora inedita e in prima stesura, pubblicati in “Carte nel vento”:
https://www.anteremedizioni.it/montano_newsletter_13_porsia
Michele Porsia (1982). La prima raccolta di poesie, Sintomi di Alofilia, è stata pubblicata dalla Giulio Perrone Editrice nel 2009. Dopo “Bianchi girari” è stato compreso nell’antologia “Poeti della lontananza” edita da Marco Saya Edizioni.
Viviana Scarinci, da “Piccole estensioni”, Anterem Edizioni 2014, nota critica di Giorgio Bonacini
Viviana Scarinci, da “Piccole estensioni”, Anterem Edizioni, 2014, nota critica di Giorgio Bonacini
www.anteremedizioni.it/piccole_estensioni_di_viviana_scarinci
Italo Testa, da “I camminatori”, Valigie rosse, 2013, nota critica di Rosa Pierno
Ne “I camminatori” di Italo Testa, in cui il protagonista segue dei prsonaggi che dichiara essere differenti dagli umani pur avendone la sembianza, con ciò indicando quanto in loro vi è di dissimile da un comportamento usuale, si percepisce nettamente l’altro come simbolo di incomunicabilità e di estraneità. Ma è lo stesso autore a metterci sull’avviso perché l’altro potrebbe essere anche un bluff “ se pensano / sempre a qualcosa / o fingono”. Infatti, potrebbero voler sfuggire a qualsiasi tentativo di definizione. Evitano gli ostacoli che l’autore sembra immettere sul loro cammino, ma d’altra parte costringono l’autore a un monologo, infatti, in tale traumatica situazione, l’autore pone a se stesso domande: sono fra loro solidali, presentano in qualche occasione un tallone d’Achille che manifesti il loro pensiero o la ragione del loro essere refrattari all’umanità? Gli altri sembrano causare alla voce narrante anche una sorta di invidia perché: “ non danno mai l’idea / di perdersi / padroni di se stessi / e vigili / in ogni situazione”. Egli li pedina e finisce con il fare la loro medesima vita, diventando, di fatto, come loro: “ho provato a seguirli / in incognito / a pedinarli / percorrere / i loro itinerari erratici / a stargli alle spalle / unisono / marciando al loro passo / a vivere / andando sulle strade”. E l’inevitabile – prevedibile – finale è: “ovunque tu cammini / camminano”. Nient’altro se ne può dire e, però, sembra già tutto detto.
“I camminatori” sembrerebbe, pertanto, essere un testo che rifiuti il commento: non costringerebbe altrimenti il critico a seguirlo pedissequamente quanto inutilmente in una sorta di grado zero della scrittura (lì dove già la poesia risulta volutamente priva di qualsiasi accensione lirica). Ci ricorda un quadro nel quadro, un’azione che innesca negli altri una reiterazione, una scena filmica (pensiamo a quel Buster Keaton così amato da Beckett e ad alcuni recenti film di fantascienza). Si tratterebbe, dunque, di qualcosa che appartiene al nostro bagaglio d’immagini, ma che non richiede necessariamente un’interpretazione. Ecco, si direbbe che il bersaglio polemico sia proprio il senso, che l’autore vuole tenere fisso, puntare con gli spilli, quasi rendere asfittico, trattandosi qui di un testo surrettizio, in cui viene cioè taciuta intenzionalmente qualche circostanza fondamentale, in questo caso, la macchina testuale stessa: volontariamente azzerata, quanto più esposta allo sguardo, si direbbe. Se però il senso è sotto accusa, l’appunto iniziale sull’illeggibilità dell’altro fa da contraltare ricordandoci che la ricerca del senso è una necessità insopprimibile. (r. p.)
***
camminano
rasenti ai muri
sugli autobus
si siedono tra i primi
non parlano
tenendosi le mani
si voltano
di scatto a un tratto
ti guardano
gli occhi grigi
campeggiano
poi scartano di lato
si alzano
serrando i pugni
e scendono
***
non sembrano
mai farti caso
proseguono
e niente li distoglie
s’avviano
semplicemente
ognuno alla sua meta
ma simili
e sempre più numerosi
s’avvistano
lungo le strade
si incrociano
in ogni luogo
ovunque tu cammini
camminano
Italo Testa vive attualmente a Milano. Ha pubblicato La divisione della gioia (2010), canti ostili (2007), Biometrie (2005), Gli aspri inganni (2004).
Suoi testi sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ha scritto diversi saggi sul pensiero contemporaneo e sulla teoria critica.
Silvia Tripodi, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
Un’empatica analisi
I primi due versi della poesia di Silvia Tripodi
“Facendo della sua stessa forma
forma altra che uguale a sé sempre si conforma”
si riferiscono, in maniera palese, al concetto di “forma”, ponendo in essere un’articolata pronuncia in cui il lettore si trova quasi imprigionato.
Ma simile verbale prigione allarga subito le sue sbarre e permette di gettare lo sguardo su un ampio spazio poetico di cui, tuttavia
“l’occhio non distingue che una parte”.
Il dire della poetessa cattura la nostra attenzione e noi non possiamo fare a meno di sentirci circondati dalla sua intensa persistenza.
Ci accorgiamo, così, che la stringatezza del testo è in grado di assumere dimensioni immense, tali da comprendere la nostra intera esistenza: siamo lì, tra quelle parole, non possiamo prescindere da esse, eppure avvertiamo di essere a contatto con qualcosa d’infinitamente esteso.
Non si tratta, nel caso di Silvia, di un misterioso incantesimo, bensì di una genuina vena poetica perfettamente in grado d’inserire nei suoi grumi idiomatici l’intero universo lasciandolo intatto.
Non siamo ottenebrati né estasiati, piuttosto siamo indotti a mantenere ben alto il livello della vigilanza poiché i lineamenti linguistici proposti c’invitano a cercare risposte.
“l’analisi ora è cosa decisiva”
dice la poetessa indicando la via di una comprensione che non riguarda soltanto i suoi versi.
Se il destino dell’uomo è conoscere, ogni vera conoscenza – suggerisce l’autrice – non consiste nel mero uso di fredde grammatiche, bensì in quell’intelligenza del vivere fondata sull’illuminante coinvolgimento.
Da qui, l’importanza dell’ “alga appiattita”, della “lunghezza esatta”, dell’ “intenzione”, ossia di un essere che aspira assiduamente a un sempre più compiuto esserci.
Anche in virtù del lavoro dei poeti, senza dubbio. (m. f.)
***
Facendo della sua stessa forma
forma altra che uguale a sé sempre si conforma
uguale, diseguale, unica e doppia
l'occhio non distingue che una parte
di quello spazio non umano sempre fisso alle mani.
Da una prospettiva compiuta in uno scatto
l'analisi ora è cosa decisiva,
l'alga appiattita, lunghezza esatta dello stare
dell'intenzione al verso.
Silvia Tripodi (1974). Vive e lavora a Palermo. Laureata in Architettura, è educatrice presso un istituto statale. Si è occupata di fotografia e nel 2010 alcuni suoi lavori sono stati esposti a Roma in una mostra organizzata dai redattori della rivista Tutto Digitale. Ha partecipato alla sesta edizione RicercaBo 2013 (laboratorio di nuove scritture - San Lazzaro di Savena); alcuni suoi testi sono stati inseriti sul sito GAMMM tra il 2013 e il 2014; ha collaborato al "progetto Gianni Toti - Totilogia" su Floema; sue poesie sono state inserite nella rivista “l’immaginazione” (marzo-aprile 2014). Collabora ai blog eexxiitt e transcriptiones. Il suo blog è partage du sensible.
Paola Zallio, una prosa inedita, premessa di Mara Cini
L’acqua, la insegna la sete
Emily Dickinson
L’acqua non può tornare alla sorgente…e la parola detta non può tornare in bocca…il sangue ha le sue vie di scorrimento obbligate. Sono le vie naturali, insite nella pulsazione stessa che viene impressa dalla nascita ai viventi.
Scrivere invece non è un atto naturale, servono appigli alle parole. Serve apprendimento e cura.
In questo testo di Zallio pare esserci un continuo confronto tra un corpo che pulsa per fede, per naturale movimento e un corpo linguistico che per fede accompagna gli affetti, le scoperte, il flusso degli eventi. Una continua percezione tra interno ed esterno, un fluido di libero scambio di un mondo con l’altro. Abbandonarsi alla lingua non è mai operazione scontata, c’è una ricerca, c’è una fatica: l’acqua, la insegna la sete. (m. c.)
pdf del testo , incipit
Paola Zallio vive a Genova. Con Lingua Acqua ha vinto il Premio Lorenzo Montano nel 2002 per la “raccolta inedita”.
Galleria fotografica del Forum 2014, Immagini di Maria Grazia Veroni
Ultima pagina, autobiografia artistica e opere di Laura Fortin
Il segno e il gesto sono gli elementi narrativi dell'astratto.
Il mio personale approccio alla rappresentazione dei messaggi che il pensiero esprime è affermativo.
L'opera è soprattutto un atto di forza della mente, un momento di analisi e verifica su quanto accade nel proprio personale percorso di ricerca della affinità con le differenti fonti di bellezza e significato, un esercizio in cui la matematica delle manifestazioni è il primo soggetto.
L'astrazione è uno tra i più efficaci mezzi con cui si consegna il pensiero al pubblico.
E' una pittura in qualche misura democratica, popolare: la ricerca, la ratio, il pensiero che costituisce un opera può essere stravolto e amato in egual misura.
Questa ambiguità ritengo sia la cosa più stimolante. Ecco che il non detto, il non finito, l'impreciso sono cifre stilistiche calibrate, sono definitive opportunità di una poetica che non ha paura di fare i conti col passato, non insegue certezze, semplicemente si evolve, come la vita.
L'opera.
ricominciare, i motivi sono impronte, sono necessari, sono battiti, colpi, scontri.
andare è definitivo, è un gesto d’amore, di pace, un filo d’erba che svetta.
il tempo è costruzione di pensiero, di frammenti senza storia apparente, di bicchieri rotti, tappeti impolverati e cementi incuranti.
ma questa casa è la mia testa, una mano che stringe, il cuore che pulsa come una notte incessante, in verticale specchio.
poco contano gli scorni, il fluire è l’opera.
L’opera non è mai detta. L’opera è viva.
Esposizioni.
2012: mostra presso L’ex Macello di Padova, in collaborazione con il comune di Padova
2014: mostra presso l’Officina delle zattere di Venezia a cura di Barbara Vincenzi
2014-2015 mostra presso la galleria del Carbone di Ferrara a cura di Paolo Volta.
2015: mostra presso il caffè tomaselli di Milano.
Link:
http://laurabfortin.wix.com/laura-fortin
https://laurafortin.wordpress.com/
Mi sono avvicinata alla pittura nel 2000, anno in cui i miei genitori decisero, vista la mia passione innata per le arti figurative, di regalarmi un cavalletto da studio.
Iniziai con la riproduzione della figura umana da autoritratti, per poi proseguire con una reinterpretazione libera del corpo e della figura.
Nel corso del tempo mi avvicinai all’astrazione, che divenne il veicolo a me più consono per raccontare la mia idea di bellezza e di poesia.
Quella che negli anni era stata solo una passione divenne la mia principale attività nel 2011, quando decisi di approcciarmi allo studio della storia dell’arte contemporanea e investire le mie risorse e le mie energie in un personale percorso di espressione quotidiano.
Lo studio dei grandi maestri da un lato e il confronto quotidiano con gli artisti viventi da un altro hanno contribuito in modo decisivo a una svolta nel mio linguaggio espressivo.
Dal 2014 e soprattutto nel 2015 ho deciso di affiancare all’attività pittorica su tela uno studio e una produzione importante sul disegno, ritenendolo veicolo efficace di poetica e contenuti nuovi e fonte di ricerca incessante su quello che sta alla base del linguaggio delle arti figurative: il segno. Partendo dall’astratto e arrivando alla “meta-figurazione”.
A oggi il filo conduttore di questa ricerca è aperto ed è improntato alla sperimentazione nell’uso dei media e all’espressione dei contenuti, senza perdere di vista il segno nella sua immediatezza e primordialità, che è ciò che caratterizza la mia cifra stilistica.
Marzo 2015, anno XII, numero 26

In questo nuovo numero, la redazione di “Anterem” presenta alcuni dei finalisti dell’edizione 2014 del Premio Lorenzo Montano.
Quello che nasce dal Premio, da ventinove anni, è un luogo che sempre si rinnova e in cui incessante è il ragionamento intorno alla poesia. Tutto questo avviene non solo mediante testi e teoria, ma anche tramite letture dal vivo, commentate in diretta, all’interno del Forum che annualmente ospita gli autori segnalati e finalisti.
Ricordando a poeti, narratori, saggisti ed editori che fino al 15 aprile 2015 il Premio è aperto a tutti i contributi, scarica il bando della 29^ edizione, auguriamo buona lettura.
Silvia Comoglio, da “Via crucis” (puntoacapo, 2014), nota critica di Rosa Pierno
Silvia Comoglio, da “Via Crucis” (Puntoacapo, 2014), nota critica di Rosa Pierno
Che ci sia uno sfaldamento nella descrizione è cosa prevedibile poiché oggetto della narrazione è il racconto della via Crucis. Raccontare della tortura e della resurrezione tramite gli oggetti che sono presenti sulla scena immaginata comporta una trasformazione, in direzione del tutto paradossale, superante il limite della congruenza: “immoto soffio”, “ciottoli silenti” a testimonianza della loro impossibilità di diventare simboli in un simile racconto. Ma implica anche una restituzione caotica del mondo divenuto contemporaneamente tutto interiore: sarà qui il luogo ove si potrà affermare che esiste un dentro dello specchio, un”’alba appena simulata”: il vero qui, infatti, non si raggiunge più con l’ordine, ma con la sostituzione, anche contro ogni evidenza, tal quale, d’altronde, accade nel miracolo della resurrezione. Sarà proprio la ‘mutazione’ a dare la stura alla scala metafisica: così la fine “fiorisce di eterno” e “l’albero ha lo specchio dentro la sua foglia”. Ogni cosa appare capovolta e da concreta si fa mentale, dove il mentale pretende d’essere l’assoluta verità.
Saltati tutti i punti di riferimento, il mondo non può più essere comprensibile: “Sono mondo – in cui l’estremo non posso più capire”. E conseguentemente le cose sembrano esclusivamente intuibili, non più logicamente correlabili. Una sintassi fratturata a livello lessicale impedisce che si formi un senso compiuto, favorendo una rotante sovrapposizione di schegge d’immagini che non si raccordano, appunto, mai in una figura intera. Tale esito è d’altronde esplicitato non solo formalmente: “il buio da me scritto per leggere e capire”. Boe disseminate indicano una sorta di corrimano: specchio, silenzio, respiro, alberi, luce, corpo, tempo, sasso in una cartografia personale che rifà il percorso della narrazione evangelica in maniera personale, indicando questo testo come un simulacro che ha valore testimoniale. Siamo sostenuti in questa ipotesi da un discorso che si fa sempre più autobiografico: “ il limite che viene di tempo a cominciare / rovescio di fessura del rovo della terra / dove, a gemito che sono, il ventre si rimbalza”. La parola viene innalzata come parola unica che tutto sovrasta: “nel bagliore dell’unica Parola che immobile si espande / serbando ripetutamente l’ora e sempre vissuto a prima volta”. C’è una contrazione del convertire, in finale, dove persino le parole paiono soggiacere a una verità rivelata: e non a caso è un’immobile verità che improvvisamente si fa decifrabile: “in cima, in cima alla collina, dove il labbro /in forma di prodigio, intesse tutto il balbettio, in vibrante semplice discorso”. (r.p.)
Sesta Stazione
Nòmini chi sono, tra gli orti e questa casa,
in un tempo a parola già prescelta, chi prese
un ramo del mio volto, se essenza, sono,
immota della fonte, o enìgma restato nella traccia
di un sacro stupore delle labbra. Nòmini e descriva
l’ocra che ricopre la cima di montagna,
e l’àlbero e la nube, e quésta stessa terra, e il témpo
di sopra queste teste che è bagliore, bagliore necessario
di un cantico sospeso nell’estasi di istanti
pròssimi di soglia, di – irrompere di mondi del tutto –
trasparenti, “a – mattutino colpo dìvampato in cielo
biànco, a margherita –
Undicesima Stazione
Vada questa notte dritta dentro casa,
passando per il viale a mura che si abbassa
sfondandosi negli occhi, un viale, un viale senza luce
dove la voce che si sente è sull’orlo –
dell’orrido più puro, flebile sul corpo
sfatto e ricomposto in ordine di croce. Vada –
dove saliranno tra gli alberi leggeri, bianchi di cicogna,
tutte le buone terre, le palpebre dischiuse, a scalzo –
moto della luce. E sia, a casa, il Tempo che ripete
l’estremo attimo che tocca l’albero a bisogno
di un tronco più leggero, e il tutto e il mare e il mondo –
a chiodo trapassati forzando inauditi! voli di discesa,
fragori di semplici e ritorti nomi sigillati tersi –
alla finestra ---
Silvia Comoglio è nata nel 1969 e vive a Verrua Savoia (To). Laureata in filosofia, ha pubblicato le raccolte Ervinca (2005), Canti onirici (2009), Bubo bubo (2010), Silhouette (2013), Via crucis (2014). Suoi inediti sono apparsi nel blog “La dimora del tempo sospeso” e nelle riviste “Il monte analogo” e “Le voci della luna”. E’ presente nei saggi Senza riparo. Poesia e finitezza e Blanc de ta nuque, entrambi opera di Stefano Guglielmin, e nell’antologia Poesia in Piemonte e Valle d’Aosta, a cura di Davide Ferreri e Emanuele Spano.
Simone Zafferani, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
L’esperienza che si fa in poesia – dove sempre chi scrive e chi legge è chiamato a sentire e provare il senso – è un’ interconnesione di segni tesa a imprimere, in modi mai preordinati, il suo tracciato. Può essere un torrente impetuoso, un sentiero in lieve ondulazione, una scarica a nervi scoperti o una serie modulare di pensamenti, ma in ogni caso prende la lingua e la porta in un luogo difforme dove “si ricomincia il mondo da un dettaglio”. Così, Simone Zafferani, in questa raccolta dispone la scrittura con un andamento che, partendo da un fondo d’ombra sale in superficie portando con sé la luminosità che anche dal buio sprigiona. E lo fa lentamente, grazie un pensiero poetico che arriva con onde basse ma crescenti. Questi versi sembrano immersi in una dimensione quasi di pacificazione, tra la parola che prova a scardinare il senso ordinario di una realtà che appare ma non è, e le cose che si attaccano alla mente con la loro voce impensata, non di questo mondo. Ma è solo un’illusoria pacificazione, perché rinominare ogni volta l’esistente iniziando da particolari che sganciano la comunicazione per incontrare una nuova significazione, vuol dire riconoscerli solo nel momento in cui combaciano con il dire essenziale del poeta (me con me, in modo osceno, precisa l’autore). E la parola attraversa la sua stessa intimità, anche brutalmente, per “tenersi saldamente all’infinito”, con uno sforzo concettuale e ideale che prova e riesce ad accedere a una percezione che ridefinisce il fulcro di ciò che ci fa stare agganciati a un inizio e una fine, rendendo impossibile la linearità del camminamento, solamente con “quattro parole di puntello”. Ma è proprio la fermezza di questo legame che consente di dire e udire i riverberi, gli echi, i richiami dell’ultima indefinita parola che ridisegna la prima, in perpetuo movimento “su una rotta diversa”.
Sembra poco e sembra semplice il sostegno di quattro parole, ma qui non si “puntellano rovine”: il mondo di queste poesie è forse fragile e sciupato, ma imprevisto perché ombroso e luminoso insieme, frutto di una voce dimenticata e riscoperta, con un suono nuovo e qualche volta commovente. In poesia anche una sola sillaba che abbia valore sostanziale è inizio di un mondo che restituisce la sua universa intonazione alle cose; e la loro presenza reale a chi le ascolta; e uno sguardo penetrante a chi si lascia avvolgere dai segni che si incontrano nell’esistenza poetica visibile o invisibile.
Zafferani, in questi testi, ha un gesto d’attenzione particolarmente lieve ma deciso nel riconoscere che la verità non è tanto la certezza di aver compreso e saputo, ma paradossalmente di dimenticare. Non per oscurare o alienare il nostro essere, ma perché “l’avventura è...imparare a non sapere”, per rinascere e per poter toccare, con sensibilità inaudita, una nuova figurazione fisica e mentale. Ci sono poesie, in queste pagine, particolarmente dense di senso e nello stesso tempo leggere, ariose, duttili nel dire l’impatto che la scrittura ha quando diventa vocalità ferma ma dal tono fluttuante, di tenerezza pura e precisa che è sentimento di forma e consapevolezza. E in questo luogo niente viene abbandonato: anche una “poesia nata male”, anche la considerazione solitaria del silenzio racchiudono in sé accadimenti come doni speciali, in una originaria e trasparente identità che solo la poesia può comprendere e portare dentro. E anche quando la riflessione prende la via della visione pensante che cattura un’azione, l’oggetto visto può scomparire in quanto tale ma rimanere in noi, scambievolmente lettera e metafora, dove la parola dell’autore, anche nell’ astrazione, si muove sempre “senza/alcuna contraffazione”. (g. b.)
Da “L’imprevisto mondo”
tenersi saldamente all’infinito
a quattro parole di puntello
e al centro un covo di grazia
e più al centro un magnete di gioia
- durissima, inscalfibile –
che regola il moto e le distanze
quando l’anima aerea s’intrattiene
coi lutti occasionali del suo andare.
dalla sezione Angelo della vicinanza
***
resta esposto e toccato,
piantato nelle radici
con i loro giusti saliscendi.
Guarda
come siano amiche le vicissitudini
venute a cercarti.
Non suturare
troppo le ferite, impasta acqua
ossigeno e sale come tu senti,
non come ti dicono.
Non regolare troppo
l’arbitrio e i fili che lo tengono.
Ascolta
la pulsazione più bassa e danzale sopra
con ritmo non suo e non tuo ma
naturalmente prossimo, come tu fossi
un angelo della vicinanza.
***
ogni giorno un dettato, una preghiera,
sillabe messe a mente, successione senza scarto,
nessuna violazione e nessun urto,
un solo senso unico.
Teoria
e benedizione, voce senza
alcuna contraffazione.
***
con pazienza d’artigiano
mettere a posto il dolore.
Sommessa, tenace
opera della sistemazione.
Tenersi accanto tutto
e guarire per contagio
e crescere per emanazione.
Simone Zafferani è nato a Terni nel 1972, vive a Roma. Ha pubblicato i libri di poesia Questo transito d’anni (Casta Diva, 2004), vincitore al premio Lorenzo Montano 2006) e Da un mare incontenibile interno (Ladolfi Editore, 2011), finalista ai premi Sulle orme di Ada Negri 2012 e Laurentum 2012). Sue poesie sono uscite in riviste (“Smerilliana”, “Poeti e Poesia”, “Atelier”, “L’Ulisse”), in plaquette e in antologie.
Sofia Demetrula Rosati, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
L’arte della sapienza
‘La solitudine della Sapienza’, di Sofia Demetrula Rosati, è un’articolata riflessione in versi concernente il tema dell’umano conoscere.
Introdotto da un esplicito “prologo”, il componimento si apre con una pronuncia emblematica:
tra le mani compassi
le geometrie euclidee non compiacciono
il cuore si esercita sul ritmo e non
procede ma persiste
subito seguita da un’altra non meno esplicativa
la saggezza ha la stessa consistenza del tempo
anticipa costantemente il suo ritardo
Che cosa dire?
Certamente l’umana esistenza è esposta all’incertezza e all’enigma, nondimeno migliorare è possibile: davvero rilevante, perciò, è l’umana attitudine a interrogarsi.
Quanto, poi, alla poesia (praticata dalla nostra autrice con non comune scrupolo), si tratta di un dire particolarmente propenso a ridimensionare i riduttivi schemi logici per evocare un quid nel cui ambito gli uomini sono immersi più di quanto potrebbe, a prima vista, sembrare.
Insomma, per Sofia Demetrula, scrivere versi è la risposta, perché per lei il gesto espressivo veramente originale è fecondo proprio per il suo ricondurre il segno idiomatico all’esordio dell’incontaminato impulso.
Senza dubbio
la fioca luce del sole non intende
dare senso a ciò che illumina
nondimeno il poterlo scrivere è vivida testimonianza riguardante il mondo e chi lo abita.
Non resta altro da fare che impegnarsi nell’opera d’arte alla quale tutti si possono dedicare, ossia quella, appunto, di abitare meglio il mondo?
Questo sembra lo scopo ultimo di ogni conoscenza e, in maniera implicita, l’invito rivolto, dopotutto, dalla nostra poetessa. (m.f.)
la solitudine della Sapienza
dialogo con Qohélet - di Sofia Demetrula Rosati
prologo
s’interroga il sapiente Qohélet, l’uomo più scomodo dell’antico testamento. colui che non mette in dubbio il suo Dio, non chiede nulla e nulla si aspetta. non è il Giobbe che ci sollecita ancora oggi insinuando il pensiero di un Dio che, a fronte di una totale devozione, non sa elargire in base a criteri di giustizia. no, il Dio di Qohélet sembra, egli stesso, solo di fronte alla Sapienza. sembra totalmente disorientato da essa. non sapere come dialogare con Lei. non esiste Sapienza tanto grande da non poter essere offuscata da un unico solo errore. e allora a che serve inseguirla, desiderarla, possederla. se poi, Lei, non si fa possedere.
e allo stesso modo s’interroga il Poeta. l’essere per il quale il dubbio è l’unica certezza. s’interroga su quella stessa Sapienza che tra le sue mani si fa strumento consapevole d’inafferrabilità.
dialoga il Poeta con Qohélet e si fa sincronia di voci. lacerando con quesiti che conducono all’impossibilità di risposta. e se anche la Sapienza fosse, in ultima istanza, asapiente? se la Sofia non fosse altro che un’egocentrica manifestazione di sé? se l’atto stesso del conoscere fosse un passaggio diretto perché la terra torni ad essere polvere. e tutto solo fumo di fumi? e se solo la parola scritta riuscisse a farci aggrappare a qualcosa che somigli a delle sagome in carboncino? se la parola scritta fosse l’unica Sapienza? non per il contenuto, ma per il tratteggiare. se fosse proprio questo movimento, il movimento dello scrivente a dare ordine a ciò che non ha mai chiesto di essere compreso? e se la poesia fosse l’ordine ultimo al quale poter accedere? l’unico senso. la conoscenza di ciò che non può avere senso?
dialogo
1
Qohélet
Un cuore saggio procede diritto
Un cuore storto divaga
Io
tra le mie mani compassi
le geometrie euclidee non compiacciono
il cuore si esercita sul ritmo e non
procede ma persiste
la saggezza ha la stessa consistenza del tempo
anticipa costantemente il suo ritardo
storto è all’opposto per diritto
2
Qohélet
E il sole che si leva
È un sole tramontato
Ogni sarà già fu
E il si farà fu fatto
Non si dà sotto il sole
La novità
Io
ogni ripetizione sorprende l’istante nuovo che
la precede e quello che la insegue per ispirazione
la novità è in tempo relativo
non vedo nulla che non sia già stato
l’eternità inaridisce i terreni e li rende incolti
3
Qohélet
Che cosa è che fu
Se quel che fu è
E se Dio fa che torni
Il fuggito?
Io
se il fuggito torna
determina un percorso
l’inizio e la fine si avvicendano nella costruzione
dello spazio e del tempo il fuggito
percorrendo coniuga il verbo che si fa carne
quel che fu fu
quel che è è
4
Qohélet
E l’altezza mette paura
Ti agguantano spaventi per la via
E il mandorlo biancheggia
La cavalletta s’intorpidisce
Il cappero pende inerte
E l’uomo se ne va
Alla sua casa indefinita
Tra i piagnistei rituali
Delle donne nel Suk
Io
spaventare l’altezza per il
trionfo del nulla
anche se sono a terra
calpesto sudari sgualciti
la stagione è incerta
tra un finire d’inverno
e un’estate che avvizzisce
l’uomo se ne va
di lui solo un tratto in carboncino
le donne fanno festa nel Suk
5
Qohélet
Per qualche mosca
Si guasta un vaso d’unguento
Di profumiere
Poca stoltezza offusca
La gloria di un sapiente
Io
In un campo di stolti
poca sapienza dà gloria eterna
il giudizio condensa l’odore del giudicato
in piccole ampolle vendute a poco prezzo
al mercato delle spezie
6
Qohélet
Sapienza è meglio che ordigni da guerra
Ma quanto bene si perde
Per un unico errore
Io
Che fece il gran rifiuto!
ebbe a dire il poeta schivato
7
Qohélet
E vedo tutto il lavoro di Dio
ma a tutto quel che accade sotto il sole
un senso l’uomo non riesce a dare
gli uomini si affannano a cercare
senza poter trovare
e il sapiente che dice io so
resta senza trovare
Io
la fioca luce del sole non intende
dare senso a ciò che illumina
gli uomini cercano con le spalle curve
e la testa china tra la polvere
con poca saggezza qualcuno
raccoglie ciottoli lungo il cammino e
con passo pesante il viandante
spaventa le lucertole stese al sole
8
Qohélet
Due coricati insieme
si scalderanno
Ma a chi è solo
quale calore?
Io
la solitudine non consuma le ossa solo calore
un falò di libri ho dovuto organizzare
per la lunga attesa del gelo
ho sperimentato giacigli di parole
coricàti sul letto le nostre scapole non
hanno bocche per dialogare
voltàti ognuno dal proprio lato
con una pietra focaia in mano
senza sapere cosa farne
La traduzione del testo di Qohélet qui utilizzata è tratta da: Guido Ceronetti “Qohélet. Colui che prende la parola”, Adelphi edizioni, Milano, 2001.
Maria Angela Bedini, una prosa poetica, premessa di Mara Cini
Una prosa ricca di anfratti sonori e descrittivi quella di Maria Angela Bedini, una trama specchiante catturata dalla cornice dei due paragrafi in apertura e chiusura:
La città che mi abita nelle vene è una fortezza scura, io la porto come si porta un dolore…
E là oltre la marea e le onde screziate udivo volti di santi spalancarsi…
Si tratta di un susseguirsi di prospettive “gemmate” dove gli elementi naturali e stilistici (vento, architetture, costole erbose, volte annerite, radici, ardesie dei tetti, , altane e cantine) confluiscono in una sorta di vena maestra impetuosa e minuscola tanto da somigliare a una gemma che dorma dentro l’astuccio di un ramo. (m.c.)
La città che mi abita nelle vene, incipit
Maria Angela Bedini è nata a Buenos Aires dove ha trascorso l'infanzia. Svolge attualmente attività di ricerca presso l'Università di Ancona. Ha pubblicato le raccolte di poesia Trasgressioni (1987), Essenze assenze (1991), Ma il vuoto fu scarso a sparire (in «Nuovi poeti italiani 4», Einaudi 1995) e La lingua di Dio (Einaudi).
Luigi Reitani, premio speciale “Opere scelte”
Luigi Severi, da “Specchio di imperfezione / Corona” (La Camera Verde, 2013), nota critica di Rosa Pierno
La cultura è l’oggetto delle evoluzioni linguistiche di Severi, il quale prova sulla propria pelle abiti altrui tramite, appunto, linguistico travestimento. Retorica domanda quella che l’autore affida al lettore: “seminagione / sillabe di diserzione // filano segni di alba, non di croce / divinas // litteras in vulgi linguam transfusas / sapere // è sangue nelle arterie / è prima voce?”. Tutto si consuma nella materia linguistica, ma anche prende vita nuovamente rilanciando, poiché la lingua è terreno esperienziale, ove persino la mistica trova il terreno più adeguato per i suoi esercizi. I due poemetti, il primo su Ferdinando Tartaglia, il secondo su Angela da Foligno, si intrecciano con la storia delle vittime del Petrolchimico di Porto Marghera e con elementi prelevati a viva forza dalla contemporaneità. La pagina diviene un terreno di coltura e di raffinamento, dove il solo prodursi della scrittura estrinseca un pensiero riflessivo di raffinato pondo. E’ la scrittura l’orizzonte a cui guardare e il suolo da percorrere, in un’evidente presa di posizione da parte dell’autore su quale sia il ruolo da assegnarle contro un senso che le pre-esisterebbe. Scrittura che vale anche come rilettura dell’esperienza altrui: il vistoso scarto tra lo stile di Tartaglia e quello di Severi, ad esempio, vale come differenza esistenziale, come prova della diversità individuale. In fondo, il commento stesso riceve qui una motivazione carnale ci verrebbe da dire!
Sulle pagine di Luigi Severi ritroveremo punti in cui la scrittura cerca distanza dall’esperienza diretta e altri dove vuole prenderla invece in carico a testimonianza dell’effettiva consistenza dell’esercizio scritturale, che è anche esercizio pragmatico, non solo mentale. Forniamo un esempio di come, a nostro avviso, la scrittura di Severi riscriva il testo di Tartaglia in altra forma: “ ma cercare di rendere / ma tornare in unione / ma cercarti nei muri”. E un esempio di come la via mistica di Angela da Foligno (e si sa quanto la scrittura mistica sia un paradosso) viene qui coptata da elementi che inseriscono la contemporaneità con estrema naturalezza nel rovello interiore: “c’è anche il fatto della favola preferita / del colpo di telefono a quell’ora precisa / del regalo mandato per posta”. Naturalmente non c’è un esito salvifico, una risposta che saturi il rovello, il dubbio, la ricerca sul linguaggio e, del tutto coerentemente, Severi si mantiene sul medesimo periglioso crinale. (r. p.)
dalla sezione I. Primi esercizi spirituali
Di geometrie ulteriori
(Tartaglia matematico)
Tartaglia celebre matematico
inciampato in te stesso e nella maglia
della tua prima infanzia, l’ansia
di ogni accento selvatico, di ogni ferita
avrà una sua ratione calchulabile,
un suo pregio geometrico / tracciabile
e poi questa fatica
di instabile, di cenobita
satanico a tentare i nessi angelici
(tra le algebre di un conto a una candela)
la sinfonia ronzante dei pianeti, l’odore
di bruciato dopo il colpo
Conclusioni provvisorie
(di veglia)
I
In ascolto assoluto,
stasi di quercia arcaica
di radici traverse, a fondo
di un’ultima terra, a legno nudo.
Non per la maestà della scomunica
ma per ogni dolore inefficiente
ogni sudore di convalescente,
capillare sommerso della storia
(per grumo nella gola
per tutti i libri letti
per ogni voce minima
ogni battito di non-memoria
II
Scrivere migliaia di pagine
che nessuno leggerà mai
sanguinare parole
cicatrizzate sole
è già una prima
definizione
Conclusioni provvisorie
(nel sonno)
I
alla sconfitta inferta
fino alle sale nere
delle voci più fragili
straniere
la certezza dei pochi
che hanno bronchi impeccabili
il dovere dei molti
la maceri
ma la tavola algebrica
sotto i colpi più logora
la mia rabbia più dura
prosciuga
II
il talento dei muti
il passo degli inabili
il silenzio degli esuli
imparare a difendere
ma cercare di rendere
ma tornare in unione
ma cercarti nei muri
manomessi, implorarti
(non ho altra ragione
che attendere
Luigi Severi è nato a Roma nel 1972. Ha scritto saggi sulla letteratura rinascimentale e sulla letteratura novecentesca. Suoi versi e racconti sono apparsi in diverse sedi cartacee e telematiche.
Nel 2006 è uscito il suo primo libro di poesia, Terza persona (ed. Atelier).
Greta Rosso, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
Il fare poetico, nel suo difforme andamento (ricco sempre di implicazioni altamente evocative e dirompenti), fa sì che il tempo e il luogo vissuti, immaginati, ricordati, e in ogni caso scritti (anche solo nel silenzio del proprio pensiero), nel lavorio interiore che il dire porta in superficie per dare nome e sostanza ai sensi delle scrivere – e sottrarre a questi le omologazioni e le conformità della lingua ordinaria – conducano spazio e durata a mischiarsi, a confondersi, a scambiarsi le funzioni percettive e concettuali. E questo produce uno spaesamento nella significazione che ribalta il prima e il dopo: dilatando o concentrando movimento e stasi, dentro e fuori, ombra e luce. Ed è propriamente ciò che si prova leggendo IL DISGELO di Greta Rosso.
Emerge nei suoi versi l’inquietudine di una consapevolezza che ridisegna le normali categorie conoscitive svuotandole del loro sentire soggettivo. Ma con un atto di privazione apparentemente assurdo: la sottrazione “di un sentire che non potevo/ avere, ma c’era...” Ecco lo spostamento nella dislocazione di un sapere: il venire meno di un senso d’esserci che ha il suo nucleo in un sentimento brulicante di vita, ma impossibile. Come un ricordo o una visione che non dovrebbero appartenerci eppure ci sono e continuamente ci vengono negati. Solo un atto poetico di lucidità e sregolamento estremi, o forse anche solo istintivamente destrutturato in fluidità e lampeggiamenti, può rendere consistente un’esistenza sgretolata, una parola intrattenibile, una voce come questa, che “lascia una scia di polvere”. Frammenti che non velano ma rivelano agli occhi qualcosa di irripetibile, perchè continuamente oscillante fra allucinazione sensoriale e acutezza concreta, luminosa. Una coesistenza dove l’immagine allitterante, in termini auto inglobanti come “lascia” “scia”, non emerge semplicemente come dato tecnico, ma (conscio o inconscio che sia) come vero e reale motivo ricombinante, dove il vedere si ritrae e lascia spazio all’attrito.
Ma verità e realtà in questi testi perdono il sentore oggettivo che li caratterizza nell’ordinarietà del linguaggio, per trasfigurarsi in ciò che fa poesia: nel caso specifico, un pensiero accidentato, graffiato, ma anche aperto a riconsiderare le trasformazioni, per cui la scrittura è necessariamente obbligata a rischiare, se non vuole decadere a insignificanza. Nei testi di Greta Rosso c’è tanto fremito e tanto disperdimento: una dissipazione emotiva, però, non ingenua né artefatta, ma coerente con la natura e la frattura che un vivere teso a “sprofondare nell’assenza”comporta. E’ un movimento a margine, un camminamento al limite di un bordo dove la presenza poeticamente umana si raccoglie e si stringe in una spazio in cui la parola di sé appare irriconoscibile, fantasmatica, lacerata in un rovesciamento dove ciò che è non sembra. Perché non ci sono agganci solidi in questi poesie, nulla che determini banali sicurezze. L’autrice intuisce il sapere fondante di ciò che scrive: perforare il senso e con “la gola dolorante...incastrare le parole...”, polverizzare le dimensioni certe per intrecciare e reindirizzare (anche zigzagando o raggomitolando) un pre-sentito sofferto, nel tempo sbagliato un “il disgelo mio/mal profetizzato.”
Una poesia, questa, che svolge la sua qualità corporea in modo tale da far pensare a parole uscite come trasudate, lente, curvate da un’attrazione fisica nevralgica che piega costantemente l’articolazione semantica della frase, nel suo spazio di sommovimenti ma anche di velature lievi, di sussurri e scioglimenti. (g. b.)
Da “Il disgelo”
***
era qualcosa di più forte del fango secco sotto le nostre suole, era
un’intubazione che lasciava la gola dolorante
così da incastrare le parole là in basso, da qualche parte.
non ci saremmo arrischiati in ulteriori prove di forza.
bastava il fatto di essere lì, uno di fronte all’altro,
i volti scomposti e umidi.
***
espone la perdita fratturata, scomposta, scolpita
ne estrae le parti eguali, la rende pulita e netta.
controlla i frammenti, li conta, li elimina.
resta infine il ricordo asettico di ciò che fu.
un quadro irripetibile che non entra negli occhi.
***
il tuo corpo di pietre nell’erba tremenda delle periferie
lascialo alla foschia, alle tettoie d’amianto e alle cantine disperate.
prenderà commiato come un solo commento sul tempo.
come un mattone, una stella, un tragitto dimenticato.
***
era usanza turbare, sollevare veli
senza essere eccessivi, censurando
pesantemente, moltiplicare le parole
come popolazioni socialmente
avanzate, rovesciare i bicchieri
dopo aver bevuto, trovare un
agio nel gelo assoluto del
pavimento.
Greta Rosso è nata a Casale Monferrato il 16 luglio 1982 e risiede in Valtellina (Bormio -SO-). Ha pubblicato in volume “Cronache precarie” (Aìsara, 2009) e “In assenza di cifrari” (Lietocolle, 2012), nonché diverse poesie su siti web quali Nazione Indiana, AbsolutePoetry, Viadellebelledonne, Imperfetta Ellisse, e sulla rivista cartacea Il Foglio Clandestino. Nel 2013 si è classificata terza ex aequo al Premio Baghetta (premio del pubblico) e prima al Premio Isabella Morra (sezione poesia edita).
Romano Morelli, saggio breve inedito, premessa di Mara Cini
NON SCRIVERTI
tra i mondi
Paul Celan
Alle riflessioni di Morelli sulla poesia e sul nostro presente, si potrebbero aggiungere altre note, altre considerazioni, altre domande … si fa poesia solo con elementi verbali o anche con altri segni? … con il linguaggio alto della letteratura o anche con scarti e frammenti di vocaboli?…sappiamo dalle avanguardie, da Duchamp, che l’arte non solo si crea o si elabora ma si può anche trovare …la poesia può essere traccia di una memoria, presagio, semplice ricordo, composizione metrica ma anche elenco, lista, annotazione…
La severa riflessione di Romano Morelli, giustamente, associa la forma del mondo al linguaggio sottolineando che nessun campo semantico, comunque, è in grado di dar conto pienamente dei grandi eventi che accompagnano l’umanità. La poesia, con più veggenza e con più timore è questo che, spesso, ci ricorda. (m. c.)
Ancora una riflessione sulla poesia e sul nostro presente.
L’attuale - anche se tutt’altro che recente - assoluta, singolare solitudine dei poeti è solo un punto di partenza, il più evidente forse, ma certo non il più importante, per affrontare il tema del rapporto tra presente e poesia.
È una questione che è stata sondata, pensata, percorsa molte volte.
E’ un fatto tuttavia che rimane sempre una certa quale insopprimibile insoddisfazione: è come se il bisogno di ritornare ad indagarla risorgesse incontenibile, come se, anche per la poesia, quel ripensamento dei fondamenti che percorre tutta la cultura dell’Occidente moderno non avesse poi consolidato granché nonostante i dibattiti e le evidenti conquiste. E’ come se, malgrado le certezze che tanto spesso assomigliano così tanto a dati acquisiti, su ogni nostro prossimo passo - quello che dovremo fare domani - continuassero ad incombere e ad accompagnarci sempre le stesse ottuse domande, la stessa paura, la stessa paralizzante incertezza.
Da tempo i poeti vivono distanti, si pèrdono e muoiono insepolti.
Il poeta oggi si trova, contro la sua volontà, contro la funzione stessa che il linguaggio gli assegna, nella condizione di un mandarino, come il fisico, il matematico, il filosofo che operano ormai su realtà talmente distanti dalla coscienza comune da essere incomprensibili - e quindi sono incompresi, e quindi ineluttabilmente soli.
La grande poesia europea si trova ad essere l’avamposto estremo e quasi perduto della coscienza dove arrivano, si interpretano, si trasmettono le informazioni su ciò che di visibile sembra apparire dell’oscuro destino che ci aspetta.
Oggi, da quest’inospitale e quasi irraggiungibile punto di osservazione è possibile indovinare (mentre nella città, dove l’aria comincia a mancare, si continua ad amare e a odiare come al solito) che non solo la via è smarrita e che davanti a noi si stendono solo misteriose, perverse, impraticabili opportunità, ma soprattutto, che quella che avevamo creduto la via percorsa in realtà una via non lo è mai stata: tutt’al più si è trattato di una serie di fortunate, sciagurate coincidenze, tratti sterrati, radure, guadi immeritati.
Non solo: oramai le osservazioni convergono sul fatto che siamo evidentemente impreparati all’evidenza di dover cominciare a costruire la nostra, quella vera, quella che ancora non c’è. Ciò è tanto più disperante perché non sappiamo dove dirigerci.
Intanto, mentre la città crede di vivere, l’inatteso incombe.
Ecco perché non della città parla oggi la poesia europea né delle parole della città essa si può servire; ma con fatica e dolore si forgia invece le parole rozze, dense, brucianti, che dicono l’orrore e la paura che ci stringono e ci crescono attorno.
La poesia europea degli ultimi due secoli è una ferita, è il luogo sensibile della coscienza europea: esposto, indifeso, dolorante e reattivo come una ferita sempre aperta.
***
I. L’uomo è linguaggio. L’uomo diventa tale nel e con il linguaggio. Nulla esiste per l’umanità senza o al di fuori del linguaggio. Nessuna cosa esiste, nemmeno l’uomo, là dove manca la parola. Il linguaggio dà forme al mondo e lo apre all’azione dell’umano.
II. La poesia è, tra i tanti aspetti del linguaggio, uso totale, potenziato e creativo. Attraverso la pratica del linguaggio in tutte le sue risorse costitutive (semantiche, sonore, strutturali) la poesia lo mantiene vivo, produttivo, strumento e luogo di conquista, creazione e comunicazione.
III. La poesia è stata – e lo è tuttora – il regno dove sentimenti, emozioni, esperienze, ricevendo i loro nomi, sono diventati patrimonio culturale cioè strumenti trasmissibili ed utilizzabili per comprendere, dare un senso a ciò che l’individuo sente e che, altrimenti, rimarrebbe nascosto, oscuro.
IV. A un certo punto, nell’Europa del XVII secolo, per una serie di avvenimenti economici, storici, culturali concomitanti l’antico equilibrio tra uomo e mondo si è spezzato, quell’equilibrio che era durato tanto da introdursi nella mente e nei nervi dell’umanità come naturale, l’unico.
Attorno a questo asse ruotavano tutte le concezioni necessarie e sufficienti all’essere umano per fondarvi un senso: destino, sapere, morale, linguaggio. Ora, alla luce dei cambiamenti sopravvenuti, gli antichi fondamenti della condizione umana nel mondo cominciano a non funzionare più, a non rendere ragione delle domande, delle nuove emergenze in cui l’umanità europea si trova a vivere e a dover decidere.
Le risposte alla necessità di rifondare il rapporto uomo/mondo sono state molteplici, diverse, anche radicalmente diverse, divergenti. E’ stato un vagare alla cieca, sulla spinta dell’urgenza, verso terre sconosciute senza potersi mai fermare.
Noi, oggi, siamo ancora nel pieno di questa dolorosa migrazione.
V. Da più di due secoli ormai la poesia accompagna in questo viaggio l’Europeo.
La poesia può e deve continuare ad essere se stessa, ciò che è stata per tanti secoli: lo strumento per l’identificazione, l’espressione, la comunicazione di sentimenti, esperienze, pensieri. Ma si trova oggi obbligata, come tutti gli strumenti umani moderni, non solo a svolgere il suo compito, ma anche, allo stesso tempo, a ripensare il suo rapporto con il mondo: deve parlare contemporaneamente del dramma dell’umanità in viaggio nella tempesta senza direzione e di se stessa, del linguaggio.
La poesia porta, in questo errare, la croce della mancanza di fondamenti, della ricerca di fondamenti, della libertà da fondamenti. Nella poesia di oggi si esprime l’angoscia atterrita di ogni errare: il bisogno atroce di una meta e della pace, nel ripetersi inevitabile, in un’attesa forse vana, del sacrificio delle nostre piccole, ma uniche vite.
VI. La potenza senza freni della tecnica, liberato definitivamente l’uomo dalla natura, apre davanti a noi un mondo senza confini dove l’unica presenza che sentiamo è quella di un mistero infinito.
Essa ci arricchisce di inaudite potenzialità, ai limiti del comprensibile e, oggi come oggi, oltre il governabile. Le macchine che abbiamo messo in moto e che ora avanzano spinte spaventosamente solo dalla forza della loro inarrestabile logica ci hanno gettato in un tempo che è troppo lontano dai nostri vecchi millenni dove avevamo radicato le nostre concezioni di vita, spazio e tempo.
VII. Come Europei abbiamo fatto esperienza precoce, significativa e ammonitrice dei pericoli di cui sono gravidi questi grumi in corto circuito: la prima e la seconda guerra mondiale, i campi di sterminio, la proliferazione atomica, la rapina cieca delle risorse del pianeta. Nessun campo semantico, oggi, in grado di accogliere pienamente questi orrori né di dire il futuro che si prepara.
Qui abita il poeta, in trincee tanto profonde da sembrare tunnel oscuri che sboccano verso l’inesprimibile non-ancora-umano.
***
La scomparsa della nostra vita sulla Terra è l’orizzonte entro il quale siamo chiamati a vivere, ad agire, a consumare le nostre così brevi vite. E con la coscienza che nessun Dio, ma noi, solo noi siamo responsabili, noi, così deboli così bisognosi d’aiuto, così tragicamente, assolutamente soli con noi stessi.
Questo è, deve essere, l’orizzonte terrificante della poesia occidentale. Di questo la poesia deve tentare di parlare, rendere ragione. Alla luce di questo sole desolante dobbiamo cercare di costruire la nuova dimora. Ogni altro orizzonte è falso, consolatorio, truffaldino, mortale.
Semplicemente dunque, la poesia deve cercare le parole per parlare di ciò di cui ancora non si può; deve tentare di dare un senso a ciò che ancora non può averne.
E con lo sguardo fisso sulla verità del baratro deve cercare di mantenere in vita la speranza.
Romano Morelli è nato a Liegi, Belgio, il 13 giugno 1953. Vive e lavora a Padova.Ha pubblicato due volumi di poesie: “E’ non è”, presso l’editore Rebellato, 1988 e “Questo essere”, Mimesis, 2013.E’ autore inoltre di un saggio su Hölderlin, “Su Hölderlin e il sacro”, nel volume collettivo: “Teologia della follia”, a cura di A. Martin e M. Geretto, Mimesis 2013.
Giovanni Campi, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
Contro comodi oblii
Le battenti sequenze proposte da Giovanni Campi richiamano un universo poetico come sospeso in una sorta di statico dinamismo che apre varchi nella lingua per chiuderli subito dopo.
“nessun giorno senza notte”
è il titolo immediatamente replicato dal primo verso nel suo quasi identico contrario
“nessuna notte senza notte, e tutte”.
Primo verso che presenta sul finire quelle due brevi parole “e tutte” capaci di dare l’avvio all’intero, articolato, meccanismo compositivo di un testo che si sofferma ma non si ferma, che indugia eppure corre.
La forma è allusiva e tenacemente enigmatica.
Un enigma davvero complesso, quello di Giovanni, che riguarda
“la luce e ’l bujo, se di sole o luna”
ossia l’universo inteso come cosmo, congiunto, per via poetica, con l’umano linguaggio vissuto quale necessità espressiva mancante d’inizio e fine e, perciò, quale divenire della comunicazione nel suo stesso farsi, tra certezza e incertezza, suono e silenzio, splendore e oscurità.
Leggendo questi versi, avvertiamo un coinvolgimento inconsueto, una sensibile partecipazione rivolta verso l’esterno come verso l’interno e, alla fine, riconosciamo che il nostro stare al mondo è parziale e totalizzante, minimo e immenso, specifico e generale.
L’ossimoro quale forma di vita?
No, perché in questo caso è espressione di un’integrità maggiore in grado di opporsi a quel rigido determinismo che spesso si nutre di comoda disattenzione, di opportunistico disinteresse.
Emerge, così, in maniera netta, la radice etica di una versificazione il cui originale (quasi provocante) dire getta luce sulla complice superficialità di tanti atteggiamenti quotidiani tesi a mantenere nell’ombra taluni tratti non proprio edificanti.
Siamo al cospetto di una poesia morale?
Sì e anche coraggiosa. (m. f.)
nessun giorno senza giorno
(detti sdetti di gc)
nessuna notte senza notte, e tutte
l'insonni, come suoni sono – nulli
e nullannulla giorno men trastulli
la data tolta e stolta a voci sdutte
e quale sorge come giorno senza
essendo desta d'esso stesso giorno
la luce, adesso, d'esto bujo 'ntorno
contorno e non ritorno d'un'assenza?
dischiuso 'l chiuso d'uso sen consumi
il senno 'n sonninsonni, senza sogni
per ciò, né men che meno men bisogni
l'abuso 'l giorno 'n notti grumo a grumi
dissimulando símile la notte
a 'l giorno 'n copia o quasi 'l ver a' falsi
' sentieri d'ieri l'oggi pone 'nvalsi
a cosa? forse torre torri rotte?
fortezza 'ndéboli babèlbabèlica
minuta derivata 'n dismisura
di nulla sfigurando ogni figura
di giorni e notti, e spira – la matèrica
in spira e spira 'n fuga 'l moto immoto
opposta uguale ne ricerca diastole
la luce e 'l bujo 'n spera: spera 'n sistole
allora 'l frullo d'ali qual tremuoto?
innebulando senni e segni 'n vaghi
sentieri detti per errarerranze
di rada forma ' verbi ' nomi dianz'e
dipoi, se sdetti – van, e 'nvan divaghi
di giorno o notte non saper saperne
la luce e 'l bujo, se di sole o luna
l'imago: vago 'l dire d'altro o d'una
allora, e se superne o forse inferne
se forse nera o forse no, la luce
non bianca: allora come dire l'una
o l'altra, e l'un'e l'altr'o se? nessuna,
nessuna luce d'ora in poi, né 'n nuce
la luce allora nera come dire?
la volta avvolta nella notte senza
il giorno, senza luce, pura assenza,
cosí di notti e giorni a non finire
fino alla fine della notte – solo
che non finisce, giorni senza giorno
nascendo, senza luce, - tutto - attorno
s'intenebri 'n nonnulla: cielo e suolo
ma l'ultima non dire né tacere,
ascolta: ché ' silenzj forse parlano:
improprj verbi non comuni cavano
vocando – suoni, e vocj e cerchi 'n spere
perché per cosa 'l giorno dopo notti
insonni o quasi, come prima, allora,
essendo l'esser luce – nera dire d'ora
in poi la notte, l'una, e tutte, innotti
finché la fine possa non poterne
ancora, d'esser sé, ma come? e quale
di questa fine 'l fine? forse 'l male?
non c'è la fine, no, per cosa averne?
aver d'averne cose cosa come dire
di giorni e notti senza fin finiti
non piú cælicoli, gli dèi, se miti
'nqujeti, non equorei, e senza mire
se quasi bujo 'l giorno nel finirsi
la notte dir che incombe – come cosa?
s'incúba forse d'íncubi? non posa
di sé che tènebre? e mai da sfinirsi?
dirada 'l bujo 'l giorno ne gl'inizj
di che símile al símile s'assímili:
lo vedi o non ancora? le invisibili
visioni ne risveglj, e ' precipizj
vertiginando immoto moto d'ess'o
non esser copie o quasi d'esemplare
esempio l'émpia d'émpiti émpj 'l dare
tra l'una traccia e l'altre 'l voto 'l fesso
che come cosa dire d'ogni giorno
se non che come se non fosse notte
di poi, tra poco: dopo 'l giorno, rotte
che sian le rotte, via, non c'è via 'ntorno
ricorda: non di men dimenticare
di ricordare – cosa? non ricordi
di cosa, non di chi, dei suoni sordi
d'allora 'n voci di ora da invocare
che d'ogni giorno non si attenda niente
se non il giorno stesso, o d'esso giorno
la luce, ché la notte tutto intorno
la luce par sparire, e tutto e niente
ma quale giorno 'n cielo, o se: che forse
la terra 'n terra non di sé ricopra
talun talaltro corp'o cosa? ad opra
di chi, questa opera? non sen accorse?
e pure, a volte, 'n cielo, c'è, di giorno,
come una luce, non si dica questa,
del sole, no, non è soltanto questa,
la luce, forse quella – del ritorno?
ancora non ancora, se la notte
non c'è ritorno: l'ultima, da farsi
disfatta, e dirsi sdetta, 'n giorni apparsi
spariti, 'n sonni insonni, questa notte
ascolta: cosa ascosa 'l tuo volere
accolga pure giorni e notti quali
che sono adesso, e d'essi – tali ' mali
Giovanni Campi (Caserta, 1964). Suoi testi sono in rete (La dimora del tempo sospeso, Nazione Indiana, La poesia e lo spirito, etc.) e in varie antologie; vincitore della settima edizione del premio MAZZACURATI-RUSSO “i miosotìs” delle Edizioni d'if, è in attesa di pubblicazione del volumetto "babbeleoteca minuta" nella collana medesima; di prossima pubblicazione è anche il dialogo "l'irragionevole prova del nove" per i tipi della Smasher Edizioni nella collana "orme di teatro".
Gennaio 2015, anno XII, numero 25

Se poesia è “agire al di sopra di ciò che si riesce a pensare”, come scrive Nanni Cagnone, se “i poeti interrogano il linguaggio al di sotto delle sue falde discorsive, che così tanto assomigliano alla superficie anonima delle cose”, come afferma Flavio Ermini, esiste sicuramente molto spazio da abitare poeticamente. Ovunque si pongano, i poeti smascherano il mondo osservandolo dai margini. Tra al di sopra e al di sotto si apre senza protezione una zona multiforme, una lunghissima crepa, l’ombra di un’inappartenenza, un’atopia dove radicarsi, una continua partenza, un esilio senza terra da raggiungere, una ferita che non sanguina.
Tutto quello che segue, a partire dal ricordo di Tiziano Salari, nasce dall’esperienza del “Montano 2014”, tra poesia, saggio e prosa poetica.
Ricordando a tutti i poeti, narratori e saggisti che l’edizione 2015 è appena iniziata scarica il bando della 29^ edizione, auguriamo buona lettura.
Immagine di copertina: dipinto di Paolo Corsino
Laura Caccia, "Per ricordare Tiziano Salari"
Relazione tenuta l’8 novembre 2014 a Verona, nell’ambito del Forum di Anterem
Relazione tenuta l’8 novembre 2014 a Verona
Per ricordare Tiziano Salari
Un altro dire
“Di un altro dire”: un dire di cui il pensiero e la parola di Tiziano Salari sono fortemente intrisi.
Partiamo allora da questa suggestione: che Tiziano Salari sia qui, come altre volte in passato, all’interno di un Forum dedicato ad “un altro dire” proprio in quanto, di questo altro dire, errante e intenso testimone.
Non possiamo permetterci, nel delineare un suo ricordo, altro che seguire le suggestioni che provengono dalla lettura dei suoi lavori; autorevoli critici ne hanno accompagnato e valorizzato i percorsi saggistici e poetici prima e dopo la sua recente scomparsa.
Che Tiziano Salari sia, nello stesso tempo, ospite e viandante di un altro dire è la prima impressione che suggerisce la sua ricerca, volta a cogliere le connessioni tra pensiero e parola poetica, a partire dalla convinzione della “centralità di ogni esperienza nel linguaggio”(Sotto il vulcano. Studi su leopardi e altro), e insieme tesa a dislocarsi, a sfidare visioni tradizionali, “disarticolando” come scrive “le mappe conosciute“ (Il Pellegrino Babelico) verso “nuove forme di pensiero…radicate in un terreno inesplorato” (Essere e abitare. Appunti di lavoro dell’Autore).
L’impressione successiva deriva dalla vastità dei temi e dei modi con cui tale “terreno” incognito viene esplorato, scavato, creato da Salari nella sua ricerca inesausta.
A partire dalla pluralità di approcci e di punti di vista, in un intersecarsi continuo di filosofia, critica letteraria e poesia, con cui, nel solco delle analisi che nel novecento hanno attraversato filosofia, ermeneutica, psicoanalisi, linguistica, Salari affronta questioni e relazioni ontologiche e poetiche.
Per articolarsi poi nel capovolgimento delle modalità espressive tradizionali che lo conducono all’interrogazione filosofica nei lavori poetici e, viceversa, ad evocazioni di immagini e sensazioni nei lavori saggistici e di critica.
E ancora, riprendendo alcuni titoli dei suoi lavori, collocandosi “Sotto il vulcano”, nella riflessione che, a partire dal tragico in Leopardi e dal radicarsi della ginestra nel deserto, si muove nella vertigine di quel “(Il) grande nulla” che nel pensiero e nell’arte del novecento troverà il suo fiorire.
Oppure ne “Il fruscio dell’Essere”, nei suoni e negli echi che mettono in gioco, insieme, la poesia e l’essere, a partire dalle “desolanti suggestioni” che, nella citazione di Baudelaire salgono verso l’alto, nel tentativo “di tradurre in canzone il grido stridente del Vetraio”, fino a quella diversificata sperimentazione poetica e sonora che nel secolo scorso arriverà a musicare il silenzio.
Nei labirinti e nelle erranze del dire
La suggestione che deriva dalla lettura dei lavori di Tiziano Salari è che la sfida all’inesplorato sia un continuo viaggio, tragico e vibrante, nel pensiero e nel linguaggio, nella filosofia e nella letteratura, tra i libri e nelle metropoli, all’interno delle biblioteche e del corpo, nell’umano e nel mondo, nel nulla poetico e in quello esistenziale, nella poesia e nelle macerie della contemporaneità.
Percorrendo molteplici e contrarie direzioni, abitando e dislocando gli opposti, ovunque si annidino i luoghi nascosti o i frammenti dispersi dell’inesplorato.
Che si muova in un luogo reale o letterario, nello spazio del mondo o del pensiero, nella biblioteca de “Il Pellegrino Babelico” o nei paesaggi metropolitani e poetici di “Essere e abitare”, ne “Il fruscio dell’Essere” o ”Fuori di sesto”, come titolano alcune opere, la sua ricerca, sempre tragicamente irrisolta, oscilla tra i meandri e i terrori dell’incognito, che non consentono vie d’uscita e di senso, e il terreno instabile della vita, dai molteplici sensi dispersi, dolenti.
Dislocandosi nei luoghi del chiuso e dell’oscuro, in una biblioteca, una torre, una selva, una metropoli, che, pur riverberati di rimandi e pluralità di voci, restano intricati, murati o, viceversa, nei luoghi dell’aperto e della dispersione, della viandanza, del dolore.
Nei labirinti e nelle erranze del dire.
“Tra il labirinto dei corpi e l’inizio della parola”, come sottotitola la raccolta di saggi curata con M.Fresa “ La poesia e la carne”.
Ci chiediamo allora dove inizi e conduca la parola che sa di dover fare i conti senza tregua con i labirinti del proprio oscuro e della propria indicibilità e che, nello stesso tempo, si perde e disperde nelle sue erranze interminate.
Quale tragica fine evidenzi la condizione del limite e, nello stesso tempo, quali nuovi inizi e rinascite questo limite consenta, nel “sublime della ripetizione”(Il Pellegrino Babelico), nel rispecchiarsi, a volte deformante a volte illuminante, di voci.
E a quali abissi e disfatte porti l’erranza senza limiti, nei territori disgregati e inospitali, e insieme a quali leggerezze, evaporazioni, “tra le torri evaporate dell’essere”(Fuori di sesto) o verso l’irreversibile nulla.
In ogni caso, suggerisce la voce sofferta di questo pensiero insieme babelicamente recluso e libero, il dire è smarrito, sradicato, straniero.
“Essere bilingue, multilingue,” scrive Tiziano Salari “disorientato e/ straniero nella propria lingua/in una sola lingua sradicato “ (Il fruscio dell’Essere).
Abbracciare l’inconciliabile
Ci domandiamo quale dire possa riuscire a sostenere tale disorientamento.
La suggestione è un dire che nei lavori di Tiziano Salari si fa interrogante e meravigliato, pensoso e vibrante, vertiginoso e desiderante, dolente e vitale.
Perché la sfida è appassionata, il rischio quasi insostenibile.
Un dire che si fa altro, sradicato tra il perdersi nei meandri dell’assenza e della morte e il desiderio fisico e conoscitivo che vorrebbe toccare il senso dell’essere e dell’esistere.
Nel tentativo di abbracciare l’inconciliabile.
Un tentativo che nei lavori poetici di Salari si muove tra i “perversi connubi di strazio e beltà”(Il Pellegrino Babelico), tra il rischioso sfidare la vertigine e gli abissi, il vuoto, il nulla e un dire desiderante che abbraccia finitudine e bellezza, assenza e presenza, mortalità e vita, nell’affrontare, con “parole che ci scuotono nel profondo” (Il grido del vetraio) , il tragico e il carnale, il desiderio e il dolore, il destino individuale e quello dell’umanità.
3 Così come, nei lavori di riflessione sulla poesia, il pensiero scorre tra le tensioni di una lettura critica attratta, da un lato, dalla voragine del nulla e, dall’altro, da una parola radicata nella vita, in una sofferta carnalità, tra, riprendendo i titoli di alcuni suoi lavori, “Il grande nulla:percorsi tra Otto e Novecento” e “La poesia e la carne. Tra il labirinto dei corpi e l’inizio della parola”.
Da un lato la sfida mortale per la bellezza e la verità di un suono, di un dire da strappare alla divinità, con “Le tentazioni di Marsia”: “La poesia è dunque una sfida a dio? Una sfida alla verità?” (Le tentazioni di Marsia. Su quel che resta da fare ai poeti e ai loro critici), si chiedono Fresa e Salari, curatori dei saggi.
Dall’altro la ricerca continua “sui sentieri infiniti della vita”, come scrive Salari, per “uno spazio nuovo di congiunzione nella scrittura per la poesia e la filosofia”, che con “Le asine di Saul” capovolge le vie dell’erranza in destino.
Alla ricerca del destino del dire poetico, la riflessione di Tiziano Salari sulla poesia è in dialogo continuo, come attestano alcuni sottotitoli “Il grido del vetraio. Dialogo sulla poesia” “Essere e abitare. Da New York a Parigi. Dialogo sulla poesia e le metropoli” e come evidenziano il confronto continuo di punti di vista e la passione di cui sono pervasi i suoi lavori, tesi a nuove forme di pensiero, a un altro dire che pronunci, insieme, consapevolezza e inquietudini, analisi critica e smarrimenti.
Tra rispecchiamenti e abbandoni dell’io
Ci chiediamo quale soggetto possa osare questo altro dire, tragico e inquieto.
Non può che farsi altro il soggetto di Tiziano Salari, in oscillazione continua tra autobiografia e spossessamento, tra rispecchamenti e abbandono dell’io.
Il pensiero, l’arte, la musica, la poesia del novecento sono stati attraversati, consumati dal bisogno di spossessamento e di dimenticanza dell’io.
Scrive Salari: “Oh spostare lo sguardo dalla pietà/per se stessi all’infinito accadere,/all’essere da cui sgorgano gli eventi,/ ai perversi connubi di strazio e beltà” (Il Pellegrino Babelico).
E ancora: «curvo sul balcone scruto nel fondo di un me stesso sempre più affievolito, disserro i palpiti di un io dissolto» (Quotidianità della fine).
La frantumazione dell’identità, che si mostra in modi diversi, nel doppio, nel sosia, nell’ombra, nello straniero, fino al suo oblio, attraversa le opere poetiche di Salari da “Grosseteste e altro” a “Strategie mobili”, da “Alle sorgenti della Manque”a “Il Pellegrino Babelico”, da “Quotidianità della fine” a “Il fruscio dell’Essere”.
Dall’arte informale alla musica casuale, l’opera, nel novecento artistico, poetico e musicale, prende il sopravvento rispetto all’autore; scrive Tiziano Salari: “l’opera reclama/il sentimento di sé/per mezzo della forma/nella perdita del nome” (Quotidianità della fine).
Tale perdita non può che determinare una dislocazione dalla centralità del soggetto alle questioni legate al senso, alla verità e, nello stesso tempo, dopo la perdita di ogni fondamento di verità, allo smarrire del senso, al vuoto.
Tra ricerca della verità e insensatezza
“Non so decidermi” scrive Salari “a rinunciare al concetto di verità, e alla ricerca delle vie per attingere la verità” (Essere e abitare).
L’interrogazione sulla parola poetica fa costantemente i conti, nel suo pensiero, con la “ questione della verità e del rapporto tra poesia e filosofia” (Essere e abitare.
Appunti di lavoro dell’Autore), nel solco delle riflessioni filosofiche ed ermeneutiche novecentesche, ma, come scrive, “in una sorta di dislocazione della critica su un terreno confinante con una nuova e inesplorata teoria della conoscenza” (Essere e abitare. Appunti di lavoro dell’Autore).
La sua ricerca filosofico-letteraria sulla verità spazia dagli aspetti ontologici a quelli conoscitivi, da quelli estetici a quelli etici, tra “poesia pensante” (Sotto il vulcano. Studi su Leopardi e altro) e dimensione etica, come testimonia l’attenzione al pensiero e alle opere di Leopardi e Spinoza.
La suggestione è ritrovare le vie labirintiche e dell’erranza anche nella tensione alla verità del dire, tra la ricerca del senso della verità dell’essere, che, assistendo, come scrive Salari, “alla deriva della tradizione filosofica occidentale” (Essere e abitare), si scontra con l’impossibilità di trovarne i fondamenti, e la dimensione della vita, quest’ultima divenuta oggetto e destino sia della poesia che della filosofia nell’età post lirica, dopo la fine della tradizione occidentale di entrambe.
Di fronte alla perdita dei fondamenti ontologici della verità, la suggestione di un dire che cerca la verità nella vita: propriamente “sul terreno della nuda vita” (Essere e abitare), scrive Salari, “come l’uomo, gettato nel linguaggio, senza più fondamenti … si radichi nella vita e nelle diverse forme di erranza” (Essere e abitare.
Appunti di lavoro dell’Autore).
Di fronte allo screpolarsi del senso, la suggestione di un dire desiderante che vorrebbe abbeverarsi a rivoli di senso: “guardando/in faccia il dolore fino alla sorgente/impietrita, nelle iperboree/regioni dove il senso/in tante parti si screpola” scrive ancora Salari “e ciò che ci intrattiene nei mondi/è la desiderante mancanza di un rivolo/di senso a cui abbeverarsi”. (Il fruscio dell’Essere).
Per giungere a ricercare, nelle forme dell’abitare, come afferma, “non tanto il senso, quanto quel soffio di vitalità o di morte che mantiene in vita le differenze, e fa sprigionare, dal fondo di ogni situazione umana, “ l’Essere che vale fra tutto l’Essere”: la poesia” (Essere e abitare).
“In bilico sull’orlo”
Un dire altro, quello di Tiziano Salari, che si muove tra visibile e invisibile, luce e oscurità, tangibile e intangibile, “nello svuotante vuoto” come scrive “ che separa
il visibile dall’invisibile/mantenendosi in bilico sull’orlo/nel colmante colmo dell’essere”(Il fruscio dell’Essere).
E ancora tra il ricercare l’inudibile e il fare risuonare il dire: “questo suono non è altro che l’eco di un altro suono/che non è stato mai udito/ma preme attraverso gli accordi/imbrigliati nella zona/più antica della mente” come scrive, nella tensione “di fondare un nuovo mondo/che a diversa sorte ci riserba/nega l’accesso, scavando/un’incrinatura nel fruscio dell’essere” (Il fruscio dell’Essere).
“In bilico sull’orlo”, tra vertigini e vuoto, tra finitudine e oblio.
La suggestione è che a trovarsi “in bilico sull’orlo” sia l’intera umanità: tutti i filosofi, i poeti e gli scrittori convocati da Salari nel rispecchiarsi dei suoi labirinti, gli esseri erranti tra le meraviglie e le desolazioni dell’esistere, le figure assunte a simbolo dello smarrimento e della crisi.
In bilico tra il dire della tradizione poetica e filosofica e un dire altro, che si spinga in un pensiero “fuori di sesto”, oltre gli estremi tracciati da un compasso rassicurante nei modi del conoscere e dell’abitare il mondo.
Tra il nulla e gli “strimpellatori rock”
Dolente e “Fuori di sesto” è il dire che fa i conti definitivi, come scrive Salari nel suo ultimo, omonimo, lavoro poetico, con “l’attimo/da carnefice”, il “male/assillante” e “nell’attimo il precipizio dell’oblio” quando “i mattini di luce vagante di collina in collina gravavano come una colpa sui fuggitivi dal nulla, che vanno verso il nulla” (Fuori di sesto).
Nel suo sradicarsi dalla contemporaneità, nel saluto che pronuncia, lasciati alle spalle, “agli dei di Hölderlin e al cielo stellato di Kant/nel divenire noi postumi di tutto il bene e il male/della Storia” e nell’incamminarsi irreversibile verso il nulla, come afferma: “Andare, il viaggio nella steppa sconfinata, nel deserto, sulle acque dell’oceano./ Poi ci voltiamo, il nulla. Dal nulla andiamo verso il nulla” (Fuori di sesto).
Una storia personale e dell’umanità che, come ultima suggestione, ci viene consegnata da Tiziano Salari, tra il “silenzio interiore” e il brusio esterno, tra, come scrive, “il cupo rovescio del mondo” e il cerchio ampio di vite”, tra “il nulla” e gli “strimpellatori/rock” (Fuori di sesto).
Forum Anterem 2014 “Di un altro dire“ 8.11.2014 Laura Caccia
Marco Ercolani, da "Si minore", Smasher Edizioni, 2012
Dalla prefazione di Mauro Germani: Da dove provengono le visioni che ci consegnano questi nuovi versi di Marco Ercolani? Esse sembrano venirci incontro un attimo prima del loro dissolvimento, colte nel loro passaggio segreto, in quella zona di confine – prossima e familiare insieme – in cui poesia ed esistenza si sfiorano e poi si tramutano l’una nell’altra, per dileguarsi infine nell’ombra totale. (...)
***
Pelle contro pelle,
ombra contro ombra,
con l’impulso di rinascere ancora,
furiosi e muti.
Fingere di non scrivere più, per estasi.
Per estasi, scrivere ancora.
Le pietre tornano vento, se sono guardate.
Rotolano libere, non gravi.
Slanciate oltre la terra, fiamme fuse nell’aria,
scelgono il loro inizio.
Ci sarà mare, domani. Un blu senza limiti.
***
Sprofonda nei bellissimi giorni.
Nessun punto della sua pelle che non gli appartenga.
Molte vite per accarezzare quelle ore.
Nei giorni splendidi si dice che le voci tremino,
e le dita. E gli occhi cambino colore.
Nel sonno futuro un si minore, inudibile.
***
Nessuna forma, ma un canto trattenuto dalla voce.
Una parola stretta nelle labbra premendo la lingua.
Questo guardarsi ora.
Il lungo strappo negli occhi.
I ritmi dell’aria, i riti del respiro.
Le montagne capovolte, le nubi fitte.
Cresce pietra nelle frasi non dette.
Finestra chiusa. Fine di tutto. Parole mai scritte.
Ritrovare un punto, nella neve, culmine della bufera.
Dopo, l’ombra totale.
Marco Ercolani (Genova, 1954). Tra i suoi pensieri dominanti: la scrittura apocrifa, la poesia contemporanea e il nodo arte/follia. Pubblica, per la narrativa: Col favore delle tenebre, Vite dettate, Lezioni di eresia, Il mese dopo l’ultimo, Carte false, Il demone accanto, Taala, Il tempo di Perseo, Discorso contro la morte e A schermo nero. Per la saggistica: Fuoricanto, Vertigine e misura e L’opera non perfetta. In coppia con Lucetta Frisa scrive L’atelier e altri racconti, Nodi del cuore, Anime strane e Sento le voci. Nel 2010 pubblica il suo primo libro di versi Il diritto di essere opachi.
Nicola Ponzio, da "Il mio nome nel tuo nome", Oèdipus Edizioni, 2014
Dalla postfazione di Giampiero Marano: (...) Nicola Ponzio trasmette e condivide con il lettore più attento una conoscenza, e non semplicemente un’esperienza. Nel libro si alternano due voci, graficamente distinte dall’uso del corsivo e del tondo. La principale è quella di un cadavere di donna in decomposizione, abbandonato sulla riva di un fiume. La seconda voce, più difficilmente identificabile, è quella di un voyeur, ma nello stesso tempo coro o anghelos tragico, che riferisce le fasi della putrefazione senza adesione, quasi con freddezza da anatomopatologo. (...)
E’ lecito rintracciare l’origine del Mio nome nel tuo nome nella dialettica mai risolta fra l’aspirazione a svelare il mondo mediante il linguaggio e la consapevolezza della sortedi precarietà liquida toccata inesorabilmente alla parola. (...)
da Dell’acqua
***
dell’acqua profonda è sodale
la lingua che dubita, annaspa
e s’incava – che duplica
e inquieta, abitando l’erranza
***
sommergimi, - rispecchiami dissetami
e poi affogami. – esfoliami il viso
e rinfrescami, stringimi. – infangami
rifrangimi svaporami. – macerami il fegato
e poi schizzami, sbiancami. – gonfiami
i seni, inumidiscimi. – corrodimi
scolorami inondandomi. – levigami
i piedi e poi trascinami, lavami. – impregnami
i capelli quindi avvolgimi, increspami.
dissolvimi cullandomi decantami.
da Agnizioni
***
accendi l’umiltà con le parole
dove c’è disfacimento.
tra l’aconito e un telo di nylon
disteso nell’atrio.
accedi a questi luoghi marginali
seminando le sembianze.
esponi alla presenza il tuo linguaggio.
***
scrivo. tu non mangi con me? qui –
dove la morte non ha regno.
ho metabolizzato pane
e tempo. tu non leggi con me?
qui c’è l’ombra, - qui l’acqua.
il delta che comprova la mia orma.
Nicola Ponzio vive e lavora a Torino. Poeta e artista visivo, ha pubblicato Gli ospiti e i luoghi (Nuova Editrice Magenta, 2005), L’equilibrio nell’ombra (Lietocolle, 2007), Esercizi del rischio (e-book, Biagio Cepollaro e-dizioni, 2007), Scanning (con fotografie di Paolo Mussat Sartor, Corraini Edizioni, 2014).
Maria Grazia Insinga, da "La porta meta fisica", raccolta inedita, con una nota dell’Autrice
[Prima lezione di Luce]
I
Le sette sorelle parlanti spossessano d’innocenza
le sette sorelle più non guardano dall’alto se dall’alto vedi.
Effusa dal mare tra sciara del fuoco e vento
imparare è solo perdita, perdita di bellezza.
II
Memento anima! Innocenza sei e tornerai.
Nel giardino liquido il giglio bianco protegge
il fuoco dai margini taglienti d’ossidiana
e il sartiame rizza gli alberi nella tempesta di vetro.
III
Ciascuno abbia pietà della sorte.
Niente, non c’è più niente. L’aria ha preso
del niente la forma. E il resto solca un mondo
spinto per la strozzatura d’una bottiglia.
IV
Non posso rifare lo stesso percorso.
Corpi raggiano e rimango solo per vederli
non smettere di cadere.
Cædere!
V
Non sorprenda morire. Precedono sontuose corolle
mentre impreparata continui valigie
ripieghi corredi di luce.
Tu, anima: raggio che cade!
[Prossemica]
So cos’è una distanza:
il tempo della palpebra
sull’occhio. Non avvicinarti
alla dimensione nascosta.
La lingua muta
lo spazio parlante.
Non puoi mandar via
selvagge distanze di fuga.
Non capire tutto
intatto è il regno.
L’orma sorge dal gorgogliare
di dorsale divina.
E non c’è niente di umano
nel senso della fine, nel capo
sul muro a secco: è il posto
delle zagare. Lasciatemi in pace.
Vivere di continuo è sisma. Slaccia
talora le mani. Nulla ricordo ma la vita
da sé a se stessa rinvia. Ho tenuto
nel grembo l’esilio, m’ha tenuta.
Non il dolore - unisce
separatezze, elimina spazio -
ma il nome differisce l’approdo.
Nell’intervallo, la musica.
Miseria vivere dove tutto è presenza.
In prossimità limbale fletti il tono
nella rivelazione niente da salvare.
E non manco di nulla se ciò che manca non esiste!
Non la presenza ma lo spazio timbrico.
Nessun intervallo qui e ora.
E l’altrove un’invenzione
sì, ma da raggiungere a volo.
***
Ci riconosce l’urlo
da questo zollarci
come nascondigli, semi
con le mani spaccate dal vero
la promessa, nel remoto
d’uno specchio d’acqua
in fondo alle gallerie esagonali
della biblioteca perduta.
[Release]
Qui non c’è timbro
né storia
solo me transitorio d’attacco
nella vuota insorgenza
- ascesi in ampiezza
ciò che non percepisco
mappa di tràdite onde
non comprensibili d’isola in isola -
Credi sia storia prima
dell’estinzione e altro non è
che decadimento
diminuzione d’ampiezza
o morte
o dio.
Appena nell’invisibilità
divento me non divisibile
inviluppo trino che non tiene
ma lo spettro subisce mutamenti
- sublime non trattiene sublime -
instabile être vivant
tento l’intonazione del mare.
Maria Grazia Insinga è nata in Sicilia il 20 aprile 1970. Dopo la laurea in Lettere moderne, gli studi in Conservatorio e in Accademia, l’attività concertistica e di perfezionamento e l’insegnamento nelle scuole secondarie, si trasferisce nel 2009 in Inghilterra per poi ritornare in Sicilia nel 2013. Si occupa di ricerca musicologica - ha censito, trascritto e analizzato i manoscritti musicali inediti del poeta Lucio Piccolo - suona in un duo pianistico ed è docente di Pianoforte presso l’Istituto “Vittoria Colonna” a Vittoria (RG). Ha ideato il Premio di poesia per i giovani “Basilio Reale” - La Balena di ghiaccio - che si pregia del sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Capo d’Orlando e del patrocinio del Cantiere del Seme d’arancia di Emilio Isgrò.
La porta meta fisica, nota dell'Autrice

Antonello da Messina, Virgin Annunciate, 1476 (Palazzo Abatellis, Palermo)
Alla fine scopri che il tuo vero grande amore è stata una porta. Cesare Viviani
Eludiamo il corporeo. Come la musica, puro movimento che elude l’oggetto da cui proviene. O come il timbro della voce leggente che elude la plumbea dimensione dei caratteri tipografici. Oppure le pagine dell’Annunciata – puro zefiro d’ali - che eludono l’angelo. Musica e parola leggente, frutto di discretizzazione del continuum, sono oggetti metafisici. È vero. Ma è vero pure che hanno un unico obiettivo: raggiungere la corporeità del fruitore sorpassando le sovrastrutture intellettualistiche.
La mia meta è fisica. E nella scrittura, nell’arte questo significa forse tornare al corpo tradendo in parte quella visione metafisica ma senza potere da essa prescindere. È un procedere dalla fisica sinestetica della nascita alla metafisica di una crescita razionale fino ad arrivare - di nuovo - alla fisica della maturità (o dell’aurea dissennatezza!).
Va bene, va bene..! La bellezza risulta dalla capacità di discretizzare il continuum sinestetico nel discontinuo del pensiero, della parola e dell’arte… bla, bla, bla; ma io sento, sento l’urgenza fisica di riportarla poi con un colpo di scena nuovamente all’informe primigenio tramite la corporeità del suono, della prosodia, di una scrittura “timbrica”.
Questo mi induce a utilizzare anche un sistema musicalmetrico: riprodurre un suono di cui si è perduta la corporeità per il tramite delle dita tamburellate in arsi e tesi. E le parole trovano posto nella composizione - il loro posto - quasi si trattasse di un’accordatura nella geografia del verso. Spostarle, poi, diventa difficile per me. Più alta avverto questa difficoltà maggiormente soddisfatta è l’urgenza di suono, di corporeità.
La rivelazione dell’Essere e di ciò che è esistente (dunque cultura) non è improvvisazione, inattesa e comoda epifania; ma lavoro che affina la congerie dell’esistenza nel discontinuo dell’arte e della parola solo per ricondurla consapevolmente (magari anche stoltamente) al continuum di un tempo primo. In questa deperibilità della bellezza – ché la bellezza sta nella deperibilità della bellezza! - in questo disfarsi del corpo che vuole tornare alla terra c’è la ricerca – la mia ricerca - di unità, di eternità, di poesia.
Varcare la soglia è riportare il noto - razionale frutto di affinamento per così dire metafisico - verso l’ignoto. Significa trasformare quel processo - che conduce il codificato esistente (cultura) al continuo del flusso primigenio (natura) - in un luogo fisico, un varco. Lo spazio timbrico ha in questo contesto un’importanza determinante. Il timbro, il suono è l’ultima coordinata concessa che mi consente - anche a occhi chiusi e in anticipo sul pensiero - di trovare la strada, il coraggio di varcare la soglia. Di vedetta sul Caos a occhi chiusi, dunque, m’abituo al dettaglio che era metafisico per ravvisare la parola al solo tocco d’avorio. I suoni più piccoli, lo so, rimarranno impigliati nelle zampe alate di serafini senza sosta e continueranno a posarsi su rami altissimi a sostenere l’eminenza del luogo, del logo…
La porta meta fisica è passaggio dal sacro al profano; secolarizzazione dell’immagine di Cristo in Uomo-Cristo-poeta. Ma sollevare il mondano al sacro, secolarizzare il sacro equivale forse a sacralizzare il mondano. Mi vengono in mente i portali delle Chiese, metafora di Cristo dove Cristo è metafora clipeata di se stesso: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo” (Gv 10, 9). Dall’ordine al caos, l’unica presenza divina con funzione apotropaico- tutelare è, quindi, il suono e in ultima istanza la flagranza della poesia, di uno zefiro d’ali.
L’universo linguistico fortemente simbolico che prolifera attorno al sema ‘porta’ sottende al cambiamento di stato, al passaggio. È Ermes - psicopompo protettore dei passaggi fatti via terra
- a incarnare lo spirito di questo attraversamento. Il messaggero di dio funge anche da interprete
e dal suo nome deriva, infatti, la parola ermeneutica, l’arte di interpretare i significati nascosti. Non per nulla, è anche il dio degli oratori, della letteratura, dei poeti nonché rappresentante del lógos. Non per nulla, il piccolo messaggero inventa nel suo primo giorno di vita la lira con la quale incanterà Apollo.
Se la metafisica è anche ricerca del fondamento, ossia di ciò che spiega il reale, “la porta meta fisica” è la ricerca del fine o della fine, del suono inteso come ponte di passaggio tra il mio
pensiero e il mio corpo, il discontinuo e il continuum, il razionale e l’irrazionale, la lucidità e la dimensione onirica, tra il fondamento e il fine, la fine.
Nadežda Mandel’štam, moglie del poeta Osip Mandel’štam, scrive: “Mi sembra che per un poeta le allucinazioni dell’udito siano una specie di malattia professionale. La poesia comincia così. Molti poeti l’hanno detto, dall’autrice del Poema senza eroe allo stesso Mandel’štam: al loro orecchio risuona ossessiva, prima informe, poi sempre più definita, ma ancora senza parole, una frase musicale. Mi è capitato di vedere Mandel’štam che cercava di liberarsi da uno di questi ritornelli, di scuoterselo di dosso, di sottrarsi al suo potere […] La Achmatova raccontava che, quando fu assalita dalla melodia del Poema, avrebbe fatto qualunque cosa, pur di liberarsene: si mise pure a lavare i piatti, ma senza risultato. A un certo momento, attraverso il tessuto della frase musicale si facevano improvvisamente strada le parole e allora le labbra cominciavano a muoversi. È probabile che il lavoro del compositore e quello del poeta abbiano qualcosa in comune e che la comparsa delle parole segni il momento critico che distingue fra loro queste due forme di creazione” (L’epoca e i lupi, trad. di Giorgio Kraiski).
Quando la notte scuote le ossa, oscillo come una scultura di Calder contigua al cosmo per divina differenza e mi espando, discontinua. Non vedo muschio: il mio ago scuce il Sud, l’isola nell’isola dell’isola. Sono pronta. Chi mai vorrebbe trovarmi! I musici non ci sono per nessuno; vivono altrove a fomentare la notte in ascolto da ere, a discretizzare da quel tempo primo pulviscoli di scomposta bellezza e a riportarli poi oltre la soglia del sonno, del suono.
È in questo percorso che la parola sancisce la sua definitiva volontà a distaccarsi dal noto per rivolgersi all’ignoto irresistibile, alla sua musica, alla residua flagranza della luce, alla porta azzurra. Maria Grazia Insinga
Enrico De Lea, da "Dall’intramata tessitura", Smasher Edizioni, 2011
Dalla prefazione di Alessandra Pigliaru: (...) La nominazione è faccenda assai complicata.
Determina un soggetto che abbia coscienza di essere tale e una lingua da considerarsi familiare.
Nominare le cose conforta sulla possibilità di mantenere in vita l’ossessione del passaggio. Eppure alla nominazione è sottesa un’ambivalenza linguistica di fondo. Insieme al nome, come suggeriva Blanchot, si decreta una sentenza di morte. Un trapasso necessario potremmo dire, proprio perché nominare riferisce di una scomparsa e insieme di una resurrezione nella parola.La poesia, che non soccombe all’ombra dell’algido concetto, mostra questo turbamento del linguaggio in tutto il suo tremore. Nei pressi di una nominazione tradita e riconsegnata alla visione poetica, incontriamo l’opera di Enrico De Lea. L’iride si stempera e racconta di un occhio che sonda al di là. (...)
***
Vuoti come ombre, eppure sono
carne che vocifera, corpi di donna o d’uomo
con ogni alibi morale, cogli umori animali.
Per la semente, per la testimonianza
assente – il passo del dominio sui dirupi.
***
Come una moneta di antico conio
che risuona a terra, nel distico
di un interstizio e lungo il tempo – nel tempio
sconsacrato d’ogni vicolo, senza
che un ciottolo leso e levigato possa
darsi pena della sottostante scure.
***
Neri suoni a costruire case,
dove l’acqua possiede il corso
dei corpi nell’agire. Nel mistero
della fondazione originaria,
dagli occhi verso oriente
l’ulivo con la vite ed ogni pietra
nell’utile erigersi.
Per vie d’acqua il legname
che tradimmo.
***
In un’ascesi che non ha memoria, nulla
del deserto, ma una sorte di arenaria spenta,
col racconto paterno, col racconto spezzato
in un’arabia di ruderi, nel greto
degli olivastri, nati a salvazione ed a sembianza,
in cima e col teatro celeste, ancora nulla.
Enrico De Lea (nato a Messina il 25.7.1958), dal 1988 vive nell’alto-milanese, dopo aver vissuto in Sicilia tra Messina e la Valle d'Agrò (in particolare Casalvecchio Siculo), a nord del taorminese.
Ha pubblicato: “Pause” (Edizioni del Leone, 1992), "Ruderi del Tauro" (L'arcolaio ed. , 2009, Finalista al Premio Lorenzo Montano 2010 – Verona), “Dall'intramata tessitura” (Smasher ed., 2011), “Da un'urgenza della terra-luce” (La Luna ed., 2011).
Suoi inediti sono stati premiati al Premio Poesia di Strada 2010 (Macerata – Festival Licenze Poetiche), dove è stato finalista nel 2011.
Con inediti è stato finalista al Premio Miosotis 2010 e 2011– Edizioni d’IF – Napoli.
Nel 2011 è stato, altresì, finalista al Premio Lorenzo Montano 2011 – Verona, con la raccolta inedita “La furia refurtiva”.
Suoi testi sono apparsi sulle riviste Specchio (de La Stampa), Sud, Atelier (su cui è stata anticipata Acque reali, poi sezione di Ruderi del Tauro), Registro di poesia; in rete, suoi testi sono apparsi, fra gli altri, su La poesia e lo spirito (di cui è collaboratore), su Rebstein – La dimora del tempo sospeso, Nazione Indiana, Compitu re vivi, Imperfetta Ellisse, Poetarum Silva, Carteggi letterari.
Miguel Angel Cuevas, da "Scrivere l’incàvo", Il Girasole Edizioni, 2011
Dall’aletta: (...) Verso l’immobilità astratta della traccia: tratto, parola. Vuoto, incàvo oppure interstizio che soltanto può essere accerchiato, recintato: la cavità richiama colloca richiede. Qui: questo luogo spoglio, scabro, frattura: da cui scaturisce e attinge la cifra riarsa, il limite dissonante, le chiazze sulla materia forma di sé stessa.
***
LITANIA:
sudario.
Trafigge ciò che nomina.
Rivela
l’esatta dimensione:
nessuno, niente.
***
QUESTO
luogo frana
delle parole pietre
della ruggine
versata.
Vi repelle: le sue scorie,
la sua pura maceria minerale.
***
MACCHIARE IL BIANCO: RAG
giungere il bianco:
disseppellire l’aria:
la cavità del nome:
nominarla:
***
PARLO
per toccare la parola che nomina:
per toccare ciò che la parola
nomina.
Miguel Ángel Cuevas (Alicante, 1958) è un poeta spagnolo.
Poeta, traduttore, professore di letteratura italiana presso l’Università di Siviglia. Studioso del Novecento, ha tradotto e curato edizioni spagnole di Luigi Pirandello, Pier Paolo Pasolini, Vincenzo Consolo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Angelo Scandurra, Maria Attanasio. Ha tradotto e curato edizioni italiane di José Ángel Valente.
Per la poesia ha pubblicato, in Italia, 47 Frammenti. Ha realizzato con l'artista Massimo Casagrande i libri d'arte Scrivere l'incàvo, omaggio a Jorge Oteiza, e Huesos sobre papel. Con lo stesso artista ha pubblicato per Il Girasole Edizioni 2011, Valverde (CT), Escribir el hueco.
Elena Corsino, "La casa del padre", prosa inedita, con dipinti di Paolo Corsino
La casa del padre
Erompa che vuole
(“Edipo Re”, Sofocle)

Paolo Corsino
1. Prologo
In questo tramonto di ceneri, un urlo.
La casa del padre ha quattro mura di fuoco. Lungo le pietre serpeggia un drago. O è un geco gigante. Intorno il turbinio del vento sull’architrave. Il tempo affamato di piaghe.
Ora che la casa del padre ha mura di fuoco, “La guerra è perduta”, dice la sentinella. “Nel bosco, sulla rupe alta c’è un incendio. La reggia è caduta.”
Ora che anche la bocca è una pustola di dolore. O antro nero di escrescenze sgorganti a fiotti e sangue amaro. Bocca mai mai mai baciata come ferita cigliosa si schiude sul mondo. Occhio di un folle.
Se con gli occhi inclini al sogno. Perché non ascolti? nemmeno adesso che è tutto fin troppo chiaro e guardi attraverso l’azzurro a intercapedine come se io fossi nel buio, come se fossi solo un suono?
Tra le mura rosso fuoco resterai finché avrai vita. Raggrinzita, incartapecorita, senz’acqua. A centellinare ogni goccia sulla terra secca e la paglia. Senz’acqua per la paura di annegare. In un’onda del mare che credevi senza risacca. Ridi? Dal nero o dalla schiuma bianca che ti prende intorno?
La donna, invece, beveva con la sete di una giumenta alla fontana drappeggiata di carrubo e nipitella dolciastra. Perché fertile è la fanghiglia. Lì lo zoccolo nero schiaccia zolla su zolla. Anche questo è il tempo. E s’inabissa. Come l’anima nel mistero.
2. L’antefatto
La testa del dormiente mi guarda. Sebbene abbia occhi chiusi. Il mio pensiero è su quella lama. Sul taglio silenzioso lungo la pelle. Sempre di notte, benché il fuoco sia divampato da meridione, in piena luce del giorno. La sorella non c’era. all’inizio il sangue non sgorgava. Ma poi più profondo fu il taglio dell’acciaio. L’arma era quella che stava nel primo cassetto.
Se la casa avesse voce parlerebbe. Con lingua atroce. Io ha appiccato l’incendio. No, non direbbe questo. Più sapiente è il fuoco. La casa non ha mai detto niente. Sa, ma è sempre stata muta.
Al principio il fuoco aveva contrassegnato il campo, tra i pruni selvatici i lecci i mandorleti, segnando il perimetro della dimora antica. Se il fuoco divampa con misura, l’uomo comprende. Ma quando è dentro, alle pareti, dietro alle porte, sotto i letti, nelle anse delle vene e non lascia cenere né detriti, ma brucia, soltanto brucia che lo diresti un’inondazione, quando tutto rimane ma è distrutto. Niente ha più nome.
Ancora non è l’alba, s’odono passi tra il corridoio e la cucina. La donna oltremarina dorme. Ha la sua quiete quando non veglia e non dispone con gesti esatti il mondo delle forme diurne. Senza dolore nuota nel sonno, dove infine vede. Lei che vede ogni cosa solo nel sogno. Io tace, acquattata sul letto – conosce il sussulto rauco del primo cassetto. Resta in ascolto.
Il padre è all’incrocio di tre strade.
Con pungolo a tre punte si scagliò allora sulla terra madre e sul mare, sulla placida vacca e sul pavone, sulla casa si scagliò e su quanto avesse generato colui che del Caos tagliò il desiderio e il bianco squarciò finché non lo separò dal nero. Il suo dente spezzò il Verbo di cui era padre e ne sputò l’eco.
3. Nel nome del figlio
Fu al mio ritorno, fu lungo la strada. Ricordo. Il vecchio andava su un carro con i suoi servi. Mi scostai sull’orlo e ristetti fermo a cavallo. Ma lui correva per la sua strada. Lì – non chiedermene ragione, – mi montò il mio nome. Il nome di chi ha gonfi i piedi e pesanti. Mi pulsava quel nome alle tempie e scorreva come luce di lama. Per non dimenticare, per essere presente, strattonai le briglie della bestia impaziente. Sapevo da dove venivo, da lì fuggivo. Un richiamo. Allerta.
Ma fu lui che mi gettò nell’onta. Non fece niente. Silenziosamente rise. Allora più penoso mi fu il mio nome. E ridendo col carro mosse contro il mio cavallo. Per saggiare la bestia, per vederne la reazione. Mi sorpresi più veloce del vecchio. Fu un niente. Io andavo lontano per non fare del male, per non uccidere il padre.
Dannata risata del vecchio. Mala sorte la mia. e la sua. Mala sorte chi ignaro del figlio contamina la voce paterna. Non vedeva il vecchio che potevo essergli figlio?
Era bianco mio padre alle tempie. Occhi fissi su quella bocca nera. disumano antro. Diede un gran grido. Accecante antro umano di disarticolate labbra spalancate. Senza dire niente.

Paolo Corsino
4. Nel nome del padre
Io respira. l’essere è qui, senz’altro luogo. come nel sogno.
Colui che parla sconnette le parole – lapilli di uranica esplosione, o vulcanica.
Con gli occhi arrovesciati all’indietro sto nel buio, come nell’acqua, ma è l’aria che dissolve il principio: quella metamorfosi del fuoco che fu grido e poi respiro. Ecco, io respira. Finalmente è straniero. Senza padre, io, che ne ebbi due, due e pure un Dio! Senza patria, se non quella folle dei presagi e degli indovini, la patria dei padri, e dei padri dei padri che mi guardano dai loro fuochi azzurri e dai marmi. Patria della parola fratturata, in modo che nel silenzio accada.
Nove monosillabi ciechi. e un bambino è gettato da rupe alta.
Rotola una palla gialla sulla superficie inclinata, di vetro. Un essere umano cammina. In bilico, senza far rumore. Un tocco di colore, senza senso nel rogo. nell’acre odore. Solo un tocco di colore. Che vuole da me costui? La città di Tebe? Maledetto sia mio figlio con le lance e le sue sette schiere.
Io scelsi il buio del senza-terra, l’oscurità senza ore. I segni che col bastone traccio mi sono solo d’intralcio.
Non vedono per te neppure le tue parole.
Nel buio brancolo, ma forse procedo. Lo spazio è questo. Che stia in piedi o sulla terra disteso. È nero.

5. Una voce che si leva nel paese
Imperdonato cieco che in irosa curiosità1 tradisti la tua casa e alla legge della tua condanna ponesti il sigillo. ora vaghi condotto da donna, figlia tua e sorella, che talamo non conobbe, ma tombe sulla terra. Piango su di te, mendico mio re, e fratello, che mai quiete avrai finché vivrà la tua legge. Legge di paura del sangue che scorre nel corpo di un bimbo. La legge sul tuo tempo.
Nei boschi, quando generasti, fui sulla soglia. Non udisti la voce che disse che il tempo è insonne vigilia2? Notte di veglia è la vita. Povero te, che sazio della tua parola dormisti e sonnambulo ti levasti con in mano un coltello.
L’uomo manduca il mondo e non lo vede.
Di te non resterà che l’eco affinché mai si scordi che sei assassino e agnello con in sorte lo stesso destino. Senza più strada né via d’uscita. Il ritorno altro non è che la conta dei morti. Non ti voltare! Non è indietro che sta il tuo principio. O follia, follia, follia di parola.
Solo ti precede colei che si fa luna e nutritura. Ti generò alla terra, nell’estro del suo furore, nell’alba della sua ombra. E ti diede forma infinitesimale. Vuoi credere d’essere senza misura? E ti genera ogni attimo ancora. nell’arca del dolore. Nel cielo azzurro tra le fasce ti dà vita, e fra le pietre.
1 Sulla “collerica curiosità” di Edipo si veda F. Hölderlin, Note all’Edipo, Milano 2008. trad. it. di T. Cavallo.
2 “Vigilia, insonne vigilia/ il tempo“, Sofocle, Edipo a Colono, vv. 1454-1455, trad. it. di Franco Ferrari, Milano 2004.
Elena Corsino (1969) è traduttrice e insegnante di italiano a stranieri. Si occupa di traduzione letteraria, in particolare ha tradotto opere di poeti e scrittori russi, tra cui M. Cvetaeva, O. Mandel’štam, I. Brodskij, F. Dostoevskij. Sue traduzioni sono apparse nelle riviste “Poesia” e “Anterem”. È autrice delle raccolte di poesia Le pietre nude (2005), Nature terrestri (2013).
Luca Ferro, "Hai presente", video, una poesia inedita
Luca Ferro
Biografia:
Sono nato a Firenze nel luglio 1948.
Nel corso degli anni settanta realizzo film sperimentali e di ricerca proiettati in festival e rassegne nazionali ed internazionali: Londra 73, Milano 74, La Rochelle 76, Parigi 78, Firenze 79 etc..
Nel Dicembre 1978 curo per il settore sperimentale la rassegna “Cinema d’artista e cinema sperimentale in Italia” tenutasi a Parigi presso il Centre G. Pompidou (Beaubourg) e il Palais de Chaillot.
Del 84 è “Pecore nere”, documentario realizzato in pellicola, prodotto da RAI 1 per il programma “Di paesi, di città....”, ideato da Ermanno Olmi.
Curo la realizzazione delle cinque puntate di “La vita filmata” andate in onda sulla terza rete RAI nell’autunno 86.
Nel maggio 87 produco e realizzo il video “Fotografie d’amore con Erode”, premiato al concorso Videomaker di Prato, giuria presieduta da R. Benigni.
Sono stato docente di materie letterarie negli Istituti superiori dal 1974 al 1998.
Nel corso degli anni 90 mi dedico a progetti volti a diffondere la pratica del linguaggio audiovisivo tra i giovani.
Dal 2000 ad oggi pur confermando interesse alla didattica della pratica audiovisiva, che si esplica anche attraverso un laboratorio di "Cinema Privato" rivolto agli studenti del DAMS dell'Università di Firenze, mi concentro principalmente sulla definizione del genere "Cinema Privato", allestendo occasioni d’incontro e di riflessione ( le “GIORNATE DEL CINEMA PRIVATO” ed il sito www.cinemaprivato.it ) e realizzando contestualmente video orientati in questa prospettiva.
Bibliografia:
Non ho mai pubblicato (e neppure dato in lettura) i miei testi poetici.
Ho pubblicato solo sporadici articoli su riviste e cataloghi, alcuni di questi sono reperibili su www.cinemaprivato.it .
Filmografia
Pecore nere, min 20'25'', 16mm 1984
Fotografie d'amore con Erode, min 7'00” Umatic 1987
Compagni per sempre, min 11'00”, video8, 1997, riel.digitale 2000
Riserva di caccia (con Fabrizio Bettalli, Marco Melani, Roberto Rossellini), min 10'00”, 8mm 1970 riel.digitale 2002
Image of Images (con Nini Guatti), min 3'00”, mini-dv 2002
Luisa a Maiano con gatti, min 3'00”, video8 2002 Trasloco (con Lapo Binazzi), min 5'15'', mini-dv 2002
" ... di Venerdì, al metano...", min 16', video8 1990 riel.digitale 2003 Francesco Grotteria, "U cavaleri", min 55, VHS 1990 riel.digitale 2003 P.F., avvocato, min 39', video8 riel. digitale 2003
Trascorrere con Laura, min 10', 8mm 1977 riel.digitale 2004
4 piani per Guido, min 12', single8 1973, riel.digitale 2005 S&A sposi nel cinema, min 16'15'', mini-dv 2006
Piccola Marylin, min8mm 1970 riel.digitale 2007
Impressioni a distanza, min 13', 8mm single8 (1936, 1953/4, 1974/75) riel.digit 2007
Coniglio, Leoni e circostanze varie, min 21', 8mm riel.digitale 2009 L'amore d'istinto, min 5'13'' , da single8 e formati video vari, 2011 La panchina del mio grande amore, min 12'18", miniDV, 2012
Inchiesta di famiglia, parte prima: Fotografia Ferro, min 64'30'' , miniDV, 2013
Hai presente?, min 0'40", 8mm 1973, riel.digitale aprile 2014 (inedito)
Lucianna Argentino, da "Frammenti di autobiografia postuma", raccolta inedita
***
In principio fu il timore e la vita, dentro quello, un antefatto in bianco e nero per lei che stava sempre nell’incerto, in ciò che diviene senza mai av-venire. Era cronologicamente equivalente all’inizio del discorso.
***
A sedici anni sognava l’Africa o Calcutta. Voleva mettere le mani nel dolore, dividere il raccolto dalla gramigna – qui sulla terra dove il di più viene dal maligno. Da tempo, oggi, ha nelle mani la poesia e con le parole separa il bene dal male, ma sa che non c’è luce senza ombra, così a volte bene e male le si confondono negli occhi, tra le mani e le mani fanno a meno degli occhi così come fa la poesia.
***
Quando si lacera il tempo lei lo rammenda col furore della penna. Ma di solito –sprovvista di segni- le cose le scuce, le separa dalla loro utilità, le ricuce sulla pagina ad altra necessità. Con le parole gli ricama un altro uso, un uso inutile eppure misteriosamente prezioso. Indispensabile.
***
Ama i verbi al gerundio. Il tempo di ciò che è in cammino e chiede e offre contemporaneità. Il tempo dei fiumi, di ciò che diviene ed è in mutamento. Lei estemporanea, lei che in ogni giorno cerca la domenica, lei che... la poesia è la domenica del tempo... l’opera da portare a compimento, l’attimo da santificare.
***
Li abbracciano. I sommozzatori abbracciano i corpi degli annegati per riportarli in superficie e lei abbraccia le parole vive nel fondo marino del suo corpo contro il loro corpo gonfio di silenzio. Le porta a galla perché sulla pagina cantino al mondo la lucentezza delle tenebre e come è giusto il nostro essere temporali e come è perfetta l’equazione di vita e di morte per noi numeri complessi nel moto relativo dell’esistenza.
***
Sosta a lungo nel farsi luogo della parola. Impara ad accendere fuochi che ripetano sulla terra il volto delle stelle – un loro tratto almeno – e siano ristoro allo sforzo di perdurare che ogni cosa ed essere compie. Insegna al pensiero l’uso domestico e quotidiano del silenzio, il suo mutare di sostanza attraverso la liquida sonorità dell’inchiostro.
Lucianna Argentino è nata nel 1962 a Roma, dove vive. Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: Gli argini del tempo (Totem, 1991), Biografia a margine (Fermenti, 1994, con la prefazione di D. Bellezza e disegni di F. P. Delle Noci), Mutamento (Fermenti,1999, con la prefazione di M. Bettarini), Verso Penuel (Edizioni dell’Oleandro, 2003, con la prefazione di D. Maffia), Diario inverso (Manni, 2006, con la prefazione di M. Guzzi), la plaquette “Favola” (Lietocolle, 2009, con acquerelli di M. Sebastiani), L'ospite indocile (Passigli, 2012, con una nota di A. M. Farabbi). Ha realizzato due e-book, uno nel 2008 con Pagina-Zero tratto dalla raccolta inedita Le stanze inquiete e nel 2011 Nomi con il blog “Le vie poetiche”. Il suo lavoro La vita in dissolvenza (quattro poemetti-monologhi) è stato musicato dal chitarrista S. Oliva e, dal marzo 2011, presentato in vari teatri e associazioni culturali.
Francesca Monnetti, da "Elisa" (di sparizione in latenza), raccolta inedita
elisa
avverso sinistro insulto astio
scomposta pressione
sottocute
il portato infetto di adamo
intatto nel mondo
si traduce ...in costale
in-frazione
figura incarnata
larvata elusa deviata
in-franta ...visione
elise o elisa
in-distinta si legge
incisa la firma
...lesa da sempre
nel nome
parto in-dolore
resa ...deforme
lesa la prole
a sinistra, per spina
in colonna ...vertebrale
deambulazione sofferta
strabismo da non venere
ineludibile il collare
coma in entrata
nascita sorretta
vigile premorte
in uscita disposta
per la madre
alterazione sopore
suppurazione stretta
espulsione imperfetta
...da anestesia totale
terminale la ferita
generata dai miasmi
di una madre
non sutura
non arretra
corrode ...infetta
il corpo non reciso
nel cordone ombelicale
password
un sottoinsieme di caratteri mobili
mondi insepolti
primi incontri
e rivisitazioni
la chiave che consente l’accesso
si scrive e si legge
pur sempre coi nomi
quanto al senso, del resto
tutto un pre-testo
...difetto ...eccesso
fuori ...dentro ...lo schermo
il vero ...sommerso
nell’inespresso
puro autoinganno
latenza
strappo
e sparizione
Francesca Monnetti è nata a Firenze dove ha compiuto studi in ambito filosofico-morale.
La sua prima raccolta, in-solite movenze, finalista al “Montano” 2008, è stata pubblicata da Cierre Grafica l’anno seguente. Una sua silloge inedita ha vinto la IV edizione del Premio Sergio De Risio nel 2010. La sua poesia è stata presentata nel sito blanc de ta nuque da Stefano Guglielmin.
Gabriella Galzio, da "La discesa alle Madri", Arcipelago Edizioni, 2011
Dalla presentazione di Tomaso Kemeny: L’energia sovrabbondante di questa voce produce un’inquietudine guerriera che, dalle tenebre sgorgata, eroicamente, alle tenebre tragiche della contemporaneità riporta il lettore disposto a soffrire-morire per rinascere oltre ogni modello demagogico di pura completezza ideale, poiché “...il rito è sangue, ripresa della vita.”
***
La discesa alle madri
torbido anfratto, chiama
quasi, sordo, fosse un gorgoglìo
nell’acqua, a immergere le lunghe ali
tu, così bianco, in nera pece albedo
angelo franto, di qua dell’ombra vegli
prima della discesa, già di sudore coli
dentro il manto.
***
Epico incedere
affatìco, dentro, nel passo avanzo
qui nell’oscurità m’addentro
senza una luce minima, sul volto
solo un passaggio d’ombre ripetute un volo
guardano a me questi angeli di torba
tutti assopiti, volgono al nero blu di lago
le grandi pieghe.
***
Prego, scendendo, salgo, madre fra madri
prego, m’addosso a corpi, ripiego l’ala
su risospinta, da una marea fondante
sul vuoto ardo, gravida, trascinata
la terra s’apra, faccia ricovero, balza
a chi vi sprofonda e alberga la sua parola
faccia di questo verbo più crudo verbo
sillabi più potente l’epicentro.
Gabriella Galzio vive tra l’Oltrepò Pavese e Milano, dove svolge attività di traduttrice editoriale e dirige l’Associazione culturale Studio d’Autore. In poesia ha pubblicato Fondali (1993), La buia preghiera (Campanotto, 1996), Sofia che genera il mondo (I Quaderni del Battello ebbro, 2000), Apocalissi fredda (Agorà, 2001) e Ishtar dagli occhi colmi (Moretti & Vitali, 2002). Di rilievo anche gli scritti di teoria, le attività di traduzione e curatela. Ha inoltre partecipato a programmi RAI sulla poesia (“L’altra edicola”, “Festival di Sanremo della poesia”) ed è presente in antologie. Tradotta negli USA e in Germania.
Gilda Policastro, da "Non come vita", Nino Aragno Editore, 2013
Dalla nota di Andrea Cortellessa: E’ questo il libro della prima stagione poetica di Gilda Policastro. E proprio stagioni è la metonimia che intitola la sua prima sezione. Prima in ordine di composizione ma, ciò che più importa, in termini “narrativi”: col mettere in scena il primo di una sequenza di lutti, inconsutile manto funebre che, alla pelle mentale di chi dice “io”, a lungo è calzato come una guaina perfetta. Si dice “stagioni” e si vuol dire dei tempi vissuti, o che piuttosto tali non sono stati (...)
Estate
Bambina ti levavo
dai seni gli occhi
Nella riproduzione delle macchie
a seguire
l’impietà di guardare
le masse colliquate intatte
dall’erbitx
Inerti
nel dolore inconvertibile
ti poso addosso le dita
per la misurazione delle masse
(coi tronchi meno grossi
si fanno i coperchi delle casse)
Filamenti d’ovatta mentre ti lavo
i capelli e ben bene sotto le braccia
(le masse denutrite non proliferano in meno
di sei / dodici mesi
nel quaranta per cento dei casi)
Godere in analettico conforto
anche di cose qui per noi indifferentissime
(sfilaccia, l’acqua, l’ovatta, prendimi per favore dell’altra acqua)
E poi mai più,
che lavorare
stanca le masse
e il contenimento è il vero successo,
in oncologia
Questa
non sei tu:
- Non il bene vecchio ma il cattivo nuovo,
una massima di B., diceva B.*:
* Brecht; Benjamin
Gilda Policastro è assegnista di ricerca presso l’Università di Perugia. È redattrice della rivista «Allegoria» e collabora con «Alias», «Liberazione», «L’Indice dei Libri del mese», «l’immaginazione». Ha pubblicato i volumi In luoghi ulteriori. Catabasi e parodia da Leopardi al Novecento (Giardini, Roma-Pisa 2005) e Sanguineti (Palumbo, Palermo 2009), oltre ad articoli su Dante, Leopardi, Pirandello, Manganelli, Pasolini, Leonetti, Balestrini. Ha esordito come poetessa a Romapoesia e RicercaBo 2007. È stata finalista del Premio Delfini 2009, la sua silloge Stagioni e altre è edita nel Decimo Quaderno di Poesia di Marcos y Marcos (2010). Pubblicato nel 2010 per le edizioni d’if il poemetto La famiglia felice, vincitore dell’edizione 2009 del Premio Mazzacurati-Russo. Del 2010 è anche Il farmaco (Fandango).
Jacopo Ramonda, da "Una lunghissima rincorsa", Bel Ami Edizioni, 2014
Dalla nota dell’Autore: “Una scrittura volutamente frammentaria, che punta su densità e concisione, attraverso la scelta ponderata, quanto più puntuale possibile, di ogni singola parola.
L’equivalente letterario di un album di scatti rubati che ritrae dettagli, presentimenti, rivoluzioni silenziose ed eventi marginali”.
Cut-up n. 140
D. era consapevole di aver trascorso gran parte degli ultimi anni immerso in un persistente senso d’attesa, come una parola sulla punta della lingua. Anche con il senno di poi, trovava difficile risalire e attribuire una collocazione temporale alla sua ultima occasione, ma non poteva negare di essersela lasciata sfuggire. Scaricare parte delle colpe sulla sfortuna pareva legittima difesa. Se non altro, sapeva di essere ancora in tempo: poteva contare su varie vie d’uscita, anche se quasi tutte comportavano l’ammissione del suo fallimento.
Nell’alveare (cut-up n. 121)
Il primo giorno di lavoro arrivo in ufficio in anticipo. Mi fanno fare un giro turistico del mio futuro, sul set dei miei prossimi anni di vita. Lo scenario della monotonia è composto da una serie infinita di scompartimenti asettici, anonimi. Strutturalmente uguali tra loro, imparerò a distinguerli con un colpo d’occhio, osservando i piccoli oggetti personali di proprietà dei dipendenti che li occupano, portati da casa nel tentativo di personalizzare il loro spazio.
Sedute di psicanalisi (cut-up n. 45)
A volte ho il sospetto che dietro ad ogni tentativo di cambiare si nasconda un nuovo modo di fallire. La ripetizione sterile dei miei errori dimostra che sbagliando si impara solo a sbagliare. A breve mi procurerò un’incubatrice per le decisioni premature e i progetti sottopeso. Nel frattempo mi limito a sfogliare distrattamente una rivista in sala d’attesa, mentre gli artificieri si preparano a far detonare i miei ricordi traumatici.
Jacopo Ramonda, nato nel 1983, scrive testi collocabili in un’area di confine tra prosa e poesia. Le sue prose brevi sono state pubblicate su Nazione Indiana da Andrea Inglese, su Absolute Poetry da Marco Simonelli, su Poetarum Silva da Luciano Mazziotta; oltre che su varie riviste cartacee, tra cui Prospektiva e La Masnada.
Patrizia Dughero, "Dipingere non è tingere", prosa inedita
DIPINGERE NON È TINGERE
(poeta e pittore si ascoltano varcando la galleria virtuale)1
dipingere è (anche) un comportamento; quel che cerchiamo è un comportamento, il processo operazionale che viene dalla fondazione dell’espressione, che proviene dalla poietica;
la pittura non è soltanto un dispositivo libidinale, che ci suscita interesse, come suggerito da Lyotard; la pittura è semmai la trasformazione di ciò che è visibile in ciò che è leggibile;
questo comportamento consiste nel rivestire una superficie con un materiale secco-umido o oleoso, che sarà in grado d’attaccarsi e di solidificarsi; la mano del pittore rivelerà un aspetto differente dalla superficie nascosta; bisognerà anche che lo strato di pittura resti più tempo possibile nello stato in cui è stata lasciata dal pittore…
cerchiamo anche il bagno del tintore, la stuccatura con la spatola per riempire le fessure e per nutrire la superficie (preparazione);
cerchiamo l’operazione grafica del grattar la superficie con una punta consumata dal tempo, lasciando tratti di matita, di penna, tratti di carboncino;
grazie alla confessione dei gesti, nella sua ideologia illustrata, la pittura guarda al gusto della menzogna; grazie al lavoro del sogno, tra eidos e morphé, per ritornare essa stessa con insistenza, nel corso degli anni, su tre temi che la qualificano:
viscosità; trasparenza; scorticatura (secondo André Masson) e noi le abbiamo imprigionate, queste categorie, nella costruzione della galleria virtuale, che congiunge l’opera a colui che l’ama e che accede al silenzio, come statuto superiore d’ammirazione:
l’ammiratore di pittura non è condannato al linguaggio, ma l’immobilità silenziosa dell’amore esclude il percorso, sempre disagevole, della lettura; si può appena parlare qui d’itinerario dello sguardo…
è sufficiente: prendere in considerazione la pastosità della pittura, con tutto il gusto possibile, non può che esser chiamato fascinazione (forse shock); la pittura diventa poesia quando il pittorico suscita il desiderio di dipingere;
la costruzione comincia dalla sua suddivisione, punto linea superficie valore colore, che sono in mutua relazione, dagli insiemi delle possibilità, delle scelte, l’atto della pittura liberato per cominciare a praticare, come l’atto di guardare liberato sullo sguardo;
… poiché il tocco pittorico ottunde ciò che è sotto, con tutti i materiali, che assicurano pastosità al colore e si avvicinano alla tintura;
il pittore fa colare la tinta, come un succo, sulla superficie, senza pennello, lasciando questa materia fluida trasparente, riesce persino a immergere la carta nel colore, l’accartoccia, la piega, per ripassarla, ad appiattirla bene, una volta seccata;
molti pittori disegnano dipingendo: un tocco non è un tratto, ma il passaggio dall’uno all’altro è facile da comprendere…
CAMERA VISCOSA
(il bianco dei quadri a colori)
la torbidezza realizzata si rivela bianca, riempimento spaziale il più neutro, il più chiaro e il primo non trasparente; la trasparenza stessa, empiricamente, è già il primo grado di torbidezza, che, pura e traslucida, deriva dalla trasparenza; i gradi successivi, fino ad arrivare al bianco-trasparente, sono infiniti;
se non ci fosse il colore, qui, ci sarebbe il silenzio; un pittore sa esperire la pianta che dà i fiori, il pulcino che esce dall’uovo, ma non lo sa dire, non resta che il nome che è nudo;
dunque la nominazione diventa un montaggio formale, come figure per vivere, per lasciare libero il passaggio al colore; ma che può sapere il secco dell’umido?
potere del nome: nominare una forza, come nominare una creatura, una persona; è per questo che il nome vero è mantenuto segreto: forse dimora d’una dea: senza rinascita, nulla è completamente vivo;
CAMERA SCORTICATA
(la pastosità dell’olio - le figure rosse e verdi)
sul problema della materia, la luce è la sua manifestazione più pura, c’è un alchimia sottile che rende il colore manifesto; noi siamo stati colpiti da questa metamorfosi, fra tronchi di legno: ciascuna immagine opera una direzione specifica all’interno di questo ciclo;
in un primo momento, l’organismo liquido e essenziale, le essenze erano trasportate dai fluidi, il respiro primario compiva un passaggio, anche quando tutto era ancora fermo: ma qui è una questione di luce,
poiché il colore si presenta all’occhio nella sua grande varietà, è uno dei segni esteriori più importanti, grazie al quale apprendiamo ciò che passa all’interno, criterio di movimento della vita: colore e luce possono coesistere e possono essere comparati; al contrario di colore e suono…
il contrasto, la vibrazione ottica, tra il rosso e il verde, nella riproduzione sono messi in sordina, creando una psico-implicazione, che è la nostra vera ricchezza; l’ideale sarebbe che tra il pittore, il mondo e le immagini, ci fosse la verità; essere in fuga o andare contro?
cominciando a filtrare i suoi lavori, l’artista scartava tutto: erano il riflesso d’un periodo travagliato, caratterizzato da cambiamenti; restando abbracciato ad una boa, dimenticando che alla fine si sa nuotare: era meglio camminare sul percorso dell’acqua, verso il mare,
nell’oscurità che accoglie fa scuotere pozze di luce; senza staccarsi dalla superficie della lastra colorata, rimanendo nella categoria di ciò che il sole cosparge, adottando una vibrazione rossa, difficile da realizzare per certi esseri, e dedicandosi a reiterare;
CAMERA TRASPARENTE
(la trasparenza degli azzurri)
lo spazio immaginato vuoto avrebbe senz’altro le caratteristiche della trasparenza; ma se è l’oscurità ad esser osservata attraverso un mezzo torbido, illuminato da luce incidente, appare un colore azzurro che diventa sempre più chiaro e sempre più pallido, quanto più opaco diventa il mezzo;
i colori traggono origine dallo scontro con il mezzo, vetro o acqua, prisma nel fenomeno, i cui confini si comportano come fessure;
l’azzurro s’offusca al calare della notte; fa dono di questo mondo qui e del suo giorno, di costruire loro dimore sognanti; apprende il distacco e la presenza; ogni sera, a cose fatte, riguadagna la sua notte, rientrando a casa;
l’azzurro non fa rumore, è un colore timido, senza secondo fine, che non si getta bruscamente sullo sguardo, che lo attira a sé, lo lascia giungere senza far pressione, in modo da affondare e annegare in esso senza rendersene conto;
l’aria che noi respiriamo, l’apparenza del vuoto sul quale s’agitano le nostre figure, lo spazio che attraversiamo, non è nient’altro che questo azzurro terrestre, invisibile per quanto è vicino e fa corpo con noi, presente anche nella camera, insensibile abito della nostra vita, che veste i nostri gesti e le nostre voci;
non è, a dir la verità, proprio un colore, semmai una tonalità, un clima, una speciale risonanza dell’aria, un impilarsi di chiarore, che nasce dal vuoto aggiunto al vuoto, tanto cangiante e trasparente nella testa dell’uomo che nel cielo: l’azzurro s’evade indefinitamente;
l’azzurro è un colore propizio alla scomparsa, dove morire, un colore che libera il colore dell’anima, dopo che si è spogliata del corpo, dopo che ha sprizzato il sangue, tutto;
ma tutto questo azzurro qui non è della stessa tinta…
CAMERA DEI TRATTI
(i disegni, matita cartoncino grafite)
i tratti lamellari si riversavano senza posa all’interno e indicavano le variazioni di corrente atmosferica, a seguire i voli irregolari;
i tessuti del corpo potevano muoversi in sincronia, o no; in un corpo integrato il respiro primario si fa sentire, affidandosi a movimenti superficiali, molto superficiali;
la profondità si disegna nella relazione tra movimenti, tra i più superficiali, nell’esser-ci;
1 Questo scrittura in lasse è stata realizzata nell’agosto del 2012, come nota d’accompagnamento alla mostra del pittore friulano Roberto Cantarutti, Camera oscura, che si tenne a Bruxelles nell’autunno dello stesso anno. Scritta direttamente in francese, qui presento la versione in italiano riadattata e ridimensionata. Alcuni passi sono stati tradotti anche in sloveno per la personale di Cantarutti che si è tenuta a Cormons (Go) nel febbraio-marzo del 2014, sempre col titolo Camera Oscura.
Patrizia Dughero, di origine friulana, mi sono laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna, svolgendo una tesi riguardante la Storia dell’illustrazione. Ho lavorato come restauratrice muraria presso alcuni importanti cantieri di Bologna. Negli ultimi anni ho ricevuto diversi premi letterari e sono presente in antologie sia di racconti brevi che di poesie, le più recenti Cuore di preda. Poesie contro la violenza alla donna e Il ricatto del pane. Scritti sul significato del lavoro, entrambe CFR Edizioni; Di là dal bosco, andata e ritorno nel paese delle fiabe, Dot.com Press Edizioni; presente anche in numerosi blog, attualmente la mia attività si concentra su articoli e recensioni, tra gli altri apparsi ne “Le Monde diplomatique”e“Leggere Donna”; recensioni sulle mie poesie sono inserite in riviste letterarie, in Italia e in Slovenia, quali “Poesia”, “Novi Glas”e “Revija SRP”. Quattro le sillogi poetiche pubblicate: Luci di Ljubljana, 2010; Le Stanze del Sale, 2010; Contatti, col poemetto Canto di Sonno, in tre tempi, 2011; Reaparecidas, 2013. Da qualche anno sto svolgendo studi sul linguaggio poetico dell'haiku e sul disagio femminile in relazione al mito nella scrittura poetica delle donne. Attualmente redattrice della rivista Le Voci della Luna, dopo alcuni anni come segretaria di redazione, sono responsabile di redazione di “24marzo Onlus”, Ong che promuove iniziative culturali e giuridiche con particolare attenzione al caso dei desaparecidos in Argentina; ho partecipato ad eventi letterari e artistici, a volte con ruolo attivo nell’organizzazione, tra cui a Bologna, 100Mila Poeti per il Cambiamento e Bologna in lettere;a Venezia Palabra en el mundo; Acque di acqua e Stazione Topolò in Friuli,oltre che a quelli legati alle attività di “Rete Identità”. Ora lavoro a tempo pieno per qudulibri, la mia casa editrice, nata nel 2012, che con due locuzioni riducibili non solo a slogan, amo definire costruita sull’ “impegno del linguaggio per una militanza della memoria”: http://qudulibri.wordpress.com
Franco Falasca, "Il mondo", una poesia inedita
Il mondo
Il mondo che guardi, il mondo ti guarda. Il mondo che vedi, il mondo ti vede.
Il mondo che mondo non è,
che attraversi ogni volta che guardi, un mondo non è, e vita non è,
ma rientra nel vuoto che lo contiene, se ti contiene ed anche ti vede, denso di colpa e pieno di vita,
vuoto ti lascia ed afflitto
per nessun segno di densa visione, che densa non è, né visione di me che notturno nato addenso il sapere con ansia e sguardo
che di mondo non sa
ogni volta che vedo e che dico e che so, cosa dico e cosa so
se il mondo non vedo,
che vedo e comunque mi appare
e sbriciola e voltola alle soglie dell’incontro che mai mi appare e mai mi viene incontro con lirico errore e sfiducia sovrana
che ripeti ed ogni volta agisce che ripeti e mi vede incarnato non lasciando tracce
né sentimenti né voglie
e non linguaggi da me a te non frasi dall’uomo a te non me non te
il pericolo il metronomo la materia, del mondo che vidi non so chi tu sia,
del mondo che oso perché richiamarmi, dovunque che vedo cosa saprei?
Franco Falasca, nato a Civita Castellana (VT) nel 1944, vive a Roma dal 1958. Ha prodotto, oltre a poesie e racconti, anche poesie visive, films super 8, video, fotografie, performances. Ha organizzato rassegne e manifestazioni.
Nel 1973 fonda (con Carlo Maurizio Benveduti e Tullio Catalano) l’Ufficio per la Immaginazione Preventiva con cui collabora fino al 1979; partecipa come artista alla Biennale di Venezia 1976.
Suoi testi e materiali vari sono stati pubblicati, oltre che nei cataloghi delle mostre alle quali ha partecipato, anche su varie riviste ed antologie e nei volumi::
Nato a Civita Castellana (VT) nel 1944, vive a Roma dal 1958. Ha prodotto, oltre a poesie e racconti, anche poesie visive, films super 8, video, fotografie, performances. Ha organizzato rassegne e
manifestazioni.
Nel 1973 fonda (con Carlo Maurizio Benveduti e Tullio Catalano) l’Ufficio per la Immaginazione Preventiva con cui collabora fino al 1979; partecipa come artista alla Biennale di Venezia 1976.
Suoi testi e materiali vari sono stati pubblicati, oltre che nei cataloghi delle mostre alle quali ha partecipato, anche su varie riviste ed antologie e nei volumi::
- "UNA CASA NEL BOSCO - Prose e racconti", Edizioni Latium/Ouasar, Roma, 1990, vincitore del Premio Letterario Orient-Express 1990
- “NATURE IMPROPRIE (poesie 1976-2000)”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2004, vincitore del Premio di Poesia Lorenzo Montano XIX edizione (2004-2005) della Provincia di Verona
- “LA FELICITA E LE ABERRAZIONI (poesie 2001-2010)”, Fabio D'Ambrosio Editore, Milano, 2011
Carla Paolini, da "Installazioni", raccolta inedita, con una premessa dell’Autrice
La materia di Installazioni non nasce dall’occasionalità degli eventi, ma dall’interesse che improvvisamente una parola mi smuove. Intorno a questo embrione energetico, il pensiero struttura e specializza nuove sintassi.
La sostanza espressiva si diffonde, disseminando segmenti come linfonodi messi a difesa delle sue intenzioni. L’organismo poetico addensa fisicità singolari, si installa sulla pagina e accetta l’urgenza di esistere.
Motteggi
motteggi balbettati
fermi sul filo del pronunciamento
la parola ci attinge
stiamo da lei senza condizioni
il cerchio della sua stigmate
produrrà il quadrato perfetto
oh spoliazioni! date voce al filare aspro delle polifonie
intrecciando l’ovvietà che ci include
con l’unica eccezione del palpito rigenerante
che si delinea nell’ombra
Bande
bande parallele di omertà
accettano il sopruso
per intendersi coltivano l’impotenza
e si incrociano su navigazioni a svista
minuzzoli di niente
incalzati dal cenno
confortatevi
l’audacia è un’illusione che attraversa in fretta
ammicca le sue eruzioni
e frana sui grandi bassorilievi del decoro
Vibrati
vibrati violenti di viola
scarnificano l’endecasillabo
lavoro di finitura sui grumi rimasti
e ripresa dell’originario inarticolato
l’obiettivo è metamorfosi
giustapposizione o contrariamente
partitura a vivere
mentre su una banda di antinomie
si accentra
il brulichio della gestazione
Carla Paolini vive e lavora a Cremona.
Si è dedicata per diversi anni allo studio di tecniche per la manipolazione della creta.
Partecipa, in collaborazione con altri artisti a progetti per varie manifestazioni culturali e a reading di poesia.
È stata finalista (con la silloge MODULATI modulati) e più volte segnalata al premio Lorenzo Montano - ANTEREM, per la ricerca letteraria.
Ha pubblicato racconti, poesie, favole su antologie e riviste e le sillogi poetiche: Impronte digitali (1993); Diverso inverso (1995); Una x Una (1998); Ai cancelli del flusso (2001); Amori diVersi (2002); Modulati modulati (2004).
Da qualche anno pubblica anche sul suo blog
http://specchio.ilcannocchiale.it
Molti dei testi scaturiti da questa esperienza sono passati dal monitor del PC alla pagina di carta e così sono nati i volumi Prosemi (2009) e Internectasie (2011): raccolte di brevi prose poetiche.website: www.carlapaolini.com
Lucetta Frisa, "Perseidi", una poesia inedita
Perseidi
Essere soli è essere nell’intimo del mondo. Antonio Ramos Rosa
Parlerò solo alle stelle.
Sono pazza forse
ma proseguo il discorso
che facevo da bambina
parlando senza parole
non sapendo parlare.
Di me invece loro sapevano tutto:
il loro tacere non è mai stato muto
sta nel pulsare universale.
Davanti alle stelle
che frusciano come le foglie dei cespugli
sono sola tutta notte
tutta notte io scintillo
guardo lontano
vedo e non
vedo.
Non siamo nati nella follia?
Non appena iniziò a muoversi
il Tempo
trascinando
astri e polvere.
Sparpagliati nello spazio
i suoi semi
non fiorivano.
Niente e nessuno
fioriva.
L’ombra
era uno specchio vuoto.
Se parlo alle stelle
so di parlare ai morti
perché a noi
tocca solo l’immagine
slontanata
della vita.
E mentre sono qui
sono morta da un’altra parte
o forse non esisto
non esisterò mai.
Ma adesso sono chi?
Stanotte la terra
va traversando lo sciame
delle Perseidi
che ci sembrano più vicine.
Allora
io volo verso le stelle
lascio cadere la casa
dietro le spalle
come un abito usato
e il mio cervello
adesso è così leggero
nel vento siderale
che mi prende e porta
Mi sento dolcemente fredda
non ho bisogno di niente.
Tutto ciò che vedo o non
vedo nasce
e muore lontano.
Prima.
Dopo.
Mai adesso.
Mai ci sono arrivi
e partenze.
Mai c’è il presente.
Nessun volo raggiunge l’altro.
Oppure
tutto è presente e fermo.
Il mio corpo e le stelle morte
che si rappresentano qui
in una vita finta.
Qualcuno
in questo momento
guarderà come me le stelle
attenderà di finire
con gli occhi puntati in alto.
Chi vuole morire
dentro un letto stretto
morire
sotto il soffitto di una casa?
Guardando le Perseidi
In questa lunga notte d’agosto
guardandole e sperdendomi
raggiungerò l’estasi raggiungerò
quel punto nel cielo
che risponde al mio cervello antico
alla terribile infanzia primordiale
chiusa dietro la nuca,
alla mia infanzia senza parole
e all’estasi
che perde corpo e voce.
Chi ha un corpo ha un segreto
da conservare
fuori di sé.
Il mio sguardo
ha scavalcato i tetti
i ragionamenti
le vette
le visioni
si è affacciato da questo balcone
come il puro desiderio
che non si vede mentre desidera
sempre verticale
scoccato.
Il mio sguardo è da preda
simile a quello del lupo
del serpente della tigre
di tutti gli animali
che guardano dritto
dentro gli occhi
perché hanno fame.
Nel buio
si catturano le luci stellari
memorie di eventi possibili
di un mistero che si assottiglia
sempre un po’ di più
ma che mai
perderà la sua struttura.
Dicono che è lassù la nostra origine.
Che lassù ci sono
padre e madre.
E sta a noi
farli tornare qui
Io ipnotizzo le stelle
loro ipnotizzano me
allargando allo spasimo
le mie pupille umane
forse entrerà qualcosa
nel mio campo visivo
che prima non c’era.
Sarei forse capace di raccontare
la bellezza del cielo notturno
nominando una ad una
le stelle ?
Come non so imparare
I nomi degli uomini e dei fiori
di tutto quanto vive sulla terra:
di queste impossibilità
è fatto il silenzio.
I profumi della notte
s’incontrano a metà strada:
verso di noi scendono
quelli astrali
verso di loro sale
l’essenza tellurica.
Di notte
l’erba e gli alberi
hanno odori che raccolgono
tutte le profondità
scoppiano dall’invisibile
una linfa nuova
trattengono i suoni
inudibili
di giorno.
Se si capovolge la lente
da qui non si vede niente
forse il fumo
di tutti gli anni
di luce mortale
e di mortali sogni
che prima furono solide cose
ed evaporarono
poco a poco
ed evaporano adesso
come un astro si congeda da un astro.
Se si capovolge la lente
noi si perderà l’ ombra?
E quale altra ombra
ci potrà confermare?
Il cielo della notte
si rivela
se noi
con questi occhi
lo riveliamo
a lui
perché noi e lui
siamo legati da un unico velo
e dalla stessa grandezza.
Stelle
la vostra linfa
scende su di noi
come un tempo scese la manna.
Guardandovi
noi non si cerca nessuna certezza
ma voi state qui a fare finta
di esserci.
Salute a voi come siete.
Salute dal nostro al vostro tempo
che mai si incontreranno.
Salute a voi
e a tutte le finzioni.
Lucetta Frisa è nata e risiede a Genova. E’ poeta e traduttrice. Tra i suoi più recenti libri di poesia: La follia dei morti,(Campanotto,1993) Notte alta,(Book,1997), L’altra (Manni,2001), Disarmare la tristezza (Dialogolibri, 2003), Siamo appena figure(GED,2003) e Se fossimo immortali (Joker,2006). Ha tradotto Emily Dickinson, Henri Michaux e due libri di Bernard Noêl (Artaud e Paule,2005 e L’ombra del doppio,2007),entrambi per la collana I libri dell’Arca delle edizioni Joker, di cui è curatrice insieme a Marco Ercolani. Collabora a diverse riviste come La mosca di Milano e La clessidra ed è presente in antologie, tra cui Il pensiero dominante (a cura di Davide Rondoni e Franco Loi, Garzanti,2001) Trent’anni di novecento di Alberto Bertoni (Book,2005) Altramarea a cura di Angelo Tonelli (Campanotto,2006) La poesia erotica contemporanea (Atì,2006) e Voci di Liguria ( a cura di Roberto Bertoni, (Manni 2007). In coppia con Ercolani, scrive libri di storie immaginarie e non, come Anime strane (Greco&Greco 2006). Con i suoi racconti per ragazzi collabora al quotidiano Avvenire. Tra i diversi riconoscimenti,il più recente è il Lerici-Pea del 2005 per l’Inedito
Galleria fotografica del Forum, 8 novembre 2014, di Maria Grazia Veroni
Ottobre 2014, anno XI, numero 24

In attesa di ascoltare “dal vivo” i protagonisti dell’edizione 2014 del Premio Lorenzo Montano, avvenimento che accadrà tra l’8 e il 16 novembre prossimi nell’ambito del Forum Di un altro dire organizzato da “Anterem”, nel presente numero di “Carte nel vento” concludiamo la pubblicazione dei testi più significativi dell’edizione 2013 del “Montano”. Ideale sèguito dei tre numeri precedenti, questo nuovo “Carte nel vento” propone finalisti e vincitori per “Raccolta inedita”, “Una prosa inedita”, “Una poesia inedita”, attraverso opere che esprimono da un lato l’articolata attualità della poesia italiana contemporanea, dall’altro il fascino della prosa breve e dell’indagine saggistica rivolta a temi sempre vivissimi.
Ciascun autore, poeta, prosatore o saggista, viene presentato da un redattore di “Anterem”. In chiusura, piccolissimo omaggio di un grande poeta totale scomparso da poco: Pierre Garnier.
Immagine di copertina: locandina del Forum di “Anterem” 2014
Stefania Negro, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
Teneri e trepidi sussurri intendono i pensieri
e hanno accorte mani per fare e per disfare
il senso comune del divenire, attendono ciò
che non è dato ancora di sapere, tese le
palme al dono dell’esistere e dell’accadere.
Come foglie d’oro che fluttuano nel vento e
nella luce splende la caduta piano piano
come per resistere e fermare il tempo del morire
così noi inesorabilmente increduli e volenti siamo.
Il bello dell’esserci
“Teneri e trepidi sussurri intendono i pensieri” è breve componimento in cui Stefania
Negro mostra una compostezza verbale attraversata da una sorta di esistenzialismo
estetico.
La successione dei versi, compatta e vibrante, segue il suo corso fino quasi a divenire
racconto senza essere mai dimentica del fascino interno esercitato dal linguaggio.
Un linguaggio che è proprio quello, che deve essere proprio quello se intende
raggiungere certi esiti poetici.
È come se una necessità, cogente e, nello stesso tempo, liberatoria, fosse sottesa alle
parole, ossia è come se ciò che non è discorso in senso stretto suscitasse l’interesse
dell’autrice in maniera costrittiva eppure non vincolante.
Stefania è libera di dire, ma secondo una certa forma stilistica.
Ora – si penserà – siffatto dire è pur frutto della scrittura dell’autrice medesima e,
dunque, non è ravvisabile alcun obbligo esterno.
Affermazione, quest’ultima, condivisibile soltanto in parte, poiché la poetessa,
certamente, scrive ma anche descrive, ossia offre immagini riferite a un mondo che
esiste in quanto da lei percepito.
Il pericolo dell’autoreferenzialità viene evitato proprio per via di un’evidente valenza
estetica non fine a se stessa, dotata d’intensa fisionomia.
“Come foglie d’oro che fluttuano nel vento e
nella luce splende la caduta piano piano”
sono due versi in cui la lingua assume il valore di un bello che aspira a essere, a
divenire lineamento di vita.
Insomma, Stefania si rivolge a noi, quasi dicendo: “Sono stata là e voi dovete credere
alla mia testimonianza”.
Perché non dovremmo crederle?
Perché non dovremmo ravvisare nelle sue parole la presenza di quell’estetico
conoscere proprio della poesia? Marco Furia.
Stefania Negro, poetessa e saggista. Ha pubblicato Fili di luce compresi negli archi del divenire,
Cierre Grafica, 2007, Erranze nel divenire, Anterem Edizioni, 2009, La geometria della luce,
Anterem Edizioni, 2009, Risonanze, Manni 2010. Ideatrice e organizzatrice di eventi culturali
multimediali.
Letizia Dimartino, una prosa inedita, premessa di Mara Cini
Non semplicemente una prosa inedita ma una raccolta di notazioni diaristiche che accompagna il viaggio di una vita intera.
All’apertura del “cassetto” troviamo foulards e tovaglie, aspirine, lettere, giorni e stagioni e i libri i libri i libri i libri…i libri. Per sempre.
Pagine che fanno un po’ tremare, soprattutto le donne, credo, che si riconoscono in quegli accessori vintage, in quelle trasmissioni televisive, in quel paese-Italia dove scrivere e star male è già un conforto. Mara Cini
Biografia di Letizia Dimartino
Direzione inversa
Ti scrivo da un posto dove non sei mai stata
dove i treni non passano, gli aerei
non atterrano, un luogo a occidente…
Mark Strand
Se mai qualcuno ci sarà che chieda della mia vita,
gli dirai che vivo, ma non gli dirai che sono salvo.
Ovidio, Tristia
***
L'arrivo alla stazione nel ferro nel nero di una cupola binari lungo l'Italia del mare dei filari degli scogli delle pietre della neve alta delle colline ampie il bar nel giallo del neon i giornali dai colori lucidi il velluto del treno sulla pelle le dita nere di viaggio la fame la sete il dondolio alle gambe il marmo delle scale i taxi gialli di desiderio le piazze che si aprono ventagli di strade città di nebbia il sonno sulle palpebre l'isola nel corpo gli anni che verranno sirene che squillano nel loro solito suono l'urlo del traffico il capo a poggiare l'aria che entra dalla striscia sottile del vetro auto troppo calda. Il Nord ed io.
***
L'auto posteggiata al sole i palazzi chiari le scale che salgono in un infinito scappo dai corridoi dai pavimenti scheggiati dalle voci dei ragazzi dai libri dietro i vetri i discorsi che non sento la borsa da stringere il verde di una vallata verde di un treno che non passa binari vuoti uccelli a litigare su rami su foglie il caldo al finestrino la fuga per il grigio della via le stanze ad accogliere la casa che apre la paura che si perde l'odore del conosciuto tutto avvolge tutto acquieta finalmente.
***
Scrivo nel disordine fra liste della spesa farmaci sparsi letto che mi attende computer sempre acceso trilli del cellulare finestre aperte sulla strada capelli da lavare vestiti da riporre armadi aperti foto da guardare dolci sul tavolo odori di cibo a cucinare libri sempre aperti musica sul fondo rossetti in prova specchi in cui guardare per piangere matite pronte per la tempera cielo dentro le stanze luce sulle poltrone riviste sfogliate desideri sepolti preghiere fra una email e l'altra mamma malata cui rimboccare la coperta cantandole una vecchia canzone lacrime sulle ciglia per ogni ricordo che passa veloce amori che vorrei avere amori amareggianti telefonate sussurrate dolori che vado a coricare poggiando la giornata sul cuscino. Perché giunga una notte qualsiasi.
***
Sul letto parlo guardo specchi rossetti sulle mensole scarpe che non devono essere usate strade da non calpestare profumi sul collo creme sul petto giornali sopra lenzuola di lino stanza bianca stanza blu divano rosso la tenda trasparente nuvole ai vetri vento che spinge una fetta di torta comodino ingombro segnalibri fra le pagine iPod sul guanciale lettere da spedire abiti appesi da provare da non mettere un amore che non c'è quel che potrebbe essere le unghie sbrecciate il grigio dei capelli che si posano sul cuscino il bianco di un letto che sa accogliere e di una pillola a calmare a dare requie alla ragione al mistero di quel che sento.
Daniela Monreale, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
Biografia di Daniela Monreale
da Ascoltare vento
***
Ascoltare vento/ ascoltare pioggia/ ascoltare
sguardo muto dal finestrino/ canzone ultima
corona dell’amore/ e dirti il filo rosso che
ricama le cadute/ dirti gli eccessi e le ansie
premature/ il finale della mossa non è regina/
non è torre bastione muro dentato in cima/
fino a quando vivrò, vorrò essere parola
***
Vorrò tessere la ragnatela del mio dire/ per
catturare volti dall’eco metropolitana/ e voglio
una parola che mi attraversi tutta/ che faccia
amore e condivisione/ che faccia differenza/
prodigio e ribellione
***
Spezza i copioni e la dura maschera /
l’invenzione del mare / la duna del braccio /
che ribelle ti chiude/ ti stringe nel piacere del
poi/ dell’immagine folle di un’impronta /
calco di sale e di lingua/ la friabile pelle si
perde/ si perde nell’acqua
Per entrare dentro la voce poetica di questa raccolta, possiamo partire dal titolo e da una piccola, ma molto importante particolarità lessicale: l’assenza di determinazione nella mancanza dell’articolo il. Ben diverso sarebbe stato “Ascoltare il vento” che suggerisce e precisa, seppur in modo astratto, quel determinato vento. Mentre “Ascoltare vento” concretizza, anche in una paradossale aleatorietà, il suo essere che permea tutta la dimensione intenzionale, sia intima sia esterna, più necessaria che voluta, di questa scrittura di parola in ascolto.
Per l’autrice, infatti, prima dello scrivere c’è l’ascolto a trasformare l’esistenza in una voce che, finché vive, vuole “essere parola ”. Ascoltare poesia, dunque, diventa l’essenza di un desiderio totale: un attraversamento nella condivisione di un dire lieve ma preciso, evocativo ma centrale nella prodigiosità dell’atto poetico. E questo è il dato reale, che si scontra con una realtà fatta di lingua pensierosa e veritiera, ma non pensante e vera, non nella leggerezza infinita di una mente quando sta nella poesia. E se questa ha una ragione d’essere, è proprio nella natura tutta umana, interiore, sognante del sentimento a cui dà forma e da cui prende sostanza. Ma ben più determinante è la volontà per cui nasce e in cui si trasforma, una lingua fortemente individuale che si oppone, senza sforzo, alla banalità delle emozioni ordinariamente emotive. Quelle che percorrono il tracciato di una norma che parla ma non sente “l’urto dell’indicibile...la ferita della carezza”.
Perché è al cuore delle parole che bisogna andare: tagliarle, aprirle, svuotare il loro sembrare qualcosa per cercare l’essere della cosa che è, che portano in sé e trasportano con sé. Ed è sufficiente anche solo il loro suono per comprendere, in una sospensione che può a volte essere dolorosa, anche la loro oscurità. Daniela Monreale ci dice che la poesia concentra un mare di significazioni in un battito che sfugge alla frase: un’epifania, un frammento di senso che, se anche semplicemente sfiorato, è percepito come una direzione offerta ai pensieri e agli sguardi. Un dono che rende consapevoli di ciò che si cerca con la scrittura: non un oggetto di sollievo, “non la primavera”, ma un segno che ci accompagni e diventi segnale per una semina della parola, e anche un precipizio nella stessa. Chi pensa in poesia sa che non si esce indenni dalla sua pratica costante: perché la materia che in essa fluttua è continuamente trasformata e può affiorare in trepidazioni o dilagare in festa, in ogni caso è il portento di una mente che ascoltando anche le piccole cose vive, i baffi di una gatta ad esempio, invogliano un sorriso e alleggeriscono tristezze.
E ancora più, possono portare a ridere e a desiderare un sonno gelido o infuocato, perché la fantasia e l’immaginazione “fanno muovere brividi”, fanno “fare farfalle”. Così si arriva con la poesia a dimenticare il sé per essere parte ed essere tutto. Essere il movimento che la parola crea con una vibrazione fisica, un’ondulazione che ha percorsi immensurabili e sembra perdere la visione, per poi ritrovarla reinventandola in una multiformità che l’autrice designa con piccoli gesti, accenni, profili che portano, con meraviglia e grandezza della semplicità, anche a chiacchierare con Dio. E dove i reticoli di conoscenza, anche se ignoti, anche se altrove conducono, con la severità del silenzio, alle delizie del poco: dove nient’ altro si è, negli interstizi del senso, che “una particella che muove l’incanto”. Giorgio Bonacini
Armando Bertollo, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
da Coordinate di galleggiamento
Testi 1 + 2 + 3
Dare visibilità ai movimenti del pensiero che emerge in scrittura, vuol dire avere una precisa idea di ciò che la propria poesia desidera o è in grado di fare e, nello stesso tempo, mostrare, pur in forma di metafora segnica, i modi in cui il percorso sintetizza i suoi sentieri. L’opera di Bertollo, alla terza prova di questa sua visualizzazione pensante, sembra proprio avere consapevolezza che la sua non è un’arte rappresentativa e nemmeno una poesia espressiva, ma una voce che fonda in sé le sue parole e la direzione dei suoi gesti. E lo fa inseguendo i fili del pensiero, del sentire, del dire e del vedere, con la leggerezza che viene dalla sostanza del respiro. Il fulcro di questa prova d’arte e di parola è l’evento primigenio, che dà origine a ciò che l’essere è e diventa: l’acqua. Qui è possibile ondulare il pensiero e trovare la coordinazione poetica che dilata i sensi: sia quelli del sentire fisico sia quelli del significare, nella “mappatura della presenza galleggiante”.
Questo significa dare sonorità e visività all’atto poetico gestuale e meditativo, per realizzare sulla pagina ciò che dall’interiorità dell’autore affiora. E la registrazione di ciò che dal fondo ritorna, con profili e spezzettature, prende fiato e segnala, non solo un’aderenza al movimento poetico che incessante si fa sulla pagina, ma un’adesione esistenziale che qualifica la scrittura e la vita che sta nella scrittura “attraverso l’esperienza”, andando anche oltre quello che sembra possibile solo vedere. Ed è così che l’autore lascia emergere le figure che stanno all’inizio della concretezza umana: quella materna che ha cura della nascita e quella infantile che ha nuova voce. Due figure che a un certo punto si condensano nella lingua dialettale, nella filastrocca che porta ritmo al nostro essere parlanti e scriventi, e prima ancora nel pianto della nascita: ma all’inizio di tutto c’è il silenzio, che è la via da cui prendono corpo i segni. Ma non un segno che incide, che lascia solchi e a volte lacerazioni, ma un segno sorgente, che nasca, che gorgogli dal fondo e che sia anche fonte vocale per una terra libera di accettare.
Ma questo lasciare e far crescere segni deve avvenire, precisa l’autore, con la forza di un soffio, circoscrivendo il vuoto in leggerezza, “per dire qualcosa appena appena”. Per far sì che il reticolo e il percorso abbiano la possibilità di esplorare anche la sospensione, la pausa che prende la voce col respiro, l’insorgere lento di relazioni che procedono anche e specialmente per contemplazioni. E qui notiamo come, in questa ultima opera, la scrittura e il dinamismo visivo riducano il loro impatto a un’essenziale presenza, sgombrando la partitura con equilibrate aperture, in coerenza formale e sostanziale con quanto nella partitura è detto. Sembra quasi che il percorso fatto da Bertollo da una piena bellezza ribelle del primo libro, passando sul bordo scenico del teatrino nel secondo libro, fino a quest’ultino galleggiamento di vita inaugurale, sia andato man mano ad asciugare le circonvoluzioni della sua parola viandante. Ma non per evocare un di più attraverso la parola-segno precisa, ma più per imprimere la giusta sintonia: che sta anche nel vuoto all’interno del reticolo, nell’invisibile dentro la struttura, nel ritrarsi dall’insorgere.
Quello che ci lascia allora in queste pagine è dunque una sorta di coreogramma fatto di tracce che si sfiorano e si accarezzano, si toccano accogliendo e lasciando vicendevolmente il passaggio, nel poco e nel giusto di un’esperienza linguistica. Giorgio Bonacini
Biografia di Armando Bertollo
Giovanni Infelìse, saggio breve inedito, premessa di Mara Cini
Dimenticare il significato: il gesto e il tratto scritto sono livelli di realtà che si dispiegano sulla pagina ancora prima di ogni “lettura”.
Se si scrive amore, amore è quella scia d’inchiostro (inchiostro?) nero-su-bianco, bidimensionale, di diversi caratteri tipografici o chirografici, in differenti alfabeti, che ne traghetta il senso…
L’esperienza del lettore (il poeta sarà il primo lettore delle proprie parole?) innalza o inabissa “la traiettoria di un’andatura incerta e malinconica spremuta dalle dita” per transitare verso una qualche “finitudine” tra noi e il mondo. Mara Cini
testo e nota biografica 1 + 2 + 3
Giovanni Duminuco, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
I MUTAMENTI DEL RESPIRO
Il segno poetico porta la parola a generare voce e scrittura, con una circolarità nella progressione del suo dire, che non è semplice ricorsività fine a se stessa, ma una sua autonoma capacità di essere, pur senza un cominciamento preciso, indicazione di significazione iniziale, e, con una conclusione indeterminata, di arrivare pur sempre a un momento finale. In altre parole la poesia porta e comporta in sé un pensiero che è origine e costruzione di un mondo. A partire da paradigmi noti, la formazione del testo ne riconsidera la sostanza avviando un processo di conoscenza fino a quel momento sconosciuta. Così, “DINAMICHE DEL DISACCORDO”, crediamo rientri proprio in questa dimensione: per l’atto poetico che mette in opera, dove il “disaccordo” del titolo sembra essere non solo un “dissenso” verso l’apparenza, ma anche una “disarmonia” che slega le prerogative del dire dalla semplificazione referenziale, agganciandole alla possibilità di un pre-inizio dove “abitare il corpo” e un dopo-fine per non “pensare al baratro”: due conseguenze che si corrispondono all’interno del vivere in sé e in scrittura, e che aprono e chiudono il poema.
Questo significa che la scrittura di queste poesie evidenzia, non solo in profondità ma anche alla superficie per la sua apparente lineatura in prosa, una distensione nel respiro interno che una lettura ad alta voce, non solo rende evidente, ma incrementa. E lo fa anche attraverso un’estensione della frase che tende a configurare ciò che è in un dove fuori dai “sintagmi imperscrutabili”, che polverizzano il vero e il reale in un depotenziamento che invece la percezione poetica sa dove cercare, e qualche volta a trovare. Lì dove la figura del vento è centrale. E proprio perché in contrasto (quasi un ossimoro concettuale) con la sua forza dispersiva, fa da cardine e da collante sia della parola sia del silenzio. Ed è così che il vento ritorna, in svariati momenti, come soffio, come danza, come respiro, come disposizione al cambiamento, come dinamica della mente, come traiettoria di un distacco: determinazioni che stanno in una sillabazione dal ritmo impercettibile e volutamente dimesso. Mai però “dismesso”, proprio perché, come precisa l’autore, “le foglie non hanno direzione alcuna, se non l’impronta del vento”.
Ed è davvero in questa assenza di percorso, in questa mancanza, che sta la presenza di una traccia: invisibile agli occhi di un’ordinaria e spenta osservazione, ma ben percepibile dalla metamorfosi che la scrittura opera dentro se stessa, e nei modi che le sono propri – quelli cioè di una pratica della lingua che sgretola e scombina ma continuamente pensa la natura, a dir vero innaturale, della lingua – per riconsiderare il mondo e intravederne un’alternativa. E per farlo bisogna “scrutare sotto la crosta” del visibile, tra le irregolarità e le crepe, tra i vuoti che sembrano riempirsi anche con il nulla di una parola talmente lontana da far pensare, scrive Duminuco, a una poetica del silenzio. E infatti l’ andamento mentale che mette in circolo la geometria morbida di questi testi, sembra veramente andare in cerca di silenzio: o almeno di quella sua parte che non è mutismo, non è mancanza di fiato o sordità delle sillabe o ritmo forzatamente in pausa. Ma è quasi l’assorbire di un vapore della voce; è come rendere più fievole il brusio delle parole che si distendono nell’aria. Non più allora il rumore del verso o della frase che martella con urgenza nella scansione materiale del tempo, ma una leggerezza dolente che “a volte preferisce cancellare”, o lasciare che il senso si produca con una necessità di fuga, o al suo opposto un convenire soffiato, intimo, nella semplicità esistenziale di una visione sospesa.
Ma cosa fa, e cosa vede questa poesia, oltre il disaccordo, sotto il distacco, dentro i procedimenti di un conflitto? Possiamo con certezza dire che l’autore fa esperienza scrivendo (la stessa forse, con differenti modalità, che fa il lettore). Prova il punto di vista che “il mutamento dei nomi” divide tra l’esserci nel mondo e il divenire in poesia. Questione complessa che ingarbuglia il pensiero, ma in questo modo lo riconsegna alla forma sostanziale del vivere il linguaggio: la rappresentazione e ripresentazione sulla pagina di un compimento: smarrire le cose per ritrovarle e riconsiderarle; perderne il senso e poi, come trafitte dalla tenebra, farle rientrare e riconoscerle diverse. Ma l’autore di questi testi è consapevole che non sempre ci si riesce o è possibile; però pur segnati da una “distanza straziante” dobbiamo tutti, autori e lettori, fare la stessa esperienza di smarrimento, accettarne il lamento e prendercene cura, perché solo lì esiste “il verso del perdono”. Giorgio Bonacini
Per una selezione di testi cliccare qui sotto
DINAMICHE DEL DISACCORDO
di Giovanni Duminuco, vincitore per "Raccolta inedita" al premio Montano 2013.
Alessandra Greco, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
(continuum) Prima luce terrena
Pulì i canali e iniziò la
separazione delle mani
eventualmente a loro volta
allo stesso tempo
una parte del peso del corpo minima o
nulla.
L’attenzione visuale.
Il corpo continua la rotazione
lo spirito visuale parzialmente
simultaneamente
progressivamente sulla spinta.
Fino all’altezza delle sopracciglia
vicino all’orecchio
allora disse: Cadi tra le mie mani e
(che lo rese umano) quanti capelli
a mostrare sposta la parola al lato in ombra
l’altro di sé posseduto.
In seguito si lega (e quadra) il cerchio.
Si comunica il nome.
Si infonde altro tempo.
Alessandra Greco, Crachée de neige dans l'eau pour faire des ronds
da La memoria dell'acqua_ studi inediti _2012/2013
Per parlare dei testi di Alessandra Greco, partiamo (in modo certamente inusuale, ma aderente alla poesia stessa, che non dà concessioni e conoscenze usuali) dalla dichiarazione dell’autrice che vede nella didascalia di una teca dedicata agli squali in un museo, uno dei motivi che ha ispirato la nascita di queste scritture. Ma cosa c’è, o pensiamo che ci sia, di meno evocativo per l’immaginazione, per il pensiero, per la ricerca che correla e comprende in sé direzioni non visitate di conoscenza e metamorfosi del senso, di una didascalia, che normalmente non è fonte di stupore? Ebbene una didascalia come questa (e se l’autrice vuole, mi piacerebbe che fosse lei stessa a leggerla) è così poco didascalica da rappresentare, per via letterale e insieme metaforica, un preciso segno intellettivo di poesia in atto.
E da lì si può cogliere l’esperienza significante di questa poesia così poco allineata, anche con la poesia stessa, nelle forme in cui esplora e va a rovistare nei motivi del suo nascere e del suo essere: la materialità dell’acqua che si presenta in trasformazioni che investono e si insinuano dentro “la cosa sconosciuta” e oltre. Verso un divenire, altro da sé, nella voce del poeta e fuori, nell’estensione di un’eco dalle sonorità a cui la scrittura cerca di dare un corpo di calore, densità e colore. “Punti di un volgimento tridimensionale” vengono definiti, con precisa identificazione, nel corso delle pagine: che sono proprie di una scienza poetica emozionalmente indagatrice. Perché questa scrittura è alimentata da una lingua che proviene da ogni luogo dell’intelletto: cognitivo, esistenziale, descrittivo, lirico, percettivo e ogni altra modalità in cui il senso multiforme disegna il mondo interno e il mondo esterno.
L’esperienza della parola che parte dall’interiorità si spinge a fondo nell’intimità e da lì esce per generare un’emozione in grado, se non di trovare, almeno di cercare una comprensione che sleghi ciò che appare indifferenziato, che faccia risalire il sommerso, che ricongiunga le origini, ma senza le semplificazioni dell’ordinario particolarismo che avvolge la realtà. E l’elemento cardine (insieme alla luce), andamento di questa raccolta e suo fondamento, è l’acqua. Non semplicemente una metafora esemplificativa di uno studio poetico, ma una cosa che agisce nel reale, mobilita memoria ancestrale nell’ universo molteplice e singolare, diffonde percezioni e prospettive, unifica mantenendo illimitate le distinzioni segniche che parlano nel vero, rivelato in “una forma elicoidale/.../chiamata ascolto o linguaggio”.
Ed è lì, nell’origine liquida della nostra nascita, che la parola concentra in sé le potenzialità fisiche che la fanno essere sonorità, voce, sollecitazione uditiva e scrittura: gesto e propagazione cognitiva. Sono i “versetti non verbali” che caratterizzano la lingua embrionale come vera e iniziale respirazione poetica; sono le lacrime e gli sguardi originari che proiettano il movimento pensante (non ancora pensiero) verso l’aperto; è lo stupore da cui non si può prescindere se si vuole imprimere immaginazione, ma anche sconcerto, nel vedere come e in cosa “si mostra la natura”. Che è un traboccamento, un’uscita, un’immissione che non si possono rifiutare se si vuole veramente tracciare “un atto di senso” su ciò che vediamo, pensiamo, tocchiamo.
Ciò però non significa un’esposizione neutra o assillante, ma portare con discrezione, e allo stesso tempo con fermezza, luce sulle cose del mondo, avendo consapevolezza anche di sottrarsi e non lasciare che un destino ineluttabile viva per noi. L’autrice ci dice, in modo
perentorio, “vivi nascosto”, come fonte di saggezza: la stessa che ci lega alla lentezza del percorso naturale della chimica del carbonio. Una natura che per fare nasconde i suoi procedimenti, così come la parola crea il suo nascondimento per completare il senso: che è sempre non finito, che evolve involvendosi continuamente fino a quell’enorme poco che è “la temperatura del punto di rugiada”. Lì dove la scrittura emozionale sporge dall’ombra e compone, anche in una sola lacrima, il suo significato. Ma questo vuol dire spostare il dire verso una forma di lirica senza lirismo, lucida, straordinariamente precisa “sul confine...di una visione niente affatto intangibile”. Una fisicità, dunque, che la voce cattura nella percezione sensibile di un’onda di sguardi che dilatano il proprio sentire. Giorgio Bonacini.
Biografia di Alessandra Greco
Gabriele Gabbia, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
pdf del testo
Versi dell'assenza
Già con i primi due versi, Gabriele Gabbia pone esplicitamente il tema della sua poesia intitolata “( - presenza? | mancata figura | non perde…)”: per lui “l’assenza” “si manifesta tardiva”.
Il manifestarsi di un’assenza appare evento ambivalente, poiché una mancanza potrebbe sembrare qualcosa di non mostrabile.
Tuttavia, nella vita di tutti i giorni, spesso pronunciamo la parola “assenza”.
Poco soddisfatto dell’uso idiomatico quotidiano, il poeta pare concentrarsi su una circostanza che assume l’aspetto di un esserci per cancellazione la cui presenza appare soltanto nel linguaggio.
Così
“Di quel che non è
potuto essere
non si può dire”
è sequenza che nell’illuminare un tratto enigmatico, si chiude, almeno in apparenza, sull’enigma stesso.
Pare quasi mancare il respiro in simile asserzione attorno alla quale ruota l’intero componimento.
Quella chiusura verbale, nondimeno, è, a ben vedere, in grado di aprirsi in maniera anche ampia per via di un’insistenza esistenziale che la accompagna.
Accanto a quei versi avvertiamo una personalità poetica assidua, partecipe, forse non disperata ma, di certo, preoccupata.
Ciò che non fu e non è in qualche modo c’è?
Dire qualcosa che non esiste può far venire alla luce tale qualcosa?
La negazione e l’assenza, che indubbiamente sono presenti nel linguaggio, lo sono anche nel mondo reale?
Ecco l’immensa apertura, poetica quanto filosofica, che Gabriele offre al lettore mostrando come una breve versificazione possa contenere un intero universo.
E mostrando, anche, di fronte all’enigma, una fiducia espressiva davvero coinvolgente. Marco Furia
Gabriele Gabbia è nato nel 1981 a Brescia, città in cui vive e lavora. È diplomato in discipline artistiche. Sue poesie sono apparse su riviste cartacee, antologie di premi, blog, websites.
Nel 2011 ha pubblicato la silloge La terra franata dei nomi (edizioni L’arcolaio), con prefazione di Mauro Germani, segnalata alla XXVI edizione del Premio di poesia Lorenzo Montano.
Silvia Comoglio, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
pdf del testo
La luce profumata dell'aria
“Quel che venne nel sonno e nella luce”, di Silvia Comoglio, è un’elegante sequenza di versi la cui compostezza non va a scapito di una vivacità linguistica a tratti quasi esuberante.
Ampliando il ritmo, Silvia concede alla luce profumata dell’aria di entrare nelle sue stanze: così, assieme a bagliori e aromi entrano ed emergono immagini, sogni, ricordi, per via di una forma poetica molto attenta e sicura di sé.
Si nota una leggerezza diffusa, un comporre versi che è anche un concedersi ai versi medesimi.
La poetessa crea sequenze di parole e, nello stesso tempo, simili sequenze creano lei, ossia la modificano, le suggeriscono i passaggi seguenti, in qualche modo le parlano, instaurando un fecondo rapporto.
Raffinata e risoluta, Silvia sa che non deve dimenticare di procedere lungo un arduo cammino, tuttavia la preoccupazione del fare poesia riesce a sciogliersi in un gesto poetico i cui esiti consistono in toni d’intensa leggerezza esistenziale.
Così, ad esempio, quell’ ”addio che sgela” appare commiato definitivo in grado di lasciare dietro di sé un non sterile liquefarsi che sa di possibilità, di ulteriore, non arida, contingenza.
L’amore, poi, incontra l’ostacolo di un rispecchiamento tendente a confondersi con il suo stesso esserci:
“in tenue e duro amore: la voce immobile di specchio semplice e risolta
in bocche a stento decifrate e appese alla tua porta”.
L’amore, dunque, è “tenue” eppure “duro”, la “voce” è “immobile” ma è pur sempre tale e le “bocche”, anche se a stento, sono “decifrate”.
In questa simultanea presenza di fisionomie contrastanti cogliamo aspetti non certo sereni del vivere: nondimeno una poetica atmosfera precisa, limpida, permette alla luce e all’aria di entrare, fecondando, assieme al mondo della poetessa, anche il nostro. Marco Furia
Biografia di Silvia Comoglio
Vincenzo Guarracino, saggio breve inedito, premessa di Mara Cini
L’attualità di Leopardi pensatore è nuovamente rimarcata dalla densa prosa di Vincenzo Guarracino (minimo assaggio degli studi leopardiani dell’autore). Del resto è facile riconoscere ancora il nostro paese in un “paese senza” nel progressivo crepuscolo di ogni illusione e grandezza.
Ma in Sopra i costumi degl’italiani Guarracino individua anche un “lievito diverso”, la necessità , l’urgenza di una “nuova scienza dell’uomo” in un contesto etico-sociale più aperto e consapevole. Mara Cini
Il tempo del nord
RILEGGENDO IL DISCORSO LEOPARDIANO “SOPRA I COSTUMI DEGL’ITALIANI”
Gli Italiani, qualunque sia la classe di appartenenza, alle “classi superiori” non meno che al “popolaccio”, sono oggi i più cinici del mondo: "ridono della vita: ne ridono assai più, e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fa niun’altra nazione".
Privi di amor proprio e di orgoglio nazionale, "passano il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi fino al sangue", presi a combattersi l’un l’altro, in una sorta di bellum omnium contra omnes: questo perché ognuno, trincerato nel suo individualismo, per non essere travolto e oppresso, deve imparare a difendersi e combattere.
Cinismo, disprezzo, indifferenza, superficialità, inettitudine, dissimulazione: qualità, queste ed altre, da “paese senza”, non di un popolo che voglia essere “nazione” o “patria”, conseguenze della mancanza di una "società stretta", di “un commercio più intimo degl’individui fra loro” e della carenza di ogni spinta ideale e di un’etica civile capace di legare l’individuo alla collettività, sottraendolo al rischio della “misantropia” e alla coltivazione del suo “pestifero” particulare di guicciardiniana memoria.
È Leopardi a dire questo ed è bene non sottovalutarlo: tanto più sapendo che proprio nel ‘24, l’anno del Discorso sopra i costumi degl’Italiani (“acutissimo, tumultuoso e spesso paradossale”, l’ha definito Walter Binni), da cui il giudizio è estrapolato, è immerso, da “Eremita degli Appennini”, tra Operette morali e Zibaldone, nel perseguimento di una sua essenziale battaglia di verità, condotta per via fantastica e insieme riflessiva; e che il deserto e la “ruina immensa” del mondo circostante, la vita come desolante “serraglio di disperati” (come lo definirà nel Frammento sul suicidio, 1832), si applica eroicamente ad esplorarli ed esorcizzarli attraverso una scrittura, di volta in volta analitica ed appassionata, gelida e tagliente ma anche calda ed effusiva, incurante di abbellimenti e “cerimonie”, per corrispondere solo ai moti del “sentimento”.
Una battaglia di “verità”, un impegno di “civiltà”, per un “risorgimento” dalla “barbarie”, per contrastare “ragione geometrica”, “cinismo”, “strage delle illusioni”, con le armi di una corrosiva lucidità: davvero un “angelo” dalla spada sguainata, il Leopardi del Discorso, “chiuso nella sua corazza” di intelligenza, come lo vedrà Walter Benjamin in una celebre pagina sui Pensieri.
Attraverso una diagnosi impietosa, condotta con "la libertà e sincerità con cui ne potrebbe scrivere uno straniero", “senz’animosità” e al tempo stesso appassionata: costruttivo, insomma, sorretto dall’ansia di “ravvivare” quell’essenziale “amore verso la patria”, da cui hanno principio “probità e nobiltà” di un popolo degno di questo nome, come dichiara nella Prefazione alle Dieci Canzoni dello stesso anno: una cosa nuova e imprevedibile rispetto a ciò che emergeva da tanti testi in prosa e in versi degli anni precedenti, governati da uno sdegno tra patetico e velleitario dinanzi al “secol di fango” e alla “mediocrità” dei contemporanei, a testimonianza della mobilità dell’orizzonte teorico e morale, tutto in progress, “al presente”, dello scrittore.
Lucido e impietoso, disincantato, il ritratto che ne emerge degli Italiani, nel progressivo crepuscolo di ogni illusione e grandezza, con sullo sfondo le “altre nazioni” europee con “più vita” e con “più società” rispetto all’Italia, istituendo con esse una sorta di confronto-scontro antropologico.
Lucidamente polemico, ma non da non lasciare intravedere dietro la diagnosi dura e spassionata, assieme a una nostalgia di verginità, un lievito diverso, una sollecitudine drammaticamente moderna per la “patria infelice”, proprio mentre si sofferma sgomento di fronte alla “strage delle illusioni”, destinata a riecheggiare lividamente nel “silenzio nudo” del coevo Cantico del gallo silvestre, metafora assoluta dell’”arcano mirabile e spaventoso” dell’esistenza ma anche emblema del deserto morale e culturale dell’Italia.
Un deserto senza consolazione, un “secol morto”, un “secol di fango” oppresso da una greve “nebbia di tedio”, da inguaribile “mediocrità” (Ad Angelo Mai, 1820), davvero: di questa Italia forse davvero è meglio “ridersi” come fanno gl’Italiani, senza bisogno di addentrarsi oltre nell’esegesi leopardiana.
A meno di non soffermarsi su un punto, conclusivo ma non marginale, del Discorso.
Mi riferisco al passaggio dove l’anomalia dell’Italia rispetto ad altri paesi, quelli virtuosi della “rinata civiltà” (Inghilterra e Germania), viene segnalata in termini che rivelano una loro intrigante attualità.
Oggi, dice, “sembra che il tempo del settentrione sia venuto”: come sottrarsi a una sensazione nuova di fronte a questo fantasma della “modernità”, che da qui aleggia e si protende sulla storia, disegnando una sorta di diagramma dell’ineluttabile marcia della civiltà dal Meridione ai paesi del nord dell’Europa, come in una sorta di materialismo dialettico, in nome della “superiorità della loro immaginazione”?
C’è un che di oggettivo e insieme di profetico in questa affermazione. Il rilievo assegnato a un Nord “civile” che sopravanza gli altri paesi, con l’Italia confinata nel confronto in condizioni di oggettiva inferiorità civile non meno che culturale, è l’elevazione del tema della “modernità” a dato necessario oltre ogni negatività.
È in questo che risiede la vera novità, la parte teoricamente più originale del Discorso e l’attualità di questo Leopardi: nella scommessa sulla “modernità”, un fatto che ha i tratti della necessità di una nuova eticità, di una nuova “scienza dell’uomo”, intesa come nuovo modo di porsi di fronte alla vita con la consapevolezza della piccolezza e finitudine umana e insieme l’esigenza di un modo diverso di stare insieme con gli altri esseri, che sembra essere prerogativa dei popoli giovani del Nord che posseggono quanto è necessario per inaugurare una “rigenerazione” civile e morale (“le virtù, le illusioni, l’entusiasmo, in somma la natura”, Zib. 115).
Oltre “la strage delle illusioni”, oltre il riso illividito di Bruto (un “ridere” per esorcizzare rovine e l’”infinita vanità del tutto”), Leopardi si protende, già “erta la fronte” e “renitente al fato”, nel presagio di nuove consapevolezze ed urgenze sentimentali ed etiche.
Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, è nato a Ceraso (SA) nel 1948 e vive a Como.
Ha pubblicato, in poesia, le raccolte Gli gnomi del verso (ER, Como 1979), Dieci inverni (Book Editore, Castel Maggiore, 1989), Grilli e spilli (Fiori di Torchio, Seregno, 1998), Una visione elementare (Alla Chiara Fonte,Viganello, Svizzera, 2005); Nel nome del Padre (Alla Chiara fonte, Viganello, Svizzera, 2008); Baladas (in lingua spagnola, Signum, Bollate, Mi, 2007); Ballate di attese e di nulla (Alla Chiara fonte, Viganello, Svizzera, 2010).
In prosa, ha pubblicato L’Angelo e il Tempo. Appunti sui dipinti della chiesa di Ceraso, Sa (Myself, Como 1987).
Per la saggistica, ha pubblicato Guida alla lettura di Verga (Oscar Mondadori, Milano 1986), Guida alla lettura di Leopardi (Oscar Mondadori, Milano 1987 e 1998) e inoltre presso Bompiani, Milano, le edizioni critiche di opere di Giovanni Verga (I Malavoglia, 1989, Mastro-don Gesualdo, 1990, Novelle, 1991) e di Giacomo Leopardi (Diario del primo amore e altre prose autobiografiche, 1998). Per Book Editore (Castelmaggiore, Bo) ha pubblicato l’antologia Leopardi, 1991, e l’edizione dell’autografo comasco dell’Appressamento della morte, 1993 e 1998. Ha inoltre curato il carteggio Leopardi-Ranieri (Addio, anima mia, Aisthesis, Milano 2003), il romanzo di Antonio Ranieri, Ginevra o l’orfana della Nunziata (Aragno, Torino-Milano 2006).
Presso le edizioni della Vita Felice, Milano, ha pubblicato le novelle milanesi di Verga Per le vie, 2008, Libro delle preghiere muliebri di Vittorio Imbriani (2009) e Amori di Carlo Dossi (2010).
Per l’Editore Guida (Napoli) ha pubblicato Lario d’arte e di poesia. In gita al lago di Como in compagnia di artisti e scrittori (2010).
Per la Fondazione Zanetto (Montichiari, BS, 2010), ha pubblicato una biografia di Antonio Ranieri, Un nome venerato e caro. La vera storia di Antonio Ranieri oltre il mito del sodalizio con Leopardi.
Ha curato le traduzioni dei Lirici greci (Bompiani, Milano 1991; nuova edizione 2009), dei Poeti latini (Bompiani, Milano 1993), dei Carmi di Catullo (Bompiani, Milano 1986 e Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005), dei Versi aurei di Pitagora (Bagatt, Bergamo 1988; Medusa, Milano 2005), dei versi latini di A.Rimbaud, Tu vates eris (Bagatt, Bergamo 1988), dei Canti Spirituali di Ildegarda di Bingen (Demetra, Bussolengo, VE, 1996) e del Poema sulla Natura di Parmenide (Medusa, Milano 2006).
Ha curato inoltre le antologie Infinito Leopardi (testi di poeti contemporanei, Aisthesis, Milano 1999), Il verso all’infinito. L’idillio leopardiano e i poeti italiani alla fine del Millennio (Marsilio, Venezia 1999), Interminati spazi sovrumani silenzi. Un infinito commento: critici, filosofi e scrittori alla ricerca dell’Infinito di Leopardi (Stamperia dell’Arancio, Grottammare, AP, 2001), l’antologia Caro Giacomo. Poeti e Pittori per Giacomo Leopardi (Edizioni di Cronache Cilentane, Acciaroli, Sa, 1998) e Giacomo Leopardi. Canti e Pensieri, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005.
Recentemente, una antologia da lui curata della poesia leopardiana, tradotta in spagnolo da Ana Marìa Pinedo Lòpez, El infinito y otros cantos, è stata pubblicata in Italia da LietoColle (Faloppio, 2009) e in Spagna dall’Editore Pigmalion di Madrid (2011). Sempre presso lo stesso Pigmalion di Madrid è uscita l’antologia Giovanni Pascoli. Poesia esencial (Madrid 2012) con traduzione di Ana Marìa Pinedo Lòpez.
Ha curato le antologie Poeti a Como DialogoLibri, Olgiate Comasco 2002) e L’AltroLario (Editoriale Como, Como 2004) e inoltre Ditelo con i fiori. Poeti e poesie nei giardini dell’anima (Zanetto Editore, Montichiari, Bs, 2004) e Parliamo dei fiori (ibidem, 2005).
Ha curato per Book Editore (Ferrara 1995) l’antologia delle poesie di Roberto Sanesi L’incendio di Milano e per La Vita Felice (Milano 2009) Dieci poemetti dello stesso autore. Nel 2010 ha curato l’antologia delle poesie dell’artista Agostino Bonalumi, Alter Ego (Ferrarin Incontri d’Arte, Legnago, VE).
Per la critica d’arte, si è occupato dell’opera, tra gli altri, di Luca Crippa (Castelli di carta. Tra disegni, collages e polimaterici di Luca Crippa, 2002), di Giorgio Larocchi (Sulle tracce di un “disegno perduto”. Giorgio Larocchi pittore, 2007) e di Mario Benedetti (In un regno notturno e labirintico, 2008).
È inoltre autore di una monografia sul regista e drammaturgo Bernardo Malacrida (Il teatro tra passione e missione, 2008) e della biografia di Antonio Ranieri (Zanetto Ed. Montichiari, Bs, 2009).
Nel campo dell’editoria scolastica, ha curato l’antologia latina per i bienni delle Scuole Superiori Giorni e sogni latini (Ediermes, Milano 1994, poi Zanichelli 2000), e, assieme a L. e M.T. Sciolla e a F.Stella, la storia della Letteratura Latina Litterae (Minerva Italica, Milano 1996) e l’edizione commentata dei Carmi di Catullo (Signorelli, Milano 2006). Ha pubblicato per l’Editore Signorelli (2005) un’antologia dei Carmina di Catullo.
È stato responsabile della collana dei Classici Tascabili dell’Editore Bompiani. È Presidente del Comitato comasco della Società Dante Alighieri. Collabora, come critico letterario e d’arte, a quotidiani e periodici.
Maria Grazia Calandrone, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
pdf del testo
Creatività e creazione
“dal paesaggio”, di Maria Grazia Calandrone, è intenso componimento che sembra trattare della creazione del mondo.
Una creazione non remota, bensì presente, continua.
Il lettore è coinvolto in un fitto susseguirsi d’immagini che presentano un divenire inarrestabile, privo di soluzione di continuità.
Il mondo, per Maria Grazia, fu ed è creato nello stesso tempo.
Forse, guardando in direzione del mare, potremmo scorgere l’Arca di Noè ancora in navigazione e, forse, certi episodi biblici si stanno ancora verificando.
Non siamo dinanzi a un gioco di gusto surrealista, bensì a un vivido sguardo sulle origini intese quali energie che continuamente si rinnovano.
La cronologia perde importanza quando ci si rivolge al fenomeno dell’esistere puntando a renderne evidente l’intima natura.
Siamo, sempre, le nostre stesse origini?
Sembra, a prima vista, che la risposta della poetessa a simile quesito sia positiva.
Dico “sembra a prima vista”, perché il sincero atteggiamento dell’autrice non è assoluto e, pur gettando luce su certi aspetti, non intende eliminare tutto il resto.
Il trascorrere del tempo è presente, ad esempio, quando vengono proposti precisi riferimenti alla storia sacra e, in ogni modo, non appare estraneo alla stessa sequenza di nove brevi sezioni ciascuna contraddistinta dal proprio titolo.
È presente, poi, una pronuncia davvero chiara:
“chi entra in possesso di un oggetto eversivo come la parola non può limitarsi a usufruire della sua mera funzionalità”.
Pronuncia che non si può non considerare specifica dichiarazione in cui la “mera funzionalità” del linguaggio è ritenuta insoddisfacente, non sempre adatta alla bisogna, inadeguata.
Talvolta occorre allontanarsi dagli usi idiomatici consueti, come “dal paesaggio” insegna. Marco Furia
Biografia di Maria Grazia Calandrone
Paolo Ferrari, una prosa inedita, premessa di Mara Cini
Dietro ogni incedere, ogni passo, ogni cammino, c’è una geometria nascosta (a volte oscura).
Dietro ogni segno, ogni scrittura e riscrittura esiste il canovaccio “scientifico” del tempo, il suo disegno, tra strappi del corpo e cuciture della mente.
Dietro ogni oggetto, ogni porta ed ogni pietra esiste una tensione creata dalla presenza / partenza / assenza del “guardante”.
Libri sacri, strumenti musicali, partiture ma anche selciati, siepi e muri sono i supporti di sequenze di memoria, passaggi, indizi di un inciampo. Ora incendio. Ora polvere. Mara Cini
Memorie d’inciampo
Pietre d’inciampo nei luoghi dove sono stati deportati gli uomini per motivi politici o razziali
Le pietre d’inciampo sono un’operazione artistica di Gunter Demnig in memoria di cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. L’installazione in progress è partita da Colonia nel 1995; nell’anno 2010 già erano state installate 22000 pietre d’inciampo. La memoria consiste in una piccola targa d’ottone dalle dimensioni di un sanpietrino installato davanti alla porta della casa di un deportato. Su di essa sono incisi il nome delle persone deportate, l’anno di nascita, la data e il nome del luogo di deportazione e la data di morte.
II Memoria d’inciampo
La scrittura è simile a una partitura; in essa esiste lo svolgimento del tempo. Ma tale proprietà non vale per l’opera artistica, dice Giovanni di Puria. La scrittura, afferma Joseph, porta alla riscrittura del Giorno del Giudizio.
Oscurato
il potere delle chiavi.
La zanna governa
dai resti del cretaceo
contro l’attimo
mondiale.
(Celan)
Biografia di Paolo Ferrari
Roberto Fassina, una poesia inedita, nota critica di Marco Furia
Fiat lux
Un tempo che il tempo non era
nell’ àtra assenza
tra macerie di minuti secondi
dall’ombra più fonda del fondo
sussurro del Verbo
alito quantico
gratuita-mente atomi primigeni
nel grembo atonale del Multiverso
perfettissimo Nulla
(…buio da buio
voce da voce
salmo cla-mante
generato et non creato
in folgore picta
misterio pregno)
sine materia sine quid
gettati
nella luce dell’essere
dispnoici perduti piccoli dei
vocis flatus relictae
blandule anime in cerca di senso
sfiatano
nere trachee
(…fragili
aporie di carbonio
in funzione d’onda)
Poetici confini
“Fiat lux”, di Roberto Fassina, è un articolato componimento in cui lucide pronunce si alternano a tratti capaci di ampliare il respiro poetico secondo cadenze esistenziali poco soggettive, tuttavia non prive di efficacia.
Espressioni come
“(buio da buio
voce da voce …”
e
(…fragili
aporie di carbonio
in funzione d’onda”)
mostrano la vivida presenza di un desiderio di dire che riesce a farsi parola poetica ben poco concedendo a propensioni psicologiche.
Siamo al cospetto di una persistenza emotiva proiettata in un àmbito in cui il sentimento e l’affettività, pur non venendo meno, hanno imboccato la via di un’umana esistenza intesa quale vero e proprio cosmo scarsamente introspettivo.
L’atteggiamento del Nostro non permette altro sbocco?
Difficile a dirsi, nondimeno viene da pensare che una sorta di necessaria coerenza sia avvertita in maniera così intensa da divenire intima cifra della poesia in esame.
Una poesia vigile che, pur non lasciandosi andare, è ben consapevole di dover rendere testimonianza anche della dimensione emotiva se intende dar valore a una lucidità altrimenti a rischio di apparire sterile.
Ecco, allora, l’uso della parentesi, quasi a distinguere, a segnare linee di frontiera.
Ma i confini in poesia, si sa, sono nello stesso tempo nitidi e labili, continui e frammentati.
D’altronde i componimenti poetici sono, per loro natura
“gettati
nella luce dell’essere”. Marco Furia
Roberto Fassina è nato a Curtarolo (Padova) il 18/12/50. Dopo la maturità classica, conseguita nel 1968 presso il Collegio Salesiano Manfredini di Este, si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, dove si è laureato nel 1975 e poi specializzato in Ginecologia nel 1979. Dal 1979 vive e lavora a Curtarolo come Medico di Famiglia.
Nel 1991 ha pubblicato “Nihilissimo Canto” (poesia) per i tipi delle Edizioni del Leone di Venezia. In quel periodo ha collaborato con poesie e racconti nella rivista milanese ‘Alla Bottega’.
Nel 1998 ha pubblicato il romanzo “Equazione Ultima”per i tipi delle Edizioni Amadeus di Treviso.
Nel 2003 ha pubblicato la silloge poetica “pesca sabèa” con la casa editrice ‘all’antico mercato saraceno’, di Treviso.
Nel 2011 ha pubblicato, sempre con la casa editrice “all’antico mercato saraceno” di Treviso, la raccolta di poesie “tangheide-lapsus in fabula”.
Sue poesie sono presenti in varie antologie poetiche.
Suoi testi teatrali satirici, aventi per oggetto il mondo medico, sono stati rappresentati a Piove di Sacco e a Padova, nel 2005 e nel 2006 e nel 2007 e nel 2012.
Scrive saggi e note critiche nella pagina culturale del Bollettino dell’Ordine dei Medici di Padova.
Andrea Guiducci, saggio breve inedito, premessa di Mara Cini
Documento (pdf del testo)
La puntuale analisi del racconto di Kafka Das Urteil lascia poco spazio ad ulteriori sovrascritture di presentazione. Sarebbe davvero pretestuoso incidere oltre su questo testo che impone invece di rileggere la storia di George Bendemann e da lì, da Kafka, ripartire per eventuali riflessioni.
E’ questo l’esempio di come al concorso Lorenzo Montano per la prosa ci si trovi di fronte a testi molto diversi tra loro: prosa poetica, frammenti di diario o di racconto, embrioni di saggio o, come nel caso di Andrea Guiducci, una compiuta analisi letteraria che sembra giustamente respingere per la sua propria configurazione inutili “commenti”. Mara Cini
Biografia di Andrea Guiducci
Sandro Varagnolo, da una raccolta inedita, nota critica di Giorgio Bonacini
https://www.anteremedizioni.it/memoriale_della_pietà per una selezione di testi e nota biografica di Sandro Varagnolo
Una lingua che riversa in poesia e non altrove o in altro modo le sue sonorità cariche di vibrazioni e riverberi inquieti, e portatrice di una qualità di senso febbrile (per usare un efficace e centrale termine dell’autore), ma nello stesso tempo una lingua sottratta a un uso estraneo a ciò che il dire poetico si prefigge, cioè senza stenti banalmente comunicativi, è una lingua che non può, allora, non “sovvertire i discorsi”. E lo fa con una naturalità interna che, pur nella trasformazione e nel rivolgimento a cui dà luogo nel suo percorso indicativo, riesce ad agganciare il reale, screpolandone la scorza e mettendone in forse le certezze e le virtù credute tali.
La raccolta poetica mette in atto un sommovimento interno alla parola, tale da aprire con fermezza all’esterno, senza però abbracciare nessuna verità (che in quanto tale e ingenuamente pensata essenziale, si presenterebbe come dogmatica), ma che “nell’ambiguità degli strumenti e delle alternative” cerca lucidamente, ma anche emotivamente, il suo pensiero. La parola scritta di Varagnolo sembra non avere mai un attimo di pace, ma è sempre armonicamente in tensione; mai dileguata, mai abbandonata a momenti che non siano sempre accoglimento di una civiltà della poesia, necessaria affinché la voce divenga esperienza della lingua e del suo dire. E la scrittura possa aderire alla vita senza confondersi, ma restare accanto, esplorare, perdersi anche, e congetturare e indignarsi. E se anche la poesia prende avvio da una conoscenza che strapiomba dall’oscurità, e non sempre il sapere a cui conduce è riconoscibile come tale, ma sembra sfuggente o dirottato su sentieri inesplorati e dunque di difficile interpretazione, ebbene anche lì, anche nell’ “imminenza della catastrofe” il fare poetico riesce ad agganciare la perseveranza di un nome o l’eco in lontananza di una memoria o l’inizio apparente di un labirinto di percezioni allusive. E’ allora che dall’affanno si scatena una scintilla che apre all’interrogazione e alla reinvenzione del reale e del vero, demolendo man mano “l’impostura del senso” univoco e compiuto. Per l’autore, ciò che è imprescindibile e che deve essere proprio della poesia è il non dare tregua e continuamente sondare l’inesauribile sentimento pensante che all’essere umano viene dall’ ”infinita cecità della vita”. E nonostante questa ferita, questo dolente sentire, bisogna continuare a perlustrare anche là dove ciò che resta sembra ineffabile, effimero, usurato.“La lingua imprigionata si dissipa”, dice Varagnolo, con ferma consapevolezza che si deve mantenere il dire nel vivo corpo di una musica scritta, che interpreta il mondo e a lui si rivolge opponendosi e cambiandolo.
In questa raccolta sembra porsi con urgenza il tentativo di ricomporre sapienza e saggezza, perché la poesia non si perda e non dimentichi se stessa in qualche recesso sottratto all’ascolto. Ecco allora che il senso si presenta con le sue modalità e pulsioni estetiche ed etiche, nessuna disgiunta dall’altra. E non sono secondarie le citazioni che introducono le parti della raccolta: Dante per il riconoscimento che si deve a un maestro di poesia; Eliot per il dolore prefigurato dall’evocazione; Stevens per la conoscenza percepibile che viene dal pensiero. Pilastri che sostengono il canto, che dal canto sono richiamati e insieme a questo vivono. Giorgio Bonacini
Ultima Pagina: omaggio a Pierre Garnier (1928-2014)

Pierre Garnier (Amiens 1928 - Saisseval, 2014)
Dopo aver studiato in Francia e Germania a cavallo della guerra, esordì in poesia nella scuola di Rochefort con Jean Rousselot . Successivamente entrò nelle Editions André Silvaire che diventeranno, con la rivista Le Lettere, la spina dorsale della poesia spaziale, movimento da lui fondato con la moglie Ilse Garnier . Lo spazialismo in breve diventò internazionale con ramificazioni in Stati Uniti, Germania e Giappone.
Opere principali: Spatialisme et poésie concrète (Gallimard, 1968), L'Immaculée conception (litanie) (En Forêt/Verlag Im Wald, 2001), Une Chronique de la nature civilisée (Éd. des Vanneaux, 2009).
Aprile 2014, anno XI, numero 23

In questo numero presentiamo alcuni poeti segnalati per “Opera edita” nell’edizione 2013 del Premio Lorenzo Montano: Alessandra Carnaroli, Romano Morelli, Anna Maria Farabbi, Adelio Fusé, Alessandra Paganardi, Lucetta Frisa, Beppe Ratti. A distanza di tempo dalla loro pubblicazione.
A distanza di tempo, rimane attiva la possibilità di riscoprire o di mantenere ancora viva l’attenzione su libri importanti. Tutto questo si inserisce in maniera naturale nella costante opera di affermazione della poesia che il “Montano” svolge ininterrottamente da 28 anni.
Per continuare ad alimentare questa storia, per rendere ancora più ricca questa geografia letteraria, ricordiamo a tutti i poeti, saggisti e prosatori che il termine ultimo per inviare i lavori alla 28^edizione scade il 15 aprile 2014.
scarica il bando della 28^ edizione
In copertina: fotogramma dal video “Lettere incompiute” di Camillo Valle.
Alessandra Carnaroli, Femminimondo, Edizioni Polìmata 2011
La violenza degli uomini sulle donne, è questa quella che viene di volta in volta definita in gergo politico-istituzionale “violenza di genere”, “violenza sessuale”, “violenza (di chi?) contro le donne”. Non solo una questione di lessico. E’ la sentenza di scomparsa del soggetto che offende e del perché offende. Infatti fatalmente perdendosi la definizione chiara del delitto “violenza degli uomini sulle donne” si opera quella mutazione per la quale la rappresentazione del discredito finisce per soffermarsi sulla presunta incapacità delle donne a salvaguardarsi. (...)
Stefania Cantatore, dalla nota che accompagna il volume
(...) Una sussultante Spoon River sfiammante breve, fitto di putrefazioni e ancora urlante il suo dolore, è quel che erge il suo canto sulle coste di questo mare di terra. Sepolcreto della carne incendiata per sacrifici alieni e incomprensibili, altare sanguinante proteso verso il nulla; ed è, lo stesso alieno, lo stesso incomprensibile, la stessa calamita del nulla, che si accalcano da ogni angolo e da ogni cronaca sui lembi che abitiamo, che ci abitano, a togliere senso e respiro. (...)
Tommaso Ottonieri, dalla nota che accompagna il volume
Per un recente approfondimento teorico di Stefano Guglielmin:
http://golfedombre.blogspot.it/2014/03/alessandra-carnaroli.html
da “Sfilate” (I fatti a sinistra, le colpe a destra, le donne nel mezzo)
Alessandra Carnaroli (1979) ha inoltre pubblicato “Taglio intimo”, Fara 2001 e “Scartata”, finalista Premio Delfini 2005.
Romano Morelli, Questo essere, Mimesis 2013
L’essere umano è essenzialmente un essere interrogante.
Sa di non sapere; non può non sentire attorno a sé il Mistero che si aggira irrequieto, non può non chiedere ragione della propria morte. Dunque vuole, deve sapere. Pascalianamente, ciò lo rende la creatura più miseramente grande. (...)
Non c’è quindi né verità né risposte, solo un cercare.
Ma, mentre inevitabilmente, “naturalmente”, si interroga, l’essere umano vive, cioè si consuma, cioè subisce il tempo, anche sotto forma di Storia – il tempo collettivo che collide con quello biografico, lo stritola e dilania – e alla fine muore: la poesia è la forma linguistica più appropriata, raffinata, più pienamente umana per esprimere questo replicarsi eroico di uno sforzo che si frange ogni volta contro l’eterno Zeitnot dell’interrogare, che ogni volta si piega sfinito sotto l’inesauribile inadeguatezza del linguaggio.
dalla Premessa dell’Autore
da Poesie 1995-2010
1
Solo qui mi piace, solo
ora, solo così.
Solo: ritto sul bordo del vuoto abisso, fiero
e sconfitto,
nella notte fradicia a fissare la morte che mugghia e chiama
di sotto,
e stùpido
sfidare il fitto silenzio eterno –sopra-,
che ghiaccia e striscia nel buio.
Né traslocare nelle Utopie
né chinare pavido il muso:
ma
qui, inchiodato, a parlare di spettri.
3
Canto quindi l’Essere
che si sottrae, l’ineludibile richiamo,
la vocazione mortale dell’Altrove –
metastasi dell’incubo
che ci perseguita e vuole
vittime tante e
sempre nuove –
e che ci rode, ci spinge
lontano da oggi, da qui, da noi.
Questa nostra Chimera canto,
questo sogno, questo mostro
duro,
questa menzogna grande
che ci fa pellegrini senza dio,
questa rogna
che ci mangia
7
Adora pure l’icona di chi è passato
in quel solito estremo rifiuto
del tempo tenace;
puoi farne un altare
ma sappi che comunque passa e cancella
ma vero è che contro il tuo andare testardo
mai il risultato
Dove hai creduto di abitare
eri solo ospite.
Romano Morelli è nato a Liegi nel 1953. Vive e lavora a Padova.
Anna Maria Farabbi, Abse, Il Ponte del Sale 2013
(...) Abse è il nulla; la stupefazione di ciò che è inesprimibile fino all’ammutolimento e, per questo, sancisce l’impossibilità di una minuziosa, totalizzante, descrizione e spiegazione. Dichiara una volta per tutte la negazione del dire fino in fondo; significa limite insuperabile; (...)
da una nota dell’Autrice
Trama
ho attraversato l’abse, il nulla
nel nulla ho trovato un paese
nel paese sono entrata
attraversando questi nodi pubblici:
la prima porta
la bottega dell’acqua
l’osteria del buio rosso
la piazza
la scuola
la biblioteca
l’ostia
l’asilo
l’ospizio femminile
il cimitero
ho infilato ogni filo creaturale nella mia cruna interiore
nascendo questo poema
io viaggio e canto
portando ovunque comunque
l’io profondo nel mio corpo che è la mia casa
La carovana di sale
preistoria del poema
link
Esco dal paese. Credo sia inverno perché nevica. Il cielo è bassissimo. Ha una densità perlacea che si sfalda in petali ghiacciati, toccandomi. Il freddo imbianca il sangue e il bianco si vede dentro il mio corpo, nella vastità della notte che è nel mio corpo.
Mi siedo su una pietra di confine. Apro la matrioska che Paola Febbraro mi ha regalato prima di morire, la sfoglio come una cipolla cosmica e mi sembra di piangere. Ha le stesse qualità della conchiglia: diffonde onde sonore.
Penso alla cultura orale delle campane, alle creature che si raccolgono attorno ad un batocchio e ascoltano. A coloro che, per comunicare, accendono falò in cima ai colli, ai monti, ai fari di terra tra le dune del deserto. Di popolo in popolo, di paese in paese.
Anna Maria Farabbi è nata a Perugia nel 1959. Ha pubblicato numerose opere di poesia, narrativa, teatro, saggistica e traduzioni dall’inglese e dal francese.
Adelio Fusé, L’obliqua scacchiera, Book Editore 2012
Preceduta da Il boomerang non torna, (2003), Orizzonti della clessidra distesa (2005), Canti dello specchio bifronte (2009), L’obliqua scacchiera conclude una tetralogia degli “oggetti anomali”.
È certo inconsueta una scacchiera inclinata, ed è tanto più sorprendente la posizione dei pezzi suoi “ospiti”: questi, a dispetto di una superficie di appoggio, che congiura contro di loro, non cedono allo scivolamento e rimangono ben saldi e ritti, perfettamente in equilibrio. O così appaiono, in una orgogliosa dichiarazione d’intenti e nella proiezione di una sfida, agli occhi dei giocatori. Anzi dell’unico giocatore. Il quale, unico suo malgrado, affronta anzitutto se stesso: è lui, e nessun altro, il suo proprio avversario, persino ogni avversario possibile. Alcune partite non consentono fughe.
Dalla nota redazionale
Dalla sezione “L’ora cava”
4
abito uno spigolo in linea
con il mio omonimo più distante
non un fremito di ciglia:
eppure è possibile
mi deposi in una gabbia illimitata
tempo a seguire e il sottosuolo
nell’intimo perforai
rimpiango la donna allegra
i suoi capelli baciati dalla pioggia
ma l’uomo ostentava dita lorde
le unghie difformi
quale la ragione del filo
e di un serrato tenersi?
facitore e guardiano
di rapsodici passaggi
l’enigma si rinsalda invano
22
è pur sempre un indefesso tramontare
che ammassando sottrae
alle tempie non si ammaina
né concede amnistie il pulsare:
da sé in sé s’inietta
soffio oblungo infine
suono della neve
antevita e postvita
24
è questa l’ora cava
di un finto compiuto prodiga
di ogni persistenza
ultima dissolvenza
sblindato riflesso mi attendo
ma nello specchio non s’infrange
il mio originale
Dalla sezione “La Quinta stagione”
80
elisio sfacelo di fedi
e rivalsa di sogni insopiti:
il sasso che nell’acqua non affonda
o i lombi di Venere
che dilaniando rigenerano
o là nell’oscuro la luce
che s’irradia ferma
sotto il cielo in Natura avvizzita
cartocci di foglie bistratto
ma c’è ancora sangue:
non sono asciutte le vene
della Quinta stagione
Adelio Fusé (1958) vive a Milano e lavora nell’editoria. Ha pubblicato, oltre ai libri di poesia citati in premessa, saggi su Sade, Kafka, Sartre, Handke, Eno (Materiali Sonori-Auditorium 1999) e il romanzo North Rocks (Campanotto 2001). Ha fatto parte della direzione di “Legenda” (Tranchida 1988-1995).
Alessandra Paganardi, La pazienza dell’inverno, Puntoacapo 2013
(...) Alessandra Paganardi ha naturale familiarità con il dolore della mente, con la malinconia dell’esistenza, con le virgiliane lacrimae rerum che si addensano su ogni destino, ma sente la sua poesia come arma complessa e potente di salvezza: complessa, perché riverberando il dolore nelle parole c’è la possibilità di accentuarlo, ma potente, perché trattando l’angoscia dentro la scrittura, dentro la materia di parole vive che ricordano e reinventano, la si può anche esorcizzare. Da sempre, parafrando Char, il poeta non può che fare arte di fronte alla morte.
Dalla prefazione di Marco Ercolani
Dalla sezione “Farsi altro”
La cava
È duro il salto – come questo marmo.
Bisogna flettere il calcagno freddo
alla salita, rendere le suole
alla polvere che si fa più scura
nel passo. Appiattire il respiro
alla pietra. Poi l’ultima stanza –
quell’orecchio di Dionisio svuotato
nel venerdì di Pasqua, dadi immensi
allineati come case a schiera.
Non sarà mai acqua
il fiume – è un rumore la voce
impigliata tra fango e sassi.
Ci siamo messi in fila anche noi –
rocce cave per il tempo che attende
di tagliare i ricordi, di spostarli
via dalla mente in blocco, uno su uno.
E tutto ricomincia a farsi altro.
Dalla sezione “Museo e parola”
I
C’è un horror vacui fin nelle pareti –
non amano l’assenza, non si deve mai
aspettare. Prima un po’ di brutta carta
da parati, quindi l’invasione
barbarica dei quadri.
Questi fiori sembrano tutti veri
- i seni all’erta, ripartiti in due
dal sentiero del cuore. Che la vita
mimi la vita, dove non sa andare
dritta e bella. I vasi alle finestre
paiono finti, covano l’abbraccio
osceno di una bambola di gomma
dicono un’intenzione di cemento
di stare sempre qui, di non morire.
Dalla sezione “Voci in ombra”
VII
Di quella pietra nel cemento
non è rimasta che un’impronta vuota.
La terra ha una memoria minerale
si riempie quando passa forte il vento
o il piede indelicato del passante
a scalciare la vita
allora il vuoto sente ancora il grave
un diapason che mai nessuno vede –
la cartina si tinge dietro gli occhi
se ritorna il dolore.
Alessandra Paganardi (Milano, 1963) ha pubblicato, oltre a varie plaquettes, le raccolte di poesie Tempo reale (Novi Ligure 2008), Ospite che verrai (2005), Poesie (Facchin Editore 2002).
Ha pubblicato la raccolta di saggi critici Lo sguardo dello stupore: lettura di cinque poeti contemporanei, Viennepierre edizioni 2005, finalista al Premio Nabokov 2008.
Dal 2003 è redattrice della rivista “La Mosca di Milano”.
Lucetta Frisa, L’emozione dell’aria, CFR 2012
“L’emozione dell’aria”, chiama l’autrice la musica (...)
L’autrice passa dapprima in rassegna i tempi del metronomo (adagio, allegro, presto, ecc...) e quindi la dimensione fisica temporale, il rapporto essere-tempo o, anche, le modalità dell’accordo dell’essere col tempo. (...)
C’è, sotto l’aspetto formale, questo richiamo dell’autrice al passato, alla tradizione, reso evidente dagli omaggi ai vari autori citati dalle diverse poesie, e dunque il riconoscimento di quanto di salvifico dal passato ancora ci viene: la musica / desiderio senza parole / annuncia / allude / elude / spacca l’opaco / va e viene negli strumenti / fa festa.
Dalla nota di Gianmario Lucini
da Desiderio senza parole
Allegro
agitazione
aria di strana festa
in seguito nomineremo
accordi
umori
distanze
altezze
timbri
che di colpo mutano registro
alterano prospettive
rovesciando mondi
ma per questo
bisogna attendere
l’inizio è sempre vivace
Presto
non va sprecato il tempo
all’inizio sembra lento
presto è rapido rapido
noi si indietreggia e avanza
sarà sudore o danza
immobile ancora e canto
immobile in gola e si sa
che l’incontro annunciato
di messaggeri e messaggi
non c’è mai stato
né ci sarà
Tempo di marcia
si dovrebbe solo obbedire
obbedire a un unico ritmo
bianca linea e nient’altro
che spicca su questo nero
e non spezzare
mai le simmetrie non spezzare
mai le simmetrie che marciano
marciano senza mezzi toni o cadute
e ci sgravano
dal pensare e dal patire
Lucetta Frisa è poeta, traduttrice, lettrice a voce alta. Tra i suoi ultimi libri di poesia: La follia dei morti (Campanotto, 1993), Notte alta (Book, 1997), L’altra (Manni, 2001), Se fossimo immortali (Joker, 2006) e Ritorno alla spiaggia (La Vita Felice, 2009).
Beppe Ratti, Talavera de la reina, Osteria del tempo ritrovato 2013
(...) Quanta numerologia? Quante lingue? Quanti anagrammi? Quanti acrostici scalari combinati a mitografemi? Quante interpretazioni riuscite a provare, per pelle e per potenza cerebrale? Nel contagio interrogativo s’annida la cifra stilistica di Beppe Ratti: una consonanza che è risonanza, quasi una tac delle emozioni e delle reminescenze – per pungolare il Lettore all’interazione, per spronare il Lettore a sondare le reazioni, peculiari e soggettive, suscitate da una poesia entusiasta, etimologicamente accesa per divino scintillìo.
Dalla prefazione di Chiara Daino
da “Talavera de la reina”
***
carnets: che narcisistico accanirsi
in iscariota cartastraccia, se scrivere è
scavare varicose, sceverare crevasses e
viscere, survécu
poiesi, aposiopesi:
achrome carme un bianco abc.
dittico apodittico:
aritmetica metrica,
ermetica, meretricia
lettera, lettiera rettilario irrealtà.
linguistica: papille, papillons,
Saussurre sussurro lips pispillìo os-oris.
encriers, un arco iris, temperare pencil,
pinsel tremper
a3: crepacci
c4: calamai; arcobaleno
***
una beck’s, un amaro:
la sete extinguenda
sed lex to rape
terapia –d’amore?-
sixteen exaltée
cucurucucù cuore.
tra lux e brux
ori-gine, vortex
cadavres exquis
rivederci ex aequo
tu quoque tacque
abràxas bruja
bruxa la ex
(distico: accadesti, distacco,
learn anelare unreal.
poesia posdatata: Aspasia depossedetti.
polvere lips overlap beLIEvers,
frottole lover fallout afterall leftover)
***
tantalo: mai, nunca, nunc, maintenant.
cancello nichil Ancel silence:
oudè en rìma,
ode in rima
(i titoli tolti, litoti, altolì:
nier dernier, rimozione rimo –
e rimiro mir, abc acabo)
Beppe Ratti è nato nel 1964 a Milano.
Ha pubblicato “Alfabeto fallibilità” per Gattili Editore, “Atlant idéal catraz” per Sartoria Utopia.
Camillo Valle, altri fotogrammi da Lettere incompiute


Ogni lettera è misteriosa. Nessuna sa esattamente cosa le è concesso di scrivere...
Questo è l’esergo del brevissimo “corto” poetico di Camillo Valle. C’è il gesto della scrittura, la penna e la mano, scavato nel simultaneo esistere – né vicino, né lontano – della città rappresentata da ciminiere e condomini, oltre che dalla natura che può esserci al di là, reale o sognata, immaginata. I nitidi dettagli cromatici dell’attrice sfumano nei non colori dei non luoghi e viceversa. Il sovrapporsi delle cose avviene quasi naturalmente, tra l’ineluttabile e il possibile. In questo spazio, è vero, “ogni lettera è misteriosa”. Tutto lo scorrere delle immagini trova eco nella tensione musicale.
Per un approfondimento sull’autore: http://indipendentidalcinema.it/riflessi/
Gennaio 2014, anno XI, numero 22

Nella sua opera di diffusione e divulgazione della poesia, azione ulteriore rispetto all’assegnazione dei premi, il “Lorenzo Montano” ha stretto alleanza con sensibili istituzioni cittadine.
La collaborazione con i Licei ha prodotto nel 2013 non solo la realizzazione di due seguitissimi eventi nell’ambito del forum di Anterem “Agorà”, ma anche la mostra collaterale “L’arte della parola”.
Di tutto ciò diamo conto in questo numero di “Carte nel vento”, in cui inoltre presentiamo i finalisti e il vincitore per l’edito dell’edizione 2013. Tutto avviene attraverso alcuni testi esemplari degli autori corredati dalle note critiche di Rosa Pierno, che confermano un’altra prerogativa di questo Premio: l’analisi ininterrotta della poesia contemporanea. I poeti proposti sono Alessandro Assiri, Antonio Bux, Peter Carravetta, Alessandro Ceni, Biancamaria Frabotta, Tiziano Fratus, Patrizia Gioia, Alberto Mori, Silvia Rosa.
Ricordando a tutti i poeti che l’edizione 2014 è appena iniziata scarica il bando della 28^ edizione, auguriamo buona lettura.
In copertina, “Music for chairs” di Alberto Mori
Antonio Bux, "Trilogia dello zero", Marco Saya 2012
Antonio Bux, “Trilogia dello zero”
Marco Saya Edizioni 2012
da Fisica del tempo
***
ad Amelia
Nell’avvicinarci all’origine ripartiamo
dalla fine riavvolgendo ogni sguardo
ciascun nome e tutti i discorsi pronunciati,
ché rimane poco e molto nel limitarsi a vuoto
finanche le persone care sono specchi
che riflettono altri noi, al di là del vetro.
***
a Jacques
Il corpo è la chiave
di una porta chiusa
sul retrocedere futuro,
una serratura nera
dove volteggia l’ora
taciuta alla finestra;
un cristallo di giorni
che frantuma i nomi
nella spinta del tempo.
da Dall’inflessione all’inclusione
***
ad Arturo
Ancor prima del moto obliquo
delle mani, la voce non giunge
che al fracasso nella memoria
quale lenta porzione del futuro
costringendo parole ad ascoltarsi
per la medesima lingua vegetale
in convertito paradosso di ragione
nella complicanza di un divenire.
da Le ore nuove (Memorie dal giorno dopo)
Nella devianza del gesto
E’ movimento d’essere ora
il domani riscritto a memoria
(dalla devianza di un gesto futuro
il riprodursi lento della condanna)
-nella regressione dell’avvento-
una prigione la propria forma.
Nel poderoso volume “Trilogia dello zero”, Antonio Bux colleziona una sorta di enciclopedia perlustrando luoghi, persone, stati metereologici, concetti geometrici, cronologia temporale, e innestando in tali incongruenti materiali un ammasso di detriti riferiti al soggetto, nel tentativo di raccoglierne tutti i frammenti. L’intarsio di figure geometriche nella sfera soggettiva ci riporta alla mente l’antico sogno cartesiano: “e nel ritorno al singolo – stando in due - / (nel binomio perfetto di divisione) // che si unisce un nome al proprio nulla / come un corpo all’incerta destinazione”. La costante frizione di concetti astratti nella sfera dell’interiorità, visto che qui le persone, non sono mai descritte dal punto di vista fisico, concreto, contribuisce a creare una sorta di straniamento, perché il sé e l’altro vengono rappresentati sempre attraverso figure intermedie (i colori, i segni, le linee, il vuoto, i ricordi, l’ombra) e, oltretutto, solo nominati mai indagati nello specifico, in una sorta di impossibilità di penetrazione psicologica. Per questo le poesie dedicate a persone hanno come titolo un nome che sembra un numero. Crederemmo, dunque, alla loro interscambialità che va ad assommare al fine un’inconoscibilità. “Era l’abisso, l’attimo della nudità / il vuoto delle forme ridotte al niente // quei corpi fatti di cose di troppa materia, / eccessi sovraccarichi di prospettiva scenica”. Anche l’apertura all’inevitabile parte biologica, al funzionamento del corpo si attesta su livelli di raccolta di una nomenclatura che non penetra il segreto di ciò che è organico e meno che mai l’unione di corpo e mente: “Gli occhi tagliati, / due sfere invertite / nel cuore interrotto”. E, sempre, gli innesti col suono, col rumore, con l’elettricità, con il ritmo, con la traccia audio, quasi in una disperata ricerca dell’automatismo negli esseri ci ricorda ancora una volta Cartesio. Bux sottopone qualsiasi oggetto a questo metodo di analisi, ancora in questo modo cercando, forse inutilmente, eroicamente, l’umano: “il rifondere la terra nell’immagine / scrostando forme dalla cavità d’orma: // un precipizio di volti, e di oggetti rivolti / nell’infanzia dei gemiti, nella mutezza”. (R. P.)
Antonio Bux (pseudonimo di Fernando Antonio Buccelli) nasce a Foggia nel 1982.Sue poesie sono apparse in numerose antologie e in diverse riviste di poesia sia nazionali che internazionali. Si occupa di traduzione dallo spagnolo di scrittori e poeti sia iberici che latinoamericani. E’ autore del libro “Disgrafie” per Oédipus edizioni.
Alessandro Ceni, "Parlare chiuso" (Tutte le poesie), Puntoacapo 2012
Alessandro Ceni “Parlare chiuso.
Tutte le poesie” puntoacapo, 2012
da “I fiumi”
Il traguardo della pioggia 1
Il dolore non è passare di qua
per la lunghezza identica
tra gli assalti nelle stanze sopra il terreno
neutro dei soldati tra le mie lingue enormi
il segreto che compare in superficie
e nuota e si fa lungo qualcosa che sarai
nel metallo più semplice,
io non voglio saperlo
il ricordo non ha amato mai ha galleggiato
in voi per me i morti che conversano
e preparano lettere
niente da vendere in voi per me
il sole in collera il mio tu.
***
Me dentro cammina sicuro questa campagna
un paesaggio mano nella mano certo che tutto finirà,
soltanto un istante ritto in piedi poi l’innocenza
della luce depreda luminosità via
reni mandrie febbre
chiunque trova ciò che aveva cercato,
nulla era fuori come tutto fuori di me.
da “La natura delle cose”
Splene
Dove le acque dolci e salate s’incontrano
spigolo il piede sul tuo passo e i pesci
emergono all’angolo dell’occhio
con le tibie sommerse del fiume,
l’elenco del mare:
livido un fiume di fatali acque letargiche
richiama i petti sfondati degli uccelli,
descrive un tracciato e cammina
quell’acqua tagliata:
acqua desolata
amata soltanto dal silenzio delle piante,
dai gesti e suoni d’un solitario animale
dove s’incanna
il fiume all’orlo della vasca e
il mare accelera in eterno
gli spiriti mangiati negli stomaci dei pesci.
La ricerca della narratività nei testi poetici di Alessandro Ceni si compie proprio mentre continuamente se ne interrompe il fluire con associazioni non lineari. Il racconto allora si compie in maniera simbolica, giacché al livello di concatenazione di nomi e verbi e aggettivi la profusione di rimandi ad altro annulla l’accumulo e pertanto quel che resta parrebbe un rimando al simbolico in quanto tentazione, ma anche disillusione costante rispetto al traguardo: “Oggi, / sobborghi di fiato, il tempo dissellante / il pungitopo, demoni domani in chiesa di colui / che accende seni di menta, attribuendosi una / maternità da uomo dagli alberi fino al sole”. Non a caso il vuoto è parola agganciata sia al soggetto (“il mio ovale nel vuoto”), sia alla religione (“in un sudario vuoto”), sinonimo della parola “senza”, la quale si presenta con ancora maggior frequenza, elencando la lista di ciò che manca e rende il mondo letteralmente inabitabile. A disegnare una scenografia simmetrica di attese concorre a tratti il tono supplice, a tratti raggelato, per la disillusione: ”la morte è a destra e dispari: / non vedo cimiteri adatti per noi”. Il cosmo sia interiore sia esteriore, come esploso, frantumato, si rileva non ricomponibile. Persino gli amanti sono caduti nella trappola: “E ci separerà la vita non la morte”. D’altronde, con il procedere della scrittura, anche il dettato si fa più asciutto e poco incline all’aggettivazione. Anzi pare che i sostantivi finiscano col bastare a loro stessi o che si accompagnino in ogni caso ad aggettivi che acquistano la densità di un oggetto: ”Noi eravamo fermi, vi dico, il mare ci portava / come immobili sogni dentro un’immobile mente” fino all’esergo in cui il cosmo pare franare nell’io, spodestandolo persino della propria identità: “così, dinanzi a voi, piante mi nomino al neutro / l’indivisibile, il sempre scisso”. (R. P.)
Alessandro Ceni è nato a Firenze nel 1957. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo: I fiumi, Marcos y Marcos 1985; La natura delle cose, Jaca Book 1991; La ricostruzione della casa, Effigie Edizioni 2012. Oltre che poeta è traduttore e pittore.
Silvia Rosa, "SoloMinuscolaScrittura", La Vita felice 2012
Silvia Rosa “SoloMinuscolaScrittura” La Vita Felice, 2012
da “Solo”
sms#3
vorrei starmene qui a fissare geometrie marine,
cadere nel cono luminoso dell’estate senza uscita,
precipitare con le ciglia incollate a sale e sabbia
nella quiete tenera di questa rimozione di me,
dimenticarmi quaggiù quando le ombre si fa-
ranno fitte, non voltarmi, non voltarmi indietro,
colare piano nel presente, un grumo secco che si
scioglie e fluisce nel domani
da “Scrittura”
sms#37
la sera e le sue longitudini scomposte in richiami,
che si dilatano lune rotte silenzi una culla che
attraversa breve l’aria come un sorriso, da oc-
cidente oltre il punto cardinale più vicino alle
ombre incerte dei ricordi, lancetta dopo lancetta
il rintocco, al buio non affondare mai le dita
nei cassetti tutti di fogli scritti bianchi e neri,
sette meno uno, aperto, un lettino duro in cui
stendersi, attendere l’alba minuscola, qualche
accenno di chiarità domestiche, un sonno te-
nero di morte, latitudine zero infine la vertigine
autentica, l’urlo incrostato tra il legno, le pareti,
ciò che resta del cielo, lo specchio che non ti
riflette, le mani raccolte nel grembo due stelle –
costellazione desiderio – cadute
sms#47
il sangue caldo nelle vene sottopelle pulsa messag-
gi in codice, non ho più parole, devo inventarmi
una lingua nuova fitta di sorrisi del cielo terso dei
tuoi occhi delle tue mani il punto e a capo delle
tue labbra la parentesi tonda dell’esitazione, la
dolcezza che ha il tuo nome, ora, vorrei imparare
a dire questo mondo altro, vorrei imparare a dirti
Il respiro lungo della prosa fa quasi da viatico a una visionarietà obbligata, forzata dalla insufficienza del reale, il quale è inospitale a causa delle condizioni esistenziali minime, frammentarie, che offre. Se tragedie vi hanno luogo è solo per produrre processi di disarcionamento rispetto a tali rastremate situazioni esistenziali, ma Silvia Rosa le rovescia costruendo alfine uno scenario di meraviglioso cartone splendidamente colorato, e mobilissimo, capace di nascondere il vuoto, o meglio la verità del reale percepito. Così la poetessa in questa breve raccolta “SoloMinuscolaScrittura” mette in scena una serie di fughe attuate tramite varie strategie: la metamorfosi, la piena coincidenza con ciò che sta guardando, l’uso della distrazione e del buio. Presta persino parole alle cose per simulare un dialogo con l’inanimato: “il sole è smarrito, le foglie morte incollate al cielo sono messaggi d’addio. o maledizioni sbiadite che ingravidano di nero le nuvole”. Nulla viene tralasciato degli appigli che possano fornirle una via di fuga dalle proprie inquietudini, o la creazione di inusitate prospettive, per forgiare un ambiente maggiormente accogliente. In questa polarità tra il sentirsi vinta e il sentirsi invincibile si consuma la tragedia di una sensibilità arroventata. La consapevolezza di un io che non si accontenta degli esiti esistenziali e non demorde dall’arroccarsi nell’ultima inutile difesa. Persino quella di immaginarsi erba del giardino, pur di raggiungere lo stato di “quando l’amore si ama amando e smette di essere un esercizio d’infinite attese e discipline”. Sottrarsi alla lancinante ferita dell’amore non è esercizio per molti e qui la scrittura diviene strumento sonoro e vibratile per le continue trasmutazioni e variazioni, le quali consentono di non credere a quel che è. Solo scrittura ripristina amore come deve essere. (R. P.)
Silvia Rosa nel 1976 a Torino. I suoi lavori sono apparsi in numerosi siti, blog letterari, riviste e volumi antologici. Nel 2010 ha pubblicato la raccolta Di sole voci edita da Lieto Colle. Nel 2011 ha pubblicato Corrispondenza (d)al limite per Clepsydra edizioni (con immagini fotografiche di Giusy Calia).
Peter Carravetta, "L’infinito", Campanotto 2012
Peter Carravetta “L’Infinito” Campanotto editore, 2012
da “Delle voci”
III a Maria
questo squallore che ossessiona
nel recinto nominale che ossessiona
nella transitività dei luoghi
nelle vie del mondo percorse e
stranamente nell’immaginazione
visitate ma anche sognate
ogni passo ogni idea ogni
innamoratissimo desiderio
è spinto su te sulla vita
sulla tua bellezza inconsapevole
che pecca di non esser mia e vissuta
vedersi vivere senza inopportune
domande mentre i tempi stringono
fra le albe immemori delle serre
e gli albeggi fantasmatici d’
inarrivabili domani
cade la pioggia ed è fredda la notte
freddissima
da “Dialogi V”
Dialogo I
per E.S.
la sera ispida di tarpate voglie e indifesa scattante a volte
indifferente sviluppante i passi nei museici blandi umidi
cameroni teorie di libri e titoli ed immagini dappertutto
un potentissimo silenzio di presenze ora a me sfuggenti a
te le ombre granulose di questo nostro incontro disinvolto
in piena padania in luglio al sole a casa tua
da “Metessi”
Metessi
5.
ora procedono battaglie e cosmicomiche ma anche
noiose seconde visioni o terze e mansuefai l’orchestra
ordisci mansioni magari l’amore le vene variabili l’umore
del caso mattino meriggi i fiori per l’anniversario, Materia
parlammo dell’inenarrabile volontà desiderante degli spettri
intravisti in frantumi e riflettenti ancora e perturbanti o Materia
imperdonabilmente le matrici indifferenti alle albe all’altro
inamovibili modi nutricanti assenze di persone amiche e non
e registri sussidiarii strascici di flessioni comunioni rispetti
obliterate ne le trame di percorsi ipotesi accenti e convenevoli
La raccolta di poesie scelte che va dal 1972 al 2012 dispone sotto lo sguardo la corposa scrittura di Peter Carravetta che negli anni non si è assottigliata, né irreggimentata. Vena poetica che trasporta un fluido denso, ricco di reperti e di schegge, non amalgamato, aguzzo a tratti, tagliente. Solo la vena ironica, troviamo, si adagi, si decomponga per una certa consapevolezza di inevitabile tragedia, di rassegnata accettazione: “e si abbassa lo sguardo attenuando i sensi tutti / nel silenzio ad intimo amico dicendo malgrado l’incubo / veramente l’amo o meglio l’amerei se non fuggissi”. Una certa amarezza per tutto ciò che considerato ideale non ha trovato posto nell’attuarsi dell’esistenza, ma trova ancora una riserva di energia contestataria, indomabile, che non si piega alla presa degli eventi. Una poesia che accetta però di soggiacere all’analisi, per tentare di comprendere le risposte date, il modo in è giunti nel tempo presente, quale via sia stata percorsa e quale in maniera errata. Ed è ancora un processo analitico che vede nella scrittura la forma di pensiero eccelsa, quell’”instabile Dire che slarga dal silenzio”. Se “nulla è fisso” è con la poesia che si crea mondo, ecco dunque che, come se si stesse sul foglio come su una superficie continua, ci si ritrova alla fine del percorso al punto iniziale dove l’ideale appartiene a questo mondo: non ne è escluso. Il lessico, come dicevamo, è spurio, poroso, inciampa sulle assonanze volutamente scoprendo un senso autogenerantesi che è come la prova del nove: “annullando l’andare il consacrare / annusando quelle stilofore creature / quell’anaforico misterico portale / dell’universo / ricerca/graffito / graffio all’argine pensante / nel brusio di fondo”. Lessico da cui incessantemente ripartire, da saggiare interminabilmente. (R. P.)
Peter Carravetta è titolare della Cattedra per gli Studi Italiani e Italoamericani alla Stony Brook University, nello stato di New York. Nato in Calabria, vive negli Stati Uniti dal 1963. Fondatore e direttore della rivista Differentia, review of italian thought (1986-1999). Ha svolto intensa attività saggistica e svariate traduzioni dall’italiano all’inglese. In poesia ricordiamo “Percorso masticato”, seledizioni 1974; “Delle voci”, Anterem Edizioni 1980; “Dialogi V”, Tam Tam 1987; “Metessi”, Ripostes 1991.
Tiziano Fratus, "Gli scorpioni delle Langhe. Poesie con radici", La Vita Felice 2012
Tiziano Fratus “Gli scorpioni delle Langhe. Poesie con radici” La Vita Felice, 2012
Non è vero che la scrittura sia soltanto una cicatrice
Queste parole sono impresse col sangue,
una chiave che gira e si estrae dal buco
come un forcipe che strappa la vita al buio.
Ma poi si esce al sole aperto, ci si inchina,
un cervo volante si posa fra le tue mani.
Rusca sulla pelle, te lo conferma, chiudi gli occhi
et inspira
Sei lettere per uomini e donne radice
A.
Chi apre questo libro rischia grosso:
dalle dita dei piedi potrebbero spuntare radici
e dalle mani fronde di carpino o corbezzolo
B.
La poesia non fa male,
non vi aiuterà a stare meglio,
nemmeno a evitare di accendere la televisione
C.
Re Artù s’è sempre interrogato sul perché
la sua sposa l’abbia tradito con un ramingo:
come tanti poeti non sapeva leggere dentro di sé
D.
Non avete vissuto abbastanza
se non vi siete addormentati sulle radici di un faggio,
o non avete baciato sotto le chiome d’una sequoia
E.
Gli alberi vivono una vita parallela,
non ci viene insegnato a distinguerli,
e per questo perdono le foglie, ad ogni pianto
F.
Covare in inverno i semi di araucaria:
in Liguria lo fanno gli anziani, decorare
i giardini è l’unica forma di soddisfazione
Poesia con radici
Spero sempre in un mondo, piccolo e laterale,
tascabile, dove gli occhi e le mani mettano radici
e la parola armi non possieda cittadinanza.
Ma si sa: agli umani bastano le unghie, e i denti,
eppure vorrei percorrere quel sentiero con altre scarpe,
scarpe più comode, che sanno aderire e ripartire
Da quali insondabili delicatezze derivano questi versi che Tiziano Fratus distilla! Venuti alla luce attraverso una decantazione favorita dalla capacità di essere in dialogo con la natura, di ascoltarne le voci e i modi, di imparare tramite la sua lezione una modalità di essere al mondo: “e infine inghiottiti in quello che i corpi / ci lasciano fare. Esiste un piano di Dio / nel volo di una falena che sbatte contro il vetro”. Il che, inoltre, non pone l’autore in posizione troppo distante dal considerare che esiste l’infinito e l’incompossibile. E la natura diviene pertanto il trampolino di lancio versi orizzonti che si collocano su piani ulteriori, non coincidenti con quello che ricade sotto il nostro sguardo. Sapere ascoltare in questo caso vuol dire donare parola. Gli alberi parlano al poeta perché il poeta riceve e trasforma e dal suo desiderio di essere un albero apprendiamo che si è effettivamente trasformato in un tronco con foglie e radici, poiché l’arte consiste in questo anche se non vogliamo darle una definizione: ci consente di dare voce a quello che sappiamo guardare, sentire, pensare. E difatti dalla riflessione di Fratus non è mai assente un’attenzione alla metalinguistica: la consapevolezza della funzione del linguaggio è in realtà l’elemento fondante della sua poesia: “Un giorno smise di chiudere la bocca. / Ibernato nel bianco, da lontano / sembrava un haiku”. Fratus crea i propri mondi incantati, ove tutto è possibile, anche la compresenza di diversi tempi storici, dinosauri compresi, e ove cultura fa il paio con natura come splendidamente esemplificato da Lovejoy. Dalla trasformazione alla transunstazione, il passo è breve, ma intenso e ricchissimo è il paesaggio che l’autore disegna incessantemente dinanzi ai nostri occhi, quasi volendo campire anche lo spazio vuoto fra natura e cultura. (R. P.)
Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) ha pubblicato diversi libri di poesia in Italia e all’estero. Tra questi ricordiamo Il molosso (Roma 2005, Torino 2010) e Poesie luterane (Bologna 2011).
Ha fondato e diretto dal 2006 al 2010 le Edizioni e il Festival “Torino Poesia”. Dal 2010 è impegnato nel ciclo di “taccuini, volumi e mostre fotografiche per cercatori di alberi” dal titolo Homo Radix.
Biancamaria Frabotta, "Da mani mortali", Mondadori 2012
Biancamaria Frabotta “Da mani mortali” Mondadori, 2012
da “Gli eterni lavori”
da La prima generazione dei biancospini
***
Oltre la soglia del letargo, una foglia
pende ancora a lato del legno, trema,
si rimette al vento con l’astuzia dei deboli.
Ha conosciuto la pietra e l’agio delle erbe
la prima generazione dei biancospini.
Irti più del filo spinato che li regge
proclamano la resistenza all’inverno
mentre un riemerso brulichio di molti
silenziosamente li lavora nel tepore.
La pianta è un cantiere sempre aperto
a chi vi torna senza averne memoria.
Sappi che frenerò ogni desiderio
di spronarla, questa ottusa pazienza
di durare, per ora, senza dare ombra.
da Poesie per Giovanna
***
Sono come i fantasmi
i poeti che ritornano
fra chi meno li aspetta.
Come loro
in eterno costretti
a pendolare
sulla stessa tratta.
da I passi senza importanza
***
E’ la stagione dei giorni lunghi
eppure il flash scatta ogni volta
sulla fisionomia sfocata delle cose.
Ad alcuni pare infondata quella
luce nella luce, più debole
e inaccessibile, come l’uno all’altra
fra le braccia dell’amante, quando
sfumano le pose in cui si ride
si fa corto il respiro e fra i gruccioni
dalle ali d’oro si sparge la voce
che in troppi saltellano sullo stesso ramo.
Biancamaria Frabotta nella sua ultima prova “Da mani mortali” non vuole perlustrare il reale e attenersi a esso, vuole rifondarlo per creare o ripristinare collegamenti altrimenti ostruiti, tranciati. La natura vi occupa un posto privilegiato, è spesso protagonista, ma come avente un diverso grado di materialità: la poetessa la umanizza, la dota di volontà, instaura un colloquio al limite della visionarietà, al limite: quel tanto che basta per la delicatezza del raccolto emozionale. E in ogni caso per instaurare con essa un probabile confronto, farne una compagna di vita. La natura deve necessariamente per Biancamaria Frabotta essere interpretata, quasi tentata affinché manifesti la sua essenza a chi è in grado di ascoltarla: “Potessi poggiando la testa sul cuscino / udire il mormorio della terra che dorme / quando sibila la sofferenza delle piante”. E’ un assommarsi di pretesti per donare alla natura parola e scopo istituendo un parallelo col sé: “Uccellino puerile che simuli il canto / a danno del bene comune per cui tutto tace / e la notte è compita, come una negra preistoria somiglia al mio risveglio agitato”. Nella sezione “Le fasi della luna” sarà il pianeta a creare le occasioni per riflessioni minime al limite dell’haiku. E se non tanto nella forma quanto per l’avvicinarsi come un asinteto a un nucleo di significanza non altrimenti riducibile o in ogni caso il più rastremato possibile. Eppure, ciò non si scontra con la capacità narrativa della Frabotta la cui sintassi prosegue in maniera lineare, mentre solo il senso è sottoposto a salti, per l’insopprimibile volontà di congegnare un proprio personalissimo teatro anche nella situazione percettiva più banale. Il colloquio inevitabilmente coinvolge i temi dell’amore, della morte, spesso convocando sulla pagina anche gli dei. In questi casi, si rilevano verbi declinati al passato che però ancora una volta più che un richiamo mnemonico adombrano una stanza teatrale, una nuova creazione.(R. P.) Biancamaria Frabotta è nata a Roma nel 1946. Insegna Letteratura italiana contemporanea all’università di Roma La Sapienza. Oltre a una vasta attività saggistica, in poesia ha pubblicato: Il rumore bianco (1982), Appunti di volo e altre poesie (1985), Controcanto al chiuso (1991), La viandanza (1995), Terra contigua (1999, II ed. 2011), La pianta del pane (2003).
Alessandro Assiri, "In tempi ormai vicini", Edizioni CFR 2013
Alessandro Assiri “In tempi ormai vicini”, Edizioni CFR, 2013
fin troppo facile intuire tra le righe le cesure
tutto il recidere delle forbici, tutto il piovere nel buio
a frenare l’entusiasmo di esser neanche a metà strada
da vamos a la plaza
***
Chissà Jonas come si scrive duemila
su questo muro che è pelle da sporcare
perché colla ce n’è ma più nulla da attaccare
***
Di questa violenza a lato che riparte in storie fisse
contro la noia delle luci spente, degli anni che ci sembrano
risplendere soltanto quando escono di scena
***
Ognuno si sente i libri addosso
come evoluzione di una lettura nervosa
che da carne diventa superficie
delle periferie dove ci hanno infilato
***
Se devo esser povero bisogna che ci creda
che resti all’ingresso del sonno di domenica
coi piatti da assaggiare imparati da un profilo
se è carne o benzina quella che dobbiamo versare
su questo cuore obeso a cinque litri da una tanica
***
Coi mali immaginari a tappezzare la tana
con la croce al collo diventare come loro
parenti alla lontana
***
La voce più bassa il nemico più grande
piano piano torna ferro il legno
non c’è più niente di civile che ci lascia in pace
***
Il sostegno scucito dal gorgoglio dei morti
il nostro cercare con gli scarti
Alessandro Assiri con la silloge “In tempi ormai vicini” sceglie di riportare alla nostra attenzione un tema storico, politico e lo fa con quella appassionata presa in carico che è tanto più vera quanto più è amara, a tratti cinica. In ogni caso coinvolgente. Le stragi di Brescia e di Bologna costituiscono un unico contenitore delle emozioni e dei pensieri dove la sorpresa, l’annichilimento dei presenti, passati in un istante dalla quotidianità alla tragedia, sollevano appunto la ferale questione: quale distanza c’era tra quotidianità e tragedia? Non era già tutto presente? Non dovevamo già essere tutti consapevoli della situazione storica e poi qual è la differenza, visto che esiste, tra l’essere sopravvissuti alla tragedia e la voglia di lottare affinché non più accada?: “senti come tace il tuo pugno alzato / adesso che indietreggi perché sei rimasto vivo / tra una scarpa calzata e un’altra perduta”. Naturalmente la voce acre di Assiri nel raccontare anche l’esito processuale non si esime dall’esprimere giudizi e critiche, ridisegnando il profilo del poeta impegnato: “Entra la corte svolazzan le toghe papaveri alti il resto son seghe / tutti i colpevoli trovati in serata con alibi pronti e corsia riservata”, giudizi che non risparmiano anche il modo in cui si credeva di essere impegnati in quel tempo storico, forse coinvolti più in un gioco che in una azione incisiva e responsabile. Ma il tempo storico è sempre anche il tempo presente della coscienza e allora un confronto tra i due stati dell’io porta il poeta a scoprire un orizzonte solo falsamente mutato dal digitale o dal precariato, ma ancora più inconsapevole e assuefatto: “Un paese che si indigna a gettoni di presenza / ha dimenticato che piazza è azione in potenza”. Eppure, il poeta ci avvisa che sono proprio i morti delle stragi a costituire per noi la possibilità di un passaggio a una più civile vita: se vivi fra noi vivi. (R. P.)
Alessandro Assiri è nato a Bologna nel 1962. Da molti anni vive tra il Trentino, Bologna e Verona, città dove gestisce la Libreria Bocù insieme alla sua compagna. Si occupa di arte e promozione culturale. Tra i suoi ultimi volumi di poesia ricordiamo Modulazione dell’empietà e Quaderni dell’impostura pubblicati con Lieto Colle, La stanza delle poche righe (Manni), Cronache della città parallela, poemetto in versi insieme a Serse Cardellini, Thauma Edizioni. Scrive in http://lastanzadellepocherighe.blogspot.it
Patrizia Gioia, "Tita su una gamba sola", Mille gru 2012
Patrizia Gioia “Tita su una gamba sola” Mille Gru, 2012
Come dinanzi a un teatrino si assiste a uno spettacolo per bambini che solo per finta è rivolto ai bambini. Non ci si faccia ingannare dal tono semplificato fino all’inclusione dell’errore grammaticale o dalla voce delicata che sembra per noi leggere i versi. Patrizia Gioia ci consegna assieme al suo effettivo candido sguardo, ma ripetiamo teatralissimo, con tutto ciò che questo paradosso comporta, la volontà ferrea di non accettare nulla come dato, e l’espediente per attuare ciò è appunto il consegnarsi alla propria voce, all’infanzia mai cessata e in perenne ribellione contro l’ordine costituito. Nulla resta indenne dalla verifica e dall’analisi, ma anche dal desiderio di credere possibili le favole, tant’è che la scelta di attraversare la valle dell’infanzia è a sua volta piena di trabocchetti e di sviamenti. Si avverte la necessità di far tutto quadrare, quello che si nota nell’esistenza e quello che raccontano i grandi, in assenza di una cornice di riferimento esclusivamente razionale: “e a proposito della fedina penale / che ci hanno spiegato ieri mattina a scuola / non ho dormito tutta la notte / perché non so più a chi chiedere / se la fedina è come l’ostia”. E apriamo qui una parentesi anche sulla “strana” educazione che si riceve sia a scuola sia dai genitori. Così la Gioia finisce per costruire un mondo a metà strada, sospeso nella propria credulità, mentre è così incline a dubitare, conquistato dalla magia di una soluzione analogica quanto più è consapevole della mancata relazione esistente fra le cose. Ci riagganciamo in questo senso al nostro incipit: si crede di assistere a una regressione infantile, ma si nota che è una lente a infrarossi quella messa in atto nei versi di Patrizia Gioia; si pensa di trovarsi innanzi a una personalità candida come sarebbe quella del Candido di Voltaire, ma solo per ravvedersene all’istante e notare che le cose non collimano, che nessuna corda o scotch può costituire il ponte attraverso cui unificare credenze e bisogni, divieti e fondamenti. (R. P.)
da Tita
***
io abito al primo piano
di una casa di ringhiera
sopra di me c’è un terrazzo
di fronte invece ancora due piani
perché non è mica tutta uguale
anzi ogni porta è diversa
come chi ci abita dentro
ci sono in cortile due negozi
uno che fa il droghiere
e uno che vende cose di lana
e un cane tenuto alla catena
bianco pieno di pelo
sempre un po’ sporco
ma non abbaia a nessuno
e mi pare contento
il giorno che mi piace di più
non è la domenica
ma durante la settimana
che ognuno fa qualcosa
sulla ringhiera
e arrivano tutti i profumi più forti
anche dalla pattumiera
da Tita su una gamba sola
***
io alla domenica
vado sempre in ospedale
certo che mi piacerebbe
di più andare a giocare
ma mio papà è là
e quando lo vedo
cerco di ridere
e di non fargli capire
che anche io sto male
perché mi sento come lui
e senza una gamba
come si fa a ridere e saltare?
***
come fare a dire le cose
se non riesci a trovare le parole
come fare a imparare a volere bene
se mancano le persone?
Patrizia Gioia, poetessa, artista e designer, è nata e vive a Milano. La sua creatività nel mondo della pubblicità è diventata parte dell’immaginario collettivo. La sua scrittura poetica è una ricerca tesa all’incontro con l’alterità, all’analisi del profondo. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo Inutile fare trasloco (Milano, 1985), Tre storie in bianco e nero (Milano, 1997), Parole di passaggio (Milano, 2004).
Alberto Mori, "Esecuzioni", Fara 2013
Alberto Mori “Esecuzioni” Fara Editore, 2013
Se il pensiero si riducesse unicamente all’orizzonte in cui insistono gli oggetti che accompagnano la nostra esistenza e fosse limitato al linguaggio da essi veicolato, nel senso che “il medium è il messaggio” del mai sopito sobillatore McLuhan, saremmo catapultati, come difatti accade in queste pagine di Albero Mori, in una bolla, sorta di epochè in cui si possono verificare alcune ipotesi. Non ultima quella della sfera estetica, in cui però questa volta è il linguaggio a farsi promotore. Alberto Mori ha dunque creato una stanza, diremmo, insonorizzata, dove ci sono strumenti musicali o strumenti che producono rumori come il telefono, la sveglia: “Quale luogo? / La rampa delle scale armoniche scoscende / Appunta veloce intervallo pianerottolo / Più tardi swinga nella clip del musical condominiale” e ove a partire da oggetti si costruiscono analogie con lo spazio, si innestano metafore, si rompe la sfera, ma appunto linguisticamente, con abbondante uso delle sinestesie: “Fra narice e pruno / sniffo chitarrista del colore assuono / Dalla tromba ancia FiatoVetro”. In tale guisa, l’ipotesi iniziale è verificata tramite la creazione di un mondo percettivo esclusivamente personale in cui il linguaggio s’incarica di costruire relazioni altrimenti inesistenti: trasparente, vibratile passaggio in cui da oggetti reali si giunge all’io che produce. Ma è un io che si costruisce esclusivamente tramite percetto e che individua nel pensiero estetico, l’unico pensiero d’interesse, ove la logica deve lasciare il passo a una maggiormente sinfonica rappresentazione e a una non meno complessa organizzazione. Così le esecuzioni che Alberto Mori mette a punto sono da vedere e da ascoltare, miracolo, mentre si legge. (R. P.)
9 (0:44)
Nel cerchio carillon giostrante
la nenia abbassa lenta
degrada ed appiatta
Scorre fantasmagoria rotoria
Poi oscillano dita xilophone
14 (2:54)
Tornasole del Reggae
Sguardi lucchettati disserrano
Oscillano ancora in narcosi penombrea
Dea Calypso danza lenta e scatenata
20 (1:44)
Trascorre alternanza
La sequenza si allunga
Varia nelle consecuzioni
Individua la serie
Raggiunge permanenza attiva
nella durata immaginaria
22 (4:05)
La tensione armonica sospinge improvvisa
La linea conchiude le mani
nel disegno tattile in composizione
Al dispiego appena meno labile
annotano evanescenze in battito
35 (1:02)
Battito oscuro
Atemporale della lontananza
Timpani taciuti simultanei
La luce scivola invisibile sulla musica delle sfere
Alberto Mori, poeta performer e artista, sperimenta una personale attività di ricerca nella poesia: dalla poesia sonora e visiva, alla performance, dall’installazione al video e alla fotografia. Dal 1986 ha all’attivo numerose pubblicazioni in poesia: tra queste ricordiamo Objects (2010), Financial (2011), Piano (2012) edite da Fara Editore. Sito internet: www.albertomoripoeta.com
Liceo Scientifico Fracastoro di Verona, documento da "Sette" del Corriere della Sera
Leggi l'articolo
Dicembre 2013, anno X, numero 21

In questo nuovo numero di “Carte nel vento” presentiamo otto autori, portatori di diversi momenti del linguaggio, selezionati nell’ambito dell’edizione 2013 del Premio Lorenzo Montano.
Nella varietà delle forme e dei pre-testi, nei mutevoli margini del senso, attraverso le opere inedite di Paola Ballerini, Doris Emilia Bragagnini, Viviane Ciampi, Chetro De Carolis, Llanos Gomez Menéndez, Pietro Pisano, Lisa Sammarco, Antonio Scaturro, questo premio si conferma ancora una volta terreno fertile per la poesia, la prosa, la prosa poetica.
Da altre terre e da un altro tempo giunge la voce di Ghérasim Luca che apre il numero: per Deleuze il più grande poeta del secolo scorso. Da altri mondi, nel rapporto della parola con l’arte e la materia, giungono le “meteoriti” di Oronzo Liuzzi.
Buona lettura, buon 2014 con la nuova 28^ edizione del Premio Lorenzo Montano.
scarica il bando della 28^ edizione
In copertina: Oronzo Liuzzi, “Meteoriti di poesia”
Ghérasim Luca, da “La Fine del mondo” con una nota di Alfredo Riponi e Rita R. Florit
Ghérasim Luca, La Fine del mondo, Joker edizioni, 2012, a cura di Alfredo Riponi, trad. di A. Riponi, Rita R. Florit, Giacomo Cerrai.
Ghérasim Luca (Bucarest 1913 - Parigi 1994), è restato a lungo quasi uno sconosciuto anche in Francia. Fino a che Gilles Deleuze lo definirà il più grande poeta del secolo scorso. “Se la parola di Ghérasim Luca è così eminentemente poetica, è perché egli fa del balbettio un affetto della lingua, non un’affermazione della parola”. Ghérasim Luca si voleva “hors la loi”, nel non essere di nessuna lingua e nel suo essere apolide, perché “nella lingua c’è una funzione conservatrice e chi ne fa uso contribuisce a rafforzare il sistema”. Aveva ripreso con una nuova connotazione l’espressione “hasard objectif” di Breton, facendola diventare parola-chiave della creazione poetica. L’esperienza delirante e ossessiva del poeta, a contatto con alcuni oggetti, gli fa scoprire che “noi forziamo il caso ad apparire, a oggettivarsi, perché le nostre inclinazioni all'amore-odio trovano nel mondo degli oggetti esterni un'equivalenza quasi continua”. I punti di contatto tra l’opera di Ghérasim Luca e quella di André Breton sono molteplici. In primo luogo “L’amour fou” appare come il testo totem. Ma Breton è anche la figura che resta sullo sfondo, che Ghérasim Luca ha sempre voluto tenere a distanza, rifiutandosi di incontrarlo personalmente. La poesia deve “esprimere l’inesprimibile” secondo la formula di Ghérasim Luca. Nuove relazioni appaiono solo in seno ad una sintassi sconvolta. Due parole chiave definiscono l’opera di Ghérasim Luca: silensofono e ontofonia. “Colui che schiude la parola schiude la materia”. “Passionnément” è il testo più famoso di Ghérasim Luca e il primo esempio del “balbettio” e della sua “cabala fonetica”. La parola è smembrata; la vocalità è essenzialmente suono, ripetizione di fonemi: durezza, dolcezza, chiusura, apertura, scivolamenti, collisioni. L’andamento ipnotico è percepibile fin dai primi fonemi lanciati in successione. «pa pa papapa pa / pa ppa ppa papapa / il pa passo il passo falso il pa / papapa il pa il mal / il malva il malvagio pa / pa pa pa il passo il papà / il malvagio papà il malva il pa / pa pa passa papapassa / passa passa esso passa esso pa pa / esso passa il pa del passo del papa / […]». Il poema è un violento invito a sollevarsi contro tutto ciò che nega la passione, dalla figura paterna fino alle microscopiche inclinazioni personali, alle follie delle nazioni.
Le tangage de ma langue. È un testo inedito, costituisce un’arte poetica, ma il suo effetto dirompente è dato dalla recitazione. Una parola sonora, come quella di Artaud. Non fu mai preso in considerazione per una pubblicazione in una raccolta, ma se ne trova traccia scritta in un libretto per una trasmissione radiofonica del 1970 e per il film per la televisione realizzato da Raoul Sangla “Comment s’en sortir sans sortir”. “È come se la lingua intera si mettesse a rollare, a destra e a sinistra, e a beccheggiare, indietro avanti…” (G. Deleuze). “Ho sempre avuto l'impressione di essere pensato come Lautréamont («… on me pense ») e Rimbaud (« je est un autre »), ma mai mi è capitato che questo altro che mi pensa uscisse da me e apparisse davanti a me in maniera concreta e sensibile come qualsiasi oggetto esterno” (Ghérasim Luca).
Al limitare di un bosco. L’ultima raccolta a cui Ghérasim Luca lavorò (La Proie s’ombre), contiene nel titolo la ragione del suo intero percorso poetico. “Il linguaggio poetico ha accesso agli oggetti del mondo come tante prede che s’oscurano” (D. Carlat, Ghérasim Luca l’intempestif). André Breton, in L’amour fou, aveva scritto: “Il surrealismo disdegna, in ultima analisi, sia la preda che l’ombra, per ciò che non è già più ombra e non è ancora preda: l’ombra e la preda fuse in un unico bagliore”. In origine “Al limitare di un bosco” faceva parte di un’opera collettiva: “Les inspirés et leurs demeures” che riuniva testi di B. Péret, G. Luca e C. Tarnaud (cf. D. Carlat, op. cit.). Il testo di Ghérasim Luca ruota attorno alla figura di Joseph Marmin, contadino della Vandea, villaggio di Les Essarts, esperto nell’arte della “topiaria”, taglio degli arbusti fino a far loro assumere una forma zoomorfa. La poesia insegue l'idea del “mito di una specie di giungla utopica” che “sorge nel mondo”, la possibile utopia di una coesistenza uomo-natura, un incrocio, all'interno del cerchio delle forme, di driadi (ninfe dei boschi), druidi (sacerdoti astrologi e maghi) e uomo.
Scarcerazione. Con “Levée d’écrou”, raccolta pubblicata postuma, Ghérasim Luca “propone al lettore l’avventura inaudita e vertiginosa di una liberazione attraverso l’assenza” (D. Carlat, op. cit.). Ventitre lettere indirizzate a uno sconosciuto dal 6 novembre al 2 dicembre 1954. È l’altro, lo sconosciuto, ad essere interpellato; è il destinatario di un discorso che lo convoca di fronte all’inevitabilità del suo esistere e alla sua assenza. È il lettore stesso, destinato a restare anonimo, che si deve riconoscere come il destinatario dello scritto (della lettera). La corrispondenza scrittore-lettore si chiude sul gesto di una doppia separazione, perché ciò che li lega l’uno all’altro è soltanto il linguaggio, legame impossibile che rinvia ognuno alla propria solitudine.
***
IL BECCHEGGIO DELLA MIA LINGUA
Parole duttili
e fin dall’inizio celate:
la conca del silenzio sfiora quella delle scogliere...
perciò questo racconto
Catturato dal magnete del nonsenso
parlo pressappoco di questo
per dire precisamente quello
Io sono ahimè!
dunque mi si pensa
(Il cieco mira all'aquila
e tira su un sordo)
Così io vivo
ciò che vedo
e la mia voce si vota
all'io che s’estingue
Come il «duttile» nel dubbio
sono io il «suono» dei miei sogni?
All’ascolto di quest’’orgia
di parole e di asceti
il mio Demone sonoro agisce
su un mondo che si nega
s’annega e s’annoda
in fondo alla mia gola
Stregone per onde ritmi
orde…
Per il rito della morte delle parole
scrivo le mie grida
le mie risa più che folli: false
e la mia etica fonetica
la getto come un sortilegio
sul linguaggio
Al di qua di questo
e al di là di quello
Fuori fuori di me
Perché essere altrove
strappa prima l'ora
poi il metro
la loro fine è qui
muro del suono
dove si fucila un eroe
infinito
la cui onda invisibile
getta un tessuto di parole
- un infimo drappo funebre -
sul nudo di una muta
sdraiato come un otto
nelle braccia dello zero.
***
AL LIMITARE D’UN BOSCO
Al limitare d’un bosco
i cui alberi sono idee svettanti
e ogni foglia un pensiero allo stremo
il vegetale ci svela
il fondo dannato d’una setta animale
o più precisamente
una remota angoscia d’insetto
che si risveglia uomo
sola via
unica fondamentale arma
per animare il mentale
che mi affretto a scrivere mantale
come mantide
solo per marcare
con un secco riso d’allarme
la parola che divora
Entità e antitesi della boscaglia
una sorta di spazzola organica e selvaggia
spunta nella testa di quest’uomo
che l'eresia dei parchi e delle serre
devasta
come una bella porta
l'orgasmo di una chiave
Così la passività leggendaria
la nobile e stillante passività delle piante
si tramuta ora in odio ozioso
in rabbia folle
in sesso rissa e sfida
la cui attrattiva è linfa sangue lava…
e svelta come il passaggio dalla donna
alla belva
ci lava d’una sporca ferita
ancestrale
e di colpo ci allevia
da questi continui lamenti
da questi falsi rantoli che ci sondano
e che sono i nostri gesti imperturbabili di sepolti
Ora solo il terrore
è ancora in grado d’immettere
nel tropismo del corpo e dello spirito
colpevole
questo prisma a doppia eco
dove cervello e sensi captano
la violenta innocenza
d’una flora e d’una fauna
le cui nozze sono un lungo ratto
e uno stupro lento come l'oro
nel piombo implacabile
Ed è attorno all'equatore mentale
nello spazio delimitato dai tropici
di una testa
all'angolo e nel contorno dell'occhio
che il mito d’una specie di
giungla utopica sorge nel mondo
Vergine come l'inconoscibile
o l'altra «faccia» della luna
e mai a tiro di fucile
o d'ascia
la sua preda è neve
sabbia bilia anca o trappola
che il respiro diffuso d’un sogno
accende
Perché intrecciati
saldati a enormi chiavi come viticci
le liane
i rami i forni e i riti
si fondono
nel cerchio delle forme poste
come per miracolo
all'incrocio delle driadi
dei druidi e dell'uomo
Altrettanti punti di mira
questi nonnulla che
fuori fuori dal tempo
dal luogo e dal peso
scelgono una specie di coppia oasi
e villaggio
per discendere negli dèi
prima delle ere
gli dèi-sito-bestia-isola-cenere-fuoco
usciti dall'accoppiamento dell'uccello
e del ramo
e che gli esiliati dal centro
e dall'ombra di un fogliame d’oro
adoreranno un giorno
tra le mura delle loro città oscure
………………………………………………..
***
SCARCERAZIONE (LEVÉE D’ÉCROU)
13 novembre 19..
Signore,
Anche se avete il coraggio d’affrontare qualsiasi pericolo mortale, non siete tuttavia pronto a versare il vostro inchiostro sull'assoluto. Dalla più tenera infanzia, siete stato torturato da inspiegabili esitazioni, da brividi che raggelavano ogni iniziativa, che vi contraevano nervi e muscoli, per esempio: quando vedevate della biancheria bagnata strizzata da una domestica, eravate letteralmente pietrificato.
Chi siete? Che cosa vi manca? Che cosa dovete fare?
Una sola risposta s’impone: siete inevitabile.
D’accordo, ma qual è, esattamente, il contenuto di una tale affermazione?
Paola Ballerini, poesie inedite da “L’alfabeto, lo sciame”
Paola Ballerini, poesie inedite da "L’alfabeto, lo sciame"
se non sanno scortare
questo tempo senza minuzie
le sillabe sono nebbia reato
del corpo privo d’asse
esattezza perduta apnea visiva
quella mancata presa
sulla superficie delle cose
proprio mentre falangi
di buio avanzano a ritroso
verso la sponda dell’inizio
da La statura dell'ombra
***
I
il luogo era trascorso
il risveglio una caduta
l’alveare muto
eppure quando l'ora si è curvata
la superficie bianca
ha chiesto di essere interrotta
di circondare la parola
di lambire l’alfabeto
lo sciame
la pagina divenuta parete
ha reclamato il suono che si staglia
contro la nebbia
***
andare a capo è
un tuffo nel respiro
gli occhi abbassati
sullo spazio vertiginoso
della pagina
andare a capo è
contare le vertebre
il bianco che sostiene il passo
la discesa nella parola
senza fretta
fino al coccige
fino al canoro della terra
***
maculopatia
la mappa presenta porzioni
opache dove si disgrega
l’immagine
quando con attenzione
riesci lentamente a
decifrare reticoli di luce
visioni inferte
bellezza scampata
all’atrofia
***
non esistono attrezzi del mestiere
benedire è lavoro nell’ombra
alba stretta di sere
è premere nell’aria la parola
alleanza nascosta tra le cose
sospensione reversibile dei semi
che si muovono tardi
e scuotono la terra
per chi va aperto incontro
all’accadere
Paola Ballerini (16/12/1962) è nata a Firenze dove vive. Laureata in filosofia, ha compiuto studi anche in campo psicologico. Suoi testi sono apparsi sulla rivista ‘Semicerchio’. La sua raccolta ‘Nell’arcipelago cresce l’isola’ ha vinto il premio ClanDestino 2009 per l’opera prima ed è stato pubblicata dall’editore Raffaelli. E’ coautrice insieme ad altri poeti del libro ‘Varianti Urbane – mappa poetica di Firenze e dintorni’’ che ha ottenuto il marchio microeditoria di qualità 2011, ed. Damocle. Nel 2012 alcuni suoi testi sono stati tradotti e pubblicati sulla rivista digitale serba 'Agon'.
Pietro Pisano, poesie inedite da “Nel regno intero dell’attimo”
Un attimo di chiarezza dura così poco.
L’oscurità resta più a lungo. Vi sono
più oceani che terraferma. Più
ombra che forma. Adam Zagajewski
***
Dentro la piana della notte
il corpo è il confine
stabilito dal peso della perdita,
qui dove l’essere appartiene
al respiro sottratto delle cose, non si muore
che per vivere
in un corpo visitato da sobbalzi,
scosse, intermittenze
interpunzioni: forse
è questo ritrovarsi
nel nudo terrore dell’attimo
disconnessi, domandarsi poi
chi è stato ad arrivare
fin qui. E se in ogni minuto
diventiamo
il fallimento delle parole
nelle parole, perché rimanere
nel calco di questa solitudine
nell’emorragia dei giorni
se la domanda è questo corpo
gettato nella traduzione
di questa musica idiota?
***
Vicino
Ci sono virgole migranti
nei giorni di festa
che entrano nei corpi
sospesi
in una commozione dello spazio
e d’aria, in un ritmo
indovinato appena per una
sola passione del vento: è quella
stessa disposizione delle cose
che aspettavamo
in una luce verde, portarci
il respiro dei giocattoli
nel regno intero dell’attimo
il treno di zucchero
che attraversava l’infanzia
nel mondo moltiplicato
la storia di ciascuno
che eravamo in ogni luogo
e in ogni tempo, avvicinati.
***
Questa stanza che mastica le ore
e sputa ricordi a intermittenza
ci ha donato la forma scura
di un pensiero
nel sonno: è una materia densa
che si versa al mattino,
ultima traccia di un mondo
sommerso dal risveglio.
***
Sette nomi più tardi
Questa asincronia
tra immagine e suono,
tra la voce e le labbra,
e le pagine e il respiro
nel vento di dicembre è tutto
quello che rimane
improvvisamente, si è soli tra le cose
cosa gettata nel vuoto che si apre
nell’andare
anche adesso i nomi
perdono sangue
tra una sillaba e l’altra.
***
La penna del destino è caduta
per terra rompendosi,
ora: ci camminano dentro
gli istanti senza suono
siamo scritti dal sangue
versato sulla pagina:
l’alba delle cose.
***
le parole raccolgono il poco
di ogni giorno
il discorso
incompiuto
che la città scrive
sui nostri sensi, dentro il dolore
dei tendini, dentro i nostri passi
le finestre non ricordano
la pelle si stacca
dal nome, non finisce
la strada dove camminano
i desideri
qui si prolunga all’infinito
la vita e il suo contagio
Pietro Pisano è nato ad Ascoli Piceno nel 1979. Si è laureato in lettere moderne nell’anno 2011/2012 con una tesi sul romanzo di Rilke, I Quaderni di Malte Laurids Brigge. Collabora con la webzine Oubliette magazine. Si è classificato come finalista in diversi concorsi letterari e alcune sue poesie sono presenti nelle seguenti antologie: Navigando nelle Parole Vol. 27 (edizioni Il Filo); Florilegio - Concorso di Poesia OcchiettiNeri 2009 - III^ Edizione (Cosenza, Maggio 2009); Habere artem vol. 13 (Aletti Editore), dicembre 2010; In questo margine di valigie estranee (Perrone Editore), 2011; Fragmenta - II volume, Edizioni Smasher 2012. E’ vincitore del Premio Laurentum per la Poesia 2012, XXVI edizione, sezione social network.
Antonio Scaturro, poesie inedite da “Notturna”
[...]come la storia delle arterie
all’altezza della mia morte[...]
se lo sguardo d’un tratto
(inconsapevolmente) si facesse tatto,
potrei allora - ma solo allora -
cedere al gesto l’angoscia,
le pupille come mani a verificare
il palpitio, il tremolio
che niente sa
e niente dimentica.
il battito lento, significa sul tamburo
dell’occhio
e in nessun altro luogo
che non sia mio, in nessun altro
nome che non sia il mio.
***
se fosse anche solo un osso
una frattura interna congeniale al dicibile
uno scricchiolio che contrasta con il silenzio degli organi,
che si estende a macchia d’olio,
che invade e valuta il cranio,
lo abita.
se fosse la congestione a fare di te
l’altare del freddo sismico
uno slancio verso il pallore
ti amerei, patologia mai verificata.
ma c’è dell’altro: il sonno non vale
come anestetico, e di notte ti penso
come si pensa a una scossa: con tutto il tremolio
del corpo raccolto dalla palpebra.
***
ricordo di quel giorno
che sembrava non contenere nessuna notte;
nessun principio della fine.
in un unico sonno spariscono i secoli, si estinguono
e ricordano le antiche bestie feroci. ritornano, a volte zoppicanti,
con i loro musi tristi a ispezionare il bruciato.
ci si sveglia, come se qualcuno l’avesse chiesto.
nella pesantezza del torace
si scioglie la tosse, nella camminata - sentiero da me al
non so dove - quando sparisci, e rimane il solco,
l’erba pressata, le pietre,
a formare un “forse torno, forse no”.
Nottu(urna)
I testi marciano alla guerra
- il testo al fronte che prediligo è il cecchino -
fuori dalle parentesi la morte si annuncia come
un’esondazione, trabocca dal testo.
“perché quel che racconto questa sera avviene questa sera, a questa stessa ora”
è così naturale la morte frontale, così tirata a lucido
senza sbavature.
la laterale giunge a
spiazzare le ore invece, fa fronte con le fionde,
ci costringe al punto e virgola; morte laterale.
la morte abita ogni girone dell’orologio
Oh gironi orrendi. In così verde etate!
tutti noi, da piccoli,
abbiamo preso quella botta
tra i piedi e la nuca
che ci consegna - un dono nel suo livello massimo di generosità -
la sventura del domani.
quando dormiamo in sospensione, la mattina
(appostata com’è dietro le cose) ci fredda al volo.
spesso la notte ci misura la febbre con un bacio della fronte,
mentre le gambe del letto
affette (come lo sono spesso)
da sproporzione, ci passano la torcia.
il prossimo fuoco dista un sonno. Solo uno.
Il futuro è una fila di bambini nati morti
la morte non è mai stata qui,
tra le cose ancora in corsa.
è sempre stata lì, al riparo:
nel principio di ogni dove.
“essere è essere incastrati”
la violenza di tutte le cose che sono
(fuori dalla nostra portata) ci colpisce, e noi
contiamo i reduci, i residui di questo corpo,
- abbiamo rivendicato anche l’ultimo colpo -.
non è necessario questo peso
questo cuore che impazza
prende sangue, rende marmo.
“mamma mi fa male la morte
all’altezza della vita”.
non siamo mai scivolati, abbiamo da sempre
preteso lo sfregio, l’attrito del corpo contro
tutte le cose.
- noi non siamo che il nostro cadere -
ma ancora prima di cadere non siamo
che le nostre mani disperate
che fiutano il fuoco
e trovano cenere.
Antonio Scaturro è nato a Giaveno il 27 aprile 1992, abita a Orbassano e frequenta il corso di Culture e Letterature del Mondo Moderno presso l’Università degli Studi di Torino.
Finalista del concorso “Opera Prima” edizione 2012.
Lisa Sammarco, prosa inedita, “Io, un falso d’autore”
Anticipiamo la prosa con il testo poetico La parola in corpo
Mi pongo in mezzo
per farmi attraversare
sono una voce tinta
un fondo di bicchiere
la grammatica di un corpo
sono come se fossi
la brevità di un luogo
Io, un falso d’autore
Sabbia. La lingua è sabbia. Che non è come dire che la tua bocca è secca. No, è la lingua a sembrare sgranata. Le papille, o di qualsiasi cosa si tratti, sono grani giganteschi che si muovono disordinatamente. Pesanti, frizionano l’uno contro l’altro al rallentatore. Cercano una compattezza che possa permettere ai suoni di uscire dalla gola. Pensi: S A L I V A. Ne cerchi la sorgente. Dove. Scorri le pagine del tuo sussidiario. Sì, qualcosa di elementare che ti possa dare una mano. SALIVA. GHIANDOLE SALIVARI. È tutto ciò che riesci a mettere a fuoco. C’era qualcosa che volevi dire. Ricordarlo forse potrebbe essere d’aiuto. Potresti trovare acqua e un punto di partenza. Fogli. Hai i tuoi fogli. S’inchiodano però in un disordine che non hai voluto. Affiorano in una sequenza d’improvvisazione. Come mossi da un fremito d’autonomia si accavallano, giocano a nascondino con le tue mani nervose, ne senti il riso di scherno soffocato, ma non sai da dove proviene. Forse sei tu che stai ridendo di te stessa. Non hai tempo. Nella sala invece sembra infinito. Ti accorgi allora che il tempo sei tu, anche se hai dimenticato d’indossare le lancette.
Il silenzio è qualcosa da temere. Poi si spezza. Un suono. Non avevi mai pensato che “spezzare il silenzio” si potesse avvertire fisicamente. Nello stomaco. È che le parole scritte hanno sempre parlato una lingua silenziosa, ora che ci aggiungi il tuo suono sono un’altra cosa. – è voce?- ti chiedi- e se lo è, da dove arriva?-
Intanto ti sfogli. Le domande restano indietro, le riprenderai dopo per sapere chi eri e dove sei stata. Sfogli. Capisci che essere lì è tagliarti a poco a poco la pelle. Brandelli che cadono a terra. Forse ciò che cade non fa neanche rumore. Non sai decidere se è un bene o un male. Non sei sicura neanche che quello sia il tuo posto.
Nella grande sala c’è l’eco di dove eri prima di quel momento. Senti il mare. Lo senti come quando è troppo buio per vederlo. Ma forse sei solo tu a sentirlo, perché in fondo te lo porti sempre dentro come un amuleto. Ti chiedi anche se sei mai stata veramente in qualche posto, un posto con un nome, così da poterlo raccontare ora ad alta voce.
Hai un bisogno urgente di orientarti. Righe sfilacciate. Ogni parola un passo. Incerto. Cammini da una parete all’altra dentro l’aria. Fogli. E sabbia.
Sabbia. La tua voce è sabbia. Ricordati, ti dici mentre prendi fiato, non devi fissare il vuoto. Vuoto? Non c’è il vuoto finché tu esisti. Ma esistere non basta per tenerti ancorata a quella sedia. Il pavimento ti tradisce come una nuvola che ti piaceva e poi scompare.
Qualcosa. O qualcuno. Dovresti cercare qualcosa o qualcuno da guardare. Non sempre, solo di tanto in tanto. La ragazza. La ragazza è lì davanti. Minuta, stretta nella giacca nera. Il verde degli occhi le sta colando sulla sciarpa. La luce la prende di fianco. Sembra un dipinto. Ti sorride. -Ci sei- sembra dire- sei ancora quella di ieri.- Una sigaretta. Fumavate una sigaretta ieri sera. C’era vento. E faceva freddo. Il vento toglieva peso ad ogni cosa. Il freddo era una scusa se volevi tornare a casa. A nascondere il tuo nome sotto il cuscino.
Il ragazzo. Con lui hai fatto un viaggio in macchina con l’autore. Quello vero, uno di quelli che entra nelle sale con il passaporto in regola: titolo, copertina, e una dolce innegabile simpatia nelle mani. Non come te che sei lì da clandestina. Il ragazzo ha un sogno. Te lo ha detto la prima volta che ti ha vista. Tu gli hai raccontato della paura. Ma non tutta. Ma ora se volesse potrebbe attaccarti ad un aquilone e decidere quando è il momento di riavvolgere il filo. Sì, potrebbe tirarti a terra e strappare tutte le tue carte di navigazione, e tu non sapresti mai fin dove ti eri spinta. Saresti un’isola alla deriva. Isola. Isla. Lisa. Coincidenze. Fogli. Aggrappati a tuoi fogli. Nella stanza, tra le luci, gli spazi sembrano elastici. Si accorciano e si allungano. Tu non sai mai dove ti trovi realmente. In verità non sai se sei di carne o di suono. Saperlo potrebbe darti un’indicazione, una coordinata per andare avanti. O fra lo stupore potresti sparire dentro una nota vuota e molesta.
Non sei neanche sicura che la tua voce arrivi fino alla parete in fondo. Non sai neanche se c’è una parete in fondo. Hai occhi troppo piccoli per tendere lo sguardo. Con un dito ti sfiori l’angolo dell’occhio destro. Zoom. No, non funziona. Ogni gesto diventa inevitabilmente una pausa prima di ricominciare. Il tempo sei tu che ti trascini lenta in qualche stagione. Se fosse autunno si prenderebbe tutti i fogli che hai scritto, ti dici. Fossi tu un autunno di vento. Fossi tu un autunno di vento e le tue parole foglie, forse una folata improvvisa le farebbe cadere fra le loro mani. Fra le loro mani, foglie. Fogli.
Fermiamo tutto adesso e aspettiamo. Aspettiamo l’autunno e potremo leggere le foglie. Le tue parole ritornerebbero al silenzio, ma si potrebbero toccare. Amare qualcosa è così, e anche capire è così a volte. Qualcuno te lo ha anche detto tempo fa – ho bisogno di toccare ciò che amo- Amo ciò che tocco. Tocco ciò che amo. E il resto? No, non è così semplice scegliere la via della concretezza. Il resto si tramuta in un rimpianto. A volte, non sempre .
Carta. Inchiostro. No, non come te che ti perdesti quando t’innamorasti di un amante della Cina del Nord . Lui non era te che amava. Lui non esisteva neanche, ma tu non ci dormivi, camminavi su e giù, guardavi il mare, il racconto dei suoi occhi e lo amavi lo stesso. Lo ami anche adesso perché capita che sei tu il tempo e il tempo è sempre.
Carta. Inchiostro. Non sai se è una buona idea pensare a questo ora. Meglio affidarsi a qualche appunto. Li versi dalla gola. Versi. Anche se vorresti ora una matita rossa per le correzioni perché scrivere è così, si possono sempre eliminare gli errori, si può anche imbrogliare, non è come la vita che comunque la racconti, dentro di te sarà sempre solo come l’hai vissuta.
Il suono adesso è indolore. Gli occhi sono anestetizzati da una luce che appare e scompare, non riesci a capire se lo sono anche le gambe, questo lo scoprirai dopo. Dopo scoprirai anche in che modo i tuoi fogli si riordineranno, se mai ci riusciranno ancora. Ma lo farai dopo, quando ritornerai al mare. Al caos delle tue stanze. Al silenzio nel buio. Al vizio della tua vita qualunque.
Poi l’ultima parola cade, ruzzola sul pavimento dopo un interminabile istante in cui credi che non riuscirà mai a toccare terra e riportare anche te a quella che sei. Un’isola. Isla. Lisa.
Lisa Sammarco è nata ad Amalfi.
Di sé afferma: "Considero la presenza di miei testi sia di narrativa che di poesia in alcune antologie del tutto irrilevanti. Mie prose, poesie e traduzioni di alcuni poeti americani fra i quali Frank O’Hara, Jack Spicer, Philip Levine sono state ospitate in alcuni importanti lit-blog come Nazione Indiana, La Poesia e Lo Spirito, La Dimora del Tempo Sospeso. Da alcuni anni curo il blog Falso D’Autore. lunamareterra.wordpress.com Ad oggi tutti i miei testi sono inediti".
Llanos Gomez Menéndez, prosa inedita, “La città di Dite”
Lo buon maestro disse: "Omai, figliuolo,
s'appressa la città c'ha nome Dite,
coi gravi cittadin, col grande stuolo".
Dante (Inferno, Canto VIII, vv. 67-69)
Accadono le azioni in ogni prisma della figura geometrica sospesa nello spazio che trascorre sfibrando scene del secondo sul secondo. Un uomo e l’altro sempre più alto inghiottirono istanti in due atti e sottomettono i piani alla disciplina temporale, lasciando cadere frammenti.
Piano d’imprimitura: nella benzina, bagnate le mani scivolono in questo asfalto verticale che annuncia il percorso spezzato nell’angolo ultimo, spigolo dello scenario contiguo.
Piano d’imprimitura: leggo impercettibile in grigio immagini in grigio e cerco le impronte nel suono per affondare lo sguardo. Cade nel secondo sul secondo e raggiungo il confine che delimita questo prisma calligramma.
Piano di livello: motore ed esplosione di parole, l’operatore aspira significati, spazi in bianco, foglie secche e l’insetto cresce; tremore, sussurro che abita la macchina, l’attrito del suo esoscheletro in questo feretro meccanico: la divisione del lavoro sociale, De la division du travail social.
Piano ed altro ed altro scivolono sui tuoi occhi senza sguardo, conversazione con i riflessi e ogni sconosciuto sono io, e tu ed il mio nome.
Piano di simmetria: attaccare gli occhi per terra, risuona la cavità del tempo e trattiene un grido che si propaga metallico; dove vai quando ti chiamano e cerchi di sembrare una domanda ed i miei piedi fermi e in fiamme ed i miei piedi fermi.
Nel rovescio, il lampo servo del fango ghiacciato ripete: non vedrai niente e morirai, ti nomino e ti blocchi; il vento e il vetro attraversano la tua respirazione e i tuoi piedi affondano nella terra.
nel suono di brina
riscatto un nome affogato nel mio centro
osservo ripetizioni – sullo specchio della marea –
disegnate nella continuità
dell’immagine luce intermittenti
lo scomparire di sguardi
tra pupille, palpebre
e dimenticanza
Sospesa gira la figura geometrica, i prismi si accumulano e un uomo e l’altro sempre più alto inghiottirono istanti in questo atto e tentano di sottomettere i piani ribelli alla disciplina lineare e la simultaneità vola nell’area. Il servo del fango ghiacciato salta e afferra fortemente lo spigolo del piano di simmetria; quindi, penetra nel piano adiacente e sommerge il suo corpo nella benzina; ascende dopo essersi bagnato con l’asfalto verticale fino a raggiungere l’angolo dal quale precipitare volontariamente sull’operatore. La caduta frattura la macchina aspiratrice degli spazi bianchi, significati e occhi, liberano così l’insetto che in modo accidentale è stato catturato e prigioniero crebbe in quel recinto trasformato in armatura e sepolcro. Il suo corpo sprovvisto di carcassa rimane all’intemperie. L’operatore per terra gira la testa per evitare lo scomodo suono che emette l’animale immobile e che lui riconosce familiare: “Dite, Diteee, Diteeee”. Ecco, lì c’è il motore della sua macchina.
Llanos Gómez Menéndez (Madrid, 1974) è autrice della pièce teatrale Batallón ciclista e del libro Arco voltaico (Amargord, Madrid, 2013). Ha pubblicato gli studi La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti. El discurso artístico de la modernidad (Academia del Hispanismo, Vigo, 2008) e Expresiones sintéticas del futurismo (DVD, Barcelona, 2008), ha codiretto (con Alessandro Ghignoli) Futurismo. La explosión de la vanguardia (Vaso Roto, Madrid, 2011). Ha inoltre tradotto, tra gli altri, i poeti Antonella Anedda, Gabriele Frasca, Alessandro Ghignoli e i saggisti Adriano Fabbris, Michele Cometa e Stanislaus Von Moss.
Insegna Storia e Teoria del Teatro presso l’Università Nebrija di Madrid. Direttrice del programma radiofonico “Sala de Ensayo” (Círculo de Bellas Artes de Madrid), è direttrice della compagnia di arti sceniche “Loco-motora Teatro”.
Viviane Ciampi, poesie inedite da “Volti”
L’accès au visage d’autrui est d’emblée éthique
Levinas
ricordati
di quel mistero
in cui
brillano i volti
l’occhio verifica
reinventa
abita
l’imprevisto
ricordati
siamo la folla
che traccia linee
fino a riempire lo spazio
*
mutano
i percorsi
lo sguardo acquisisce
diritti
lungo
il tragitto
*
la cara
immaginazione
quella cagna
d’immaginazione
spinta
più
avanti ancora
fino
al limite
del limite
*
diceva Spicer
a Lorca
i versi
insieme
dovrebbero creare
risonanze
vivere
da soli
non possono
e tu
passante
dimmi se
guarda se
controlla se
dammi un tetto
dammi un titolo
per questo vivere
*
volti
nella colata
del tempo
conoscono l’arte
del cambiamento
la sintassi
avviene
attraverso
un semplice
schiocco di lingua
*
distinti
da maschera
o maquillage
bucano lo schermo
e se ne vanno
a invecchiare altrove
Viviane Ciampi è nata in Francia, a Lione, nel 1946. Vive a Genova dal 1967. È co-fondatrice della rivista d’arte e cultura on line Progettogeum (www.progettogeum.org) e redattrice di Fili d’Aquilone on line (www.filidaquilone.it). Ha tradotto vari saggi dal francese di Bernard Noël, poi apparsi sulla rivista di Donatella Bisutti “Poesia e Spiritualità”, e per la rivista annuale di Jacques Darras e Jean Portante “Inuits dans la Jungle”, Ed. Le Castor Astral, un’ antologia delle poesie di Alda Merini. Ha curato e tradotto l’antologia “Poeti del Québec”, Ed. Fili d’Aquilone 2011. Collabora, dal 1998, come traduttrice da e per il francese al Festival Internazionale di Poesia di Genova e ad Alliance Française della stessa città. Ha pubblicato: Domande Minime Risposte, Ed. le mani 2001; La quercia e la memoria, Ed. Il ponte vecchio 2004; Pareti e Famiglie, Ed. Liberodiscrivere 2006; Inciampi, Ed. Fonopoli 2008; Le ombre di Manosque, Ed. Internòs 2011; Scritto nelle saline, Ed. Genesi 2013. Dirige la collana di poesie “Stelle vagabonde” per le edizioni Internòs, di Chiavari.
Doris Emilia Bragagnini, poesia inedita, “Claustrofonia”
claustrofonia
il muro tace, non risponde più
si lascia guardare angolandosi
in riproduzioni lessicali nei passi
o sfarfallii - armati - sottoluce
ogni tanto un urto di temperatura
differente, a porte chiuse ] tolte le dita
da maniglie ingoiate a sorsi, uscite laterali
agglomerate al bolo circolante, contropelle
la risalita dei ricordi sfida il cemento
dell’anima in guardiola, divelta e sugosa
chiaroscuro del Merisi
stretto chicco d’uva fragola come fosse un uragano
moltiplicato a schizzi su pareti in guanti bianchi
divaricate a terra ora
"... tu aprimi al tuo fiato singultato, viola di Tchaikovsky"
Doris Emilia Bragagnini, nata in provincia di Udine, dopo un’iniziale formazione scientifica si diploma all’Istituto Statale d’Arte dello stesso capoluogo. Considera e definisce con queste parole la sua biografia più essenziale: ”nata nel nordest vive da sempre a due passi da sé, qualche volta v’inciampa e ne scrive”. Compare con suoi testi in alcune antologie e prefazioni per sillogi poetiche, in blog e siti letterari web come: Filosofi Per Caso, Il Giardino Dei Poeti, Neobar, Torno Giovedì, Arte Insieme, Carte Sensibili, Le Vie Poetiche, VDBD, La poesia e lo Spirito. Ha partecipato al poemetto collettivo “La Versione di Giuseppe. Poeti per don Tonino Bello” (edito da Accademia di Terra d’Otranto, Neobar 2011). Inserita nell’antologia Fragmenta (premio Ulteriora Mirari ed. Smasher, 2011). È redattrice del blog di letteratura e poesia “Neobar”.
Cura il blog personale ”Inapparente Crèmisi” http://inapparentecremisi.wordpress.com/ .
Chetro De Carolis, poesia inedita, “Hammerklavier”
Hammerklavier
Batte forte le tre.
Meraviglioso cola nella misura il tempo.
Lo marca, con passione, lo scandisce.
Lo tira, lo scompone, lo dilata.
Lascia in sospeso. Disfa, lega, rifà.
E adagio cade netto sul rintocco,
mai disatteso.
Batte forte le sei.
Sbriglia le crome indocili, le sparge, le rincorre,
le sincopa, scompiglia la Via Lattea.
E la sostiene. Fino al nuovo rintocco.
Riempie sempre esatta la misura,
con molto sentimento.
Batte, batte le nove.
Un poco più agitato, altera il metro.
Toglie un accento.
S’inclina l’orbita dell’astro.
Sospiro.
E torna a battere, piano sui tre quarti.
Lento al buio ritarda. Vacilla su una nera
imprevista. La soffoca.
Sprofonda, nell’eclissi della bianca.
Tace.
S’arresta il fiato dell’universo attonito.
Serra, il silenzio,
eterno.
Tlin tlin clin clin tlin tlin clin…
Risale il peso, scintillando ad libitum.
Il pendolo riprende il battito, opalino.
Piena libera l’una.
Chetro De Carolis nasce l’8 gennaio 1972 a Roma, figlia di artisti.
Dottore di ricerca in Letteratura francese (Roma, La Sapienza), specialista delle forme del narrare nel XVIII secolo, ha pubblicato saggi su Prévost, Montesquieu, Godard d’Aucour, Diderot; in maniera più marginale, si è interessata ad autori del XX secolo (Beckett, Queneau) e, nell’ambito del LARC (Laboratorio Ricerche sul Contemporaneo), a testi dell’«estremo contemporaneo». Dal 2005 al 2010 ha insegnato a contratto la Letteratura francese e inglese e la Traduzione letteraria, in diversi atenei italiani (Roma, La Sapienza ; Napoli, L’Orientale ; Salerno). Dal 2005 è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Sigismondo Malatesta.
Traduttrice. Tra i suoi lavori : A. Hamilton e M.G. Lewis, Les Quatre Facardins / I quattro Facardin, Roma, Bulzoni, «I Libri dell’Associazione Sigismondo Malatesta», 2008 ; Vivant Denon, Point de lendemain / Niente domani, Roma, Portaparole, 2013 ; Molière, Le Misanthrope / Il Misantropo, in Molière, Teatro, a cura di Francesco Fiorentino, Milano, Bompiani, prev. 2014.
Negli ultimi anni si è via via concentrata sulla traduzione poetica, sia a livello pratico che come oggetto di riflessione: per la Revue Italienne d’Études Françaises (www.rief.it), ha tradotto e commentato poesie di Riccardo Held, Valerio Magrelli, Gilberto Sacerdoti (RIEF, 1, 2011) e Jacques Réda (RIEF, 2, 2012).
Attualmente lavora a una nuova traduzione delle Poésies di Mallarmé, per la collana «I fiori blu» di Marsilio, Venezia (prev. 2014).
Tra i suoi work in progress : Abolìa, diario in versi, in italiano; Cellule, poema narrativo, in italiano; Frammenti, poesie in diverse lingue, che si propagano nella materia attraverso una serie di opere d’arte plastica, « Isole »: alcune di queste poesie – «Sibelle», «Entre», «Ein-Fried-Hof» – saranno pubblicate nel prossimo numero della rivista francese Incertain Regard (juin 2013).
Oronzo Liuzzi, immagini, “Meteoriti di poesia” con un breve commento di Alfonso Lentini
Queste "meteoriti" luccicanti e colorate di Oronzo Liuzzi sembrano provenire da un altrove, da una dimensione aliena dei cosmi o delle menti e sembrano farsi portatrici di messaggi muti ma intrecciati a una misteriosa idea di bellezza...
Oronzo, come me, lavora con i sassi e con altri elementi naturali, intervenendo su di essi con discrezione e rispetto. Estrarre, "spremere" poesia dalle cose, dagli oggetti, dalla natura: mi sembra sia questo uno dei fini più alti che gli artisti contemporanei dovrebbero perseguire. (A. L.)

Oronzo Liuzzi (1949), laureato in Filosofia Estetica, vive e lavora a Corato (Ba).
Artista poliedrico, utilizza tecniche espressive diverse. Ha pubblicato una ventina di libri tra poesia e narrativa. Tra gli ultimi volumi editi ricordiamo Plexi (Campanotto 1997), Via dei barbari (L’Arca Felice 2009), In odissea visione (Puntoacapo 2012).
Settembre 2013, anno X, numero 20

Rosa Pierno, presente nella redazione di “Anterem” dal 1992, ci propone un itinerario poetico attraverso i finalisti dell’edizione 2012 del Premio Lorenzo Montano per la sezione “Opera edita”.
La sua attenzione critica si è soffermata su Gian Maria Annovi (“Kamikaze”, Transeuropa 2011), Primerio Bellomo (“Primo vere”, Enchiridion 2011), Francesco Marotta (“Esilio di voce”, Smasher 2011), Marco Ercolani (“Sentinella”, Carta bianca 2011), Luigi Fontanella (“Bertgang”, Moretti & Vitali 2012), Antonio Pietropaoli (“Dissezioni”, Oèdipus 2011), Paolo Ruffilli (“Affari di cuore”, Einaudi 2011), Alessandro De Francesco (“Ridefinizione”, La camera verde 2011).
Ogni poeta viene qui presentato, oltre che con la nota teorica di Rosa Pierno, con un testo esemplare tratto dalla raccolta.
Alessandro De Francesco, “Ridefinizione”, La camera verde 2011
ancora discendendo si immette giù per il tubo una
clessidra di vene e la sacca che potrebbe contenere
tutti ma prima è necessario liberare i fatti dalle cause
sta guardando il paesaggio dal treno in galleria
somiglia alla polvere come se fosse possibile tornare
nel vano scale bianco sul pianerottolo vuoto
passavamo dal parco premevamo l’interruttore
l’ingresso di finto legno illuminato a timer un
lavoro di emersione
Che in Alessandro De Francesco vi sia la necessità di partire da ciò che lo circonda, e in particolare dalla valutazione geometrica degli oggetti, la quale gli consente di collocarli in uno spazio misurabile e di conoscerne le distanze, quasi fosse l’unica cosa che se ne possa attestare con certezza, è fatto incontrovertibile di tutta la sua produzione poetica. D’altronde, se è vero come diceva Wittgenstein che “La verità non è nelle cose ma nel linguaggio”, e se: “come adesso che il pensiero non ha verità da / proporre la domanda e visto dal buio molto di quanto afferma le azioni che potremmo compiere sono una pellicola in un proiettore spento”, ciò equivale a dire che quando si avverte insufficienza nell’espressione, e per mezzo dell’espressione stessa, ciò implica che si stia di fatto agendo in una sorta di scatola chiusa, ambiente asettico in cui si può sperimentare quanto del linguaggio ci travolga anche in modo consuetudinario, ci trasporti alla deriva, ci privi di relazioni esperienziali. Il testo di De Francesco lo si può anche assumere come coincidente con tale esperimento e, di conseguenza, si potranno verificare i meccanismi di filtro messi in atto, le lacune lasciate volutamente aperte anziché provocarne l’occlusione con materiali incongrui, la verifica dei pesi e delle misure nella rete dei significati, lo scarto rivalutato a fronte del risultato atteso e forse trovare in questo, ancor più che in qualche definizione dogmatica, la consegna, il lascito di questo lavoro. Lavoro di raccolta delle differenze anche minimali, delle variazioni rispetto alla via prestabilita, contro la regola unificante, che trova un suo naturale limite nella biologia, forma fisica, di cui il testo è ricchissimo di riferimenti: “ancora discendendo si immette giù per il tubo una / clessidra di vene e la sacca che potrebbe contenere / tutti ma prima è necessario liberare i fatti dalle cause”. Come accennavamo in esergo, liberarsi dalle convenzioni, ad esempio di causa ed effetto, come humeiano dettato richiede, vuol dire inevitabilmente anche riposizionarsi in quanto soggetto, fosse pure un soggetto che rifiuta identità e che si forma solo tramite l’accumulo dei suoi momenti percettivi e ideativi. D’altronde, un tale soggetto, alla fine, quadratura del cerchio, non può che individuarsi attraverso le sue coordinate geografiche come recita l’ultima poesia: “fruscia / si sposta /esce”. (r. p.)
Antonio Pietropaoli, “Dissezioni”, Oèdipus 2011
Dissezioni
dapprima si verifichi il grado di tolleranza
alla discussione, alla critica, alle intemperanze.
poi si prendano le misure più adeguate,
le posizioni più opportune – mai al centro
della scena, piuttosto ai margini, in angolo
(da dove si domina la scena).
ci si disponga quindi ad osservare
interloquire rimuginare interagire,
come tra perfetti estranei.
infine si proceda al primo affondo
un’incisione netta, qui, dove non circola
più sangue, dove tutto è melma e ristagno
(ma con dolcezza, mi raccomando:
era, è stata, fu, carne viva)
Nella scrittura di Antonio Pietropaoli, le parole si susseguono fluenti come cavalloni sulla spiaggia che riescono a sorprendere a ogni rincalzo di rima facendosi di volta in volta più pressanti: “mi disloco e mi slogo, mi sgolo tra me / e me, in silenzio, e così finisce che mi sfogo / e mi raffiguro la mia albicocca diroccata / come un’albicocca da un verme devastata”. L’apparente facilità derivata da una fluidità da filastrocca non per questo ne assume il non-sense. Anzi, potrebbe rivelarsi come aspetto ludico di una dramma d’insufficienza: il soggetto non può opporre che la parola. Senza mai perdere contatto con gli aspetti giocosi con i quali si può rivoltare il punto di vista con cui si guarda alle cose, pure “il dileguar del vero” e” il sogghignar della menzogna” non lasciano spazio a una elaborazione a-problematica della realtà, a una rinuncia. Nonostante il tono a tratti scanzonato, ilare o ironico, resta intatto lo scontro frontale con la realtà, il quale denuncia una incapacità di accettazione da parte dell’autore. Vogliamo dire che il tono – a tratti licenzioso – non copre il rumore sordo della disputa. Le strategie approntate dal poeta – vere e proprie pantomime foniche diremmo – sono tentativi di adattarsi, di trovare un modo di coabitare: se l’uomo abita sempre un mondo, non è detto che questo mondo sia ospitale. Sarà però il risultato più un infilare smacchi e delusioni in una lunga collana che un giostrarsi e un risolvere e nemmeno per il rotto della cuffia. Non è esattamente il recinto di accettiana memoria quello messo insieme da Pietropaoli con le sue strategie, ma una sorta di costante gioco al rialzo e si direbbe che ciò accada quanto più sa di perdere per quel non rifiutare nessuna possibilità esperienziale. In questo senso “Dissezioni” è titolo che indica che né il dolore né le condizioni peggiori portano a una consunzione o una disfatta poiché nell’analisi e nella consapevolezza si produce appropriazione: fare di tutto questo il proprio sé. C’è sempre qualcosa da cui ripartire, di cui scrivere. Fosse pure la propria amara disillusione, ma anche una accordata adesione a quel che è, all’esistenza, sempre accolta con sonora e calorosa partecipazione. (r. p.)
Francesco Marotta, “Esilio di voce”, Smasher 2011
scrivi strappando chiarori di pronome
dalla voce la luce malata
che s’innerva al rantolo
di un verbo scrivi con lo stilo
di ruggine che inchioda l’ala
nel migrare anche la morte
che sul foglio appare dal margine
di sillabe di neve s’arrende alla caccia
al sacrificio necessario
dell’ultima lettera superstite
Nell’ultimo libro di Francesco Marotta “Esilio di voce” Smasher, 2011, risalta, immediato, il forte motivo della scrittura ingaggiante con la realtà una lotta per l’egemonia, poiché si direbbe che il senso appartenga soltanto alla scrittura, a una realtà artificiata, dunque. Innanzitutto è una scrittura che s’accampa su qualsiasi superficie: pelle, occhi, carne e si appropria di vocaboli che appartengono alla natura: argine, margine, sentiero, pietra, acqua, cielo. Ma soglie, ombra, specchio in qualche modo ne fanno echeggiare come un falsetto la nuda sostanza, pura inconsistenza, denunciandone la falsa legittimità ad accamparsi in vece del reale. Già in difficoltà, il linguaggio viene aggredito dal poeta che ne mostra con grande tensione le lacune, le fallacie, gli scarti dal senso comune in agguato. Torsioni imposte al linguaggio non ottengono che di mettere in nuce fatiche, eccedenze, discordanze e, forse, un’offerta di silenzio. Ma anche il silenzio, come pausa in ovattata neve, pur se “accordo muto”, non è che misero traguardo. La guerra non vede una sola battaglia, ma molteplici vittorie e sconfitte. Il poeta denuncia la supposta vittoria del linguaggio sul reale, e in fondo l’insensatezza della pratica della scrittura rispetto all’esigenze di un’esistenza che richiede di essere vissuta e non scriversi addosso. Eppure, il linguaggio non è il nemico, lo si vede nella raffinata elaborazione poetica che non disdegna assonanze e rime sparse, quasi inattese, le inarcature frequenti, le variazioni incessantemente cercate, pur nella ripetizione di alcune parole-chiave, le quali fungono da boe per il reticolo tematico, il tutto nella forma della metrica libera. Tale cura, affettuosa e carezzevole, ci restituisce una voce interiore accorata e umanissima. In ogni caso la tessitura che si va stringendo forma un tappeto sonoro in cui i termini della scrittura sono frammisti e oramai inglobati con i lessemi appartenenti all’ordine naturale e forse l’impossibilità di distinguere fra di essi potrebbe costituire l’utopico sogno di Francesco Marotta. Se è certa la disfatta è anche salvo l’onore data la resistenza attuata tramite tale metafisico esercizio, in qaunto l’assenza appartiene alla totalità e riduce ogni dettaglio al nulla. La stretta rete ha trattenuto pagliuzze d’oro in sospensione acquorea e ora bagliori indicano l’esistenza della sostanza così strenuamente cercata, impossibile da individuare altrimenti che con la scrittura, naturalmente, poiché al vuoto, a “ciò che arde senza pensiero” si oppone proprio l’oscuro denso corpo della scrittura e non è detto che non sia essa la via salvifica da percorrere per non diluirsi nell’assenza: “l’ultima possibile nascita d’indivisa appartenenza”. (r. p.)
Gian Maria Annovi, “ kamikaze”, Transeuropa 2011
brilla corpo-kamikaze:
stella avariata
spunta le dita dei passanti
le falangi per aria
in un volo armato di
colombe
(tutto il mondo è bombato)
che nel balzo ti inclina
la schiena
che ti sbalza la pelle
di costole / di vertebre
che piombi acceso sul selciato
Il contatto tra un terrorista che accetti di suicidarsi per portare a termine la sua azione omicida e il singolo in un qualsiasi angolo del mondo che vi riflette avviene mirabilmente tramite il riflesso delle posate, come se il loro bagliore potesse essere un segnale, un decifrabile messaggio, quasi potesse valere come anello di collegamento.Flebilissima analogia che equivale a dire: nessun contatto possibile, e proprio mentre si subiscono indirettamente le conseguenze dell’atto terroristico. Una non accostabilità che però pretende un giudizio. E pertanto richiede il passaggio tra immagine mediatica e immagine interiorizzata, in un vano tentativo di acquisire quest’ultima come un dato d’esperienza. L’autore prova a immaginarsi quel che accade al corpo del terrorista mentre l’esplosione deflagra: fra brandelli di corpo e fili elettrici, letteralmente presta il proprio corpo all’altro e valuta quel che resta. E viene qui in mente il ruolo dell’immaginazione nella conoscenza esplorato da Cartesio e da Spinoza. Tra splendidi rottami di immagini sbranate dalla fiammata, Gian Maria Annovi inscena la contiguità di ciascuno con quello che accade nel mondo e si prova a imbastire punti di sutura con una storia che sembra trasvolare sulle nostre teste, che non ci appartiene e a cui pure partecipiamo. “Calcola il limite del credersi presente”: immerso nel farsi della storia è, in realtà, assente da se stesso nella maniera più propria: quella dell’alienazione. Schiacciato dalla macchina mediatica, “parla la lingua che non conosci / che non comprendi ma ha / senso”. Preciso come un laser Annovi inchioda con una definizione: “tu corpo-ostaggio / ostinato ostacolo a te stesso”. Corpo che trova un utilizzo soltanto nella macchina propagandistica dei mass media. Eppure non è prevedibile e chiusa questione: il doppio si rivela l’autentico, nel meccanismo che tutto distorce: “ma tu mi miraggi / e malamente mi raggiri”. Ancora nel corpo e attraverso il corpo: entrambi distorti (attentatore, fruitore mediatico) da una storia che non riconosce entrambi, se non parzialmente, se non temporaneamente. Non è che l’ansa di un gomito ed ecco che i due figuranti divengono fuscelli trascinati da un medesimo gorgo privo di direzione e scaricati in una fossa comune. Un unico appello e un unico strumento resta: la lingua. Attraverso la lingua si può comprendere ed evitare. Perché la lingua costringe al pensiero e il pensiero reclama il corpo come cosa non riducibile a esso. (r. p.)
Luigi Fontanella, “Bertgang. Fantasia onirica”, Moretti&Vitali 2012
Solo restai con me stesso
e di lontano mi trafisse un grido
come uno sghignazzo d’un uccello nero
che volava sopra le rovine. Per terra
era rimasto un quadernetto (un pegno, forse?)
dimenticato da Gradiva. Lo sfogliai
trepidante guardando i disegni a matita
della Pompei antica e di colpo pensai
nulla si dimentica
senza una nascosta ragione.
Una passeggiata onirica, poiché apparizioni di dei e di persone vissute in antica età si susseguono sul lastricato pompeiano percorso dall’autore. È da un denso tessuto di studio e vita vissuta che tali fantasmi emergono e le figure leggendarie si intersecano con più le fugaci apparizioni delle persone su cui egli ha posato, in strada, per un lungo istante lo sguardo, che avrebbe voluto fermare e che dunque, ora il poeta crede di riconoscere. Il divario fra ciò che è realmente vissuto e ciò che è immaginato comunque resta: “colsi un fresco ramo d’asfodelo / pensando quanto inutile / fosse tutto il mio sapere / e quanto indifferente il mondo ad esso” misurando così anche la necessità di rifugiarsi in un mondo più accogliente e rispondente del presente alla propria interiorità o almeno in cui s’intreccino senza soluzione di continuità cose lette e cose reali. Il linguaggio si fa levigato, plana, si mostra suadente e lineare, quasi per irretire il lettore e per rendere più concreta la presenza onirica, non è però nemmeno lontano dal volere abbagliare l’autore stesso (ora in terza ora in prima persona). Non è che un rincorrere ciò che non è reale e mai lo è stato, eppure nella rete testuale s’intercetta lo sfarfallio, il bagliore, la serica figura di una giovinetta, il flebile rumore di leggiadri passi che da soli danno senso alla ricerca. E che importa se essa si basa su indizi del tutto illusori e su illazioni. Inutile chiamarli deliri, averne paura, temere di trovarsi dinanzi le proprie visioni in carne e ossa. Passato e presente condividono sempre più il medesimo teatro, acuendo la percezione di una saldatura tra quel che sappiamo e quel che viviamo. A tratti il disconoscimento può essere frutto solo di una voluta dimenticanza: un rimosso “capace di operare e di produrre effetti / sotto influsso di eventi esterni” e non alieno dal tirare in ballo un “erotico sentire”. In ogni caso, capace di riportare alla vita, anche in un momento spento o arido dell’esistenza. Verranno a ricongiungersi donna ideale e donna intravista, ma non crediamo sia così saldato il divario tra mentale ed esperienziale, restando intatta l’insanabile frattura, la consapevolezza della sua irrealizzabilità fisica. (r. p.)
Marco Ercolani, “Sentinella”, Carta bianca 2011
Disegno sul muro con temperini spuntati, città inutili e favolose,
composte di nuvole o di foglie. Di quelle città, dove sono sveglio
e dove dormo, sono io la sentinella.
Le vedo, circondano il precipizio: sono montagne reali.
Non conoscere le risposte e non comprendere le domande: sapere.
Ogni realtà rinvia a realtà ulteriori, tangibili come la polvere nell’aria.
Se la luce che arriva sul foglio fosse tanto forte da cancellare le parole...
Sebbene le forme aforistiche, brevissime, sospese nel bianco siano come nebulizzate intorno a un fulcro che non si individua, pure i lettori possono puntare saldamente i piedi su alcune parole che si ripetono e che servono per tenersi ancorati durante la lettura al fine di ricostruire una griglia di riferimento. Non cesellate, ma quasi gettate, a tratti legate a una rifrangenza casualissima, ricche dell’humus dell’ambiguità che colloca i periodi non in un costellazione, ma in un’aureola che si espande. Eppure, le frasi sono raffrenate, più che tenute insieme da alcune affermazioni assertive: “ha il dovere di”, “nessuno deve esserlo”, in ogni caso da tempi verbali che sono perentori: solo presente e futuro, verbi nominali o verbi che annunciano profezie, verbi che aprono al progetto: “la sentinella aprirà le porte della casa che custodisce” o infiniti che valgono come comandamenti: “Custodire ponti da cui erompe l’acqua violenta dei fiumi”. Ma ecco ci stiamo avvicinando, ora ci sembra di distinguere più chiaramente il modo colloidale con cui le frasi stanno assieme: “Vivere dentro pagine che tornano come ossessioni”. Sarà il libro in cui risuonano i mille libri “venuti” anziché a venire (parafrasando Jabés). La coscienza dello scrittore è completamente immersa nella scrittura. La presenza costante di riferimenti a opere d’arte non è che uno specchietto per le allodole, a nostro avviso, poiché il soggetto del testo qui è esclusivamente la letteratura e le definizioni presenti, più che parlare di arte, inseguono solo le scritture che ne fanno uso. Questa presa salda sulla materia scritturale è di per sé il soggetto nemmeno paludato di un iperspazio letterario, di una camera degli specchi in cui il lettore è presto preso dal vortice, in cui non deve cercare l’identità dello scrittore, ma della scrittura, se mai fosse possibile. Tale è la strana, efficace macchina messa in piedi da Marco Ercolani, in cui l’autore si assume l’onere di tessere la spola fra le scritture ‘altre’, di essere lo scompaginatore dell’ordine altrui, ma solo appunto per rilanciare la scrittura. Non è escluso lo svuotamento di senso per dare maggior risalto all’attività della scrittura come l’autore stesso, annuncia: “I libri si rispecchiano l’uno nell’altro” e “ Gli stili sono strumenti accordati da interpreti diversi”. A noi misurare, quanto si sia distanti dal libro leibniziano. Anche se qui non è importante la totalità, ma il metodo. (r. p.)
Paolo Ruffilli, “Affari di cuore”, Einaudi 2011
Il letto
Il letto per l’amore
è un campo di battaglia
del mistero:
vi dura la pace
nella guerra e nel conflitto,
più si è morti
più si vive meglio
da risorti
e, colpendo,
ognuno
vuole essere trafitto.
Il sacro vi si infanga
e si bestemmia,
salvato
nel suo essere violato.
Chi cattura
vuol farsi prigioniero
e la ragione è sempre
di chi ha torto.
Qualsiasi arma
è buona
in questo corpo a corpo.
Di insolita, risolta leggerezza, senz’altro raffinata da una consumata capacità espressiva ed esperienziale, i versi di Ruffilli divengono subito una seconda pelle, in cui ci troviamo perfettamente a nostro agio. Senza tema di rivisitare il tema più affrontato in poesia, usando parole semplici e comuni, il poeta riesce perfettamente e con sapiente naturalezza a trasmetterci la freschezza e l’essenza del fatto amoroso, anche se non dovremmo usare l’astratta parola ‘amore’ che rimanda a ciò che non si percepisce: qui piuttosto con la stessa ossessione con la quale si reitera l’atto dell’unione fisica, si tenta la pagina con l’elenco degli attacchi e delle vinte resistenze, con le penetrazioni e le disfatte, in un elenco, cioè, tutto giocato sul piano dell’esistenza, del contingente, della trasformazione inesausta: nessuna astrazione, dunque, se non per prendersene gioco: “E nell’averti in me / è il ritrovarmi / intero / al centro / senza che / mi costi / nella coincidenza degli opposti”. Si noti anche il ritmo velocissimo, sempre inviato a soluzione, come farebbe un pescatore che al minimo strattone, tiri con colpo da maestro la lenza e la preda in barca. Allora, dicevamo, mai astrazione in questi versi, nemmeno però mai privi di un pensiero a tratti aforistico, di ironia giocosa, e, vorremmo dire a gran voce, felice! Che mette in conto gli smacchi come un non evitabile aspetto dell’amore stesso, d’altronde subito virato da Ruffilli verso l’aspetto complementare e favorevole. Gran maestro di cerimonie, sapiente dosatore di inganni e illusioni, sempre consapevole del gioco contraddittorio, ma non per questo negativo dell’amore, il poeta ci conduce per mano nell’esplorazione di ogni singola percezione, odore, sapore, temperatura corporea, di ogni sorriso o soddisfazione con una lingua docilissima e capace di esprimere sottilissime nuances. Ove l’essere posseduto equivale all’essere perduto e salvato allo stesso tempo, dove il riconoscere che qualcuno ami più dell’altro non è motivo per abbandonare la presa, ma per giocarsi la partita con maggior passione: tant’è che essere in amore equivale tout court ad essere. (r. p.)
Primerio Bellomo, “Primo vere”, Enchiridion 2011
prossima l’alba
cede al giorno la notte
al chiaro il sonno
si smemora nel vento
al primo verde il bosco
*
s’apre al mondo ed è
già fiore aria vento
ed ombra il muschio
lutto e segreta gioia
il lasciarsi accadere
Ciò che si palesa in forma oppositiva: la notte che cede il passo al giorno, il buio che si dissolve al primo chiarore dell’alba, è inscenato in un canto dove il passaggio da un estremo all’altro è attuato con graduali trapassi. Le tinte si scuriscono, acquistano viraggi sinistri, l’oscurità non si spegne, grava indelebile: “fu sorpreso dal / lato oscuro del vento / dal suo cercare // nell’abbraccio dell’ora / l’alba di un altro cielo”. Fra le fibre del testo viene a insinuarsi un granello, qualcosa che provoca fastidio, disagio e una sensazione di mancata aderenza. Sono parole che hanno un carico filosofico, che s’innestano, estranee, in quella che era una dichiarata descrizione naturalistica dell’alba o della primavera. Parole che appartengono a questioni problematiche, disarcionanti: ‘impensato, ‘assenza’, fantasma, ‘oblio’. Come in una scatola scenografica in cui si passasse da un sogno a un incubo, i colori sono radicalmente cambiati, ogni elemento appare gettato o macchiato dall’oscurità, desostanziato, percettivamente incerto. La trasformazione è tale che le cose assumono altre valenze: “aggruma e scioglie sensi / veglia di nuovi segni”. Eppure, di fatto, nulla sembra veicolare nuovi significati, anzi gli elementi in scena appaiono deprivati persino di ciò che originariamente avevano, ove parrebbe, pertanto, che il senso, quando sia univoco, costituisca un pericolo per la polisemia.
Nella seconda poesia che compone il brevissimo libro, il giardino zen - seconda scenografia la chiameremmo - tutto sembra già estenuato: ‘il niente del cielo’, ‘arreso al suo finire’, ‘senza più ombre’, quasi un meccanismo con cui risalire all’origine, immaginare il momento primordiale, quello in cui ancora non è apparso il senso. Fallimentare esito, però, testimoniato da un’immagine ancora naturale: “leggi nel bianco / l’enigma del vento / troppo vasta l’aria / ala della distanza”. La natura resta una risorsa che, a prescindere dalla possibilità d’immaginare l’origine, contribuisce a facilitare una percezione molteplice che diventa antidoto bastevole al fine di ricreare il mondo, naturalmente non più naturale, ove ‘scintilla’, ‘fuochi’, ‘stimma’, ‘seme’, ‘varchi’, ‘sangue’ si oppongono all’impensato e si radicano nel senso con la tenacia e l’imperio di un atto volontaristico. (r. p.)
Marzo 2013, anno X, numero 19
.jpg)
Silvano Martini scriveva che "la letteratura, in particolare la poesia, allarga lo spazio della vita". Con la proposta di altri autori finalisti al “Montano 2012”, nell’emozione dell’inedito come nel numero scorso, questo nuovo “Carte nel vento” prova ad allargare gli abituali confini dei generi, spaziando tra poesia e prosa poetica, tra saggio e prosa. Tutti gli interventi sono commentati dai redattori di “Anterem”, esattamente come accaduto dal vivo in occasione del Convegno Anterem di novembre 2012.
Ricordando che l’edizione 2013 del Premio Lorenzo Montano è in corso fino al 15 aprile 2013, auguriamo a tutti gli appassionati buona lettura.
In copertina, Kiki Franceschi, Le scrittrici
Scarica il bando del Premio che scade il 15 aprile 2013
Emidio Montini, poesia inedita, con una nota di Marco Furia
Tutto è terra
1
Tutto è terra, semina profonda,
acqua – umore che feconda.
Tutto è aria, tempo che confonde,
fuoco – la morte lo diffonde.
Tutto è terra, brulichio battente,
acqua – sogno del demente.
Tutto è aria, luce che converte,
fuoco – la vita lo diverte.
2
Tutto è terra, anima perdente,
acqua – enigma renitente.
Tutto è aria, mistico quarzo,
fuoco – febbrile a marzo.
Tutto è terra, sforzo salutare,
acqua – arcigno navigare.
Tutto è aria, stormo variegato,
fuoco – un unico peccato.
3
Tutto è terra, effimero vincente,
acqua – nascosto continente.
Tutto è aria, testamento segreto,
fuoco – a ciò egli pone il veto.
Tutto è terra, l'ora che fa male,
acqua – tana primordiale.
Tutto è aria, fiore che rinviene,
fuoco – amore lo sostiene.
4
Tutto è terra, urna giudiziosa,
acqua – sfera misteriosa.
Tutto è aria, flora di carburi,
fuoco – egli fa che duri.
Tutto è terra, festa di cicale,
acqua – diametri di sale.
Tutto è aria, dio innamorato,
fuoco – ossido sanato.
“Tutto è terra”, di Emidio Montini, è raffinata poesia cui la rima baciata conferisce un ritmo
dinamico e, nello stesso tempo, riflessivo.
Dinamico, come dimostrano, ad esempio, i versi
“Tutto è terra, anima perdente
acqua – enigma renitente”,
riflessivo, come nella pronuncia
“Tutto è terra, urna giudiziosa
acqua – sfera misteriosa”.
La distinzione, come si può facilmente vedere, ha valore del tutto indicativo, poiché i due aspetti sono contemporaneamente presenti.
Un’elegante compattezza è la cifra stilistica di una versificazione che accetta l’uso della consonanza ritmica, essendo ben consapevole di come nessuna forma debba essere rifiutata a priori.
Ho letto con piacere e interesse una battente sequenza poetica che mi ha indotto sia a correre da una parola all’altra, sia a soffermarmi su pregnanti, brevi, articolazioni verbali capaci di promuovere
feconde meditazioni.
I tempi, ovviamente, variano: l’itinerario di superficie si svolge secondo ritmi veloci, quello più profondo per via di cadenze che tendono ad attenuarsi al fine di consentire riflessioni ampie e
coinvolgenti.
La lettura, tuttavia, resta unica pur nei suoi diversi aspetti, poiché Emidio è tenace creatore di una lingua che si lascia percorrere secondo diverse direzioni, ma che si guarda bene dal pericolo di una
frantumazione disgregatrice.
L’esito è efficace e poeticamente convincente.
Emidio Montini nasce nel 1954 in una valle del Bresciano fra le più laboriose e chiuse a tutto ciò che non ricada sotto la voce “tempi e metodi”. Forse, a condurlo ignaro verso quella vanità chiamata poesia, può essere stato quell'elemento, primitivo e sacrale, ereditato da parte materna. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni poetiche dal 1978 ad ora: Poesie (La Voce del Popolo, Brescia 1987); A Colloquio con l'Angelo (Edizione del Leone, Venezia 1990); Mutamenti e Identità (Edizioni del Leone, Venezia 1992); Cassandra la Bella e altre cose (Edizioni Tracce, Pescara 2002); il romanzo breve Il Panico e la Grazia (L'Arcolaio Editrice, Forlì 2008); Uodishallo - Diario Africano (L'Arcolaio Editrice, Forlì 2009); La Moneta a noi Donata (L'Arcolaio Editrice, Forlì 2010); Parola di Scriba ( L'Arcolaio Editrice, Forlì 2011). Numerose le recensioni su quotidiani e le segnalazioni in vari premi letterari, fra cui un secondo posto al Premio Montano.
Tiziana Gabrielli, poesia inedita, con una nota di Marco Furia
Dall'ombra all'ombra
Dài loro annunzio duplice:
di te e di te,
dei due piatti della bilancia,
del buio, che chiede di entrare,
del buio, che consente di entrare
Celan
Preludio
Scintilla nel nero
il canto dell’ombra
perduto mondo, perduta lingua
del vuoto
e l’ignoto
il suono è
quel che non dice
e sa
dell’incessante
ac-cadere
Dire la Vita
prima di ogni pronunzia
per chiamarla per nome
nel silenzio di tutti i nomi
dal silenzio di ogni inizio
À rebours
*
‹Di buio in buio›
per segni ed enigmi
sui bordi dell’essere
così si ri-torna, non si avanza
è deserto la rosa
rizoma della parola
prima
ec-centrica radice
che si (in)-frange
ad un passo dal giorno
**
Impercepiti sensi
fuga di accenti
destini a scomparsa
Diviso il cielo
esatta la luce
fresca
e nerissima
nel folto del bosco
Deporre il velo,
assottigliare l’orma
dell’identico
nel multiversum
dell’‹uguale a zero›
Dal calice del nulla
fiorisce l’assente, l‘ardente
‹sete di pienezza›
***
‹Di perdita in perdita›
l’evento del suono-senso
e sconfinamento
a un altro dire
‹Vera narratio›
dell’Uno pre-logico
arché-daimon
nell’‹ingens sylva› dell’inexplicable
in-conosciuto sapere
del nuovo pensiero
nascente
Respiro al respiro
dimora esodo dimora
principio fine
Da parola a parola
da silenzio a silenzio
due-in-uno
nel sottosuolo della lingua
voce e arco
alle cose penultime
L’Antipensiero
*
L’‹altro-dal-pensiero›
dice l’estraneo
‹mappa albale›
spazio dell’attesa
t r a
sabbia e oblio
caduta e luce
dal Nulla al Nulla
**
Altrimenti che della parola
dentro le ciglia
del vocabolo
fiato di luna
sulle sillabe sdrucciole
S-radica e scuote
l’acqua sulla roccia
nel solco che unisce
e divide
il ventre rovesciato
della terra
Dal buio pro-voca
l’Altrove
nell’intermittenza
del sangue
e il bianco
che non sa finire
***
In squarci e aperti
da fuga a fuga
margine atriale
tra sentire e pensare
Oro e oblio
seta e miele
lingua e verità
(s)fondo liminare
ri-frazione pendolare
nell’intervallo di ogni assenza
nello stupore acceso
di un bisbiglio
spartito è parola
sepolta
nella nebbia
da cui germogliano i nomi
come luce rapida,
abbacinante
e guizzo di fiamma
Passaggi e versanti
(ac)cenni e varianti
fra l’ostacolo
e la trasparenza
nella somiglianza remota
di un barbaglio
Risuona nell’ombra
l’in-concepibile, l’impensato
che si dà a pensare
“nel silenzio di tutti i nomi
dal silenzio di ogni inizio”
e
“Da parola a parola
da silenzio a silenzio”
mi paiono due coppie di versi che bene rappresentano l’atteggiamento poetico di Tiziana Gabrielli.
Il silenzio cui la poetessa si riferisce, lungi dall’essere inespressivo, è culla del linguaggio.
Dal silenzio sgorga la parola che, dunque, vive anche dell’assenza di se stessa.
Non c’è contrapposizione, antagonismo: il silenzio non è avversario della parola, è sua parte.
Se il linguaggio non contenesse silenzio risulterebbe immodificabile, sempre uguale: non a caso, gli idiomi che, per così dire, non conservano memoria del silenzio sono bolsi, noiosi, banali.
Il silenzio avvia la parola (spiccare il volo è già volare).
Così, gli ampi spazi bianchi di questo componimento costituiscono energia disponibile e gli stessi caratteri grafici, oltre a vivere la loro originale ed elegante esistenza, mostrano il carattere silenzioso della propria nascita.
Non v’è alcun senso del nulla in un silenzio ricco di potenzialità.
Il tutto per via di un tocco preciso, mai incerto, tale da conferire alla versificazione la musicalità peculiare di un ritmo incalzante eppure melodioso.
Tiziana Gabrielli (1969), laureatasi (cum laude) nel 1996 in Filosofia presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, si perfeziona presso la Scuola Normale Superiore di Pisa sotto la guida di Remo Bodei, professore presso l’UCLA (University of California, Los Angeles) - che le conferirà nel 1999 il “Premio di filosofia - Viaggio a Siracusa” (sezione Tesi di laurea) - e di Claudio Cesa, professore emerito di Storia della filosofia moderna. Nel 1997 l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli le conferisce una borsa annuale di ricerca sotto la direzione scientifica di Xavier Tilliette, professore emerito presso l’Institut Catholique e il Centro Sèvres di Parigi e la Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Perfezionatasi in Bioetica presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma tra il 2003 e il 2004, consegue nel 2004 il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, collaborando contestualmente con la “Bayerische Akademie der Wissenschaften” di Monaco di Baviera e la “Schelling-Forschungsstelle” di Berlino e Brema.
Filosofia e poesia dialogano costantemente nella ricerca estetica di Tiziana Gabrielli, che si nutre delle più fertili contaminazioni con le arti visive, la musica e il teatro.
Attualmente i suoi studi sono orientati, per un verso, alle nuove emergenze dell’etica applicata e, per altro verso, alle più feconde declinazioni dell’estetica come polifonia
di forme, linguaggi e codici semantici ed ermeneutici da cui far germogliare l’impensato.
Le sue liriche sono presenti in numerose antologie e riviste ed alcune di esse sono state tradotte in spagnolo e in greco moderno.
Tra i principali riconoscimenti si segnalano: Menzione speciale per l’Italia al Premio mondiale Nosside Internazionale (2007); Premio Letterario “Sergio De Risio” (sezione poesia inedita) sul tema “Il pensiero poetante” (2008); Premio nazionale di Filosofia “Le figure del pensiero” (sezione Aforismi); Premio Letterario Internazionale Maestrale - San Marco – Marengo d’oro (sezione poesia in lingua) (2008); Concorso internazionale “Lettera D’Amore” (2010); “Trofeo della Cultura. Histonium alla Carriera 2010” conferitole dalla Giuria del Premio nazionale di Poesia e narrativa “Histonium” 2010; Premio “Parole 2.0 – Poesia in movimento” 2011. Finalista al Premio di Poesia Lorenzo Montano – sezione poesia inedita (2009 e 2010); finalista (sezione Poesia) al Premio Fabrizio de André “Parlare Musica” (2010).
Rinaldo Caddeo, prosa inedita, con premessa di Mara Cini
La riflessione sulla creatività in poesia può portare verso direzioni impreviste. Laddove si ipotizza una volontà si incontra un enigma: la scrittura “dice” e insieme interroga. Laddove si prevede una collaudata struttura sintattica si presenta un effervescente processo alchemico: il mondo rinasce da un gesto. Il principio della casualità, sempre fecondo nell’arte, fa poi germinare altre significanze latenti.
La scrittura (ma anche la fotografia, la pittura, il cinema) è traccia di un’assenza, una “strisciata in cui si è trasfuso il mondo” , un nastro di segni che si svolge e riavvolge “senza nessun messaggio definitivo”. E per Caddeo forse abita qui l’essenza della “grande” poesia.
CREAZIONE E POESIA: ABISSO ASSENZA NASTRO DI MOEBIUS
Il viaggio di Dante avviene nell’oltretomba, in luoghi sotterranei prima, poi aerei. Laura non è nemmeno un nome, è l’aura, l’ora, lauro, l’auro: il senhal petrarchesco, come e più dei senhal provenzali o stilnovistici, è sempre qualcosa d’altro. Identifica per depistare, più che distogliere per indicare. Risolve nell’altrove l’analogo. Rivelando l’altro, dimostra e nasconde ciò che di simile si cela nel diverso, ciò che di dissimile cova nell’identico. L’ossimoro petrarchesco, unendo gli opposti li smista. Ne allenta la pressione, neutralizzandoli in altro luogo. La letteratura italiana, fin dalle origini, abita altrove.
La grande creazione non appartiene a questo mondo. Canta la mancanza, l’erosione, marca una latenza. Non ha nessun messaggio definitivo, non ha nessun compito circoscritto. Non serve a niente e non è a servizio di nessuno, se non per derisione, coperta o scoperta, ironica o manifesta. La prerogativa sua è di capovolgere. È il nastro di Moebius della lingua: se saliamo da un lato, alla fine della poesia, ci troveremo dal lato opposto.
È un mondo parallelo, uno dei tanti in cui viviamo. Le rette parallele, almeno nella geometria euclidea, non si incontrano mai, ma si affacciano in continuazione una sull’altra. Si ignorano e si spiano. Si fanno anche sberleffi, si lanciano impunemente improperi. Si fanno la guerra senza farsi del male: intanto non si incontreranno. Si copiano all’incontrario come quando la tua immagine allo specchio ti guarda: la sinistra è a destra, la destra a sinistra. La realtà è capovolta, come la scrittura mancina di Leonardo, le lettere sono capottate da uno scontro frontale realtà/intelletto. Del resto anche all’Inferno si procede dal lato mancino.
C’è anche un’elica nascosta del DNA nostro che si ritorce all’elica del linguaggio. Un poesia che si azzuffa con la realtà (Jacopone, Angiolieri, Villon, Pulci, Folengo, Rabelais, Shakespeare, Rimbaud… Mandelstam, Celan): due parallele non-euclidee che s’intrecciano, si sfiorano, si dividono e si stringono per dividersi di nuovo.
«In quel muro in quel foglio/ nell’area bianca che la tua mano cerca/ il mignolo bagnato nell’inchiostro/ sopra strisciato con fiducia/ azzurro corso d’acqua rapinoso/ vena arteria in cui scorre/ a occhi chiusi il mondo». 1 (Cattafi). Basta il dito più piccolo, il mignolo, a creare il mondo, un nuovo mondo, se la punta del dito, bagnata d’inchiostro, lascia una traccia di sé, un segno, su di un foglio bianco o su un muro qualsiasi. Quella traccia ha un duplice valore. È altro senso, un significato pittografico: è un fiume, con il suo corso d’acqua rapinoso. È una strisciata in cui è si è trasfuso il mondo. È il gesto fondamentale, liberatorio, distruttivo/creativo, che fonda sia la pittura sia la scrittura (il linguaggio dei gesti, tra l’altro, antecede il linguaggio verbale). Il mondo non è più, grazie a questo gesto, il contenitore, ma è divenuto il contenuto che, a sua volta, ci contiene. Il mondo è rinato in quel gesto, noi siamo in quel gesto e fuori di esso. Noi siamo dentro e fuori, contenitore e contenuto, vi apparteniamo e non apparteniamo. È lui che si è compenetrato e appartiene a noi. Il nastro di Moebius del testo di Cattafi ha trasformato la parte (noi) nel tutto e il tutto (il mondo) nella parte.
Questa poesia di Cattafi ci racconta la storia dell’uomo. L’uomo è nato quando ha trasformato il mondo con le mani e con la mente. Le dita divengono mani dell’immaginazione. Le une plasmano l’altra. E la mente conduce le dita della mano secondo un progetto di modellabilità del mondo. È l’impronta bianca su terra rossa delle mani dell’uomo paleolitico di 15000 anni fa. Sono le mani, sia destre, sia mancine, sia piccole sia adulte, che hanno scritto, in 3 D e a colori, renne, bisonti, cavalli, (forse rappresentazioni del cielo, icone e prime mappe zodiacali del cosmo), sulle pareti delle grotte di Lascaux o di Altamira. È la prima tag (firma/parola chiave) della storia. Da allora tutto si è ripetuto. L’eguale è ritornato diverso, nel suo eterno, sconquassante ritorno. Da allora è cominciata la multiforme decadenza della storia dell’arte, come ha notato Picasso.
La poesia non è in un luogo, non è nemmeno a sé stante: la poesia è attraverso la strada, per un deserto, a una finestra, in un quadro, su di una pellicola cinematografica, in una fotografia. Non- luogo di ogni luogo, luogo di ogni non-luogo, è il luogo di un luogo.
Le Muse classiche sono nove, quelle moderne molte di più.
Una tavola, un pavimento, un muro, un arenile, un soffitto, la parete di una grotta, una tela, un cielo stellato, una marina, una lastra d’acciaio, una palizzata, una tavoletta di cera, un i-pad… l’iscrizione, l’epigrafe, l’epitaffio, l’haiku, l’aforisma, il graffito, il graffio, lo strappo, la tag, l’action painting, il dripping, una preghiera, una cantilena, un grido, tourbillon d’hilarité et d’horreur (Mallarmé), un’arsione, un taglio, il gesto fondamentale, avviene lì, sopra una superficie. Ma la poesia è soprattutto situata nella pagina bianca. Ercolani ne intercetta le ribollenti latenze. «Il foglio bianco nasconde parole non nate. La scrittura ne rivela alcune.» (Ercolani) 2. «Lo sguardo allora/ germinerà dalla pagina/ e s’aprirà una vertigine/ in questo quadernetto giallo». (Magrelli) 3. La scrittura incide lo sguardo nella pagina che scrive. La possibilità di vedere innesca un risucchio, gorgo del caos e di una ri-nata vita della parola da pronunciare.
E alla superficie sale la profondità, dispiega quel che non si vede, ciò che si trova piegato dentro. In fondo. Scavato nell’abisso. «Quando trovo/ in questo mio silenzio/ una parola/ scavata è nella mia vita/ come un abisso» (Ungaretti) 4.
«Un coup de dés jamais n’abolira le hazard» (Mallarmé) 5. La pagina bianca è abisso di un naufragio che risucchia e si riporta a galla. Il ritmo che scende e sfiora la spuma dei gorghi che sale, è una piuma, l’alito di una sirena, il caso di un colpo di dadi, la cifra di un azzardo. Il verso è il luogo di un’elargizione necessaria contro e verso l’assenza.
Francesca Monnetti, poesia inedita, con una nota di Marco Furia
flash crash
... in giardinetto titoli
“E dove dunque vogliamo arrivare?[...] Dove ci trascina questa possente avidità, che è più forte di qualsiasi altro desiderio? Perché proprio in quella direzione, laggiù dove sono fino ad oggi tramontati tutti i soli dell'umanità? Un giorno si dirà forse di noi che, volgendo la prua ad occidente [...], fu il nostro destino naufragare nell'infinito. Oppure, fratelli miei? Oppure?”
(F.Nietzsche, Aurora)
digital logos
disconnessione
slogan seriale
in logo
presenza virale
... epidemia ... massimale
come legante
vitale l'assenza
... l'essenza
non vale
in-avvertenza
pluscarenza
... collante ... minimale
esile interfaccia
discontinua traccia
... irreperibilità
uncovered
rischio di controparte
svelati liquami
di lividi cuori
dissapori ... livori
incagli
... dis-valori
di scambio
... d'uso
dis-amori
minusvalenze
crediti
... deteriori
sintagmi
triti ... tesi
atrofie ... afasie
da paresi
lesi candori
...
in-sofferenza
dilazione
... scadenza
incombenza
decoupling
... infertilità
regressive impact
meno pronti contro termine
suoli inevasi
... stasi
elusioni
... insane evasioni
speculazioni audaci
aeree ... deiezioni
... BOR ... BOT ... BTP ...
... BERS ... BEI ...
... SPREAD ... BUND ...
... JUNK BUND ...
...
inconvertibili azioni
non smaltibili
innesti
ibridi
sofisticazioni
congestioni
...
margin-ali
tagliati fuori
delusi
reclusi
lasciati
soli
disabilitazioni
... in-attività
contrazioni in benchmark
perdita di riequilibrio
controparte
a rischio
decurtazione
priv-azione
per altrui dissolversi
interferenza
svalutazione
da azione
svincolo
... dis-obbligazione
disavanzo
degenza
indisponibile
indigenza
perdurare
dello stato
d' insolvenza
... dilatata
imponibilità
...
endogeno
esogeno
congenito
... crac
flight to quality
obbligazione di scopo
STEP DOWN ... STEP UP ...
... STEP DOWN ... FLOP ...
.... DOWN
urge ... necessario
rifugio nel bene
... quale bene ...
non più garantito
il proprio fondo
comune non tiene
... ormai un lusso
ogni bene ...
dis-investita risorsa
risibile opzione
rincorsa
cedevole
non più durevole
future
... perpetuo
default
no stop loss
effetti da scompenso
transazione
sfumata
negata ripresa
... rinegoziazione
trattativa
privata
... di-versificazione
calo del tasso
d'interesse
identità
in diminuzione
... in considerevole
perdita
anche il clone ...
mediazione
inesitata
da mansione
interdizione
colloqui
in rarefazione
dematerializzazione
... nessun rischio escluso
globale ... radicale
compromissione
accumulo
da eccedenza
prodotto
... in dominazione
rimozione
oltre ogni limite
... di sottomissione
recessione
borderline
sul baratro
... insostenibilità
...
da discredito
morsa
... credit crunch
miseria e perduta nobiltà
primordiale tensione
menar le mani
nutrirsi
liberare le viscere
riparare dormire
accoppiarsi
coprirsi
accontentarsi di briciole
accoppare lenirsi
contare le ferite
risanare
ricucire
ripulirsi
estinguersi ...
... precipitare
in esaurirsi
manomorta
cappio al collo
... irreversibilità
un-clearing house
intimo scompiglio
ramo morte ... rigor
mortis ... ramo vita
... contro danni
diretta prestazione
... in-differita
causa propria
conto terzi
sovrastrutturale
r-assicurazione
... personale
surrogata
collettiva ...
aggravata
unità di rischio
vaniloquio
la speranza
di una vita
acquiescenza
postuma
immanente
per quietanza
in-fida
brusca
più che certa
fuoriuscita
... causa malus ...
... terminal bonus ...
margine di rendita
esiziale
... indennizzo
residuo capitale
disdetta
riscatto
ricatto
... carovita
...
recesso
esigibile
in sinistra
... dipartita
fumo nei segnali
in evidenza di nesso
spie spente
accese
su spine ... in rete
... senza rete
nessuna via di fuga
tra penuria, congerie
di prese ... simulatori
... interruttori ...
... moltiplicarsi
di rese ...finte riprese
... via etere ...
... via cavo ...
uno solo lo sfiato
da cunicolo stipato
di straforo
... fuliggine
... prurigine ...
... vitiligine ...
... scaturigine
per - tra - foro
otturato
...
s-caduto il soggetto
ancor peggio che
alterato
... spira
sputo
schiuma
schianto
sibilo
... pulviscolo
neanche predicato
del proprio predicato
... violato ...
... scaricato ...
... evaporato ...
... deriva
del proprio derivato
demo ... crasi
... in crisi
refoli
scuri
gelidi
scorie
subodori
... subalterni rumori
da filtri ostruiti
di graticola
avanzare
di pessimi sentori
convulso scomporsi
di perifrasi
... senza sole
... senza cuore
involuto
sfibrarsi
di parole
sporchi giochi
al ribasso
vocaboli avulsi
... a incastro
in guasto, incalzare
di pseudo-incuniboli
intrusi
in occlusi
sensori
estremo degrado
procedure di scioglimento
orrori ...
... fratture
fetori
dis-valori
al fondo del fondo
... labi-ali
... labili voli
... fitte condense
voc-ali ... cadute
da spuri vapori
...
... farsi ... disfarsi
in en-diadi ...
... disseminarsi
in plurimi orgasmi
contro
insane vertigini
... fibrillare ...
... sedare ...
... raggelarsi ...
(s)darsi
in spasmi
e prolassi
... arresti ...
... inerzie ...
... discese ...
... dissesti ...
... rimbalzi ...
... collassi
da lasso
rigore
...
da usura
... paura
granuli e fibre
senza sutura
senza ...
... struttura
in filigrana
raggiro
ristagno
sventura
... perduta misura
fissione
fusione
per fredda calura
in-dotto
rifiuto
ridotta
visura
precaria
distorta
dispersa
natura
abiura
eretta
franata
postura
... mancato riscontro
chiusura
...
verso singolo
e/o consorzio
di varia umanità
pronunciata nullità
società ... modello
parentale, mono
pluri personale,
anonima ... S.r.l.
... S.p.A.
... impresa d'aria
in volatile
liquidità
indice dei titoli
digital logos
disconnessione
uncovered
rischio di controparte
regressive impact
meno pronti contro termine
no stop loss
effetti da scompenso
contrazioni in benchmark
perdita di riequilibrio
flight to quality
obbligazione di scopo
miseria e perduta nobiltà
primordiale tensione
un-clearing house
intimo scompiglio
fumo nei segnali
in evidenza di nesso
demo...crasi
... in crisi
estremo degrado
procedure di scioglimento
... impresa d'aria
Con “flash crash”, Francesca Monnetti presenta un rarefatto poemetto in cui pronunce minime si susseguono secondo originali cadenze che paiono sopprimere la naturale densità del linguaggio.
Dico “paiono”, perché, a ben vedere, tale densità continua a sussistere in affascinanti dimensioni idiomatiche che esulano dai normali canoni.
Non si tratta di mero intento evocativo, bensì di vera e propria volontà di porre in essere uno specifico universo verbale costituito da parole e frasi emergenti in maniera davvero inedita.
Siamo al cospetto del riuscito tentativo di offrire al lettore uno spazio sprovvisto di prefissate frontiere, una galassia nel cui àmbito i collegamenti tra i brillanti astri non sono imposti.
Possiamo dunque creare nuove fisionomie, partecipando a una spiccata originalità linguistica che non ci impedisce di proporre, in piena autonomia, insolite costellazioni.
Lungo questo percorso, molteplici orizzonti si aprono davanti a uno sguardo ora più indipendente, più consapevole dei propri desideri e delle proprie attitudini, uno sguardo ormai anche in grado – suggerisce la poetessa – di scorgere una presenza che è anche enigmatica assenza:
“esile interfaccia
discontinua traccia
… irreperibilità”.
Un’irreperibilità che è mancanza di qualcosa che pure c’è e parla per via degli affascinati versi di questa poesia.
Francesca Monnetti è nata a Firenze il 4 ottobre 1967. Sempre a Firenze ha compiuto studi universitari in ambito filosofico-morale. Attualmente vive nella provincia del capoluogo toscano e lavora nella scuola pubblica come insegnante di scuola primaria.
La sua unica raccolta edita di poesie è giunta finalista all'edizione 2008 del Premio di Poesia Lorenzo Montano (sezione raccolta inedita). Si tratta della prima pubblicazione in volume dell'autrice; ha per titolo in-solite movenze (Cierre Grafica, Verona, giugno 2009) e fa parte della collana “Opera Prima”, curata da Flavio Ermini.
Il blog di poesia contemporanea blanc de ta nuque, ideato e curato dal poeta e critico Stefano Guglielmin, ha ospitato un intervento di Giorgio Bonacini (“Il suono del senso”) sulla raccolta, assieme ad alcune poesie dell'autrice.
Una sua silloge di poesie inedite (siccità,equinoziale e in-fluenze), presenti nella seconda raccolta inedita dal titolo pen-insul-aria, ha vinto la IV edizione del Premio Letterario Sergio De Risio (2010), dedicato al pensiero poetante, la cui giuria era composta da Renato Minore, Cesare Milanese, Flavio Ermini, Giancarlo Quiriconi, Jaqueline Risset, Filippo Maria Ferro, Giuseppe Langella, Marco Tornar, Raffaele Saraceni. La prima stesura della raccolta pen-insul-aria è stata segnalata durante la XXV edizione del Premio Lorenzo Montano. La medesima (in seconda stesura) è giunta finalista alla I edizione del Concorso di Poesia e Narrativa “L'Erudita” (Giulio Perrone Editore - Roma). La poesia singola Siccità ha vinto la sezione omonima del predetto premio, la cui giuria era composta da Cristiano Armati, Paolo Febbraro, Matteo Lèfevre, Giorgio Manacorda, Walter Mauro, Giorgio Nisini e Cinzia Tani; appare anche nel volume antologico dedicato al premio, pubblicato da Giulio Perrone Editore (marzo 2012).
Una poesia singola, dal titolo Fotocopiando enon inclusa nella raccolta edita, è comparsa nell'antologia Poeti Italiani nel Mondo, Book Editore, Bologna 2006.
Nell'anno 2004 un altro testo poetico (insensata - controtempo) è giunto in finale al Premio Firenze - sezione poesia inedita. Con un'altra composizione inedita (con-versi-amo) l'autrice ha ottenuto una segnalazione di merito al Premio Internazionale di Poesia “S. Domenichino- città di Massa”, 2006; tale testo è stato pubblicato sul sito del suddetto premio.
Su invito della redazione della rivista “Anterem” l'autrice è intervenuta a vari eventi, con letture pubbliche di composizioni edite ed inedite.
Una silloge di poesie inedite (Aria di resa e di ripresa), presenti nella seconda raccolta inedita, ha ricevuto una segnalazione da parte della giuria del Premio Letterario Castelfiorentino, edizione 2011, ed è stata inserita nel volume antologico del premio.
Nell'anno 2012 un'altra poesia inedita (flash crash ...in giardinetto titoli, contenuta in una terza raccolta, non ancora edita) è giunta in finale al Premio di Poesia Lorenzo Montano. Sempre nel 2012 una nuova silloge inedita è stata segnalata al Concorso Letterario Arno fiume di pensiero, la cui giuria era presieduta dal Professor Marco Marchi, docente di Lettere presso l'Università degli Studi di Firenze; tale silloge è stata pubblicata sul sito del suddetto premio.
Giovanni Duminuco, prosa inedita, con premessa di Mara Cini
La “foto incollata al muro” della prosa di Duminuco potrebbe essere una di quelle cartoline ritoccate, con i rosa molto rosa, gli azzurri virati al verde e il bianco e nero dell’originale che affiora dal fondo. E tutto intorno appunti, immagini, tracce. Questo è un testo-collage dove sembra di vedere – più che i caratteri tipografici – la sottostante chirografia dell’autore, le sue sottolineature, le sue cancellature… tutti i segni visivi ed affettivi di una personale geografia che, come “stormi di rapaci” rievocano, richiamano, presagiscono “l’imminente sopraggiungere della sera”.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Giovanni Duminuco | 35.57 KB |
Andrea Lorenzoni, poesia inedita, con una nota di Marco Furia
Il verso “conoscenza dell’irrazionale, proprio” chiude il battente ritmo del componimento di Andrea Lorenzoni con una sospensione (all’avverbio “proprio” non segue alcun punto) che, a mio avviso, partecipa dei caratteri dell’apertura.
Ciò che è meramente sospeso rimane interrotto, incerto, chiuso in sé, mentre ciò che è aperto si offre al mondo o, anche, semplicemente a un evento contingente.
Appunto questo mi pare il caso in esame, poiché il dettato di Lorenzoni, così ricco di fitte pronunce, pare essere interessato alle singole circostanze.
L’atteggiamento poetico è chiaramente rivolto a considerare l’umana condizione, la problematica assiduità dell’esserci, secondo lineamenti espressivi che colgono negli aspetti specifici gli elementi indispensabili per orientarsi.
Un po’ come gli antichi naviganti prendevano quali punti di riferimento le stelle per seguire la rotta lungo una massa d’acqua di cui l’occhio non scorgeva perimetri o confini, Andrea si rivolge ai concetti singoli, alle particolari immagini, per costruire le coordinate di un linguaggio complesso e semplice nello stesso tempo, tendenzialmente infinito.
Ecco, dunque, il gesto aperto di cui parlavo all’inizio: le pronunce sono prive di punto fermo perché la capacità dell’uomo-poeta di porre in essere invenzioni linguistiche non è sottoposta, a priori, ad alcun limite.
Insomma, siamo al cospetto di un vero e proprio frammento di un tracciato in possibile ulteriore espansione.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Andrea Lorenzoni - Un passepartout | 21.57 KB |
| Andrea Lorenzoni - Note biografiche | 61.27 KB |
Silvia Favaretto, prosa inedita, con premessa di Mara Cini
La lingua si forma nella gabbia del corpo. Un principio squisitamente fisiologico che di norma sembra sfuggire ai più. Ma quando e dove, precisamente, ha origine questa vocazione? Quando si nasce o non piuttosto quando si inizia a usare la lingua della madre e della propria comunità, quando ci si sporge sul mondo intenzionalmente con i propri pensieri?
Per Silvia Favaretto la lingua, come un embrione, si forma dentro. Come un embrione, a maturazione, si distacca . L’eco del distacco si prolunga nel tempo generando nuovi richiami.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Silvia Favaretto | 235.43 KB |
Stefania Negro, poesia inedita, con una nota di Marco Furia
Ondoso fluttuare di risacca
esala di marine il profumo salmastro
e aleggia nel vento l’anelito del
tempo, ore comprese nel sole, nel fuoco
stellare e nel dissipar della luce
del buio notturno vertiginoso varco
verso l’altrove, universo dilatato
nell’erranza della coscienza. Siamo
fotoni, buchi neri, acqua che scorre, ortica
pungente, mirto inebriante, alterazione,
mutazione perenne, scivolando di continuo
nel qui ed ora sofferto e gioioso, lucido e
folle, amaro e sereno, vivido ed esangue
come un volo di farfalla dentro il
ventre della terra che genera e produce
e annichilisce nel buio scabroso
e nell’oro che riluce.
“tempo, ore comprese nel sole, nel fuoco
stellare e nel dissipar della luce”
è suggestiva pronuncia di un articolato componimento nel quale Stefania Negro contempla l’umana esistenza nel complesso divenire di un universo che, nonostante i grandi passi avanti compiuti dalla scienza, non ha certo perduto il carattere d’immenso, quanto intimo, enigma.
“Siamo
fotoni, buchi neri, acqua che scorre, ortica
pungente”
in “mutazione perenne”, in continuo, sempre rinnovato, movimento.
Questo tema, caro ai poeti, si arricchisce di tratti che a residui di gusto surrealista uniscono un’intensa carica evocativa perfettamente in grado, per via di precise ed efficaci immagini, di mostrare una condizione fonte di poetica meraviglia.
Mi riferisco, in particolare, a quel “volo di farfalla dentro il / ventre della terra”: qui un leggiadro e delicato dinamismo sembra svolgersi all’interno di un greve ammasso materico, ponendo in essere un contrasto in grado di suggerire come gli opposti possano convivere.
Non si tratta di mero talento provocatorio, bensì dell’evidente intento di raggiungere un significato ulteriore per via di lineamenti linguistici inusitati eppure poeticamente validi.
Non manca quella cadenza descrittiva, quell’indugiare su un cenno per poi passare senza soluzione di continuità a un altro, quel ritmo che sulla brevissima tregua e sulla subitanea ripresa fonda la sua peculiare musicalità, non manca, insomma, quella tendenza alla descrizione sinfonica che già in altre occasioni ho con piacere riscontrato nei versi di Stefania.
Stefania Negro è nata a Lecce dove vive e lavora.
Autrice di saggistica filosofica e letteraria, di poesia, narrativa e testi per sceneggiature.
Ha pubblicato la raccolta poetica dal titolo “Fili di luce compresi negli archi del divenire” presso Cierre Grafica nella collana Opera prima nel 2007
Nel gennaio 2009 ha pubblicato con Anterem il saggio “Erranze nel divenire” .
Edita sempre da Anterem è la seconda raccolta poetica dal titolo “La geometria della luce” , maggio 2009.
La terza raccolta poetica è “Risonanze” edita da Manni nel novembre 2010.
Collabora con riviste letterarie ( testi di poesia, narrativa e critica letteraria ).
Organizza inoltre eventi culturali ed è ideatrice con Simone Franco ( attore e regista) del progetto Multidisciplinary art.
Daniela Attanasio, poesia inedita, con una nota di Marco Furia
Tre per cento
Conosciamo solo il tre per cento della materia
il resto si restringe e si espande in millesimi di pensiero.
Qual è la differenza fra la lanugine svolazzante
dietro la porta della cucina e la polvere
dell’universo? materia dispersa – roccia gas fuoco e terra
la maglietta bucata sotto l’ascella o lo scudo d’Achille
istoriato e battuto a caldo visto in trasparenza
dallo sguardo di un cieco...
c’è neve bianca e lucida di ghiaccio
distesa come un telone a coprire imperfezioni
a rimodellare nel segreto della copertura
un paesaggio sconfitto dall’uso.
Prendiamoci questo –
mi viene da pensare,
il bianco del ghiaccio senza disegno
l’energia della terra che spunta dalle sue radici
prendiamoci la riserva di generosità
tenuta sottochiave come un bene di famiglia
e le possibilità, le tante possibilità – dalla lingua all’amore:
le parole chiuse della passione
quelle della poesia
il rispetto o la fiducia sigillate nella bocca
la conferma di una vocazione
prendiamoci il concreto del tatto
l’assonnata bellezza del mattino
l’odore del mare
e quello di un corpo sotto le lenzuola
prendiamoci la benevolenza dei cani
i colori di Rothko e i tagli di Fontana
il crepitio del gelo che sfibra foglie e rami
la forza, la grazia
il rumore animale dell’elicottero che sorvola il quartiere
“Tre per cento”, di Daniela Attanasio, è un’intensa poesia in cui una misurata discorsività iniziale conduce a esiti di grande apertura.
“Prendiamoci questo” è verso davvero importante.
Certo, possiamo riflettere a lungo sui tanti aspetti non sempre positivi del nostro stare al mondo, possiamo avvertire il senso del limite insuperabile della fine, possiamo sentirci esposti e indifesi, ma tutto questo (e molto altro) significa che, innanzi tutto, ci siamo.
Si tratta, nel caso di Daniela, di una consapevole capacità di accettare: la vita è, in ogni modo, occasione, opportunità.
Ci sono
“il bianco del ghiaccio senza disegno”,
“le parole chiuse della passione”,
“l’assonnata bellezza del mattino”,
“i colori di Rothko e di Fontana”,
ossia ci sono gli uomini, come genere, come sviluppo millenario, come storia, come linguaggio, come arte, ma, soprattutto, insiste la poetessa, ci sono proprio questi uomini, qui e ora.
Del resto, apprezzare l’attimo e la singola immagine non significa sottovalutare il valore del passato, significa, al contrario, arricchirlo, riuscire a pensarlo come “energia” “che spunta” o come “conferma di una vocazione”.
Il passato vive soltanto nell’oggi e il futuro – questo mi sembra il messaggio – potrà essere senza dubbio più soddisfacente se al vivido, partecipe, sguardo non sarà estranea la “lingua dell’amore”.
Un amore che è anche empatia della lingua, come dimostrano le ben orchestrate cadenze di “Tre per cento”.
Daniela Attanasio, romana, ha pubblicato quattro libri di poesia: La cura delle cose (Empiria 1993), Sotto il sole (Empiria 1999, Premio Dario Bellezza, Premio Unione Scrittori), Del mio e dell’altrui amore (Empiria 2005, Premio Camaiore), Il ritorno all’isola (Nino Aragno 2010, Premio Sandro Penna). Sue poesie sono presenti nell’Almanacco dello Specchio Mondadori 2009. E’ presente in diverse antologie nazionali e internazionali e ha collaborato come critica con quotidiani e riviste letterarie.
Kiki Franceschi, prosa inedita, con premessa di Mara Cini
Una messa in scena, quella di Kiki Franceschi per Mary, dove il “mare selvaggio” di un’epoca “grande e complessa e terribile” si fonde con i “luoghi inesplorati” del romanzesco e con le vicende altrettanto terribili degli stessi protagonisti-scrittori. Ma, alla fine, protagonista ossessiva è la pagina ancora da scrivere e già macchiata dai pensieri. Non importa se il quadro riguarda la letteratura “alta” o il privato di una “figurina snella vestita di scuro”, fermare i sogni causa quasi sempre (anche ai metteurs en scène) “ la stessa squisita pena”.
L’ombra di Frankenstein
Un monologo per voce femminile
Agosto 1823
Mary Godwin Shelley
una figurina snella, vestita di scuro scrive
seduta presso una scrivania,( una finestra aperta) proiezioni di paesaggi, mani, nuvole, onde. Silenzio. Appena un po’ di luce ne delinea il profilo
ad alta voce
Quando mi sveglio dalla monotonia delle mie visioni e dei miei pensieri provo a fermarli con la stessa squisita pena che si prova nel fermare il fluire del sangue. In quei momenti sono come dissolta in un’incredibile tenerezza e provo amore verso tutti coloro, anche estranei che risvegliano e evocano in me tanto sentimento, tanta armonia; sento di amare tutto, alberi cielo,oceano. Discendo nelle caverne più profonde della mente e sfido con occhi d’aquila il sole.
Scrivo perché è naturale come il respiro. Scrivo perché vorrei strappare il velo di questo strano mondo.
Scrivo storie, frammenti di un’epoca grande e complessa e terribile, riduco a immagine, a visione, quei frammenti. Ho cominciato da bambina. Mi piaceva sognare e i miei sogni non li raccontavo a nessuno.
Volevo sentirmi in compagnia solo di me stessa. Complice di me stessa. Scrivevo solo quando le visioni figlie dei sogni prendevano corpo e colore, odore e sostanza. Nei giorni in cui progettavo il Frankenstein ero terrorizzata, da me, dalla mia fantasia, dalla capacità che avevo di rievocare e dare vita ai personaggi di una storia tremenda…. eppure la scrivevo, come se fossi posseduta, come se non potessi sottrarmi all’angoscia maligna che srotolava i suoi fili e scrivendo tentassi di raggomitolarli per tenerla a bada.
Sono passati solo sei anni…Quel tempo oramai è così annebbiato, confuso, slabbrato. Debbo tenerlo a bada per non morire anch’io. Mi sento come una formica sola davanti al formicaio distrutto. Che senso ha?
Solo ieri ho rivissuto quei giorni eroici,frenetici e sublimi. E’ stato un caso. Un lampo e sono ritornata indietro all’interno dei ricordi.
Si passeggiava io e il babbo presso il Covent Garden e ho visto il manifesto:c’era il mio nome… riduzione teatrale del Frankenstein di Mary…l’hanno portato in scena…Grande successo pare… ho provato uno strano sentimento tra fastidio e stupore… Mi sentivo a disagio, fuori posto, non ero io, era un’altra Mary, non ero io. Godwin ne era felice,m’ha detto quanto orgoglioso di me, io ero incredula, estraniata, come divisa, slegata da me.
Lontana.
Ora c’è meno luce, oscurità del pomeriggio attenuata dalla luce di candele. Mary è seduta, scrive su di un quaderno nero
Villa Diodati ….era il maggio del 1816.. Era freddissimo, umido, la pioggia incessante ci costringeva a casa per giorni e giorni, tutti insieme intorno al caminetto acceso a chiacchierare, a raccontarci delle meraviglie della scienza, della misteriosa forza che c’è nell’elettricità, di Volta che a Londra si era incaponito a fare esperimenti su rane morte e sembra riuscisse a farle muovere con scosse elettriche. Tutto questo era meraviglioso, sorprendente. Per non annoiarci troppo, si leggevano a voce alta, a turno, alcuni volumi di storie di fantasmi che ci erano capitati tra le mani, Claire, Byron, Percy, Polly Dolly, e io.
Interrompe lo scrivere, parla tra sé sommessa
Polly Dolly…povero Polidori, gli avevamo affibbiato questo feroce sopranome per i suoi modi affettati…ha fatto una tremenda fine, ammazzarsi così giovane. Il laudano è facile da trovarsi, è una tentazione per le anime deboli.. Anche Fanny, povera straziata sorella mia… anche lei l’ha fatta finita così
Si sente un pianto brevissimo e sommesso. Si alza, va alla finestra.
e parla piano tra sé con tenerezza. Riprende a scrivere
Si leggeva dell’amante infedele che, mentre pensava di stringere la sposa che amava, si era trovato tra le braccia il pallido spettro di colei che aveva abbandonato, e quella storia dell’ uomo che dava il bacio della morte a tutti i discendenti della sua stirpe… Stavo così male…come se sentissi, percepissi la morte, il suo dolce nauseante odore…
Era stato Lord Byron a proporci di scrivere una storia di fantasmi e tutti e quattro, Byron, Polidori, Shelley e io avevamo cominciato, forse anche Claire scrisse qualcosa ma non lo concluse. Per me non fu davvero un divertimento. Mi sentivo come presa da un vortice, inghiottita, risucchiata. Andavo sempre più giù all’interno di una profondissima angoscia, e dentro quel pozzo nero ero stranamente immobile, come se mi osservassi, o meglio, osservassi qualcosa che lavorava nella mia mente e che non capivo
alza la testa dallo scritto, appare assorta,
ero rapita dal mare selvaggio e dai luoghi inesplorati che stavo per esplorare.
Si alza, voce più decisa
Le mie percezioni erano il mondo.
Cambia la luce, ora è quella forte del mezzogiorno. Dalla finestra spalancata si vede un paesaggio aspro di montagna
luglio 1816…
Shelley e Byron avevano rinunciato a scrivere.. troppo banale dicevano. Polidori e io eravamo affascinati da quanto la nostra fantasia inventava. Mostri e vampiri, diversi da quelli delle favole ci stavano accanto, ci divoravano, ci rendevano inerti come bambole di pezza.
Montavert, 21 luglio 1816..
Io e Shelley avevamo iniziato la scalata verso Montavert. Niente di più desolato di questa montagna, gli alberi travolti dalle valanghe erano tutti piegati in mezzo a distese di pietra. Scrivevo mentalmente il mio racconto. Senza carta né penna, scolpivo parole nella mia testa, pesanti come quelle pietre.
In quella immensità che confinava col cielo ero poca cosa. Percy mi teneva per mano ma io salivo a fatica e mi sentivo sola. Salivo a fatica e pensavo alle novità scientifiche a Galvani e Volta che usavano l’elettricità per animare rane morte…. chissà cosa si poteva fare per sconfiggere la morte, la decomposizione… Fu durante quelle chiacchierate che la mia immaginazione iniziò a donarmi visioni forti che ne generavano altre in rapida successione, con una vivacità molto al di là degli usuali limiti delle fantasticherie. Mi sentivo come ammanettata, vinta, incapace di oppormi a quel tumultuoso, torbido, maligno affiorare dal vuoto nero delle memorie.
Era spaventoso.
E’ spaventoso. Perché affiorano nella mia mente queste tremende visioni? Perché prendono il sopravvento e non riesco a tenerle a freno ?
Sto male, ho paura, la morte mi afferra per i capelli, aiutatemi. La mia bimba è morta nella culla.. L’avevo allattata, stava bene. Sono andata a prenderla e era morta. La mia bimba senza un nome ancora, così piccina e indifesa. Anche io sono sola a fronteggiare la morte. Vorrei urlare “ aiutatemi”, ma la voce non viene fuori, rimane a farsi nodo nel fondo della gola e io urlo con la testa, con il cervello e mi dibatto e sudo. Ho tanto freddo. Aiutatemi.
Nessuno mi aiuta. Neppure Hogg. Neppure Shelley che mi guarda sgomento e non ce la fa a dirmi niente. E Claire è troppo presa da se stessa. E Godwin mi ignora. Sono al bando. Sono una creatura mostruosa anch’io. Ho preso tra le braccia la bimba ed era morta. Morta. Sola, nella culla, senza di me, senza che la consolassi, la accarezzassi. Dovevo essere attenta, non lasciarla neppure per un attimo, forse non sarebbe morta.
Non aveva ancora un nome, piccola tenera cosina indifesa.
Era mia, l’amavo tanto e non c’è più. Un attimo e niente. Tutto finito.
Non ha neppure pianto, non ho il ricordo del suo pianto. Dei suoi occhietti blu. Riesco soltanto a sentire ancora caldo sui miei seni, il tenero e risoluto tocco delle sue piccole mani che cercavano il latte.
MARY legge dal suo diario con una voce freddissima
15 luglio 1822
il mare restituisce il corpo di Shelley sulla spiaggia di Viareggio. Il poeta ha in tasca un volume di Sofocle; nell’altra un volume di poesie dell’amico Keats, con una pagina ripiegata, come se l’avesse frettolosamente riposto. Non si è appurato ancora se Ariel, la sua barca abbia fatto naufragio per la tempesta o per l’incursione di pirati risicatori che infestano le acque nei dintorni. Di sicuro la barca potrebbe aver cozzato sugli scogli della Meloria dato il tempo proibitivo. Un ponente di forte intensità o una delle tante trombe marine che si formano al largo in direzione nord ovest potrebbe aver causato il fatale incidente. Questo scrivono le cronache
San Terenzo, 23 luglio 1822
Sono le sei del mattino, l’aria è fresca dopo la pioggia incessante della notte passata. Sul mare c’è una leggera nebbia ma il sole si è alzato e la spazza via. Sento d’improvviso, realmente, con forza che Shelley è morto davvero. E so che questo dolore mi sarà accanto per tutto il resto della mia vita, mi morderà le calcagna come una iena per impedirmi di vivere.
Shelley è davvero morto. Non c’è più. Tutto finito. Vuoto. Assurdo. Morto, disperso. Le sue ceneri disperse. Il suo cuore in una scatola. Un regalo che ho fatto agli amici cari. Io non lo voglio. Il suo cuore era troppo grande e libero per stare dentro una scatola.
Sono sola ! Le stelle possono vedere le mie lacrime; il vento beve i miei sospiri; ma i miei
pensieri sono come un tesoro sigillato, che non posso confidare a nessuno…ho solo queste pagine bianche che macchierò di neri pensieri..
Kiki Franceschi nasce a Livorno e vive da più di trenta anni a Firenze. Discende da una famiglia di schiumatori di mari, bucanieri di origine corso- marsigliese, i “ Franceschi” appunto, che le hanno trasmesso sicuramente il gusto per l’avventura, l’amore per il mare, gli spazi aperti. Si è laureata in Lingue a Pisa, ha dipinto come una forsennata, ha scritto e tradotto, tenuto conferenze. Nel 1979 si avvicina al gruppo Lettrista , nel 1981 entra nel movimento INI, cominciando una sperimentazione poetica e visiva che ancora persegue. Dal 1970 ad oggi conta oltre quaranta personali in gallerie italiane e collettive in musei italiani e esteri: Centro per l’arte contemporanea, Gallarate, (Varese); Forte Belvedere, Firenze; Centre Pompidou, Parigi; Grand Palais, Parigi; Museo Reina Sophia, Madrid; Fundacion J: Mirò, Barcellona; Centro Cultural La Recoleta, Buenos Aires; Museo di Kemi, Finlandia; Museo Vittoria Colonna, Pescara; Museo Marc Petit, Ajaccio; Museo della Carale, Ivrea, Maison d’Italie, Parigi. Ha scritto saggi poetici per i tipi di Polistampa e Gazebo, editori in Firenze.
Kiki Franceschi, immagine, Le scrittrici

Febbraio 2013, anno X, numero 18

I testi che presentiamo in questo numero sono opera dei finalisti per “raccolta inedita” al Premio Lorenzo Montano 2012: Pietro Altieri, Daniele Bellomi, Giovanni Campana, Enzo Campi, Silvia Comoglio, Loredana Semantica. Per introdurre questi poeti sembrano ideali le parole del filosofo Federico Ferrari, tratte da "Anterem 85": "La parola poetica crea un mondo, crea il mondo, perché espone il linguaggio e le cose al loro momento inaugurale, al loro momento iniziale. (...) La parola poetica crea spazio nella trama compatta e continua della storia, offre uno spazio in cui si possa muovere l'immagine presente in ogni momento della vita. In questo spazio, l'immagine appare e la cosa può vedersi come mai si era vista, al di là di ogni previsione, di ogni pensiero calcolante, di ogni cibernetica".
Le opere degli autori proposti spaziano tra poesia lineare, poesia e prosa poetica, poesia e segni musicali, poesia e saggio. La qualità distintiva di ciascun autore emerge, oltre che dai testi, dalle acute note critiche di Giorgio Bonacini. Ancora una volta “Carte nel vento” testimonia il lavoro intorno alla poesia contemporanea svolto dal Premio Lorenzo Montano. Siamo lieti di confermare che è in corso il “Montano 2013 – 27^ edizione” per aggiungere nuove pagine a una lunga storia.
In copertina: foto di Sara Fazzini in occasione del Convegno Anterem 2012
Scarica il bando del Premio che scade il 15 aprile 2013
Accedi all'area dedicata alle opere.
Pietro Altieri, poesie da “Ubiquità del bianco”, con una nota critica di Giorgio Bonacini
da Nessuna pietà per chi si volta indietro
Eravamo morti e respiravamo
Paul Celan
Vicolo cieco
Nessuno respira,
in attesa di un nome.
Un’ombra sconosciuta
sosta
agli angoli di un volto.
“e il Vicolo Cieco
è sulla faccia di tutti”.
Abendland
Trascinarsi in ginocchio alle foci del Futuro
con la neve nascosta del tuo respiro.
Dove in cielo splendono due soli
ogni cosa proietta al suolo
una duplice ombra.
Deboli fuochi fatui
nel sonno bianco e nero.
Nessun piede umano lascia impronte.
Stelle infrante precipitano
sulle Terre della Sera.
XX Secolo
Fiordi vivi di sguardi, l’ora nuda
curvata sul quadrante.
Le lune spente dormono per noi.
Fredda la fronte penetra negli occhi
di chi rimane o ripete.
Più giù la vita, lampeggiante,
conficcata nel vuoto, un dito
indica, indugia.
Il freddo non ha fratelli.
Allora
La notte sulla nuca,
ad angolo retto,
a tradimento.
Il dolore culmina, cessando.
E adesso
il gesto eluso, ripiegato,
come un vagito,
nell’utero dell’ombra.
Le cose senza peso,
separate nel sonno –
carne assalita dal bianco della neve,
senza un filo d’infanzia.
Mordeva luce
alle radici dell’aria.
Emorragia d’ossigeno:
bolle di parole
le scoppiavano in gola.
Scrutammo a stento
lo spessore del sangue –
quel cuneo oscuro
tra vertebre e vuoto,
l’assoluta opacità del suolo,
del respiro.
Clessidre nere
Lingua
È la lingua
a scegliere le bocche,
crune del dire.
Senza saperlo
essere,
prosciugato nell’eco:
ossidi di stelle.
Profili pensili,
scavati
nelle vene del vuoto.
L’oscillare del nulla
tra due specchi.
da A Sud di se stessi
Attesero che un nome
diventasse neve, poi
sparsero capelli e cuori,
all’infinito, su tutte le pareti.
Nulla
Nulla restando
freme.
Fermo sul filo del mondo,
sull’orlo del grano.
Nell’urto meridiano della luce.
Il volo adunco di un uccello:
accenna, acceca.
da Tutte le direzioni e nessun senso
Camminarono attraverso una città di
film in bianco e nero, strade che
sbiadiscono con migliaia di volti
corrosi dal fumo. Figure del mondo
rallentano fino ad essere catatonico
calcare.
William Burroughs
Il tempo
Il cieco incide cifre
sulla tua fronte,
un numero nero ad ogni errore.
Cenere, color pensiero,
cenere, e cicche spente
- pezzi di vetro
a un centimetro dalla tua voce.
Lacera l’aria verde,
poi ricuci il bordo.
Un’ora stinta ruba le promesse,
adegua i passi al suo respiro.
Non ha fiumi la notte,
soltanto corde
sospese vive tra una lama e l’altra.
Il tempo non ha rive.
Respiro
Traduci il sonno in una sera sola,
agli eremi di un nome,
trapassi l’aria con un altro
respiro di stupore
- terra di meduse,
nessun sale sazia la nostra fame
- terra di rose,
le tue dodici infanzie esterrefatte,
ad est di ogni errore.
Nessun sonno.
Nessun sonno.
***
In poesia il senso è a disposizione di chi sa attendere la sua apertura, che spesso avviene in modo oscuro o lentamente improvviso, mentre si è, ci dice Altieri, “in attesa di un nome”. E proprio in questa raccolta l’autore ci mette davanti la possibilità vitale, di un significato come ombra immaginativa, tesa tra l’esperienza che la scrittura designa e indica e la trasparenza o disvelamento che va oltre quel fondale bianco che fa da scena vuota di un’esistenza ancora iniziale. Ecco, allora, uno dei motivi di questa poesia, dove la metafora si fa veramente cosa-di-parola: non connotazione per dire altro, ma un altro dire in voce nitida: a volte fredda, laconica; a volte tesa nel suono che la muove; a volte dura e pulita; a volte leggera e soffiata, ma sempre scolpita e avvolgente, così da dare svolgimento e significazione a geometrie di profondità, di precisazione e di sollevamento. E ne vediamo gli effetti nei tanti testi in cui gli elementi naturali più soffici e impalpabili, ma anche fra i più percepiti dal corpo, risaltano e operano come attori di scrittura: neve, gelo, acqua, vento, aria. E per ognuno vediamo il verificarsi di vortici, frantumazioni, sospensioni in cui la parola, già figurativamente corposa, si trasforma e trasfigura in sé la concretezza e l’essere stesso dei fatti di natura. C’è una stupefazione tale da rendere possibile anche i contrari visivi e concettuali: ad esempio l’intromissione dell’alba nella notte, con rotture di sbarramenti fisici che preannunciano esplosioni di luoghi temporali, istanti che cadono “tra i rottami luccicanti dell’occhio”.
Ma è anche una poesia, questa, che prende dal silenzio e contemporaneamente lo ospita, riducendolo ulteriormente in un rumore opaco, fatto di vuoti ancor più lacerati dall’aria. Sembra veramente una lingua fatta dalla stessa materia a cui dà voce. Lingua fatta con lo stesso attrito, stessa sostanza, stesso colore, fino alle ferite inflitte, al taglio che “lesiona i suoni”. Ma la parola è anche soffio sillabico, corpo di musica, vocalità minimale che non esce indenne da qui: da questa gestualità sonora che sottrae segni all’ascolto per riportarli e lasciarli a pause notturne. E’ una voce di sinestesie efficacemente estreme; una voce che vede con sguardi che assalgono e appesantiscono l’aria. Dove gli effetti sono visibili, perché sono fatti di vento che disperde e fa riemergere alla mente “le frasi mai dette”. Quelle che permettono alla poesia, e in particolare a questa poesia, di crescere in se stessa oltre il dire e il sentire la sua origine: verso un inizio futuro mai definitivo.
La parola deve allora essere trovata nella sua giusta dimensione: che non è più quella conforme a una supposta realtà designata, ma nella sua metamorfosi e metafora dove “solo se ascolti, piove”. Uno sgocciolamento, dunque, una frantumazione che acquista e perde il suo sentimento pensante, innumerevoli e indeterminate volte. Ed è così che Pietro Altieri svolge il suo andamento frastornante, ma ugualmente lirico, senza soggettività, senza contemplazione, ma facendo oggetto di scrittura un panorama lacerato,un paesaggio della mente che fotografa immagini così sottili “che nessuno vede”. Quasi fossero conficcate in un’aria solida, densa, in un biancore che trascina a sé il giorno e la notte e impedisce o svuota ogni tentativo di raggiungere la felicità ingenua del cuore. Ma senza preclusioni, senza tacere la dimensione emotiva che anche una sola e semplice parola può creare. Perché anche “se c’è la neve” e “la pietà non viene” si accende ugualmente in un angolo un sussulto di tenerezza e di tristezza quotidiana, in un quasi crepuscolare “martedì/e gli angoli sono ancora spenti”.
Pietro Altieri, nato a Napoli nel 1952, vive a Roma.
Insegna Storia e Filosofia in un liceo scientifico.
Si è occupato a lungo di poesia, ha pubblicato su diverse riviste come "Galleria", "Pragma", "Il Rosso e il Nero", ecc. Inoltre ha scritto due raccolte di poesie, "Specchi Ustori" (Andrea Livi Editore, 1991) e "Ubiquità del bianco" (reperibile sul sito on-line http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=568923, con prefazione di Milo De Angelis).
Ha recentemente scritto un testo in prosa, dal titolo provvisorio “Una disperazione confusa”, ancora inedito.
Daniele Bellomi, inediti da “Ripartizione della volta”, con una nota critica di Giorgio Bonacini
ripartizione della volta
(opera prima)
nistagmi: tre movimenti involontari degli occhi
*
si vede la media di un cielo sereno, il sole
al meridiano e alle lune la fiamma
di candele a paraffina
il filamento di tungsteno penzolante
dalle ampolle a gas: ho avuto
con un solo movimento
il posto dell'arciere
ho vomitato anche da morto il fotogramma,
nell'arco
degli elettrodi ho segnato il cratere positivo,
eppure
è rotta la sensazione luminosa, il flusso
che ha detto
di non rimanere ora salta
perché non sbaglia nessuno a trascinarmi via,
a non usarmi per guardare non si unge
un re di questi tempi senza sporco sulle mani;
non ho visto non ho sentito non parlo
non reato allora ma segni e convoluzione, trattamento
delle immagini più o meno di favore o instabile
non so niente di questi soldi non miei
che porto in mano, non più nemmeno
l'arco che scarica lo xeno a terra l'odore
che c'è di radiazione: non si passa il vaglio
con il vaglio, la vista come curva in un fuoco, il fuoco
è il medesimo
**
l'immagine che si gradina, si sgrana,
rimuove la sfocatura
non vi serve a costruire: osservate
direttamente
dai vostri occhi il movimento accidentale, il rumore
casuale,
occidentale delle fibre, il reticolo colpevole,
occhi e carne, il montaggio finale
che squassa via i semi e il cristallino:
le persone sono sconosciute, quelle di anni fa;
guardale ballare
serenamente, rivedile come sono ora,
prova a riconoscerle
per la pellicola che salta e ritrasmette
in successione, si scansa sulla pista, prova
a riconoscersi come noi il tramite è il divano, la fissazione
in uno schermo;
a cose passate, a cose che non sappiamo quando
ritornare: ripetile ancora se non puoi
***
non lascerò
che mi si tocchino le cornee, a meno che
tu non me lo dica, ponendomi dei pesi;
per l'entità
di questa depressione che attende
il bulbo, lo varco sui millimetri elastici
della deformazione; di forza in forza
meccanica
si tratta sempre di un ricarico dei circoli,
di uno sgravio
dei getti d'aria che lasciano le cicatrici,
i segni screpolati
delle tue mani quando guidi,
ad esempio,
l'essere magari
una tecnica ancor più sicura
per vederti sola; se una lente permette
la superficie, la vibrazione riflessa
in un segnale, non voglio che ti stia a contatto,
perchè aspetto un certo
acconto delle pareti, ma non più
di questo stimolo
irriflesso
****
non è uno solo il battito o il rumore
più sordo dei canali
avvitati, dei ritorni
innalzati alle aperture,
e le chiavi girano
nel montare insieme le parole
(fra poco, adesso, dopo, perso, fra di noi)
da distimie: quattro variazioni disarmoniche sul tono dell'umore
*
caffè in grani, secco:
crudo a somiglianza
di qualche malattia visibile; le vetture (i cambi,
simili a scheletri
fibrosi) prendono alla gola:
nuove fasce di prezzo, di occlusione, nuove
tensioni tangenziali per uscire
e così moduli elastici, capelli,
sottintesi della lotta;
con questa quiete che si nuclea, le immagini
chiuse nelle urne,
artefici come in ogni caso
di una germinazione
(sembrando due tratti
cervicali in cui il diaframma
si interpone)
sono litanie, lamentazioni, un devastare
ci sono angoli esatti per il rollio, di sufficiente
devianza per pulire
gli pneumatici, la terra come
soffio di organi cavi accorciati
ad altri ordini, il prossimo
allungamento, tra quei segni:
in quella direzione, con la stima
del litio, degli occhi, la mente è quel limite,
il modo che più perfetto ho inteso:
c'è chi scocca
un deserto e larghi spazio di terreno,
chi i transiti
per gli dei delle soglie, tutelari che sciolgono
l'autorità paterna
chi, per immensi culmini, arie
senza inizio, vede
torsioni senza termine alcuno
**
non l'amnesia desiderata, il vuoto
delle sacche
minime, amniotiche, ma guaine
e guaine
a dividere nemicamente, deridere
la voglia
dell'abbraccio, il progresso
in questo stato di locomozione: l'errato
governo della cellula
semicircolare, incidentale
più di noi
gli orli si sono striati: il cambio
va fatto
nei giorni altri, alterni, meno sui vestiti
nuovi,
che ancora tengono senza ispessimenti,
ripiegano
giunzioni intermedie all'inchino
quindi un microsisma o i dieci
somiti dell'embrione:
aderenze come abbozzi
primitivi ma pronte
a cambiare, far sparire
ciò che varia l'inizio
del flagello
o la mobilità del passo, una cerniera
al mondo
***
(impossibile la creazione
di un cratere dal globulo retratto
il coagulo:
ci sono solo gengive, soffiaggi
ed estrusioni alla difesa immunitaria,
ma la guardia
in piedi è un canale per la levità)
disconoscere
le zone di passività, quindi
il pugno elettrico la separazione alfa
beta e gamma:
i liquidi bombardati
di particelle sbordano
si fanno sacri al proprio calco
si può ridurre lo scheletro,
non l'ultimo
corpuscolo
del sangue, l'errore di libellula invischiata
da una rete,
né il ciclo di krebs in propaganda
di uno sforzo
****
e finalmente il battito
cerchiato di rumore,
ponteggi alzati in tempo
e l'altro è il discorso
che facciamo e noi che siamo intatti
nel montare insieme le parole
(adesso, lo stesso, resto, ciò che è perso)
ripartizione della volta
adesso devi andare allora osserva il bianco di lesione in cicatrice
per la notte estesa altrove fino al campo ottuso dello specchio
andata avanti sui chilometri senza ritorno per distanze appena
appresa dalla luce e pensa a ciò che non succede se non guardi
assorto verso il punto che non circola degli astri o per le sorti
di una delle mille attenzioni verso il moto nell'idea che prima
o poi dovrai porre rimedio all'anomia della visione e suturare
ogni passaggio assiduo per colpi e colpe andando a vuoto
ad iniziare dalla retina mancando agganci a corpi erranti
appesi sulla volta e pure avendo scorte proprio al centro
della via a terminare l'esistente per se stesso o per te solo
osservi un'altra via di sorta in cui rimane tutto per cosciente
remissione o inalterabile dai moti ai modi opposti e stabiliti
dentro mondi di persone assorte e sillabate in questo niente
in questo breve tempo che non risente di attrazioni e desideri
cosa fare del consulto della divisione in brani e tracce disperse
per gli anni di distanza per quello che non viene mai da solo
e solo allora interpretare per predire nella pietra per qualcosa
che non potrà accadere se non in altro caso di effetti sentiti
o attraversati e notazioni spinte fuori per inerzia pur sapendo
cosa fare e se non implicarsi in opposti e rotazioni mascherate
dagli sbarramenti adesso devi andare e indaga il fegato e oramai
il poi non è più il dopo smarrito che grida nell'abito che smetti
o appena smesso fermato dopo lunga osservazione delle stelle
grida ancora in cerca del reciproco per malattie degli occhi
o le ferite e il mare gonfio di aria estratta e soluzioni dentro
al vuoto in cui vederti solo a far barriera da percosse e fenditure
rese adesso feritoie aperte e imposte nelle viscere senza temere
che gridando dietro non si veda senza luce e poi soltanto
invano o il vano come nuovo punto da cui parta un fuoco
atteso per bruciare arreso al ricevente della parte giusta
in sfregio al posto non più possibile ma così immobile conta
mai davvero realizzata credendo in tutto ciò che potevamo
***
È nel principio del suo percorso materiale, che la scrittura unisce in sé la concretezza di cosa linguistica e il concetto di essere mentre struttura il suo fare, in uno sviluppo di autoconformazione che stabilisce, senza supporti ingenuamente referenziali, ma consapevole dello spazio e del tempo in cui agisce, il suo autonomo andamento. E proprio questa sembra essere la parola poetica che Daniele Bellomi sperimenta: una partitura spiazzante, un vero e preciso versamento che procede dentro un’esistenza di linguaggio che è l’esistenza in sé. Ciò che accade – se qualcosa accade – è frutto dello scorrere in grafia di una forza materica, di un rilievo, di un attrito significante con una valenza tale da far sì che la contorsione di senso divenga la sua energia.
Un torrente, dunque, che non è però un flusso di coscienza, ma un andare del pensiero linguistico che materializza le sue figure, le sue schiume, i suoi corpi erranti. E così come alcuni titoli delle sezioni rimandano a barcollamenti, a strabismi saltuari, a disagi, a un disequilibrio percettivo – situazioni dunque che obbligano a una costante, faticosa e vitale attenzione – allo stesso modo “il verso terminale del discorso” è sempre aperto sulle cose che iniziano a muoversi: a respirare nel mondo che questa poesia riesce (anche liricamente seppur in modo trasversale, sfibrato, deconcluso, sbordato) a narrare.
Ed è qui che gli agganci sul reale si allungano e nello stesso tempo si sfilano dalla realtà che, contrariamente al vero oggetto materiale, a cui la conoscenza dà senso e da cui incessantemente attinge, è solo un dato parziale.
Questa poesia, dunque, sceglie una conoscenza che prende avvio dalla scrittura e con essa si alimenta. E se è vero, come si dice, che il poeta sia scritto dal proprio linguaggio... allora il nostro autore ne è un esempio. Nella scrittura egli percepisce la necessità dell’urgenza e della lucidità e l’intransigenza volontaria della sua significazione: fino al punto di toccare ed esteriorizzare anche le sfumature innaturali del senso. Perché come dice Bellomi, con un’ ambiguità lessicale efficacissima nel rendere la polidirezionalità del linguaggio poetico, “non c’è verso/che ci abitui al fondo”, anche pensare che qualcosa ci elevi nel pensiero e nel suo riconoscersi fuori dalla lingua, è un’ illusione. L’unico sapere che la poesia può avviare a processo è quello che lei stessa mette in moto con il suo dire. Forse è una consapevolezza estrema, ma è la certezza di provare, scrivendo, l’andamento mentale che si affaccia ai limiti dell’essere, con tutte le sue possibili linee di percorso e di demarcazione. E questo significa sperimentare l’oggetto/lingua a partire dalla sua materia: la concatenazione fonica e grafica nella produzione lineare di versi, che non può però risolversi completamente nella metamorfosi esteriore che produce il suo soggetto. Il tratto distintivo poetico, dunque, è destinato a non avere compimento totale, né per via metaforica né letterale. La forma/scrittura scava continuamente, aggancia e destruttura, abbraccia e disperde e, con la sua forza compositiva, osserva sempre, nel bianco della pagina, un movimento che procede “di lesione in cicatrice” e sempre accoglie “il verso che le sta di fronte”.
Daniele Bellomi, nato a Monza il 31 dicembre 1988, studia Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano. Ha seguito il Corso di Poesia Integrata, nel periodo 2010-2011, sotto la direzione di Biagio Cepollaro. È co-fondatore del blog di poesia e scrittura non-narrativa plan de clivage. È autore dei blog asemic-net e eexxiitt. Suoi testi sono apparsi altrove online su «Poesia da fare», «Niederngasse», «Nazione Indiana», «Gammm» e «Lettere Grosse». Presenta qui la silloge inedita ripartizione della volta, sua opera prima.
Giovanni Campana, inediti da “Delle parole (e loro luoghi)”, con una nota critica di Giorgio Bonacini
TRATTATELLO IN PENSIERI SCIOLTI E VERSI
§ n. 21 Della restituzione che nella parola della poesia ha luogo.
Una restituzione, insomma, un ritorno… a qualcosa di nuovo che da sempre siamo. Sarà forse il divino della sua musica a fare questo, nella poesia; sarà che il ritmo è degli dei, sarà che un dio pulsa in esso; sarà che essa genera luoghi e silenzi che altrove nelle parole non troviamo, luoghi e silenzi in cui essa ci inoltra, pieni d’ogni sussurro e tuono della terra. E anche d’ogni luce, naturalmente, e ombra... luoghi ombreggiati o riarsi; e cose, anche le cose, e le dolcezze e i pianti, le lacerazioni, i presentimenti. Tutto porta la parola della poesia, questo inoltrarsi che essa è, questo perdutamente ritornare a qualcosa di mai prima visto, mai toccato, qualcosa che sempre è luce, anche nella più amara e buia delle parole di poesia, poiché essa sempre è un vedere, come la parola stessa sempre lo è… e il vedere - è così facile dimenticarlo…- il vedere è luce. Forse, se poesia è la poesia, se davvero accade in essa questo perdutamente inoltrarsi in un ritrovamento, una restituzione di quel che solo ora è dato in una insuperabile singolarità, se questo nella poesia accade, è perché essa tocca il luogo, inoltra nel luogo in cui tutto è tutto... E il corpo, questo corpo della mia esistenza, questo mondo delle cose, insomma, non è più il miraggio della vita che mi sfugge, qualcosa di perduto: lì, nella parola della poesia, tutto è raggiunto nel suo luogo, il luogo ultimo (sempre è così per la parola, ma mai come nella poesia questo si mostra…); ed è pienezza che si compie, è parola a cui nulla manca, parola che è tutto – tutto è tutto nel luogo ultimo - anche quando è struggimento, quando dice la mancanza... o il dolore, anche il dolore…
Parole che vedo (18)
…a volte,
traluce il cosmo in uno specchio di gioia
lacrimata, tutto
si fa in me uno
in una
lucida ubriachezza,
e l’anima, bocconi, in sé travasa
persino ogni cesura ed ogni orrore
composti in un abisso di pietà
ci parli, non so come, verità,
in questo grido
di bocche rovesciate e corpi e fuochi
di città morenti
eppure
anche è tuo il grido
colmo e le manine
che accendono di soli i nostri passi
tutto è qui, tutto, in una
parola totale…
§ n.22 Della poesia e del corpo.
L’abitare il luogo ultimo non può che essere un abitare la pienezza. E la voce, che è del corpo, la voce stessa che porta le parole della poesia, e il ritmo – che, anch’esso, è del corpo - sono il sacro in cui il luogo ultimo è ridato, tutto è ridato; e lo è in un significare che nulla può separare da quella voce, una coincidenza perfetta, una pienezza senza scarti che si brucia - e insieme s’arresta, esce dal tempo… - nell’immediatezza di quel suono, in quelle nascoste caviglie e tamburelli che sempre danzano nel verso…
Parole che vedo (19)
…riverbera dai tempi e ancora impelle,
quasi rintrona in questo
limbo d’assenze, un’altra risonanza
…caviglie e tamburelli…
e …il tendine disciolto allo sfrenato
numero del dio…
e …la furiosa
gioia che libera…
non si abbevera l’anima, oramai,
che a inconsolabili perdite
lenite in un’eterna pacatezza…
Parole che vedo (20)
…un vostro tacere fa assorte le cose,
l’anello
d’un immenso silenzio ci racchiude
su noi vegliate?
o, allo sguardo pensoso, non dissacra
ogni rotondità di cerchi eterni
la ferma furia della
linea che inghiotte?
o la faglia segreta del non dire
sprigiona una luce pagana,
l’inebriante cecità di un divino pulsare alla tempia
nella scocca che folgora l’istante…
§ n. 23 Se le parole, come ogni altra cosa, siano anch’esse limite e troncamento.
Che le parole siano anch’esse limite e troncamento, che esse, alle quali affidiamo ogni nostra cosa, affidiamo noi stessi, esse che portano i nostri affetti, le cose più care, che le parole siano anch’esse in un brutale troncamento, come è di noi stessi e delle nostre vite, questo è, ovviamente, un grande tema, che s’impone con la forza di innumerevoli evidenze, tema che, in questo senso, verrebbe da dire fin troppo facile, addirittura scontato. Le parole, viste nella loro tronca opacità, nella loro afasia, le parole in quanto dette a mezzo – sempre, lo sappiamo, sono dette a mezzo le parole – le parole in quanto lacerate, tronche, sanguinanti…: questo è forse ciò che più facilmente è rilevato in un primo indagare, al di là delle tante apparenze liete, anche festose... Parole come luoghi interrotti, ponti interrotti, potenze infelici, in fondo, impossibilità; ricche, questo sì, di struggente bellezza, non povere di fascino, certo, non prive di promessa, non che le parole non siano gravide di desiderio, alimentate da un fuoco vitale… Promesse mancate, piuttosto, fuochi immancabilmente volti ad un irreparabile spegnimento. Si può negare che questo – anche questo – sempre siano le parole? Non si può che ammutolire di fronte a questo carico di laceranti impossibilità, parole che non sanno dire, non possono dire, come, in fondo, sempre accade alle parole... Così possono essere viste, così possono essere vissute le parole. Così sono d’altronde le nostre stesse vite: tronche, vite cieche, linee spezzate. Non si può fingere che così non sia, qui non è ammesso.
Parole che vedo (21)
…sottace penombre un timbro
più interno; a volte,
mi so nel punto che vi abbuia
in perdute sagome: parole
in figura di uno stanco nulla
precipito in una
sfinita mutezza
ma freme irrequieto un contorno…
Parole che vedo (22)
…ci ingannate, parole,
col vostro tutto tondo che ci scoppia di luce
tra le mani; eterno
non resta che il passato, eterno sarà stato
questo rimpianto senza fine…
basta… in voi prolungano il giorno
non altro che perduti bagliori,
smagra l’ora che passa e la gloriosa
luce quotidiana
la grande attesa di rivelazione…
Parole che vedo (*)
…scialbano, un tempo densi,
gli attimi lunghi d’una scolorita,
ormai, attesa di riscatto: “L’urlo
che trapassò le tempie cade a terra -
mi dice un cuore fatto stanco - nulla
passa la soglia”….
Mi guardo intorno: pure
dietro le cose allude un permanere
strano,
anche il mio corpo attende,
anche quel grido,
appeso al proprio istante senza fine…
§ n.24 Di come l’irriducibilità della domanda e la certezza della risposta non possano che ingrossarsi nel tempo...
A questo, tuttavia, non ci si può arrestare, alle parole viste nei loro limiti opachi, alle parole così come appaiono ad uno sguardo cieco, come sempre è, anche, lo sguardo dell’esistenza, una cecità che viene dal cieco confine dell’esistere. Qui si parla del loro luogo vero. E il luogo vero delle parole è ogni volta sempre l’oltre di ogni troncamento. Nessun azzardo nel dire questo. La verità – con tutto il trepidante silenzio che deve accompagnarla - non è pretesa assurda. Essa viene a noi semmai con la forza serena di una chiara evidenza: le parole sono più di noi, e di là, da quel luogo maggiore, di là esse vengono a noi. Con esse abitiamo luoghi sconfinati. Non luoghi indefiniti - qualcosa di nebuloso in cui perdersi, disperdersi - è, semmai, che sconfinatamente abitiamo quei luoghi, il luogo di ogni parola. Così lo stare, l’andare, e l’alzarsi, il conversare, il camminare, così l’angolo della strada, il negozio all’angolo, e l’ora, l’attesa, e il saluto, il viaggio… Ogni parola è in noi ogni volta uno sconfinato abitare, ogni parola. Lo scavo può dunque continuare: la domanda s’ingrossa ad ogni spiraglio di risposta… e la risposta… la risposta – senza togliere nulla all’irriducibile drammaticità della domanda – si fa sempre più certa...
***
Che la poesia ponga sempre in se stessa un atto di autoriflessione sulla sostanza materiale che la compone, cioè la lingua nelle sue diverse diramazioni significanti, è un dato che tutti riconosciamo come ineludibile nel fatto poetico: come atto di conoscenza (e anche ri-conoscenza) sia esso implicito o esplicito nel testo. Ma è raro trovare una meditazione tanto personale, quanto universale – per chi ha a cuore il pensiero della scrittura – come questa. Una concentrazione di ragionamento che ha al centro, come luogo di immersione ed espansione, le parole.
Per gran parte in prosa, questo argomentare si apre, ogni tanto, a illuminazioni, a sovrapposizioni e anche ad apparenti oscurità. E il tutto senza chiusure o compressioni o sviamenti, ma sempre tenendo il filo di una ricerca interiore che pone domande e accoglie risposte, che sono esse stesse interrogazioni per ulteriori risposte mai definitive; così come avviene inevitabilmente in un andamento pensante in cui l’autore è consapevole di non sapere fino in fondo ciò che ha di suo nelle parole, ma di una cosa è certo: “...ho voi parole...”. E Campana per indagare questa cosa, che è la parola nel suo fare, che dice in sé e fa dire in noi e a noi, parte dalla percezione del proprio essere in quanto corpo e Io: ambedue partecipi, anzi di più, fautori indissociabili dell’esistenza. Ma quando proviamo ad estrapolarli in un atto di conoscenza, allora divengono altro da noi: infatti, non è irrilevante che si dica “il mio corpo”, “il mio pensiero”, e se qualcosa è posseduto da me allora, precisa l’autore, “io non sono quella cosa”. Siamo, dunque, di fronte all’inquietante e forse innaturale, ma reale rapporto tra l’Io e l’altro; una relazione però straniante, perché proprio nel momento in cui la consapevolezza di ciò che le parole sono, o sembrano essere, è così lucida, Io e l’altro convergono in una altalenante associazione che lo sguardo mentale segue ma non afferra in pieno. Ed è qui allora che le parole, più che ascoltate vanno indagate nel loro ascolto, nel loro luogo, affinché, dice Campana, la cosa nominata ci venga restituita come significato toccato.
E’ con le parole che vediamo, perché il dire illumina il detto e il non-detto, e tutto sembra essere voce che accende “l’azzardo di una/parola totale”, che è motivazione suprema, forse irraggiungibile, ma sempre più avvicinabile. E ciò fa sì che in questo testo la scrittura sia frutto di una pensosità che si muove sempre intorno al suo centro: lì dove ogni parola è inesauribile, dove nessuna parola è “fuor di metafora”. Lì dove le parole abitano e sono il luogo del loro e del nostro senso. Dire veramente: è questo che noi, anche se imperfettamente, facciamo con il suono e con il silenzio. Porgere dei sensi in un percorso che sia contenuto e che contenga la parola detta, la parola data come dono di libertà, senza sottomissione alcuna. E dov’è che la parola rivela, seppur nascostamente, il suo restituirci a una vita pulsante, toccante, inseparabile dalla voce che coincide con la pienezza del suo essere Io e corpo? E dove la scrittura è limite, impossibilità di un dire totale e prova di sconfinamento continuo? E dov’è che le parole “sono più di noi”, ci dice Campana chiudendo il suo trattatello, se non in poesia?
Giovanni Campana è nato a Modena nel 1949. Laureato in filosofia. La sua esperienza intellettuale è dominata dalla durezza del confronto tra il riferimento religioso, sia pure incessantemente problematizzato, e la piena immersione nel pensiero filosofico ed epistemologico contemporaneo. Ha pubblicato il volume di poesie Pensieri sulla soglia e Autoglosse con Cierre Grafica.
Enzo Campi, inediti da “Ligature”, con una nota critica di Giorgio Bonacini
da preamboli
*
una serie di idiomi vacui
come pulviscoli smottati
dal vento si leggono
a malapena tra soglie
destituite e frammenti
di cornici scarnificate
dall’incedere del tempo
e dall’acqua emerge silente
la serie dei feticci per
rinverdire delle parusie
il coatto codice dove
tutto viene a sé senza
contatto alcuno o forse
solo decede riconoscendo
all’orante il fitto reticolo
della sua indecidibilità
*
l’animale che ci sorprende
nudi e provoca il disagio
la voce la sola che possa
dire isola senza colpo ferire
la zattera che aspira alla
deriva il nerofumo che si
spaccia per vapore o nebbia
il punto ortivo a cui ogni
verbo vorrebbe tendere
la mano non sono mirabili
espedienti per restare al passo
ma solo meteore semantiche
attraverso cui farsi largo
per approdare nella radura
e rivendicare il diritto di
affiancarsi all’inesprimibile
*
se il verbo qui mortificato
indica l’impossibilità di una
destinazione traghettando
l’ombra nella diafana luce
di un’aurora privata della
rugiada ove cristallizzarsi se
la morìa dei referenti implica
la chiamata al sorgivo se le cose
tutte si consegnano tronfie
all’inevitabilità della perdita
non si potrà dare del morente
al viandante che asseconda
l’enigma rinnegando l’urlo
ove auditori e astanti
coltivano la mera illusione
d’una possibile risoluzione
*
che siano grumi di catrame
ad otturare i crateri o biancume
di calce stesa a cancellare il verbo
che siano soffici palle di lana
ove ci si raggomitola a riccio
o semplici espedienti per rendere
palpabile l’inaccessibile
che sia celata vertigine di estasi
cristalline o lavica caligine calata
di netto sull’impavido letto che
ospita il seme al nero resta
il fatto che ogni singolo trauma
qui disilluso rifiuta qualsiasi
encomio e si pone in bellavista
per meglio ricevere il sasso
scagliato dall’inquisitore di turno
da ligature
*
solo libere andate
e reclusi ritorni
minima la pioggia
a colmare la crepa
sfocato residuo
che rigenera altro
dal necessario
e si svela l’incanto
nel simulato incarto
da cui esonda
l’infertile seme
*
dicono poco o niente
del particolare per
abulica mania ma
alludono al coatto
universale per poco
che sia o per il niente
che sarà e celano
ciò che cala dall’inguine
dismesso e si comprende
bene la solfa sperando
che la disposizione
di veti e veli sia
massima e fluente
*
tra volute d’equivoci
e esodi di senso solo
un obolo saettante come
preso tra i denti masticato
appena poi sputato nella
grezza gavetta risata grassa
e stille di sdegno una sapida
saliva che cola lenta e il tonfo
sordo per inaugurare la saga
in cui rendersi alla frattura
*
non cose da parte a parte
attraversate né gesti simbolici
per quanto affrettati o peggio
fissati in posture nessuna affezione
morbosa verso cunei arroventati
né ricicli semantici di improbabili
lessemi o meglio sopraffazioni
di senso vendute all’incanto
al miglior offerente nessuna
diffrazione né punti né colate
d’inchiostro a confondere le tracce
non uno spettro che rinviene
senza clamori all’inaudita presenza
solo aporie a inondare il vuoto
pneumatico della dissolta dimora
*
poi che da dopo a venire si dà
lo scarto a principio di cosa
o solo uno scatto che abiura
la fuga per quali ampi deserti
ci si lascia sabbiare per quali
declivi le parole sono chiamate
a franare per quali estreme
unzioni che già bussano alla
porta rivendicando il lascito
del morente si deve ancora
transitare per quali fasi ci si sfalda
nel poco che rimane nel punto
ultimo che si àncora al senso
sottraendosi al gesto sorgivo?
*
non fu risoluto
a urlare lo sdegno
né mai lo ritennero
abile a tenere per
mano la labile babele
che regola il flusso
delle maree in cui
rischiare l’approccio
con la risacca e ancora
oggi coagulando mito
e misticismo si chiede
perché debbano essere
sempre gli altri a decidere
se sia lecito e produttivo
praticare l’asfissia
*
pavidi scarti o vaniloqui
se pure sobri e inguainati
si danno come improbabili
apici che invitano alla
scalata e le pietre interrate
a metà nell’impervio sentiero
non restituiscono le voci ma
s'industriano ad assorbire
il rumore dei passi senza
che nessuna utopia possa
supplicare l'inaspettata grazia
*
nessun lucore se pure miniato
di fino a differire la serie
delle tenebre abortite né furie
improvvise o navi di mota varate
a vetro crudo nessuna loggia
da cui lanciarsi a peso morto
né vestiboli in cui urlare
il silenzio dell’assenza nessuna
leva a cui ancorarsi né perni
protesi o fulcri o indomabili
indigestioni di senso nessun
pendolo basculante per dettare
l’intervallo tra l’andata e il ritorno
solo grumi di sillabe infeconde
ammonticchiate a caso magari
annodate e messe in nota relegate
a piè di pagina come meri accessori
*
sciamando perfidi bisbigli
sghembi s’inarcano i cinici
simulacri si deforma l’imago
che staziona sotto l'arco e
fin anche lo speculo si infrange
in mille risibili cocci rimpiangendo
il tempo in cui poteva riflettere
l'identico e non la sparuta
parvenza di un qualcosa che
non rischia nemmeno il gesto
del semplice riconoscimento
*
a riffe confuse dadi smussati
e inconclusi a cose di poco
conto se pure enumerate
come innestate in chiare
legende o vacui palinsesti
o elenchi puntati alla meno
peggio a cose di troppo che
esondano dalle meste bordure
a fissaggi di lampanti refusi
a cadute di fonemi slabbrati
livide ingessature e scarti
semantici a tutto quello che
qui si dice a tutto l’altro che
qui si tace coincidono sull’asse
uno o più spaesamenti
*
si dissuade dal continuare
enumerando a ritroso i passi
compiuti nereggia le orme
con colate di caldo catrame
o recupera frasi fatte da
innestare sui margini elude
lo scherno degli inquisitori
di turno e marchia a fuoco
il crocevia ove tutti
sono chiamati all’enigma
rivendica il diritto di incenerire
le radici malate o si asseconda
lanciando il sasso ma solo per
nascondere la pavida mano
*
una lama lucida argentea
sadicamente privata di
ruggine e un vecchio
pennino saturo di pece
saettano convergono
ritornano ricoprono
o solo recidono nervi
e nodi e frasi di troppo
la mano serrata non lascia
la presa ma è questione
di sapori odori o conati
dettati dalla nausea imperante
e le ridicole maschere che
ancora velano un sottile
filo di perfidia attenuano
la viva voce che vorrebbe
far riemergere il silenzio
*
non un lamento né risibili
singhiozzi solo un sussurro
lasciato nello stallo a sfumare
cade di getto la falce sul collo
e il chiodo che cuce le labbra
si offre alla luce per sfatare
il sacro gesto della meridiana
non un tempo univoco né ore
limitate alla sola contemplazione
se mai istanti inanellati come
spirali per mordersi la coda
e andare a capo magari più volte
è solo vana vanità da misero
inchiostratore che sì emerge ma
solo per riproporre e consolidare
sull’asse il giusto inabissamento
da chiose
*
se ci si perde per labili margini
o chiari varchi ove tendere l’arco
e scagliare il dardo dell’anelata
rivalsa se ci si ostina ad esibire
l’ascesso come unica chiave
per l’accesso a un quando che non
sarà mai l’adesso e solo preserverà
i cadaveri semantici di una lingua
privata d’ogni specie di lucore se il
senso scema e se ne muore della
mancanza d’attrito tra l’inevitabile
circolo e l’intrigante scatola cinese
se l’alterco tra la pietra di fiume
e la sapida lapide inonda le radure
vanificando l’aperto ecco che l’ultimo
afflato di un canto tarpato coltivando
l’interrogazione si trattiene ancora
ai bordi per celebrare la sua finitezza
*
se un rumore di fondo un sibilo
ovattato o un edotto chaos magari
un ansimare diffuso perforano
i timpani se il rifiuto della sete
di possesso non riesce a trattenere
a sé l’interrogazione sputando
un ultimo afflato appena esalato
o un rombo abortito magari un nodo
nervoso che riannoda distanza a distanza
se l’irrisolto viandante ricerca
la strada del solo cogito in cui rendersi
prossimo all’inesprimibile se il coro
dei feticci ancora implora la prima
pietra di indicare la strada maestra
non si potrà dare del morente
allo scrivente che cancella le orme
per riproporre in eterno il passaggio
***
Fin dal titolo (e sappiamo che i titoli in poesia non sono dei semplici dati indicativi) questa raccolta di Enzo Campi sviluppa con estrema coerenza, il suo percorso dentro il fare di una lingua che cerca in sé l’esperienza significante. Uno scavo interno perché fuori dalla parola poetica “la moria dei referenti” non può che ricondurre necessariamente alla fonte sorgiva del legame tra la parola e il dire. Là dove il vero si consegna in metafore e i significanti raggiungono grumi o nebulose di significati e segni. E’ da qui che il senso scaturisce in voce intima: a volte allusiva, a volte decisiva.
In poesia il percorso che i testi ci indicano non è quasi mai lineare, e tanto più in quest’opera che, respirando su se stessa annoda distanza e vicinanza, così che può essere compresa (in una delle sue molteplici comprensioni) anche partendo dall’ultima poesia: che è la fine iniziale di un reticolo indecidibile ma, in alcuni punti di snodo, determinato. Così l’autore, a partire da un brusio, da un soffio strozzato che il poeta, ultimo vero parlante, nell’impossibilità di trattenere, riesce ancora a pronunciare, arriva a dire (ma non a tutti, non al conforme, non al “coro dei feticci ” che chiede la prima pietra ) che non può indicare una strada precisa. Perché nessuno può dar seguito a questa richiesta; nessuno che sia, mente e corpo, lucidamente dentro una scrittura viva. Scrittura che è rifiuto di ogni rigidità semantica, ogni illusione comunicativa e ogni allusione a un senso compatto.
Il poeta, quando dà voce al suo pensiero in grafìa e fonìa, pone ogni volta in essere un passaggio che si auto-riforna continuamente. Sembra ripercorrere i suoi passi, ma in realtà “cancella le sue orme” anche dalla sua coscienza, elimina i vecchi accessi dalla sua conoscenza e riporta il tutto a una nuova consapevolezza. Non c’è allora nessun contrassegno primigenio, nessuna primordiale pietra perché ve ne sono, fra le tante, almeno a due a porre il segno metaforico del reale che il viandante/scrivente riconsidera continuamente (in eterno), incoraggiando l’apparente incomprensibilità (l’enigma) dei gesti sonori o silenziosi. E queste due sono: la pietra di fiume e la lapide.
La prima, posta in mezzo alle turbolenze d’acqua del senso, ne devia i passaggi senza preavviso né preveggenza, dove è anche possibile una sua dissoluzione o un suo esodo. Poiché il senso, che ha significanza solo quando il fiato si concretizza in voce e il movimento in scrittura, può rimanere tale anche deflagrando in barlumi o in frantumi, o arrivare fin dentro le lontananze di parole che a volte sono “chiamate a franare”. La seconda, che sembra nominare un punto fermo, in realtà chiama alla sottrazione, liberando la poesia, con un atto di ribellione estremo, anche dalla fonte sorgiva. A tal punto da addentrarsi, “nel poco che rimane”, in sopraffazioni di senso che incorporano nell’oscurità un magma sillabico, fino al dolore di un ribollio sovrabbondante.
Ligature è dunque un poema ricorsivo che emerge dalla fluidità e dalla vicinanza di un’inevitabile conseguenza poetica: sia che la parola, come una lama, tagli la realtà, sia che ne riconsideri, come un pennino, le diverse modalità, resta sempre indistinguibile dal suo dire, dal suo fonema esistenziale che “vorrebbe far riemergere il silenzio”.
Enzo Campi è nato a Caserta. Vive e lavora a Reggio Emilia. Autore e regista teatrale. Critico, poeta, scrittore. È presente in alcune antologie poetiche edite, tra gli altri, da LietoColle, Bce Samiszdat, Liminamentis. È autore del saggio filosofico Chaos - Pesare-Pensare, scaricabile sul sito della compagnia teatrale Lenz Rifrazioni di Parma. Ha pubblicato per Liberodiscrivere edizioni (GE) i saggi Donne – (don)o e (ne)mesi (2007) e Gesti d’aria e incombenze di luce (2008); per BCE-Samiszdat (PR) il volume di poesie L’inestinguibile lucore dell’ombra (2009); per Smasher edizioni (ME) il poemetto Ipotesi Corpo (2010) e la raccolta Dei malnati fiori (2011). È redattore dei blog La dimora del tempo sospeso e Poetarum Silva. Ha curato prefazioni e note critiche in diversi volumi di poesia. Dal 2011 dirige, per Smasher edizioni, la collana di letteratura contemporanea Ulteriora Mirari e cura l’omonimo Premio Letterario. È ideatore e curatore del progetto di aggregazione letteraria “Letteratura Necessaria – Esistenze e Resistenze”.
Silvia Comoglio, poesie da “Silhouette”, con una nota critica di Giorgio Bonacini
ho messo in scena - l’álbero e le rose,
la silhouette del vento e del mio amore
In do maggiore IV
: → bianchíssimo più bianco il cuore
che ébbe in una stella - il suo tutto - incandescente,
la sua netta - térra - di preghiera ---
*
: → precíso, precíso è lo stupore
nell’incanto di sempiterne memorie della voce ?
“góte píccole di mondi dove – qui-è-il-cielo!
e quésto di recente appena – respirato!
il pruno scuro nell’ansa dell’inverno → il modo eterno
di dire e sillabare sono stelo - e ómbra -
mite a suono ---
In do maggiore V
: → è térra – In-altézza-di-radice!
quanto già predetto déntro questo specchio, quánto ?
già cantato, cantá-to a menadito: do re mi
di inverni e molte estati, e lúci - supine - di sutura:
dimore incerte degl’álberi di passo - fioríti - sulle fronti ---
In do diesis
(in luogo di p.s.)
→ : dísse - a bassa fiamma - l’estremo suo profondo
schiarirsi nella terra, il suo farsi - tótem - abbacinato
In re minore I
... nell’antro – Di ogni sogno!
vénni io a dilagare perché tua essenza
è il termine rubato al vetro che riluce, misura
fatta di radice límpida di sguardo ...
*
Guardarvi in ogni stanza come se voi foste
profondo témpo a sortilegio : → nuda causa prima
del giorno che ricresce nell’ángolo davanti
il mare e la montagna, e il solco ripiegato
in lunga sua figura : → “álbero dell’acqua
sott’acqua già imbarcato, “ócchio chiuso chiuso
déntro il suo tinnio, nell’anima che soffia
róse - di nuda - nuca bianca ---
---
In re minore II
: → e dópo - dopo la deriva - ci sia un elmo,
úno - per ogni - nuova stanza, e un fiore
apérto - di nótte - a meraviglia : un raggio
ricurvo come prua, e lúna - Luna-in- abbondanza!
a rimedio - dei rimedi, ad intátta
síllaba dei cieli ---
*
:→ muore - muore-il-mondo! tacéndo
a paradiso, muore - quell’éssere per sempre
sotto la tettoia, in qualúnque
sguardo dell’ortica → “muore, muore scuro
nel báttere a galoppo di álbero e nitrito,
intátto per ogni suo peccato in ógni ?
suo castigo ---
---
In re minore III
…ébbi - innanzi agli occhi
álberi e cerbiatti álti e di profilo ?
l’álba e la mia tana battuta contro muro…
*
generarti a nome del mio tempo
fu l’unico segreto, specchiato e dondolato
in sogni impenitenti - di labbro e di fessura ?
fu lava - ai piedi già ghiacciata, l’incavo
segreto di paura nel buio sconosciuto ?
il mare! archetipo di spazio nell’atto di dormire [ ]
[ ]
In re minore V
[ tutto fu misura di conscio crepitare a terra di boscaglia,
“álbe – Rese alte! da incógnite tue rose, “fíbula del tempo
di guardia alla fontana ---
*
:→ fiorisci - dúnque - in rottura di parola,
nel sempre che si accosta ?
a boe, e puri soffi, a módiche tue brezze
accólte - nel mondo - in entroterra: gomene
Trainate curve! fino al corno in cui cantando
abbellisci a squarciagola: → profilo che ti chiamo
smussato delle labbra : → mio - strano dire
di mio - strano cuore ---
---
In re diesis
( in luogo di p.s.)
→: sono elmo di tempo che si avvera, gomena
Trainata curva! in abbaglio di materia : módica tua brezza
di ombra senza terra ---
In mi settima diminuita I
Gioco già cosparso - di ciglia e di memoria
l’orlo di pietra ignota e terra smisurata : lábbra ?
prensili di luna, contratte - nei geli degli inverni ?
ómbre e violacciocche vegliarde e frettolose,
sottopeso piegate come fronti ---
In mi settima diminuita II
L’UNO verso l’altro,
a tempo di segreto: sbáttere di porte
in volo interrogate: álberi che vanno
óltre - la lúcida cometa, sciólti
in ordini leggeri - di scavi
e migrazioni ---
In mi settima diminuita IV
L’INCAVO - tra il sogno e il tuono
è la rosa plasmata a dismisura, térra
che occupa se stessa germogliándo
in ácque di silenzio, in vértici a dimora
di un lungo solo bacio perfétto di ventura ---
---
In mi settima diminuita VII
:→ tuo viso - l’altezza che sprigiona
silenzi già cercati nel cavo delle mani ?
fiamme di materia - nate - dall’éstasi che fece
di quésto quasi tempo sicure dispute di sogno ---
---
In fa diesis I
: → sí-lhouette di rosa non rosa
la bruma che atterra ombra e paura : l’ócchio
reso dettaglio di forti fruscii di voci ---
*
: → sospeso ora a mezz’aria è il largo tinnare
di un fondo di suono, l’orco e il profano
a inizio profondo di cambi di impronta
nel folto del bosco : múra ?
di schiuma leggera, vermiglia sui rami,
sui lumi - incisi di vero, veggenti di cieco
colpo di vento, térra che scorre proibita ---
---
In fa diesis IX
[ pronún-cia, pronuncia sottovoce
il non-sogno guardato a tenerezza : i pioli
del cielo - da stanare ...
…
L’esodo che viene è la vostra sola testa tenuta tra le mani,
il lámpo - oscuro e trapassato - del mondo che ricade
dénso nel suo capo, nel moto che tránsita di fuoco,
óltre le locuste - nere - di peccato –––
_____
In la diesis I
Parte e si diparte lo stormo degli uccelli,
spigolo che curva terre costruite
in opposti versanti di radice : occhio e mondo
scuri di frontiera, sabbia e pura gemma
di notte che si allarma in lunga traiettoria,
a sogno che già dorme in moto di presagio,
in néro álbero d’ortica ---
---
In la diesis II
:→ l’ócchio, mi siete l’occhio
fiorito sul leggio, e il conto degli scarti
nel sogno navigati, come térre, terre a profezia ...
*
: → filare bellí-ssimo e vivente il corpo diventato
asprezza! dell’orbita del mondo : stormo
di altíssima dimora, apérto, aperto a sentinella
nel verbo dell’ortica : → lá-crima svegliata stornando
térra dalla terra, “l’ómbra - dall’álbero fantasma ---
In la diesis VI
[ spargete - immóbile vi prego - quésto lungo bosco,
la chiusa dei lunghi mondi - venuti - qui per gioco ...
*
:→ fíno a questo dire è salita ?
con l’árgano la voce: silhouette - informe interamente,
strana luna corsa tra le porte della stessa stanza, sfogliata
sull’orlo dello sguardo - stupefatto - di sibilla [ ]
[ ]
***
La poesia è sicuramente, per chi la fa, opera di lingua totale. Lingua che ingloba in sé le potenzialità e le diversificazioni tecniche e significanti di ogni forma del dire, virtuale o in atto che sia, in modo tale da farla essere scrittura vitale e non solo d’arte. In questo senso il canto di Silvia Comoglio sceglie una direzione modulare e sonora (già sperimentata in altri suoi libri), particolare e fondamentale per la sua idea poetica, resa totalmente evidente con la notazione musicale a titolo di ogni suo testo. Leggere la partitura di queste poesie è quindi un’esperienza unica: tutto è concertazione e concentrazione di suono e ritmo. La grammatica innalza le sue sonorità, i segni si espongono, il sintagma si spezza e si ricrea nella voce mentale e nella concretezza di consonanze vocaliche che danno parola al testo e prefigurano un ascolto.
Ma è quando il senso si riversa nel suono che il lettore viene catturato e obbligato, con il piacere di lasciarsi avvolgere e coinvolgere, ad agganciare le sue interpretazioni a riverberi, a onde, a rifrazioni sonore che prefigurano e indicano un percorso. In queste poesie il linguaggio viene frantumato e ricompattato continuamente, e l’aspetto sillabico-fonico, imprescindibile in una scrittura/lettura vocale, è determinante per il candore e l’armonia che la musica imprime nel paradigma esistenziale in cui l’autrice è immersa e da cui emerge per dirci cos’è che avviene lì sulla pagina. Un mondo prende vita e voce, un mondo che abbraccia il tutto naturale, emozionale e immaginario che solo una lingua incantata, ebbra e amorevole può rappresentare. E lo sviluppo che Silvia Comoglio opera del soggetto poetante dentro questa materia, è completamente aderente al percorso narrante di un io che la poesia estrae dal poeta per dirsi nuovamente.
Scrive l’autrice: ”→ stanotte – sono – chi racconto/.../”. E lo scrive in due momenti diversi, per due figurazione diverse: una di memoria slegata e verità di percezione, l’altra di finzione senza falsità innaturali. Ed è tra questi due poli, tra bugia e leggera follia, tra rosa e micro-bosco, che prendono vita le circonvoluzioni di una voce sognante e sonante. E’ nella notte, nell’oscurità che emerge pian piano uno scintillio di luce che chiama le cose a darsi forma, protette da un’intimità lieve, sfiorata, mai violata. Un soffio interiore consapevole che cercarsi e guardarsi è libertà d’immaginazione vera: musicata e dondolata al ritmo del corpo, del respiro, dell’occhio, in melodie anche spezzate e zigzaganti, ma sempre in armonia con la scrittura che ne è la consapevolezza e la bellezza reale.
C’è una struttura, che tiene l’andamento e la compattezza di questo poema, sostenuta da un equilibrio che possiamo chiamare affettivo: quello di una lingua tenera ma ferma, che mostra senza pudore i suoi tratti trasparenti, a volte informi, a pelle liscia, cuore infante di stupore arcano e mistero sibillino che sta “nel letto della voce”. Perché è nella parola che si ama; è con il suono che si abbraccia e si trema. E in quell’oscuro chiarore, che è il lato ombroso del linguaggio, dove il tanto e il poco sembrano pronunciati con timidezza, in realtà è lì che si situa la passione del canto: dove ciò che sta davanti si intuisce ma non si vede, se ne percepisce la silhouette, il contorno sufficiente a circondare e a stringere “l’ombra e l’ombra e l’ombra”.
Ma l’ombra, che non ha spessore né attrito, è anche sintomo di una leggerezza che percorre e lega la modulazione dei testi. Una notazione sospirata, ondulante che scrive e sogna come dire ciò che dice: terra e aria, gravità e levità. Infatti nelle varie poesie la presenza di elementi vivi del paesaggio naturale ha la capacità di costruire, intorno a se stessa, un microcosmo di fisicità che àncora la scrittura a un sentimento capace di pronunciare i versi come fili d’erba. Ma, ancor più, di risuonare in consonanza o dissonanza con l’alba e i piccoli animali (lumachine, rane, uccelli, scoiattoli) che vivono nel testo e ne rispecchiano, senza nessuna ingenuità, i moti spontanei. E lì, dove il fulcro dei testi si raccoglie in parole, sillabe, fonemi – scansioni precise di lingua, voce, suono – lì sta la natura poetica del mondo. Un luogo che da questi segni è nominato e con questi segni rifatto nel tempo e nello spazio, nella storia e nelle storie, nella consistenza e nella forma, perché, e pensiamo a Wallace Stevens, il poeta suona e non suona le cose come sono.
E anche i sogni o i movimenti sonnambuli, che l’autrice pone quasi a fiaba di fanciullezza iniziale, a cui la poesia sempre tende e da cui ha origine, stringono a sé un vortice di vento i cui effetti, pur vedendosi soltanto in superficie, sprofondano in una ventosità estenuante, una “ùr-/genza di stare contro/.../” per dare realtà all’immagine vera di un mondo ricreato “nel vento/eterno del prato”. Ma in questa scena di quotidianità trascendente Silvia Comoglio riesce a darci, con una mirabile capacità visiva, una folgorante visione del suo strano cuore, nello strano mondo del suo strano dire in un “làmpo di ànatra che guarda la persiana buia della casa---/”.
E’ questo il dicibile difforme, ma poeticamente reale, che l’autrice ci mette davanti: come a dire che non c’è vita senza poesia e la morte sta nella mancanza di canto. Perciò si deve scrivere sillabando il respiro nella mitezza di un suono d’ombra, in questa sinestesia che è il centro della voce. Non una riga senza avere pensato o sentito ciò che essa scrive, dice Joë Bousquet; così per Silvia Comoglio è la metafora del canto a sentire la concretezza nella vita del poema, in una voce che sempre si dà “déntro il suo nome precíso”.
Silvia Comoglio è nata nel 1969 e vive a Verrua Savoia (To). Laureata in filosofia, ha pubblicato le raccolte Ervinca (2005), Canti onirici (2009), Bubo bubo (2010). Suoi inediti sono apparsi nel blog “La dimora del tempo sospeso” e nelle riviste “Il monte analogo” e “Le voci della luna”. E’ presente nei saggi Senza riparo. Poesia e finitezza e Blanc de ta nuque, entrambi opera di Stefano Guglielmin.
Loredana Semantica, poesie da “L’informe amniotico”, con una nota critica di Giorgio Bonacini
13
E’ uno scivolamento costante. lo smottamento del tempo. che frana a pioggia sui nostri occhi. tredici secondi che illuminano. sassi. ortiche. bocche. è uno scenario disumano. grigio cupo e rocce. lampi di straordinario. solo a tratti.
12
Io lo so com'è ch'è il vento. come a un certo momento. con le foglie si solleva e corre. come filtra dal di dentro. e soffia oltre le porte. io lo so come fuoriesce. da molte bocche storte. come alimenta un fuoco. di benzina e nulla. come sibila piangendo. o ride dei suoi colpi. piantando chiodi. dodici e lunghi per infliggere tormento.
11
E’ così che siamo fatti grandi. di pietra. su cui poggiare i nostri credo. le statue d’intaglio. il bronzo colato. il gesso dei nostri piedistalli. di marmo la forma. i sensi smarriti. la progressiva perdita del sacro. è così che tracciamo undici rotte all'infinito. e navighiamo distanti senza toccarci. guardando in lontananza. la consapevolezza dei nostri disincanti.
10
E’ un destino scelto. la solitudine del dieci. dove gli altri non c'entrano. non per scelta. né per il destino. e nemmeno per la solitudine. che anzi è spazio così profondo. dove tutti trovano posto. nel tempo loro. dentro.
9
Si scrive sempre l'effimero del mondo. gli ultimi pezzi. il titolo deciso. le molte pagine di versi. dal nove è un parto sotterraneo. pasto di viscere e memoria. nascerà intero il mostro. non per la luce e nemmeno per la gloria.
8
Non lo credevano possibile. che crescesse come gli altri. che si facesse grande. che le curve gonfiassero la carne. otto espressioni di meraviglia. e tanti complimenti. per quanto inutili ogni volta. a dare forma al corpo. a fermare la sua rivincita potente.
7
Di una magrezza estrema. i sette anni. credevano d’avere per missione. di far ridere tutti. come un buffone.
6
Poi si fece un varco. un altro navigare. dove mancavano alleati e pure il mare. passava veloce il tempo. ripassando parti. da ragazza timida e scontrosa. sei gradini per l’accesso. all’atrio sottomesso della scuola.
5
L'ovale del viso incorniciava. l'attaccatura dei capelli. lei tutti da un lato. lisci e neri. io ricci e quasi biondi. tirati in alto indietro. verso la sommità del capo. in una coda. a scoprire bassa la fronte. da bambina. nella foto della quinta elementare.
4
Un fiocco in testa. l’altro. in disordine sul petto. quattro dita penzolanti e corte. un fiocco modesto. discinto e senza corpo. che a nulla valeva inamidarlo. appuntarvi le medaglie i premi vinti ottimi voti. ugualmente non reggeva il confronto. con quello degli altri. sempre perfetto per forma e per colore.
3
Si direbbe il numero perfetto. se non fosse uno stato. rinnegato per tre volte.
2
Nacque e fu un errore. di sesso femminile. avrebbe dovuto avere un genere diverso. l’altro dei due possibilmente. sempre che poi. non ne esista un terzo. né carne né pesce. degli idonei ad essere. personaggi per sempre. alla ricerca di se stessi.
1
Dicono che accade. che prossimi alla foce si ritorna all’uno. al grembo della madre.
0
Per dire il fiato
non basta un solo stato
e poche righe in rete
non bastano alla bocca
povera di dita
i tasti freddi
inverni inesauribili
milioni di rinate primavere
per dire tutto il fondo sincero
l’aprirsi dell’anima il respiro
che soffia dai polmoni possente
acceso
insostenibile all’umano peso
e gonfia guance occhi e trombe
la grazia del creato
l’acqua rigogliosa di cascata
il fragore bianco alla discesa
gli zoccoli i ruggiti
i versi di tutti gli animali
le piante aperte in gemme
i frutti e meravigliosi fiori
i loro semi nei soffioni
il volo magnifico di stormi
a disegnare onde in cielo
fluttuanti come un velo
il grano al vento come seta
il senso infinito di ringraziamento
l’appartenenza al mondo della vita
degli esseri esistenti e benedetti
nel segno universale
grandioso naturale
della Madre nostra
scintilla planetaria
miracolosamente ancora
terra viva.
***
Una scansione temporale inversa, dove il già accaduto appare come un presente ulteriore, può significare una ricerca che tenta di rendere sensibili ed evidenti a se stessi connessioni e significati vissuti, ma che necessitano di nuova percezione ed esperienza. Dalle profondità del passato, scandito in sequenze di ore piene di tempo compresso, si recuperano momenti esistenziali, prove di vita che, momento dopo momento, ritornano all’oggi: o meglio allo zero presente di una esterna, perché visibile in scrittura, interiorità singolare e frastagliata nei suoi eventi.
Ma per chi è in atto di poesia, consapevole del suo fare concreto, come ci mostra Loredana Semantica in questi appunti poetici numerati, sa che anche la scansione materiale del testo produce la sua significazione: ad esempio nell’emozione di un senso che è gratitudine e palpitazione anche a partire da una piccola fonìa grafica: là dove annota che la perfezione della sessantatreesima ora “risparmiò una e. e dentro aveva il tre” e la fatica di una nascita all’infinito. Si vede dunque chiaramente la valenza poetica di una forma del sentimento che va dall’alfabeto alla significazione continua di un perenne inizio di senso. Una progressione continua, dunque, una scansione che sembra avere un andamento che è più una distensione che un cammino. I testi infatti si presentano sulla pagina come delle riflessioni senza versificazione, salvo il fatto di essere punteggiate, e perciò respirate interiormente, con un ritmo che è connotazione di un lento stato, come di attesa.
Scrivere allora diventa un modo, passo dopo passo, di raccogliere figure e sostanze, percezioni e immagini, in un brusio modulato che prende corpo e pensiero. E dove noi che leggiamo ne sentiamo le fluttuazioni, da un estremo all’altro, di quel particolarissimo essere lirico che è l’ansia del poeta. Ogni tanto però il testo da lineare ritorna in strofe, senza segni di punteggiatura, rette solo dal proprio scandire lo spazio e il tempo della scrittura e della lettura: della parola detta e della parola taciuta, anche quando “accade che si scriva/ed è un errore”. Ma non c’ è modo di smettere il canto, perché è lì a dare evidenza esemplare al proprio dire, a disincarnarlo dal corpo centrale per desiderio di leggerezza o di precisazione nel suo offrirsi totale.
E nonostante l’io sia una “preda indifesa”, nel testo si lascia andare a circonvoluzioni di assoluta e precisa libertà, dove la luna ritorna ad essere la poesia centrale: in un impeto di suono, rime, assonanze che scandiscono un momento di bellezza e purezza.
Poi qualcosa ripiega in se stessa e dentro di sé tace, seppur con fatica, anche i modi in cui la vita si snoda, si arrotola, si contrae e sembra all’apparenza contraffarsi. Ma nonostante questa ferita dentro il senso, questa difficoltà nel comprendere i segnali e la voce che tenta di fermare la conta delle ore, c’è ancora un TU, un altro a cui donare ciò che appartiene e che abita la poesia: la parola. E se anche sono “parola vuote”, quando le vedi davanti, una dopo l’altra, sono “come fiori offerti. come fiammiferi accesi”. Perché non è possibile, quando il linguaggio chiama la lingua a farsi suono, voce e poi scrittura in segni necessari alla propria sconosciuta origine, non considerare l’ascolto di sé, che scrive se stesso, di natura universale, nello “scivolamento costante” verso un’origine materna, inesauribile.
Loredana Semantica, nata a Catania nel 1961, è laureata in legge, sposata con un medico, ha due figli, vive e lavora a Siracusa come funzionario pubblico. Si interessa di poesia, fotografia e lavorazione digitale di immagini. Proviene dall’esperienza di partecipazione e/o collaborazione a gruppi poetici, di fotografia, arte digitale, litblog, associazioni culturali nel web e su facebook. Ha pubblicato in rete all’indirizzo http://issuu.com/loredanasemantica le seguenti raccolte visuali e/o poetiche: Silloge minima (7/11/2009) Metamorfosi semantica (3.2.2010), Ora pro nomi(s) (27.3.2010) Parole e cicale (13.8.2010) L’informe amniotico (27.2.2011). Gestisce il blog “Di poche foglie” all’indirizzo http://lunacentrale.wordpress.com/.
Le recensioni di Marco Furia su Luca Artioli, Silvia Comoglio, Mauro Germani, Giovanni Infelìse
“Onesti versi” su Luca Artioli
Luca Artioli, “La casa a cui vieni”, L’arcolaio, 2012, pp. 79, euro 11,00
Onesti versi
Con “La casa a cui vieni”, Luca Artioli presenta una raccolta nella quale si coglie una sorta di non detto assiduamente presente.
Il linguaggio è piano, il fraseggio del tutto comprensibile, eppure qualcosa chiama da fuori.
Un fuori che tuttavia è anche dentro a quelle parole, a quelle articolate immagini, a quel poetico àmbito verbale.
Qualcosa c’è e non c’è, si mostra e non si mostra in un divenire idiomatico che nel descrivere l’esterno partecipa di un’interiorità onnipresente nella sua minima, immensa dimensione.
Dimensione intima di un’attitudine espressiva piccola ed enorme nello stesso tempo, non misurabile in metri o grammi, bensì in intensità dell’esserci.
Il percorso della silloge si svolge, così, lungo direttrici dettate da una salda consapevolezza del valore dell’esistere.
Le persone, gli avvenimenti, gli oggetti sono lì, appaiono per via di un atteggiamento poetico che parla la sua semplice lingua.
Leggiamo:
“E se piove sarà divano, piedi
scalzi e onesta poesia”.
Il “divano” diventa, in una giornata di pioggia, quasi circostanza esistenziale (non a caso è usato il verbo essere: “sarà”) ed elemento di passaggio da una maggiore naturalezza (“piedi scalzi”) a un’“onesta poesia”.
L’aggettivo è di non secondaria importanza.
“Onesta” non pare alludere a un’auspicabile sincerità quale traguardo da raggiungere, ma a una dimensione dello stare al mondo che continuamente si ripropone e, dunque, è progetto, desiderio, necessario sbocco espressivo.
Non mancano tratti capaci di meravigliare
“Sediamo sull’erba come
chi entra nella notte”,
d’indurre a una riflessione sulla stessa natura del comporre versi
“il chiostro della poesia”,
o di suggerire un rimpianto che sa farsi solida constatazione
“La solitudine dei gesti incompiuti
racconta della mano che non ha
carezzato, del piede immobile”.
Il tutto per via di tocchi precisi, misurati, volti a non interrompere una narrazione poetica che assume, in quanto tale, un importante ruolo.
Il lettore può apprezzare, di pronuncia in pronuncia, una raffinata trama linguistica in cui il senso di trasferimento proprio del racconto (forse già annunciato, in forma di moto a luogo, dal titolo) si avvale di un costante e indicibile quid che, pur non essendo parola, è onnipresente.
Non si tratta di un’origine in senso stretto, ma di un ininterrotto accenno sotteso, quasi un rimando che non si riferisce a un’entità esterna poiché vivido riflesso che fa parte di quella medesima entità.
Siamo fatti anche d’ineffabile: questo mi pare l’onesto messaggio di Luca Artioli.
“La parola del sogno” su Silvia Comoglio
Silvia Comoglio, “Silhouette”, Anterem Edizioni, Verona, 2013, pp.47, s.p.
La parola del sogno
“Silhouette”, di Silvia Comoglio, si presenta quale intensa raccolta in cui il vivido desiderio di una lingua differente diviene originale espressione poetica.
Per la poetessa, l’usuale grammatica, lungi dal costituire inderogabile complesso di regole, è, piuttosto, orientamento, tendenza cui non è necessario adeguarsi in modo rigido.
Qualcosa di realisticamente onirico è presente in versi che paiono talvolta generarsi reciprocamente, altra volta quasi dondolare nel vuoto di una peculiare musicalità che manca eppure c’è, altra volta ancora proporre immagini precise per poi aprirsi su universi inaspettati.
Il sogno è indissolubilmente legato alla nostra vita: ci accompagna giorno dopo giorno, istante dopo istante.
Silvia si assume l’impegno di offrire, con responsabile creatività, specifici sbocchi espressivi a tale aspetto dell’umano esistere.
Pronunce quali
“Parte e si diparte lo stormo degli uccelli,
spigolo che curva terre costruite
in opposti versanti di radice: occhio e mondo
scuri di frontiera, sabbia e pure gemma”
e quali
“Predice incanto la notte pura a tempo
insonnia che illumina il tuo stato
di lingua ancora ebbra, di eco che rapisce”
mostrano in maniera evidente la tendenza a evocare un vivido altrove linguistico la cui esistenza emerge da un interno che è, nello stesso tempo, esterno.
L’identità dei tratti linguistici è, dunque, labile?
Sì e no.
Sì, se ci riferiamo all’affievolirsi delle caratteristiche tipiche del comune idioma, no, se apprezziamo originali fattezze verbali per nulla imprecise, anzi distinte e perfino tenaci.
Impegnata molto seriamente nella costruzione della sua lingua, la poetessa procede con assidua determinazione: si tratta, nel suo caso, di un vero e proprio progetto espressivo che viene posto in essere in forma di poesia.
Diversi sono i modi di scrivere e diversi sono quelli di leggere.
L’intero, qui, si compone delle sue parti e, contemporaneamente, è ciascuna parte, poiché l’intensità del linguaggio conferisce specifica fisionomia a tutto lo scritto come al singolo brano.
L’assonanza, più che essere frutto di armonie interiori, diviene nei suoi aspetti generali e particolari con il procedere della lettura.
Occorre rendersi disponibili al dialogo con un’autrice che è presente non dietro le sue parole, bensì con le sue parole.
Soltanto se simile disponibilità non fa difetto, l’orchestrazione di “Silhoulette” si apre, senza segreti, a ogni ulteriore lineamento di senso.
O, meglio, taluni segreti persistono, ma ora – ce ne rendiamo conto – sono anche nostri: sono, a ben vedere, enigmi in cui non possiamo non imbatterci quando usiamo la lingua.
La corda della chitarra vibra nel cavo della cassa armonica come pure in coloro che ascoltano, poiché ascoltare uno strumento musicale è già suonarlo.
L’intento del poeta è certamente quello di coinvolgere i suoi lettori, di far echeggiare in loro i suoi versi: credo che Silvia Comoglio, per via di un dire intimo ma non privato, giunga felicemente a siffatto esito.
La voglia di poesia è contagiosa?
Nel caso di “Silhouette”, sì, senza dubbio.
“Il sostegno della poesia” su Mauro Germani
Mauro Germani, “Terra estrema”, L’arcolaio, Forlì, 2011, pp. 103, euro 11,00
Il sostegno della poesia
Con “Terra estrema”, vivida raccolta articolata in tre parti, Mauro Germani non delude le attese suscitate dal titolo.
Il suo è davvero un viaggio in una terra estrema, in un’ultima regione esposta sul magma dell’indicibile.
Non si tratta di una sottile linea di confine ma, appunto, di una “Terra”, ossia di un territorio nel cui àmbito l’esistere partecipa di particolari qualità.
Qualità che, secondo logica, dovrebbero essere tra loro incompatibili, ma che, qui, appaiono distinte e nello stesso tempo fuse assieme.
Leggiamo:
“in silenzio, tu
altro da te, altro nell’altro,
solo, a frantumi,
nello specchio rovesciato
del mondo”.
Germani, come si vede, dice e si dice.
L’enigma dello stare al mondo (equiparato a uno “specchio rovesciato”) è vissuto nei termini di una scissione multipla (“tu / altro da te” ma anche “altro nell’altro”) in grado di porre sotto minaccia lo stesso concetto d’identità personale e di inoltrare l’autore o qualsiasi altro individuo, come dice Marco Ercolani nella sua intensa nota introduttiva, “nell’abisso del dolore”.
Siamo al cospetto di un non rassicurante processo dalla durata tendenzialmente illimitata che, nel caso in esame, trova un saldo ormeggio nella parola stessa della poesia: al pericolo di dissoluzione, il Nostro oppone l’argine dei suoi versi.
Avendo sotto gli occhi i conturbanti esiti della propria sensibilità lucida ed estrema, capace di cogliere con rigorosa chiarezza aspetti difficili da sopportare, riconoscendo in sé, quale intimo lineamento, un’inquietante visionarietà (“Forse corpi di corpi, / corpi dentro corpi”), il poeta reagisce con l’uso di un idioma che assume i tratti della pronuncia salvifica.
Se nella scienza medica una corretta diagnosi non è ancora cura, in poesia tali due aspetti tendono a coincidere o, almeno, a confondersi: dire, con poetica franchezza, una contingenza (o un’emergenza) produce già effetti benefici.
Il poeta condivide le inquietudini dei suoi simili e le rende esplicite, sicché la sua è parola individuale e, contemporaneamente, collettiva, comune.
Si tratta di un’offerta per nulla generica in cui ognuno può trovare il sostegno di una lingua originale ma mai estranea: la scrittura, almeno una certa scrittura, può essere di grande aiuto.
Con cadenze che alternano forme di verso libero a lineamenti di prosa poetica, attestato al di qua del limite oltre il quale dalla feconda rappresentazione dell’enigma si rischia di cadere (con pericolo di annientamento) nell’enigma stesso, incline alla pregnante esattezza di ritmi precisi articolati in una complessa versificazione, Mauro coglie dell’immagine l’aspetto liberatorio, l’impulso a proseguire, a non restare ancorati a quello che, in senso stretto, viene rappresentato.
Emblematico, a questo proposito, il “Nudo” di Munch riprodotto in copertina?
A mio avviso, sì.
“Un doloroso desiderio” su Giovanni Infelìse
Giovanni Infelíse, “Dépassé”, Book Editore, 2011, pp. 71, euro 12,00
Un doloroso desiderio
L’oggetto o, se si vuole, il protagonista di “Dépassé”, complessa raccolta di Giovanni Infelíse è, a mio avviso, l’inarrestabile scorrere del tempo, il suo procedere senza sosta dal passato verso il futuro attraverso il presente, il suo essere intimamente parte dell’uomo secondo lineamenti di memoria, di senso del qui e ora, di aspirazione, di attesa, di desiderio, di disinganno, di dolore.
Il poeta vive la dimensione esistenziale in maniera molto intensa ed evidente è la sua determinazione a renderne testimonianza.
Ma, come testimoniare?
Fino a qual punto le parole possono essere considerate appropriate?
Quesito di enorme portata che non scoraggia il Nostro, come dimostra il fitto dettato.
Possiamo utilizzare in modo diverso il linguaggio, possiamo modificarlo, ma non possiamo farne a meno.
Non è una condanna, è un’ineliminabile condizione della nostra vita.
Infelíse, così, non rinuncia al dire.
Il suo è un dire prosodico ed evocativo.
Una sorta di poetica offerta di sincera fratellanza consente al lettore di non sentirsi estraneo a un articolato flusso idiomatico, d’immergersi nella peculiare densità di una pregnante atmosfera.
-Se sono qui in mezzo a voi, quel voi è già un noi- dice il poeta coinvolgendo e coinvolgendosi in un tempo esistenziale coincidente con la vita stessa.
Leggiamo:
“Parli di un sacrificio ebbro di disperazione,
una dura prova sragionando allarma
il tempo dell’altro”.
Esiste non soltanto il mio tempo, ma anche quello dell’altro: il rilevante problema che si pone, perciò, riguarda l’impegno necessario a entrare in rapporto, a comunicare.
Il contatto con l’altro richiede disponibilità, esige qualcosa di più, qualcosa che, aprendosi al diverso
“è tutto ciò che allontana
dalla consuetudine e dalla devozione,
da una desolata certezza”.
Il tempo dell’auspicabile dialogo è dunque nostro e altrui.
Siamo di fronte a una possibile perdita o a un eventuale acquisto: c’è un rischio da correre se non si vuole vivere nella “desolata certezza” di uno sterile individualismo.
Lo scenario non appare per nulla sereno, poiché implica un esporsi dall’esito incerto:
ogni decisione, per quanto ponderata, partecipa di una natura aleatoria che, ci accorgiamo, permea tutta la nostra vita.
Prenderne atto, tuttavia, non significa necessariamente cadere nel più cupo sconforto.
Di fronte all’ineluttabile accidentalità di noi stessi e del mondo, Giovanni scopre nell’incertezza fiduciosa un atteggiamento capace di attenuare l’inquietudine:
“Resta il dubbio a offrire un’oscura calma,
una trepida sorgente che s’apre al pelago
e all’abitudine di amare il giorno
che a te mi porta con dolorosa gioia”.
Quasi una dichiarazione, resa particolarmente efficace dall’ossimoro “dolorosa gioia”.
Siamo al cospetto di un dubbio non sterile, tale da costituire un àmbito in cui prendere respiro e una tregua da cui ripartire, un dubbio che, da solo, non condurrà l’umana specie a condizioni di pacifico equilibrio, ma che, in ogni caso, avverte il poeta, potrà essere d’aiuto lungo un percorso
“in cui ognuno resta ciò che era:
un desiderio doloroso”.
In tali non tranquille circostanze è presente, però, una consapevole speranza:
“Ora siediti e parla,
siedi vicino e parla”.
Sta a noi, anche se non siamo seduti l’uno accanto all’altro, porre in essere una relazione per via del linguaggio: occorre cogliere e sviluppare al meglio simile opportunità.
Quale poeta, del resto, non crede nella parola?
10 anni di “Carte nel Vento”: tutti i poeti e i prosatori pubblicati
Avvertenza:
per leggere i contenuti relativi a ciascun autore, è sufficiente scriverne il nome nella
finestra “Ricerca” nel colonnino a sinistra del sito
Sebastiano Aglieco, Pietro Altieri, Marcello Angioni, Cristina Annino
Lucianna Argentino, Alessandro Assiri, Daniela Attanasio, Dino Azzalin
Luigi Ballerini, Daniele Bellomi, Armando Bertollo, Giorgio Bona, Leonardo Bonetti
Silvia Bre, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Giovanni Campana, Enzo Campi, Allì Caracciolo
Lorenzo Carlucci, Alberto Casadei, Guido Caserza, Alessandro Catà, Alessandra Cava
Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Gaetano Ciao, Domenico Cipriano, Roberto Cogo
Silvia Comoglio, Federico Condello, Marina Corona
Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto
Mauro Dal Fior, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Evelina De Signoribus
Tino Di Cicco, Vincenzo Di Oronzo, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria, Giovanni Duminuco
Marco Ercolani, Franco Falasca, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina, Silvia Favaretto
Federico Federici, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory
Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Kiki Franceschi, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Marinella Galletti, Mauro Germani, Alessandro Ghignoli
Gianluca Giachery, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Carolina Giorgi, Marco Giovenale
Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Cesare Greppi, Maria Grimaldi Gallinari
Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini
Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin
Giovanni Infelìse, Carlo Invernizzi, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Marica Larocchi, Alfonso Lentini, Tommaso Lisa, Andrea Lorenzoni
Loredana Magazzeni, Marianna Marino, Francesco Marotta, Giulio Marzaioli, Stefano Massari
Daniele Mencarelli, Manuel Micaletto, Francesca Monnetti, Emidio Montini, Sandra Morero
Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Luigi Nacci, Stefania Negro
Francesco Onìrige, Cosimo Ortesta, Luca Paci, Giuseppe Pellegrino
Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Luisa Pianzola, Stefano Piva, Chiara Poltronieri
Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Maria Pia Quintavalla
Andrea Raos, Jacopo Ricciardi, Giuliano Rinaldini, Gianni Robusti, Marta Rodini
Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa
Sofia Demetrula Rosati, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti
Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Massimo Sannelli, Viviana Scarinci, Evelina Schatz
Massimo Scrignòli, Loredana Semantica, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Pietro Spataro, Maria Paola Svampa
Italo Testa, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato
Luigi Trucillo, Guido Turco, Giovanni Turra Zan
Tonino Vaan, Matteo Vercesi, Maria Luisa Vezzali, Ciro Vitiello
Gennaio 2013, anno X, numero 17

Entrando nel decimo anno di “Carte nel vento” è doveroso ricordare tutti i poeti e prosatori che finora ne hanno accompagnato il cammino, tra conferme di autori già noti, proposti in gran parte per testi esemplari, e scoperte di nuovi talenti, spesso punte della nuova poesia italiana. In pratica, molto del lavoro intorno alla poesia svolto negli ultimi anni dal Premio Lorenzo Montano. Questo periodico trae infatti argomento da tutto quanto accade nella composita geografia del Premio, tra i suoi vasti confini. Il presente numero è interamente dedicato ai vincitori del “Montano 2012”, commentati dalla redazione di “Anterem”, e presentati non solo attraverso le opere premiate ma anche con l’aggiunta di contributi inediti che ne amplificano il discorso e la poetica.
Per proseguire nel cammino, per rinnovare questa particolare storia della poesia con altri autori, è già disponibile il bando della nuova edizione.
Scarica il bando del Premio che scade il 15 aprile 2013
Accedi all'area dedicata alle opere.
In copertina: olio su tela di Laura Caccia
10 anni di “Carte nel Vento”: tutti i poeti e i prosatori pubblicati
Avvertenza:
per leggere i contenuti relativi a ciascun autore, è sufficiente scriverne il nome nella
finestra “Ricerca” nel colonnino a sinistra del sito
Sebastiano Aglieco, Marcello Angioni, Cristina Annino
Lucianna Argentino, Alessandro Assiri, Dino Azzalin
Luigi Ballerini, Armando Bertollo, Giorgio Bona, Leonardo Bonetti
Silvia Bre, Alessandro Broggi, Roberto Bugliani
Laura Caccia, Rinaldo Caddeo, Nanni Cagnone, Giovanni Campana, Enzo Campi, Allì Caracciolo
Lorenzo Carlucci, Alberto Casadei, Guido Caserza, Alessandro Catà, Alessandra Cava
Roberto Ceccarini, Giorgio Celli, Gaetano Ciao, Domenico Cipriano, Roberto Cogo
Silvia Comoglio, Federico Condello, Marina Corona
Marcella Corsi, Elena Corsino, Erika Crosara, Albino Crovetto
Mauro Dal Fior, Alessandro De Francesco, Enrico De Lea, Chiara De Luca, Evelina De Signoribus
Tino Di Cicco, Vincenzo Di Oronzo, Edgardo Donelli, Paolo Donini, Antonella Doria
Marco Ercolani, Franco Falasca, Gabriela Fantato, Anna Maria Farabbi, Roberto Fassina
Federico Federici, Paolo Ferrari, Aldo Ferraris, Paolo Fichera, Massimiliano Finazzer Flory
Giovanni Fontana, Luigi Fontanella, Kiki Franceschi, Mario Fresa, Lucetta Frisa, Adelio Fusè
Miro Gabriele, Tiziana Gabrielli, Marinella Galletti, Mauro Germani, Alessandro Ghignoli
Gianluca Giachery, Lino Giarrusso, Andrea Gigli, Carolina Giorgi, Marco Giovenale
Alfredo Giuliani, Lorenzo Gobbi, Marcello Gombos, Cesare Greppi, Maria Grimaldi Gallinari
Ermanno Guantini, Vincenzo Guarracino, Mariangela Guàtteri, Gaia Gubbini
Gian Paolo Guerini, Stefano Guglielmin
Giovanni Infelìse, Carlo Invernizzi, Gilberto Isella
Ettore Labbate, Marica Larocchi, Alfonso Lentini, Tommaso Lisa
Loredana Magazzeni, Marianna Marino, Francesco Marotta, Giulio Marzaioli, Stefano Massari
Daniele Mencarelli, Manuel Micaletto, Francesca Monnetti, Emidio Montini, Sandra Morero
Alberto Mori, Alessandro Morino, Renata Morresi, Luigi Nacci
Francesco Onìrige, Cosimo Ortesta, Luca Paci, Giuseppe Pellegrino
Camillo Pennati, Gabriele Pepe, Luisa Pianzola, Stefano Piva, Chiara Poltronieri
Giancarlo Pontiggia, Nicola Ponzio, Michele Porsia, Maria Pia Quintavalla
Andrea Raos, Jacopo Ricciardi, Giuliano Rinaldini, Gianni Robusti, Marta Rodini
Cecilia Rofena, Andrea Rompianesi, Stefania Roncari, Silvia Rosa
Sofia Demetrula Rosati, Pierangela Rossi, Giacomo Rossi Precerutti
Luca Sala, Tiziano Salari, Luca Salvatore, Massimo Sannelli, Viviana Scarinci, Evelina Schatz
Massimo Scrignòli, Maurizio Solimine, Lucia Sollazzo, Pietro Spataro, Maria Paola Svampa
Italo Testa, Matilde Tobia, Maria Alessandra Tognato
Luigi Trucillo, Guido Turco, Giovanni Turra Zan
Tonino Vaan, Matteo Vercesi, Maria Luisa Vezzali, Ciro Vitiello
Laura Caccia, Premio Raccolta inedita 2012: da “D’altro canto”, premessa di Giorgio Bonacini e nota di Stefano Guglielmin
Davanti a questo esistere,
all’ora locale, dilatando la strada
e la storia ai loro sguardi
in ogni traduzione e carezza
Quantomeno non si lascia
alle spalle erbe abbottonate al cielo,
terra e porti fuori
angolo Qui è parola
minuscola all’unisono,
ferma sulla nostra pelle, ha impronte
minerali, filo spinato
tra le sue fenditure Un canto
piegato verso i traslochi
in prestito dalle proprie origini dove
le foreste si smarriscono,
dove nidificano
Quando si avvia a parlare il poeta non sa qual è e dov’è l’inizio da cui spingersi, parte verso una direzione ancora sconosciuta e comincia a dare voce e scrittura, per prendere vita e ridarla. Così, per Laura Caccia, partenza e percorso prendono forma con l’ignoto: che è principio di attrazione e di conoscenza. La sua è una scrittura che affonda in un sentire, fisico e intellettivo, dove ciò che non si sa è quasi una fluttuazione potenziale, un vuoto d’ombra da cui emergono, come quanti di realtà, “notizie... paragonabili a un’ emozione...”. E da qui comincia a farsi strada, in un tragitto di sequenze e conseguenze, un senso che cerca nel reale l’accordo con l’esistenza. Partendo dal non-ancora-conosciuto, che ha il suo rifugio nel mondo che c’è, l’autrice incide con una metafora ancora oscura, ma che va lentamente a prendere luce. Una luce, però, non omogenea, perché la poesia, questa poesia, non può che dislocare parole e connessioni difformi, non comunicazioni in un “inizio capovolto”, dove l’umanità sembra andare al contrario.
Ma il poeta ha, nel suo sguardo lucido, un orizzonte di appartenenza e memoria, di vuoto e spaesamento, non come sintomi contraddittori, ma cambiamenti e rinforzi incessantemente persi e ripresi, e ogni volta arricchiti dal mare di nomi che la parola poetica si prende a cuore di far crescere. La voce dell’autrice si costruisce in versi che sembrano percorrere un labirinto ricorsivo, un andamento di circonvoluzioni piane, senza stacchi: così come è senza fratture la visione a cui è data “tutta la leggerezza che occorre” per transitare verso l’inconosciuto. E più la percezione si avvicina alla fonte di ciò che risuona nella mente, più il dire aumenta il suo sforzo per sostenere il senso che sembra non appartenere nemmeno alle cose. Ma se così è, allora il sentimento che anima i segni deve portare necessariamente a una voce che convoca il nulla. Ma chi scrive sa che è la poesia a riconoscere e a dare nuova identità al suono che si è perso, con un respiro che, anche se flebile, non è mai compromesso con i dati apparenti. E’ sempre un’opposizione alla realtà, un contrasto che intreccia silenzio e voce senza appartenere né a l’uno né all’altra, né ad entrambi: ma al loro imprimersi ed esporsi, in vista di una vita reale e perturbata da un esproprio che porta stupore contro le anticipazioni del senso comune.
I versi non conoscono tregua, emergono e si diffondono come per ripopolare il mondo, e lo fanno con una naturalezza inimmaginabile in un pensiero che non sia mosso dall’ adesione totale con la parola da cui è prodotto e che produce. Così l’opera che si fa apre a una visibilità altra, non ancora codificata, dove può capitare di “smarrirsi tra le incrinature” della sua materia. Ma ciò è un bene, per polverizzare “verità illegittime”, che solo la poesia, come una scienza dell’incanto, può ricondurre al vero. Laura Caccia chiede al lettore di affrontare un perturbamento che raccolga in sé la perdita di senso che spinge a rientrare nel sonno del silenzio. Perché solo così il vivente può riavere parola e scrittura, per ospitare la meraviglia e musicare il dolore. Ma c’è un rischio: non riuscire poi a tenere salda la concretezza dell’ immaginazione. Un’esondazione potrebbe portare all’oblio per troppa oscurità o all’ accecamento per troppa luce. Qui, però, dove non c’è sperpero di lingua, la poesia riesce a dare alle figure il riconoscimento del proprio dissentire, grazie alla fervida emozione che “scioglie sintassi e orizzonti”.
Questi testi non sono mai dettati da smania di dire, ma da un sentire polivalente che sgorga dalla sorgente di una respirazione parlante, ai margini di quel vortice lento, che diffonde grafia e fonia a formare una propria interiorità. E’ questa la sfida che i versi accettano: spogliare una supposta verità e riportarla al canto intimo di “vita inedita”, di “grammatica umana”. Sono fruscii e luccichii dentro cui anche smarrirsi, ma sempre per poter rinominare “lo stormire del mondo”. Ecco la disposizione all’ accoglienza di ciò che non si sa, ma che certamente è: raccogliere la precarietà di ogni significato e la dissipazione che attua la sua semina, per far crescere una lingua senza abusi. Una lingua che dilati la sua esistenza fino a contenere, anche solo nello spazio di una sillaba o nel tempo di una pausa, lacerazioni e ferite, dimenticanze e perdite. E’ a questa tensione che Laura Caccia affida il suo pensare, impaginando un reticolo che contamina se stesso nella cura risorgiva del poema: con ritmi e ondulazioni che mai si perdono o inciampano in ingenuità o artificiosità. La poesia è un’arte speciale: ha in sé la propria consistenza e la propria dissolvenza, ed è qui che segna ciò che è “affidato alle sue tracce”: un sommovimento incurante delle moltitudini che ripiegano; una sollevazione che porta traslochi e discordanze di senso e smantella le immagini chiuse per dare esistenza, per riparare, per dare un nido.
Postfazione di Stefano Guglielmin
6 poesie da “D’altro canto”
Laura Caccia, nata a Varallo Sesia (1954), laureata in filosofia, lavora nella scuola e si è dedicata per diversi anni alla pittura.
Dopo Asintoti, Cierre Grafica 2004, l’interrogazione sulla parola è stata la ragione e l’oggetto principale della sua scrittura.
D’altro canto vuole essere un omaggio ai poeti, la cui eco ne ha contaminato la ricerca, e a tutti coloro che si prendono cura del dire e della sua indicibilità.
Laura Caccia, Poesie inedite da “Fame di voce” (1999-2003)
Da questa luce precisa di marzo,
il suo calibro di sete: l’inconoscere dell’alba,
il respiro che tace. E questo altrove
comune, strofe immutate di cieli
che i cieli non conobbero. Ora che è stretto il grido
a dirci di ogni cosa prossima,
impensata, la proprietà del buio, fauci ai vinti,
labbra iniziali e ciò che fugge
dentro le ossa, ai bordi del silenzio. Gravita
lo sfondo sui ripiani a piccole
dosi, nell’esortazione del sangue la nostra
ombra felice. A volte saranno
dintorni colmi al di sotto
della pelle, frammenti di ciò che non ha difesa.
Tra le contraddizioni ai cardini
del viso dove cerchiamo l’inizio e il trasalire,
appena dubbio, stupore.
Un’esitazione di terra e stelle flesse,
rarefatte, suoni dall’udire
asciutto gettati al centro del principio.
Nel sipario di una screpolatura,
come nel sonno che interrompe le stagioni
trattenendo a stento il fiato.
Non una voce, al capogiro improvviso
inatteso d’essere rogo
d’attrazione, sortilegio d’abbraccio
alle notti inarrese.
……………………….
Sarà immersa nel posarsi e lievità
nell’abbandono dei segni, fino al chiarore
che non dà tregua ai morti,
ai mari verticali. Sulla pelle a risalire
le trame degli occhi, in un gesto che accolga
mutazioni, tendini di luce
e pioggia a esserne grati.
La finitudine al suo inizio, così legame insieme
e ulteriore, fino a che il verso
tramuti il vuoto tra le ceneri, l’ora divenuta
erba, l'ultima ferita a vegliare
la voce. Perché
abbia tempo umano
e moltitudini nel balbettio sulle labbra dove
si addensa ogni origine.
Dai vetri appannati confonde
i luoghi, le similitudini, trattiene tutti noi dentro
il suo respiro a sfigurare
le ragioni che gravitano in prossimità dei sensi.
Dipende da quanto è essere
luogo e identità oppure
il sonno che balbetta le sue
visioni. Così piega a simulacro ogni fugacità,
tessitura perenne
al guscio di stagioni
ruvide, stupite. Tiene il dire sospeso, l’ossido,
il fiato corto, l’anima in festa.
……………………….
Scrostavi il buio a freddo
e spatola, le figure sghembe, le moltitudini
accanto. La notte trascinata
tra le pietre e gli archi a tutto
tondo al lievito d’udito, lungo i sentieri impigliati
alla risacca dove vegliamo
segni, controfigure ai vivi come grammatiche
inquiete. Saranno germogli del mattino
gli alfabeti che si rifrangono
nei corpi a confondere
ogni cosa da sempre, dove non appare.
L’oltrepassare è la tua ostinazione,
non è solo delle stelle spaesare
distanze e sguardi inadatti, così che intoni tutto
il nostro affidarsi. L’ora
è polline, una faglia dipinta al desiderio
d’essere soglia e a braccia
l’accadere, uguale
l’occhio che intorno ama.
Dentro di noi sarà traccia, apparenza al suo
distare, accanto benché
minuscola e riverberi
e tuttavia sia, la morte sottratta alla sua grazia.
Nelle braci di un canto
retrocede senza altra
tenebra che la voce a mani nude, l’erba
in equilibrio sul vuoto.
……………………….
Le parti del corpo, ognuna
con la sua durata: la testa ferma in questo istante
mentre le gambe camminano
tra i secoli. Dentro bozzoli
di stirpi, estremità ovunque disperse, qualsiasi grido,
le figure chiare, le anime
blasfeme. Se l’approssimazione
nasce al desiderio, una pronuncia cresciuta
nei canoni dei boschi,
negli esiti umani, prima che si smarriscano i gesti,
le andature. L’altrove in noi così
accanto da non metterlo
a fuoco, a sorprenderne
il battito sarà vana la cura, uno spolvero disperso
di materia dove l’impensato
sorriderà, lievito al verso nell’assenso del dolore
in agguato tra le cerimonie
delle ombre. Nelle vene
ne conserveremo le impronte,
in fondo cosa dimostrano l’ostinazione
dei ciottoli, il logorio
delle città rastremate
in un ciglio di terra a dirupo, secoli di strade
a dire ciascuna sera profuga,
fatale. Se sarà
dare voce l’acconsentire di ogni fibra
alla sua eco mortale.
……………………….
Tenere testa al senso, al nostro
stare così remoto e prossimo, lo avrebbe amato
e tanto meno. Venuti ad abitare
attimi, l’alfabeto terreno del respiro, il desiderio
che raduna i vivi. Una controfigura
tra sintassi di morti e stormi
a mani concave. Muta
tra i corpi la stessa profondità, sradicati suoli,
presente dopo presente
alla caduta dei segni sulla pietra. Come erbe
di tempo inquiete di fango
e chiarità, nell’azzardo scosceso
a rugiada e vigilie. Dove
si incresperà il nome che ci bussa alle porte
a cuore vivo, lungo prossimità,
metamorfosi in un battito
uguale. Ogni inizio e fine nel coro innaturale
dentro la parola che manca,
il grido che i secoli hanno privato
di luce. La voce di tutte le generazioni
non basta a se stessa,
polvere al guado in un setaccio
d’ora. Se cerca fiato e germoglio, lesione
di figure dentro
il verso che ignora,
dal suo riflesso al tremolio che incrina.
Questo istante respira.
……………………….
Saranno maree le anime di gennaio
scese in corpo a caso. Secoli di guerre e di nevi
non battono all’unisono,
come le ghiaie di corrente,
le congetture unanimi. Ne abbiamo fatto
un tempo indifeso, così proteso
a eccedere, così incerto a ogni cosa.
Nelle tracce ancora prive di voce nei volti
sottostanti, ogni risonanza
d’essere, ciascuna morte
che custodiamo: una parola divisa nell’oscuro
del giorno si fa tempo
e conoscenza fino all’osso. Allontana eternità
nel vento divenuto vertigine lo stupore
disarginato tra le pietre,
un capoverso fossile di luce
al volo delle labbra sarà brezza, nel fondale
del tuo dormiveglia. In grembo
tiene finestre col loro carico di cielo nella loro
versione inesatta, non la terra
su cui poggiare
il capo né alibi è istante
che al nostro cospetto avviene. Abbeverare
così le moltitudini in pegno,
quello di vivere poi aveva
il suo peso, da quando la condotta
delle erbe insegna.
……………………….
Vedi alla voce: materia rarefatta
e sangue, scorrendo senza meta e figure
come a toccare il senso,
il segno non incontaminato
che corrode le pietre. Tra fondamenta e carestie,
in uno scarto che ingorga
radici alla sua fame, le stagioni
imbucate tra le ossa, sconosciute ai greti.
È perseveranza d’essere
nella sua devastazione, una pronuncia muta
a fare di ogni presenza ascolto,
ciascun passaggio
inaccesso, ogni ombra e notte,
gocce d’acqua, respiri. Le vibrazioni dei rami
intorno alla luce
nel rovescio del cielo,
dove procediamo così a trattenerci, tracce
a malapena. Ovunque e mai
intriderà la pelle per una manciata di ossa
e di anime a sghembo.
Forniremo indizi
anche se inutili: al loro
punto di rottura, la sottrazione dei venti,
il respiro interrotto,
di profilo. Nomi che salgono a fatica
nell’ordine degli steli
a pozze e buio.
……………………….
Da qualche parte l’udire
tocca il suono. Lo tratteniamo ai polsi di scritture
corrotte, afasie addomesticate,
se sulla pelle delle cose
ne racconta ombre e stupori, moltitudini ovunque
tra le versioni contemporanee,
invisibili stanze moltiplicano i nomi. In un pensiero
irragionevole, il suo calore nel sangue
che allatta gli orizzonti
e questo improvviso
biancore di neve, custodito dalle ceneri
nelle zolle abitate dall’assenza.
Non dire, sulla soglia a pena, come superficie
di vento, vivi dopo vivi. A decifrare
chiaroscuri esposti
come fosse laggiù resina
di luce, il suo tempo superfluo. E di questo
movimento profusione,
lungo le estremità che slabbrano
asfalti, lingue d’acqua e massacri. Tra i fiori
dell’uranio l’umano
insonne smisura. In questa chiarezza
lievita indugi, anziché
sottrarsi ogni identità respira.
Senza farne voce, irrisolta
nel calco che affila, avendone cura,
la misura e l’arbitrio.
……………………….
Ogni nostro corpo finito e sfinito
d’aria e di voce, di demoni, stragi e ancora
prima di morte, nel mutare
che cresce come fosse un dettaglio
inesauribile, stupito, il suo accadere specifico.
Un arsenale ai sopravvissuti,
viscere e nudità in questa sintassi umana,
nella pronuncia a corde tese,
spalancata in ogni
moltitudine a capo. A tenerci
a mente, a prenderci in parola. La sola a dilatare
costellazioni a braccia aperte
in un grumo di pena
accolta tra le camicie mentre sembra che muti
la leggerezza appesa alle pareti.
Saranno voci in punto stette alle bocche mai
finite, l’apnea del cosmo attraversa
volti e respiro, come fossero
richiami sterrati per aratri
e rimozioni. Ovvero qualche notte di strade
rampicanti, saghe di cieli
nelle stanze da poco a frantumi. È cosa
breve l’andare. E smarrimenti
di rotte agli orli di città
in risacca, un esercizio
sulle labbra all’unisono, tra le albe dove
ogni mattino è porto.
……………………….
A ripetere uno stesso suono
è voce che chiama, insensata, a tradurre
finestre e mondi, parafrasi,
un crepitio immenso questo
archivio di stelle. Poiché una pagina in anticipo
sulle mani, dove tende,
si tende. E attecchirne generazioni, quasi rugiada
tra le conversazioni a corda tesa
in ogni storia minore,
lungo il senso sommerso. Il ritorno
scagliato nei boschi, le immagini precipitate
in una lingua tentata,
senza saperlo balbetta.
Al riparo del fiato dal fondo dei decenni saranno
corpo e mutazione, le ossa
prendono la forma del sonno, la sua lesione,
un’apertura che sorprende a volte
la notte. C’è una luce
al guado in cui sprofondano
passi e rifugi nell’ordine: fianchi guerrieri, abiti
e respiri in affitto, il canto delle acque,
gli alfabeti umani. Se insiste
un’armonia d’urto e innesto, quando non ha
più tempi da condurre, altro
da arare, come riconoscerci in cocci
d’alba, vento d’argilla e pietra,
sillabe in gola.
……………………….
Esige altro la voce che involucri
di risonanza: chiede doglia e bersaglio, ferita,
morte insaziata. Mai l’ultima
parola, polpa ostinata,
latitudini di acque, ardesia in fiore, ombre
di metamorfosi tra i passanti.
Accanto espone il suo tempo
impoverito, un vibrato estremo si fa grido, sussurro,
fertile copia, un’esposizione
che squarcia i secoli a macchia. Se ustiona i sensi
fra amnesie nel disordine muto, notti
tra le labbra concave
il volto immenso d’essere
e insieme il luogo quotidiano da cui giungi.
La fronte violata dove
si sporge il mondo. Se resiste in un nodo a filo
teso, quasi emerso da una metafora
di terra fra secoli aspri,
remando pagine contemporanee,
così l’accadere intrinseco, la congettura
che non salva l’inverno.
Prendi ad esempio
il livello di buio, il respiro della neve
al guado, l’incandescenza
e il vano che arano
incanti e bufere, il segno deposto,
il tronco, la polpa, il pane.
……………………….
Come è potuto accadere. Che ci siano cose
a cui non abbiamo dato voce:
e popoli, uomini, mattini e frulli. E silenzi .
La chiarità senza preavviso
se accosti secoli al disamore, suoni di radio, alture
stupefatte tra le connessioni
che trattieni sulla tovaglia stesa. Attraversa i volti
dispersi come fiato sui vetri, a spatola
di stagioni sembra cosa
da poco. Scava fami e polpa
schiusi come una fioritura improvvisa, una traccia comune, il dettaglio che smuove
la materia e sposta il campo
visivo dal suo cumulo d’alba, breccia per ogni
soglia e ostacolo. Si vedono ombre
che sgorgano rugiada ed un improvviso calore
sulla scena che raccoglie realtà,
simulacri, costellazioni
di città, fuochi fatui. La luce
non ha eco, anche se la parola potrebbe
e ciascun corpo riflesso.
Ma le acquisizioni dell’acqua
rimbalzano nello stesso suono mai concluso,
la pagina bianca su cui canta
fin dove arriva la voce.
Sono coaguli in controvoce a filo di mondo
per meraviglia nuda.
……………………….
A quale radice o pane, a quale musa
inesperta. La partitura sospesa nella pienezza
limpida che ignora, così
simulare l’estensione, il fiato breve, la parola
che diventa corpo per averne corpo,
umana e al tempo
disumana metafora di ogni
generazione all’unisono. La prima notte del volto,
una profondità screziata nel divario
dei vivi, identità e misura
che prosciuga fino al foglio, attuale. Se potesse
trattenerla sorgiva di segni accanto
a sé, mutare necessità al chiarore
che penetra la pelle. Lungo il tatto esile e breve
a spolvero in un malinteso
inciso tra i profili della nebbia.
Come raschiare lingue sui confini del corpo,
il cosmo che si inalba nel suo sguardo
immutato di febbri, controsensi.
Graffiti dispersi come pioggia lungo i vetri,
verità disuguali dove non sono.
A volte gli orizzonti hanno la densità dei nomi
mai raggiunti, a volte tremano:
al contatto di tutto il prima
e l’oltre, è un fatto normale.
Se la voce riesce a farsi tatto, a posarsi
sui corpi, a toccare le cose.
……………………….
Si esercita a nascere la voce forgiata,
l’atroce meraviglia. Nel suo magma d’alba, fino
a che punto si spinge, dove
si mescola alle folle e ai respiri,
dai destini delle strade ai visi in cui la realtà insegue
il suo sguardo e il fiato in un ammasso
di pietà. Se a monologhi di nubi e asfalto, accesi
legami nell’intonazione mortale,
scarti il suo nodo opposta
al calore dove resistono anfratti,
cardature a macchia visibile. La sua necessità
altro non è, vicino il nome
aggiunto alla sua moltitudine,
nell’aratura delle acque, al setaccio di tangenziali
e insonnie, l’apparenza inattesa
sul lato opposto della scena, pietra e vagito
a chi somiglia, opposizione di sguardi
e muse. Le cose accanto,
il sangue in attesa. Dove
balbetta il vento tra i muri, di questa poca
ombra che levighiamo,
se le labbra cadono o trattengono
l’ultimo ospite, amato. Le dissonanze a riva,
similitudini di erbe feriali,
ogni atomo, ogni esercizio
di vita: ciò che siamo e non siamo, specie
comune, dismisura.
……………………….
Questa fame: la voce umana,
una recita che dimentica la parte e l’insensato
dentro di noi che inciampa
nella sua pagina incolta
senza appello, fiato animale agli strappi delle vie
in un’esposizione d’essere
in curvatura morte e parola, somiglianze nel viso
potato tra i legni delle ombre.
Ciò che sulla pelle
in superficie strappa i venti,
i gusci testardi delle cose. Muove segnali al suo
punto di tensione dove la mente
è grumo, diserba asfalti e maree senza punti
d’appoggio. Soffio e cratere
dove sarà ieri incontro,
esodo ignoto d’eco
nel silenzio che crea per ogni canto improprio.
L’eco di tangenziali affacciate
sulle fronti dei boschi, adombra
cosa in un niente di figura. Più della luce, verso
i corpi e le ombre, si tiene
alla caduta e quanto più terrena può, è qui
il suo dire: un’approssimazione
che si fa polvere
di rugiada e arbitrio
tra i nomi di cui cerca, avvicinandosi,
la ferita, il debito.
……………………….
A una voce si sfama, gheriglio
e volo, radura. Mai finita: negli strappi, nel tatto
luminoso, sradicato, lingua
di macerie e talee non addomesticata né indolore.
Chiede nomi, silenzi, rischi collaterali.
Tiene il cielo teso
senza orizzonte, nei legami
che dispiega, un’eresia sui paesaggi dischiusi,
né ci appartiene la parola
che aderisce e se domanda è
senza rimedio, screpolatura di destini quasi fossero
indirizzi sconosciuti al loro inquieto
respiro. Affama profezie,
ombra del dicibile a filo d’acqua, alla rinfusa,
la riva divenuta scrittura.
Si inabissa, riemerge quando abbandona il certo
vicino e il pretesto ad evaporare senza
ombra né luce. E attecchire
in gola una radura di notte
leggera. Superficie su cui disperdere vertigini,
farne sostanza intorno,
febbre e pane lasciati
sul gradino. Raduna vasta la piega del labbro
vano sul fondale, la pietà
che invoca e butta cose
e innamora finità al suo estremo confine,
il segno in anticipo, vano.
Leonardo Bonetti, Premio Opera edita 2012: da “A libro chiuso”, Sigismundus 2012, con una nota di Rosa Pierno
IL LIBRO LUOGO D'ABBANDONO
Il libro è un’utopia tentata, defraudata.
Luogo di un abbandono, pagina che chiude pagina,
recinto di ombre più che di luce.
Il libro deve nascondere. E’ un oblio di pietra, un
tentativo venuto prima della forma.
A due pagine aperte corrispondono mille pagine
chiuse in un rapporto esageratamente sproporzionato.
Vero luogo di privazione, è nel suo silenzio che si
aprono tutte le frontiere del mondo.
Perché c’è una scrittura prima della scrittura che non
esaurisce la misura dei suoi significati.
E ogni lettura sarà riscrittura; e il lettore colui che
aggiungerà una parola al libro chiuso e, dopo averla
scritta, lo chiuderà nuovamente.
E’ la distanza che passa tra la parola scritta e l’atto
della scrittura che permette al lettore di profondere
tutto se stesso nella pagina chiusa.
Il libro chiuso ha pagine saldate; si può leggerne il
dorso senza rammentarne l’oblio.
Il libro è un mondo non esauribile. Anzi, sostitutivo del reale. Parrebbe possibile affermare che vi è più vita e realtà da scoprire in un libro che nell’esistenza che pure gli dà la stura. Apparentemente silente, monumentale, distante, utopico, macchina produttrice di oblio, ma sono proprio queste le chiavi di volta da cui scaturiscono plurime voci, percorsi, confini, ombre rigogliose, la proiezione dei secoli: sulla “pagina chiusa, alitano respiri eterni”. Se è vero che l’interrogazione sul libro ci riporta immediatamente alla mente i testi di Jabès, con cui Bonetti condivide anche parzialmente lo stile, è anche vero che sarà proprio negli interstizi di quest’operazione poetica che si potranno rinvenire le vie non intraviste prima. Equivale, per noi, al vetrino che apparentemente pulito, messo al di sotto del microscopio sveli un’ulteriore dimensione. Una sorta di cannocchiale che, se stabilisce come oggetto dello sguardo il libro, finisce col mostrare di fatto i meandri e le rifrangenze dell’inesauribile, poiché, miracolo dell’inversione, il libro è vita. Infatti, “A libro chiuso si può sperimentare l’assenza del suo corpo senza compiacimenti”. Anzi parrebbe che esista una relazione profonda, che funziona come una serratura a scatto, nel rapporto fra noi e il libro: se il libro è chiuso, se sta accanto a noi o fra le nostre mani, o se invece ne apriamo le pagine, ecco che tutto intorno a noi cambia, le scenografie, le reti, le profondità, gli echi. E in questo meccanismo, “in questo inganno eserciterà tutta intera la sua libertà”, poiché nessun senso ne può essere estratto, né potremo possedere. E’ qui che si misura l’originalità della voce di Bonetti, in questo spogliare il libro di tutte le sue particolarità, caratteristiche precipue per farne uno strumento, un oggetto equivalente allo specchio di Alice nel paese delle meraviglie, qualcosa da cui si passa e che consente “cambiamenti meno apparenti e più duraturi”. Varrà anche come antidoto al potere, poiché il libro si rivela capace di fagocitare e trasformare tutto, ma avendo al centro l’umano, o meglio, risospingendo i valori umani sul gradino più alto, in una vera e propria rivoluzione. Allo stesso modo di un aratro che rompa il muro di terra in zolle, il libro “promuove una sfida eterna tra la sua costellazione e la sua possibilità”. E per tutto questo, mirabilmente, è sufficiente che il libro sotto il nostro sguardo sia chiuso, preservando “il mistero dell’essere, dell’oblio, del nulla”.
Leonardo Bonetti è nato a Roma nel 1963, ha esordito per Marietti con Racconto d’inverno (2009), vincitore nello stesso anno del Premio Nabokov. Nel 2010 ha pubblicato sempre per Marietti il suo secondo romanzo, Racconto di primavera, accompagnato da una nota critica di Walter Pedullà. Con questo libro ha vinto recentemente il Premio Carver 2011.
Leonardo Bonetti, Una riflessione a margine su “A libro chiuso”
A libro chiuso
riflessioni a margine
di Leonardo Bonetti
Perché A libro chiuso? Perché un libro dovrebbe essere rappresentato attraverso la propria chiusura, la propria resistenza all'esibizione? Forse per un problema di moralità, di diffidenza calvinista verso le estroversioni della cultura?
Non credo. Questa immagine verbale, così a me sembra debba essere intesa, nasce infatti da un'esperienza vissuta sulla pelle del libro stesso. Sulla mia stessa pelle. Frutto di un rapporto che ha origine nell'infanzia.
Sin da piccoli, infatti, apriamo il libro trovandoci di fronte alla sua pagina luminosa, aperta. E la parola ci appare fissata, immobile, persino eterna. Crediamo che dietro questa sua immobilità si nasconda un enigma da sciogliere. Noi dobbiamo capire, comprendere, far nostra la parola scritta sul libro. Sin da piccoli la nostra esperienza del libro si fissa nello sforzo di comprensione del significato della sua parola. Ed è solo quando assolviamo a questo nostro piccolo dovere che possiamo chiudere il libro, riporlo nella nostra libreria, sui nostri scaffali, accanto ad altri libri chiusi, saldati, imprigionati. Sicché ogni qual volta passeremo di fronte al libro chiuso nella nostra libreria avvertiremo un sentimento di turbamento, un'attrazione o una repulsione, l'urgenza di riprendere il libro e aprirlo di nuovo o, invece, il bisogno di allontanarcene con spavento. A volte, infatti, noi sentiamo di non aver portato a termine fino in fondo la nostra comprensione del libro. Che qualcosa ancora deve essere sciolto del suo enigma di parola. E questo avvertiamo e viviamo come una umiliazione.
Ebbene, io credo che una tale incapacità di ridurre il libro a significato definitivo non debba essere vissuta come una mortificazione ma, semmai, come un impulso verso il mistero del senso della parola del libro. Perché la parola affonda sempre, nel suo significato più fecondo, all'origine del pensiero e del rapporto tra natura e mondo. Così che la congiunzione possibile attraberso la parola poetica acquisisce una funzione più sottile. Essa è il tramite che ci permette di passare dal significato al senso. Con questa parola intendendo non la ricerca di un luogo ultimo ma, semmai, la direzione di un cammino.
Il libro chiuso è dunque tra altri libri chiusi, saldato nella prigione di una libreria. Quella libreria fisica è il nostro cuore. Il libro chiuso è sepolto dentro di noi. Abbandonato. Possiamo paragonarlo all'infanzia perduta, al bambino ripudiato nel fondo della nostra memoria. E mi viene alla mente l'apothesis greca, l'esposizione del bambino, l'abbandono del bambino alla morte. Nella Grecia arcaica questo è a volte il luogo d'inizio di un libro. E penso all'Edipo. Il bambino esposto e abbandonato non è morto. Vive ancora. E dentro di noi il libro chiuso, come l'infanzia che crediamo perduta, non è materia inerte. È ancora capace di sprigionare una energia, di innescare una reazione salutare. Il bambino abbandonato che è in noi, il bambino creduto morto, è la nostra speranza perduta, l'immaginazione offesa, la scintilla mancata.
È a partire dal bambino che abbiamo esposto e abbiamo abbandonato che potremo vivere le epifanie dei fatti più insignificanti. Attraverso la scintilla dell'immaginazione capace di tramutare un semplice dato di fatto in mondo, in visione.
Dobbiamo credere nel bambino abbandonato che è in noi.
Il libro è chiuso perché solo nella sua chiusura può costituirsi di una materia di parole dimenticate, di detriti, una pietraia di parole appartenuta a un registro sotterraneo, a un bagaglio fuori dalla memoria razionale, all'ombra della coscienza, occultato in un qualche angolo riposto. Parole di una memoria dell'ombra, ma non per questo meno sperimentabile. Ed è l'esperienza di questa memoria di libri, di queste aure interrotte che fa il libro chiuso.
Tanta è la fiducia nel libro che è solo nel momento di maggiore debolezza del libro stesso, quella che viene giudicata apparentemente come la sua massima fragilità, quando è chiuso e dimenticato, che il libro agisce contro la nostra volontà e alle spalle della nostra capacità di controllo. Non si tratta di una vendetta del libro, sia detto chiaramente, ma solo di un'affermazione naturale del suo potere povero, indigente. Perché il libro chiuso è un contropotere. Il potere della sua sapienza che non vende e non nasconde. Un potere nascosto costitutivamente, senza calcolo.
E allora la parola del libro chiuso è nell'arco di un ponte che approda a due rive del sé. Tra queste due sponde di fiume gioca incessantemente la sua fortuna. L'arco del ponte suo arco d'orizzonte. Uno spazio stretto tra fiume e foce, tra canali e luce di canneti, e dune e sabbia e vento e sudore. Arco di ponte e di parola tra due lingue, tra due voci. Così che la scrittura, arretramento e sconfinamento possibile, sia occasione da tentare in un luogo e in un tempo che divorano se stessi.
Vincenzo Vitiello, Premio Opere scelte 2012: da “Una filosofia errante”, Anterem edizioni 2012, con una premessa di Carlo Sini
In occasione della XXVI edizione del Premio Lorenzo Montano, il riconoscimento “Opere Scelte” – speciale e fuori concorso – è destinato dalla Giuria del Premio a Vincenzo Vitiello, per aver orientato il pensiero oltre i canoni acquisiti e i sistemi già dati, al fine di cogliere una parola rivelatrice – filosofica e insieme poetica – in grado di registrare i mutamenti che accadono nel sottosuolo della storia. Il premio viene attribuito a Vitiello proprio per aver esplorato la natura di tali sommovimenti, i quali, prima di apparire alla superficie della coscienza, si annunciano attraverso segni la cui interpretazione è sempre difficile e rischiosa, avendo essi a che fare con la verità dell’essere. Con tali motivazioni, grazie alla decisiva partecipazione della Regione Veneto, viene riconosciuta a Vitiello la pubblicazione di una raccolta di riflessioni selezionate tra quelle che più compiutamente danno conto del suo lavoro, ovvero della necessità di individuare nell’essere il luogo essenziale in cui il nostro destino si decide. L’opera ha per titolo Una filosofia errante e viene edita nella collana “Itinera” di Anterem Edizioni. È introdotta da un intervento di uno dei più significativi filosofi italiani, Carlo Sini, Accademico dei Lincei.
Due immagini della premiazione di Vincenzo Vitiello: scatti di Franco Falasca


Galleria fotografica di Maria Grazia Veroni: Le premiazioni 2012

Agostino Contò

Giorgio Bonacini

Ivan Castelletti

Laura Caccia

Leonardo Bonetti

Manuel Micaletto

Mara Cini

Marco Furia

Paolo Fichera

Rosa Pierno

Francesco Bellomi

Stefano Guglielmin
Manuel Micaletto, Premio Una prosa inedita 2012: “Acquisizione”, con una premessa di Mara Cini
"Acquisizione" è come un breve manuale per l’uso: ci sono istruzioni pratiche e considerazioni dotte per affrontare l’onda delle parole. Per esempio la parola acqua. Per “esercitarsi fino all’acqua” . Ma quale acqua? Un’acqua forte di tutti i suoi possibili significati semantici, capace di liberare dagli argini tutte le sue form(ul)e.
In ogni discorso è in agguato una vena di comico. Una bolla di vapore spaesante può formarsi sia nella fraseologia spontanea che nella costruzione di strutture linguistiche colte e codificate.
Manuel Micaletto – Prosa Inedita
acquisizione
magari non tutta, magari solo un bicchiere, che sembra una miseria ma vi sbagliate, un bicchiere è, de facto, un ingrandimento dell’acqua, l’acqua messa a fuoco, un primo piano, un particolare, un’acqua al dettaglio e nel dettaglio.
oggi ad esempio c’era un rubinetto, e non bastava girare, serviva tirare, spingere verso l’alto. l’acqua si creava cioè senza i giri, senza accartocciarsi, ma con uno slancio cervicale, si inarcava, si levava come se non potesse esserci acqua senza un soffitto a custodirla, come se il soffitto fosse per l’acqua un garante, come dio per l’etica, o per meglio dire un nume tutelare. le macchie d’umido.
in tutta onestà, io non so se ciò che ho visto, oggi, immediatamente dopo lo stacco e i giri, è l’acqua, davvero l’acqua, o se invece è un bacino, la stanza premuta in una conca, una lordosi del piatto oftalmico, un accerchiamento olografico, una saturazione di ciascuna cosa ma come dall’interno, un embolo o ancora il sonno, che è una bolla e non si smentisce.
sta di fatto che: l’acqua non si può vedere, ma solo avvistare (e avvitare, nel più fortunato
dei casi: pensiamo proprio ai rubinetti) e a maggior ragione oggi, che ciascuna america è stata scoperta e nessuno grida più “terra”.
questa non è solo l’acqua di oggi, ma un primo modo di estrarre l’acqua, che diremo “parabolico” e che sprigiona quasi un’acqua-vapore, che si sviluppa in altezza, un’acqua-boa (sia serpente sia galleggiante) e conclusa in se stessa, perfino autoreferenziale, autarchica, indipendente, un’isola; un’acqua-uovo ermetica, a tenuta stagna, liscia e impermeabile, capace di almanaccare il mondo tubo per tubo, uno stato sovrano, un potere centrale e un taglio dei ponti, la ragione intima di ogni embargo, un’acqua gerarchizzante e giurista e giurata, come un nemico o una promessa, costitutiva
infine, quel che più importa, integra.
coi lavabi e le manopole, comunque, non abbiamo ancora chiuso. (all’acqua vera e propria, invece, arriveremo solo in un secondo momento). abbiamo trattato l’acqua verticale, l’acqua analoga alle travi, etc. va detto che a volte succede il contrario, succede che uno debba spingere verso il basso, esercitare pressione (un po’ come accade per il gas), esercitarsi fino all’acqua.
primo avvertimento: per l’acqua occorre allen(t)amento, non si può arrivare all’acqua impreparati, poiché l’acqua è liquida ma inflessibile e ci ripudia. non c’è un secondo avvertimento.
questo è un secondo modo dell’acqua, ed è una sorta di pantano, è una condotta più goffa, impacciata, pesante e in qualche modo enfatica; è un’acqua che esaspera la sua uniformità, la tende e la dilata finché non diviene lentezza.
(un capitolo a parte, invece, meriterebbero i materassi ad acqua, che usano cioè l'acqua come carburante per innescare il sonno, e a dire il vero non si capisce dove finisce l'acqua e dove comincia il sonno, sicché il rischio è quello di dormire l'acqua, e non riesco proprio a figurarmi, a quel punto, cosa potrebbe succedere. forse il mare. di dirac).
dicevamo che non è possibile comprendere l’acqua, che l’acqua è insolubile, e non parlavamo a sproposito: nessuna abduzione, ma piuttosto abluzione; bisogna essere sommozzatori, non logici. mi vengono in mente, anche, le acque gemelle di putnam. una “semantica dei mondi possibili” fradicia – ma forse queste acque sono fin troppo estrinseche, forse qui c’entra davvero il riferimento sganciato dalla comprensione – era per non citare proprio talete.
veniamo all’anatomia dell’acqua. l’acqua è quella pellicola, quel diaframma che si frappone tra noi e il mondo e che non è il freddo, o almeno non del tutto. questa si può dire, a ragione, una buona approssimazione dell’acqua.
(la differenza principale che sussiste tra acqua e freddo, e che ci permette di distinguerli con discreta precisione, sta nell’evidenza che l’acqua può essere “aperta”, “chiusa”, “messa”, “controllata”, “buttata”, “tirata” – a me è capitato addirittura di “stringerla”, magari al petto – mentre niente di tutto questo può essere fatto al freddo. abbiamo dunque sull’acqua un margine di intervento, di partecipazione che col freddo ci è invece precluso).
vogliamo essere più scrupolosi. vogliamo andare a fondo, vogliamo affondare. chi tra di voi si è mai imbattuto nell’acqua allo stato “selvatico”, se così si può dire; chi ha sbirciato l’acqua anche una sola volta, anche di sfuggita, sa che ai lati è squamata, che normalmente ha la forma di una spirale e quando e dove finisce si nota distintamente una coda.
se invece l’acqua è bloccata, allora si compatta, si infittisce, sigilla le scaglie, si contrae, come in preda a un crampo, si carica a molla e sembra sul punto di esplodere da un momento all’altro.
a lasciarci sbigottiti non è mai il contenitore ma il contenimento, questo accumulo impensabile di (es)tensione che si eterna, oserei dire si tramanda, e non si scompone davanti a nulla, neppure ai nostri pigiami a righe, ai nostri spazzolini sciupati, ai tubetti colgate, e viene da pensare quasi a una dignità dell’acqua, a un portamento, un contegno. (l’acqua, almeno quella nelle bottiglie, ha un’etichetta vera e propria, fateci caso).
non è in discussione.
se è vero che noi possiamo passare sopra all’acqua, possiamo attraversarla o sorvolarla, occuparcene o ignorarla, è altrettanto certo che l’acqua non passerà sopra a noi, non farà finta di non vedere, e se non laverà (che è altra cosa da “levare”, è più “tirare a lucido”) le nostre colpe, non è detto che voglia graziare anche i nostri capelli.
barare ma fuori dai giochi, muero porque no muero, quello che l’universo sarebbe stato senza il cedimento della creazione.
la cosa peggiore è: quando le acque si rompono, improvvisamente plurali, divise, faziose, quando si scuce la falla e cede l’ordine, il criterio dell’acqua, ed è allora che accadono le cose più terribili.
più precisamente, il bastione, l’avamposto da cui irradia i suoi tentacoli. non ci tocca, neppure ci sfiora: diversamente, ci sovrasta.
non so se credete ai mostri marini, o almeno al calcare, ma sappiate che i tubi servono proprio a questo scopo, a proseguire la morte come un discorso. a permetterne anche un deflusso, una scappatoia.
controindicazioni: se noi chiamiamo l’acqua, ecco che quella arriva, ma in cambio pretende qualcosa, e non si tratta di una contropartita alchemica, equilibrata, si tratta ormai di un ricatto (non tratta, è un tratto caratteristico, niente trattative) poiché l’acqua è assetata di conquista, è imperialista, tende a occupare tutto lo spazio e nessuno può assicurarci che un giorno non reclamerà proprio il nostro.
niente abissi, però. l’acqua è proprio una forza opposta agli abissi, una tensione del tutto superficiale, l’acqua è anzi sfacciata, è tutta in superficie, sta in alto, più in alto della terra.
abbiamo preso le nostre contromisure, abbiamo argini, grondaie, canali di scolo, questi tentativi laterali di formare fermare l’acqua, di educarla, disciplinarla, di iscriverla nel piano cartesiano, di cavarne una geografia leggibile. non sto dicendo la forza della natura, gli uragani e pompei.
sto dicendo, piuttosto: distrazione, non distruzione. l’acqua sostanzialmente passa, e così noi. non si ferma e non si sofferma, non indaga e non studia. non si muove dal letto e non va neppure agli esami. sempre come noi.
non pensiamo, in questo modo, di aver sciolto o sezionato o illustrato l’acqua (ma giusto un abbozzo, uno schizzo), perché l’acqua è inestricabile. non pensiamo di averla esaurita. ma un sommario, un indice.
perché si potrebbe pensare altrimenti, si potrebbe pensare che io sia un acque-dotto.
Manuel Micaletto nasce in bold il 4 agosto 1990, a Sanremo, e si chiama Manuel Micaletto. E ha 20 anni (quasi tutti consecutivi, peraltro). Sanremo. Non riesce a farsi una ragione dell'acqua. Ama i letti, soprattutto se sono libri. I suoi morti preferiti sono, in ordine sparso: Cioran, Schopenhauer, Kierkegaard, Borges, Leopardi, Benn, Bene, Unamuno, Landolfi, Blanchot. Ma i morti gli piacciono un po' tutti, e fantastica un giorno di adottarne moltissimi e giocare con loro e vederli crescere e iscriverli al college. Questo vale per tutti i morti, tranne che per Wallace. E' felicemente spossato, è magro e anche carino, 3403456789. Ha conseguito la maturità classica e frequenta la facoltà di Lettere Moderne all'università Statale di Milano. Suoi testi sono capitati su “La Mosca di Milano” (sotto lo pseudonimo di Manuel Lotario). È co-fondatore e autore (assieme a Daniele Bellomi) del blog di poesia e scrittura non-narrativa “plan de clivage”. Fa parte dell’ensemble di ricerca letteraria “eexxiitt”. Collabora inoltre, nella veste di editor, alla rivista di letteratura e teatro online “Niederngasse”. È astemio, non si diverte, e nemmeno voi dovreste, a pensarci bene. Giura, inoltre, che non è solito parlare di sé in terza persona. Continua a non capacitarsi dell'acqua.
Si ostina (il nostro eroe, Manuel Micaletto) a intendere la poesia come quell'atto (se ne esiste uno) contrario alle cene di classe, alle gite, all'ERASMUS e più estesamente alla vita. Un crampo del discorso, un rafforzativo dell'organismo-linguaggio, un accento del muscolo (e così via): contr-azione, non tanto nel senso di "azione contraria a", ma in quello di spasmo e di azione allo specchio, rovesciamento dell'azione.
Manuel Micaletto, Poesie inedite
I
*
alcune, nella scuderia delle cose, partono e arrivano
a perdifiato. queste diremo a rotta di collo
o altrimenti a precipizio, a piè sospinto, o ancora
cose di buona lena, e non conoscono
che un vuoto, uno, a vario titolo.
le restanti non offrono
che il cappuccio di medusa,
la cuffia cerata, l'astuccio
di pongo: per questo dette
cose a tenuta stagna, o ancóra
a impacco,
una camomilla.
*
anche l'occhio è una spora,
un impiastro: se non lo credi
frugalo, affettalo con buon giudizio,
fanne una porzione, un pannello, fanne
oggetto di studio accurato, passalo
per il collo di un alambicco,
fanne un ping pong,
un flipper.
II
*
ora invece tutte quante le cose, in punta di piedi,
stirano il muscolo, la macchia fibrosa, al fondo
- e il pistone, a tutto spiano
si mostrano
per come sono: snodabili, convinte alla torsione
questa medesima stanza
non fa resistenza, si imbarca di proposito, rivolge l'elastico,
il sangue in panne - col mento arriva un palmo
avanti alle ginocchia - escogita una fionda, uno stretching.
*
(se il mondo non fosse elastico
si sarebbe accartocciato
in un dolore di stomaco)
(un'altalena di calci)
*
noi, da calotta a calotta, spaccati
lungo la fessura, come uova di cioccolato
custodiamo un caucciu, un nastrino,
un amuleto da niente, da scemi.
III
*
quanta acqua hai totalizzato?
Paolo Fichera, Premio Una poesia inedita 2012: “una parola libera dalla parola”, con una nota di Marco Furia
Paolo Fichera, Premio Una poesia inedita 2012: “una parola libera dalla parola”, con una nota di Marco Furia
una parola libera dalla parola
la stele scritta dal nome letto, la fronte
ancora a chiamare la verità sbozzata
l’unica voce che non chiede memoria
che chiama presenti gli ultimi
frammenti, come interne rovine.
fuori l’interno genera le tracce
insorge per riannodare nel filo
la tela, s’addensa il suono
più forte nella sua povertà.
la corda resta. tesa.
“una parola libera dalla parola” è il primo verso della poesia di Paolo Fichera.
Un verso che getta un cono di vivida luce su tutto il breve componimento.
Nessuna parola, in realtà, può essere libera da se stessa e nemmeno da quel complesso sistema chiamato linguaggio, poiché, se così fosse, non sarebbe tale.
Il poeta riesce tuttavia a conferire valore a simile pronuncia: la sua, anziché un’asserzione, è la manifestazione di un desiderio grande, immenso.
La sua libertà non richiama un’assenza, bensì una tensione verso un altro dire, verso una lingua originale non irrigidita in forme poco appaganti, tale da far emergere
“l’unica voce che non chiede memoria
che chiama presenti gli ultimi”.
L’ultimo verso, che a mio avviso si rispecchia nel primo, propone l’immagine di una “corda” “tesa” quale restante, ineliminabile elemento.
La corda, lo sappiamo, è un intreccio di fili tra loro identici, sicché l’eliminazione anche di uno soltanto di essi rende l’insieme più debole: se essa “resta”, ossia permane inalterata, dobbiamo pensare che nessun filo è stato reciso.
Dobbiamo insomma ritenere che il Nostro non nutre desideri di tipo nichilista, che la sua è voglia di qualcosa di più, di meglio.
Per esempio, di una parola affrancata da uno sterile ripetersi, vale a dire di una parola come quella della poesia e, nel caso specifico, proprio della sua, il cui tocco, intenso e raffinato, davvero convince.
Paolo Fichera è nato a Sesto San Giovanni nel 1972. Ha lavorato in editoria. Ha progettato e diretto il quadrimestrale Pagina zero – Letterature di frontiera. Per la poesia: è stato pubblicato in antologie, su siti e riviste nazionali e internazionali e tradotto in inglese, francese, spagnolo, arabo, serbo-croato, albanese. Sue raccolte di versi: Lo speziale (Lieto Colle 2005), Innesti (Quaderni di Cantarena 2007), La strada della cenere (Fara editore 2007), nel respiro (L’arcolaio 2009).
Paolo Fichera, dalla raccolta “Bosco”, in corso di pubblicazione presso Anterem edizioni
*
in nodi l’alba che non ha frammento
mentre fingo inconoscente il frantume
di ogni opera stipata in orgogli malsani
mentre un’opera ruggisce nel profondo
di un’opera l’acqua è fibra innata a non dire
a non voler restar pensiero che il mio sangue
dona ora al nido che la mano ad artiglio
stringendo crea nello spazio di un foglio
*
a te che ombra aspetti nel solco
ora che il precipizio oscura
ogni resa pensata – a morire spezzati,
come assenza scagliata
nel bosco feroce e calmo e vivo e santo
mi inchino a ogni deserto, mi inchino
all’indivisa armonia delle mani, mani
che raccolgono marciapiedi e specchi
a sera il grido indorava la danza
iniettava in occhi coincidenze
e bestie placate nel flusso di una fame
ordinata dalla pietà di una grazia
*
non è sacro questo sangue
questa scheggia illimitata di trapassi
animati da organi? – mentre il vuoto
pulito dalla sua pelle gonfia
la gola di una pietà che si fa
culla nel relitto di una traccia
Ultima pagina: Un musicista parla delle poesie di un artista. Francesco Bellomi su Gianni Robusti (1946-2010)
Un musicista, che parla delle poesie di Gianni Robusti, che non si considerava poeta, e per farlo deve parlare prima di un’altra persona: Carla Canedi. Questo è quello che succede quando si ha a che fare con la creatività vulcanica e totale.
Carla Canedi, Carlina, è stata:
- la persona più anomala, geniale e brillante che abbia mai incontrato nel mondo dei musicisti
- la compagna di tutta una vita e di tutta una morte per Gianni Robusti
- l’unica che sapeva dire la verità fino in fondo sempre e comunque, a qualsiasi costo.
Tutto inizia nel 2000 quando Carla Canedi mi commissiona “40 minuti di musica erotica” da eseguire all’inaugurazione di una mostra di “Arte Erotica Astratta” organizzata da Gianni Robusti nella sua fornace di Cunardo (Varese).
Per la ricorrenza verdiana del 2001 è la volta de “La Traviata Straviata”, titolo inventato da Gianni Robusti per un evento musicale con voce, pianoforte e due percussionisti, su musiche di Giuseppe Verdi re inventate da Francesco Bellomi.
Infine nel 2002, sempre nello spazio magico delle antiche fornaci di Cunardo, “Klangfarbenmelodie”, 12 brani per clarinetto, chitarra e percussioni, per una proiezione di diapositive con relativa mostra del fotografo Antonio Bandirali.
A tutto questo si mescola indissolubilmente l’odore dell’inseparabile pipa di Gianni, della sua corporatura tozza da scultore del ferro e ceramista, della sua strana risata e del suo sguardo. Con lui sempre Carlina, la più veloce, la più leggera, la più bella.
Un giorno a tavola io dico che bisogna aggredire violentemente la materia se vogliamo riuscire a cavarci qualcosa e Gianni mi risponde: “anche per chiudere la porta a tutto il dolore e il rumore del mondo per mettersi a lavorare il tuo pezzo di carta o di lamiera ci vuole una violenza totale”.
Questo scultore, che in gioventù fu allievo prediletto del grande Lucio Fontana, sapeva cosa voleva e cosa faceva: non barava con se stesso e con nessun altro.
Infine l’ultimo abbraccio nel 2011, sotto la pioggia che mascherava le lacrime perchè tutti sapevamo. Carlina lo ha seguito dopo meno di sei mesi, compagna di vita, di malattia e di morte.
Cosa centra tutto questo con le sue poesie?
Centra perché queste poesie sono state il pane e il metallo che ha riempito le ultime telefonate e le ultime lettere tra me e Carla Canedi “nei mesi della malattia, quando le forze non gli permettevano di affrontare materiali appena più pesanti delle parole”, come lei ha scritto nella prefazione al libro, parlando di Gianni Robusti e forse sapendo già che queste parole sarebbero state giuste, dopo poco, anche per lei stessa.
Il tutto è chiuso nel cristallo della poesia n. 217
Trasgredire la morte
guardandola
senza nostalgie
in versi di vento e di mare
sulle tracce
di confini sfuggenti.
Ora non posso che dire grazie a Maurizio Mingardi per aver impaginato il libro delle poesie, per aver fornito le foto delle opere, per aver condiviso con Gianni Robusti vent’anni di cammino.
Grazie a Gabriella Canedi, per aver autorizzato la pubblicazione di testi e foto.
Per Carla Canedi e Gianni Robusti tutti i miei suoni e tutti i miei silenzi.
Da Le mie poesie, C2M edizioni, 2011
*
Il grande vuoto oltre il viaggio
nello spazio di una polaroid.
Ci si perde in linea d’aria.
*
Una lotta impari con la sorte
per disgrazia ricevuta
sulle ali di una realtà simulata
da un teorico delle ragioni
sul vivere e morire
l’ombra che genera il numero.
*
Punti di fuga
e forza di gravità
del pensiero
per una impossibile rotta.
Quasi un territorio da mappare
in un film digitale.
Nessun destino nelle formule
senza poter dire “ho vissuto”.
*
Percorrere la luce
sulle tracce del diluvio
in una scia di bianco silenzio
parlando per non capirsi
in un infinito rilegato.
*
Solo belle storie
malinconiche
fatte con materiale altrui
quando la poesia
sta con gli sconfitti
e le loro esistenze
impossibili.
*
Trasgredire la morte
guardandola
senza nostalgie
in versi di vento e di mare
sulle tracce
di confini sfuggenti.
*
Zone d’ombra in libertà
di un impressionista delle scene
per riguardarci con sconcerto
in un’immaginifica visione
antagonista del vero.
*
Utopia della parola
in una lettura progettata
con il suo dono nello stile
se il luogo del cuore
è sul confine
del vivere in bianco e nero.
Dalla premessa di Carla Canedi
(...) Le chiamava poesie ma non voleva essere considerato un poeta. Solo un artista che assembla materiale diverso per costruire il suo universo di simboli (...) Parole che cercava e trovava solo in un inserto settimanale (...)
Le sculture di Gianni Robusti, l’allievo prediletto di Lucio Fontana

Gianni Robusti
An bar v9
Ferro su-masonite-cm-100x100

Gianni Robusti
Locus
Installazione cotto

Gianni Robusti
Sciamanata

Gianni Robusti
Un-altra-luce
Carta e vetro su tela cm.100x100
Gianni Robusti: una biografia dell’artista
Gennaio 2012, anno IX, numero 16

L’esperienza della ricerca continuamente si rinnova. Coltiva una storia delle idee e delle forme, ben sapendo che un pensiero può diventare oggetto d’arte. Procede verso una nozione di verità. Procede tra forma e senso, nella tensione. Tra mimesi e realtà, ascolta una voce nel buio.
La difficoltà di essere poeti risiede anche nel mantenere attivo questo labile ascolto, mentre intorno tutto è stordimento.
Alcune tendenze della poesia italiana contemporanea, con i commenti della redazione di “Anterem”, costituiscono la parte prevalente di questo numero che ospita i finalisti del 25° “Montano”. I contributi di questi autori, espressioni di varie sensibilità e forme, si pongono quale ideale viatico per la prossima edizione del Premio che scade a fine marzo.
Oltre alla poesia, in questo XVI “Carte nel Vento” che ci restituisce la variegata offerta del Premio Lorenzo Montano, figurano prosa, musica, saggistica, critica letteraria, arte visiva.
(immagine di copertina di Kiki Franceschi, Historia)
Stefano Massari, da "Serie del ritorno", La Vita Felice 2009, con una nota di Rosa Pierno
**
la morte che dovevi diventare che dovevi mangiare che dovevi dividere
come odio dal pane ogni gesto del tuo giorno ogni giorno del nostro anno
in tutte le nostre case di sentenza e redenzione dove dovevi ritornare
dove dovevi restare in posizione di artiglio e convalescenza
**
la morte che dovevi conservare che dovevi tossire paziente come l’attesa dei laghi
che dovevi pregare in posizione di violenza e comprensione per restituire ai padri
corpi di figlio senza circoncisione senza colpa senza generazione
**
la morte che capivi al buio nascosto nella parte impazzita delle leggi che ti scavavi
tra le gambe lungo l’arteria femorale quando mentire era salvare non avevamo altro
**
sono storia la nuda madre la sana viscere e lana sono pane
conio bilancia olio sulla pelle dei primi strappata ai testimoni conosciuta
alle croci sconosciuta alla morte addestrata
**
sono morte la chiara velocissima e immorale bestia feconda
festa cardinale acrobata superstite destino senza il male
sono il figlio tribunale e la madre altare muscolo visibile del vuoto
**
allora sono io il muro io il nascerti io che muoio sono
il tribunale quotidiano in ogni buio in ogni volta che parliamo
al nostro male chiuso ai chiodi addosso al nostro addio supremo
sulle mani piene di calore ottuso che più a nessuno sarà dato
o ricordato negli anni che questa colpa superiore non trattiene
**
allora sono io che ho perduto gli occhi che confidavano tutto
fino al sangue o nello scontro quasi incesto che domandavano tutto
senza un gesto o ringraziamento che scrutavano dentro il braccio teso
la forza della terra in tutte le obbedienze
Si apre, la raccolta “Serie del ritorno” di Stefano Massari, con un gesto che fa spazio all’imminente, paventandolo, ma anche con la rinata consapevolezza di sentirsi forti (si è più forti se si deve difendere qualcuno che si ama). La volontà può avere un ruolo fondante e dunque è individuato anche l’orizzonte in cui il gesto si attua: “come sempre è la legge”. Nello spazio diradato della notte, mentre la sua lei gli dorme accanto, il poeta verifica la dislocazione degli oggetti percepiti e conosciuti. Se è presentissima l’influenza di Nietzsche, lo è in maniera del tutto originale. Parole che appaiono più simboli che termini costellano il testo poetico: eterno, danza, inizio, anello, enigma, vendetta, serva s’innestano in un tessuto esistenziale in cui si ha il coraggio di affrontare l’aspetto in ombra delle cose, la sua alterità, la sua macchia: “Tutto il tuo corpo pane bianco e inerme / tutto questo mio sporco a cui acconsenti / nascondiamo tutti un male vivente per sempre / nascondiamo tutti una vita altra e qualunque”, per giungere a una scrittura in cui la sintassi si frange sempre più sotto la spinta del molteplice e dell’inevitabile emergere della contraddizione. Una profondissima umanità che risale come un anelito fomentato dall’amore, e in continuo colloquio con la morte. Naturalmente umanità è inseparabile dagli orrori che essa subisce e compie. Ma è sempre lei, la donna amata, la sua presenza, la sua voce a fare da contraltare, a spronare all’azione. L’amore si colloca come unica forza attiva possibile nella strategia e non solo per resistere, ma per essere diversi: “non sanno quale dio del loro perfetto mondo stiamo finalmente lasciando / non sanno che noi noi due adesso stiamo nascendo”. Una scrittura, dunque, che è analisi, ma anche progetto. Apertura all’evento.
Enzo Campi, inediti da "Il Verbaio", con una nota di Giorgio Bonacini
prélude
non ci sono chiavi più o meno adatte
per prima cosa lo spasmo.
di pari passo con il tonfo.
l’uno elettrico l’altro sordo.
poi la retina.
irrimediabilmente circoncisa dalla luce.
la latenza singhiozza
un baluginio di garbugli di voci
la latitanza favorisce l’appropriazione indebita
l’ampio gesto claudicante
dell’attempato Efesto rinnova
i fasti della fucina di Lemno
e le parole si consegnano tronfie
al loro destino di cenere
non c’è spinta che sia definitiva
pas mal
infidi dettati
ancorati al piede
s’avvitano giambici
se mai limbici
a designare diametrie
ricucite
in punto e a capo
lungo la croce
che rinsalda il nodo
e glorifica il peso
profferta a inaudita pena
dilaga pavida e insincera
la storia di chi sa e conosce
l’incoscienza di una lingua
che può risuonare
solo come contrappunto
s’incava
come sabbia sotto l’unghia
la permanenza al senza
che imprime la sua firma
declinandosi nell’evanescenza
e quel neonato silenzio
che si configura
come antenato del senso
voltando le spalle
alle piaghe e ai germogli
muova il suo passo
verso il punto
che sfugge alla presa
non sono io la luce
che rifrange
la radianza del sibilo
nell’antro auricolare
né il mio verbo
potrà mai vibrare
su quella nota estrema
che devasta il costato
è ancora tutto fermo
nello stallo
della forclusa iconoclastia
ma sopra vive
in fondo al senza fondo
se pure dissestata
l’idea di una levata
ribattuta punto a punto
La poesia di Enzo Campi chiede tanto al lettore, principalmente in termini di cooperazione nella costruzione di un senso diffuso, già preesistente nel testo, ma estrapolabile nelle sue diramazioni dalla lettura materiale, anche quella dell’autore/lettore. Ma il tanto che questi versi chiedono viene ripagato nell’accoglimento di una scrittura significativamente straripante, magmatica, ma mai abbandonata a sé o al caos. In quest’opera l’urgenza che preme nello srotolamento del flusso verbale è segnata, fin dall’inizio, da un angolatura del percorso che dalla mente arriva al corpo, con un viaggio di grafia e voce in cui la coscienza della parola si arricchisce fino ad assorbire la sua in-coscienza, estrapolando e interiorizzando ogni sua relazione con l’esterno, con l’altro.
Ed è così che, da una disgregazione/ricomposizione, nasce nell’autore la domanda: “fagocito ergo sum?”, con un evidente traslazione dall’astratto al concreto, dal fuori al dentro, dall’estensità all’intensità, dall’esprimere a un più pertinente imprimere una nebulosa di sensi che andranno sia a implodere e a oscurarsi nel “nulla/di cui siamo costituiti”, sia a esplodere e a irradiarsi dal “neonato silenzio” che è origine di ogni voce che abbia ragione, ricerca e significatività di poesia. Ma in questo essere scrittura sorgiva, non c’è e non ci può essere una presa stabile sul significato, perché questo non ha nulla di pre-scritto o pre-detto, oscillando (come esplicita il titolo dell’opera) tra stasi ed estasi. Così il senso, costantemente teso a disequilibrare un’illusoria simmetria, infrange l’ordine e lascia fluire in un continuo ricominciamento i suoi fonemi, che si formano in lingua e deformano il dire con un dispendio rigenerativo di energie.
Lo sgretolarsi del linguaggio, però, pur inudibile nel “suono fuorviato”, prepara alla conoscenza la cosa (un reale per se stesso inconoscibile) chiamando “l’errante alla parola”. Ma da dove viene e che cos’è questa “erranza” su cui si costituisce il poema di Campi? Certo non è la chiarificazione di un andamento sghembo già stabilito, perché ciò che si produce scrivendo sono configurazioni sintagmatiche che, in figure vive, tendono a un’interpretazione che ne sblocchi la potenzialità avvolgente; e allora ciò che colpisce, nella parola destrutturante ma non distruttiva dell’autore, è quell’oscura illuminazione che il poeta riconosce nel segno di un gesto, che potrà anche essere destinato all’oblio, ma, anche solo per quel poco riverberato da una sillaba, porterà con sé un corposo, materico, primordiale cominciamento ad essere, nutrendosi “di muffa/e di muschio.” E’ dunque nell’umido e nell’ombra che nasce la sua urgenza. E da questi luoghi risale, ancora in suoni appena percepibili, in materia appena palpabile, in “sbavati fonemi” ma già capaci di procurarsi il sostegno di un’immaginazione verbale; di spingere ponendosi all’ascolto di tutti i suoni, per dare vita originaria a una lingua che prova il mutamento dei tragitti che ne fondano la possibilità di un’esistenza. Tragitti che sono gli elementi erranti, coinvolgenti e particolari nelle figurazioni di un soffio d’aria, una zolla di terra, un fluire d’acqua, una vampa di fuoco, che vagano entro il respiro di un corpo scritto.
Tiziana Gabrielli, un inedito, "Dal segno alla parola", con una nota di Marco Furia
I. LIMEN
È visione il segno
nel bianco
della pagina campo
e coltura
È e non è
sa e non sa
il suono dell’ombra
pro-logos e impronta
sulla bocca dell’antro
nient’altro
II. «NEL CAOS DELLE COSE»
Dal di dentro all’oltre
tra l’origine
e l’in(de)terminato
è un tumulto il principio
la fine in-finita
l’eterna contesa
«a sfera radiosa»
tendono
le cose prime
il respiro e la carne
nell’ora dell’ignoto
che viene
III. TRA SILENZIO E VOCE
In soglia - di soglia - in soglia
l’Uno e il suo contrario
davanti agli occhi
della Notte
l’«Antinotte»
spalanca il Nome
dell’essere-assenso
al silenzio
duplice eco dell’Altro
altrimenti che della parola
che si fa incanto
e nostalgia
dell’impronunciabile
Con “Dal segno alla parola”, Tiziana Gabrielli presenta una sequenza elegante, nel cui svolgersi gli spazi bianchi paiono esprimere, più che il silenzio, la muta cadenza di un sussistere poetico.
In particolare, alla terza sezione, la poetessa si sofferma sul gioco dei contrari, ossia su come ogni concetto venga definito anche per via del suo opposto, in un contesto che, ben lungi dall’essere considerato sterile, è avvertito quale essenziale àmbito dell’umana esistenza.
Un dubbio viene suscitato dal titolo, perché, se la parola è segno, appare impossibile ipotizzare il passaggio da un’entità a se stessa.
Forse per segno s’intende una traccia a priori confusa, poco chiara?
Non saprei, giacché il segno, proprio in quanto tale, indica qualcosa e, dunque, è già lingua.
Un certo gesto, ad esempio, può benissimo sostituire una certa parola.
Forse s’intende, con atteggiamento incline a una sorta di surrealismo idiomatico, il passaggio da un tratto a un identico se stesso? Oppure a uno eguale e contemporaneamente diverso?
Il persistere del dubbio non m’impedisce di apprezzare una poesia davvero espressiva, in grado d’insinuarsi all’interno della lingua con intelligenza e sensibilità.
E qual è l’esito di ogni buona versificazione se non quello di far emergere, tra le pieghe del linguaggio, vividi tratti capaci di riferirsi in maniera originale all’accidentalità del nostro stesso esistere?
Alessandro Broggi, prosa inedita "Senza utopia", con premessa di Mara Cini
Broggi propone un testo di sole venti righe. Venti righe dense in “un’assoluta assenza di dettagli”.
Eppure questo stesso testo potrebbe prolungarsi all’infinito (quasi), senza diluirsi, replicandosi “in una inquieta situazione di stallo”, un po’ come nelle vicende de La Modification di Michel Butor dove tutto scorre modificandosi impercettibilmente verso “un’ infedeltà parallela” fino all’ultima “goccia di senso”.
a R.K.
Imprevedibili rimbalzi trarranno forza come processi di purificazione planetaria. Sfrenate manipolazioni delle loro attrattive si svolgeranno in assenza. Non esisteranno livelli di riferimento. Rappresentazioni astratte dell’abbondanza inghiottiranno immagini e confessioni. Come se nulla fosse convincente al di fuori di un’assoluta assenza di dettagli.
Un’infedeltà parallela sostituirà la gerarchia con l’accumulo. Ne saranno prova i registri emotivi chiamati in causa. Una trama opportunistica di interessi acquisiti trarrà ispirazione da dati spremuti fino all’ultima goccia di senso. Un parossismo di prosperità prosciugherà e verrà in cambio prosciugato.
Una grande utopia potenziale sarà diventata un congegno organizzativo, un residuo. Forse sarà solo un offensivo scherzo dell’evoluzione. Ampie distese di reticenza monumentale fronteggeranno le attrezzature del nuovo in una inquieta situazione di stallo. La soglia infinita dell’esporre renderà la loro voluta serietà istantaneamente sfuggente. Un destino manifesto soddisferà l’impulso a sbarazzarsi di ogni sorpresa.
Legalità deboli coesisteranno in rapporti flessibili. Le loro insegne saranno sgargianti ma non memorabili. Il dominio di un ordine finito simulato sopravvivrà nella tensione verso la radicale indeterminatezza. Una tautologia senza crepe sarà, dopo tutto, la sua stessa ragion d’essere. La stabilità del clima sarà una sanzione definitiva.
Mariangela Guàtteri, video, "Trilogia"
Viviana Scarinci, “Vince chi muore per primo”, su Stati di assedio di Mariangela Guàtteri, Anterem Edizioni 2011
[un dolore solo]
un frattàle di una nota
che organizza il tempo
e in ogni altra dimensione mg
Ascoltare Mariangela Guàtteri che legge Stati di assedio, fa delle parole un’enormità visibile: è fare esperienza dell’enormità di una visione inversamente proporzionale al numero delle parole usate per dirla. Stati di assedio è ideato, secondo precise restituzioni architettoniche a una gigantiasi, nel senso di deformità per eccesso, ben compresa nel singolo dettaglio e riprodotta secondo precisi stadi. In questo lavoro, che l’autrice stessa definisce articolato dalla paura, la costante a stordire del terrore è arginata da un controllo lineare in un assemblaggio plausibile che risolve l’espressione algebrica dell’emotività innescata nel concetto di paura. Nel pixel infinitesimo di un frantume verbale c’è già l’affresco di tutta l’opera. Ma non su di uno schermo. Tutto l’affresco della Guàtteri non si compone per schermate. Giorgio Bonacini nella prefazione infatti avverte della qualità di “disegni sonori” della lettura che si sta intraprendendo, riprendendo due parole che compaiono tra i primi versi del libro, che poi l’autrice, come altre formule, reitererà. Puntuale, la voce della poetessa, impegnata nella lettura dei suoi versi, fa intendere che quel disegno è solo l’ossatura che compare sul foglio. La lettura che Mariangela Guàtteri fa della sua poesia dice come una poesia autenticamente dissennata, elargita da una pianta perfetta, sta nel suo, pronta alla dizione, in una vocalità vicinissima a tre punti dell’essere estremo: il potere, il piacere, il dolore. Dico dissennata come segnando un confine tra il senno e il non senno che induce lo stremo dell’essere alla veggenza. Il testo è anche diviso in queste tre parti, che l’autrice chiama Neurosi. Neurosi I il potere, Neurosi II il piacere, Neurosi III, il dolore. “Le Neurosi sono allora tre segmenti di un solo programma articolato in routine, veri e propri code-verse annidati nel corpo del testo” (Federico Federici). Le Neurosi sono il blackout delle normodotazioni umane. Se il potere è “la detenzione di esistere”, il non potere risiede nella sparizione della volontà a modificare, quindi nella scelta di non avviare “un processo volontario di alterazione”. A ridosso di questo concetto è avvertibile tutta una proliferazione politica che la Guàtteri controverte dalla società ai corpi che la compongono con un linguaggio tecnico tanto più crudo quanto più si rivolge a materia organica. Cessare il solco della propria volontà sull’asse ibrido dell’orizzonte comune, significa accostare per gradi sempre più spaventosi l’azzeramento, in un incedere paritetico al proprio fenomeno “sognare polvere in rivolta che mostra i lati” perché solo “un accesso immediato si trasmette l’esistente” altrimenti perduto nell’alienazione metodica delle scelte. Nel parlare a sé rivolti, può stare il primo grado dell’azzeramento, il vero riconoscimento che avviene trasecolati dai desideri, giunti all’oscuro del tempo e di qualsiasi altra coordinata, nella circostanza immobile di essere uno che è mosso dal fatto plurale di venire assediato “senza mediazione/mi parlo/distillo/la purità muove/e ho gusti di darmi desiderio che infiamma per essere ogni mio tutto”. Venire presi dall’imboscata del dialogo con l’elemento alternativo di se stessi, ossia venire presi da un sé alterno che non subisce l’apoteosi di comparire, è come attraversare un desiderio barbaro e nullificante, che scatena la mossa della paura, è come essere trafitti da una corrente incontrovertibile che conduce alla continua verifica di esistere, enunciando se stessi a partire dal corpo e dal sangue “la paura mi conduce al peccato/col vostro corpo salvatemi/col vostro sangue inebriatemi”. E’ il corpo come presupposto fallace all’esistere che bisogna parossisticamente comprovare. E’ “l’indigenza del divino” che dà al corpo la separazione che lo rende vuoto, e che spinge alla gara iniziatica di un’azione radicale, un’azione che recida di netto la sensazione di non appartenersi. E in tutto il disamore che c’è nel potere questo, “vince chi muore per primo”. Tuttavia la Neurosi II, si apre con la definizione del piacere che per quanto sia non più la “detenzione” ma “l’abbandono di uno stato di esistenza” (che lascia ancora ogni intenzionalità a margine) esso conduce per cedimento ancora più da presso alla zero distanza dal baratro che separa il corpo e il suo latore. L’autrice a questo punto fa sapere che il corpo ha una possibilità nel piacere, cioè quella di giungere “in procinto di essere anima”, e ciò accade in virtù di un’imponderabile “contagio” con l’altro. Dalla Neurosi del piacere scaturiscono tutte le mosse corporee della metafisica animale, ed è un catalogo snocciolato di seguito, trattenuto il respiro, quello che catapulta la cognizione dalla Neurosi del piacere all’alienazione finale. Nella terza Neurosi il dolore confina il libro e l’esistenza. Là dove il potere, o il suo contrario, ha liberato i corpi dall’esistenza codificata e il piacere ne ha reso plausibile direttamente nella carne la sottigliezza inumana, il dolore è un buco “lo stato di ansia collettiva che diserta la memoria”. L’essere, reciso dal ricordo di poter ricordare, è eviscerato, per cui non nutribile. Il dolore è una costrizione che rende inagibili a tutte le dinamiche di scarto, in cui l’azzeramento smette la ricerca nell’inedia definitiva che prelude al distacco. Il dolore inghiottisce da “un pensiero assoluto”, così trascendentale che disgrega corpo e ambito, come sgranando il rosario circolare che non si interrompe malgrado l’interdizione dolorosa pare compiersi nel nulla da cui ancora è vinto, chi muore per primo.
Francesco Bellomi, musica, Handbook of nothing (02)
Convegno “Parola per parola”, galleria fotografica di Maria Grazia Veroni
Alessandro Assiri, da "La stanza delle poche righe", Manni 2010, con una nota di Rosa Pierno
**
si affrettava il passo e sembrava si spostasse,
l’unico spazio che all’uomo è concesso
tutto quel vuoto che manca all’adesso
**
la voce che non sento
è la mia lingua che non dice
le lettere spedite dall’esilio
a un indirizzo sconosciuto
dove il dialogo è uno spasmo
un tempo ormai reciso
**
rumore di ferro, di catene pesanti
si ama solo trascinando
**
fuoco di un presente
improvvisato
calore necessario
alla tua parola che sognava
di succedere
**
anniversario degli oggetti
condannati a esser densi
come noi che sorridiamo
tra le radici e le stelle
attraversando un silenzio
**
a capo
così la pagina non finisce
come spazio bianco
delle paure orizzontali
ma prosegue
amplificandosi
dal basso
**
di stanza in stanza
così divento casa
al plurale immaginando
mattone su mattone
costruire lontananza
con la calce dell’addio
Operare con le parole un diradamento per cogliere qualcosa, non diremmo l’essenziale, né un concreto risultato, piuttosto soltanto un percepire inusitate prospettive, nuove vie: “come meli che la grandine ha scosso / aggrappati alla vita / tentano il frutto”. Solo ciò che si tocca, che si vede, può dare qualche certezza, il linguaggio non dice, “il dialogo è uno spasmo”. Ma quanto possa servire la percezione in quest’afasia è pressoché dichiarato: “dimmi cosa c’è tra questo nulla e me”, dove se si percepisce il nulla è ancora al linguaggio che si chiede di tessere relazioni e dare definizioni. Pratica paradossale, ma non per questo non perseguita. Alessandro Assiri ci sembra un equilibrista che si sia assicurato la caduta per verificare i limiti delle possibilità del linguaggio e la praticabilità della sua assenza. Il suo esercizio linguistico non frantuma la frase, costruisce un dettato semplificato al massimo, che si potrebbe, forse, definire a trama larga. Certo, lo scenario che egli disegna è privativo: “restano solo storie / di seme che cola / senza ventre / per terra” e rari sono i tentativi di rianimare il senso lì dove non ci sono che tracce superstiti. L’immaginazione vi è usata come esca e le parole sono rese oggetti senza ruvidezze: nessun rostro che artigli prossemiche parole. In ogni caso si cercherà di mettere in nuce l’esistenza nuda: “si vive / e forse è troppo ancora / si vive solo / per nutrirsi di sole”. E, nonostante questo, le parole sono sempre in agguato, quasi impossibile tentarne la riduzione, allo stesso modo in cui sembra impossibile ridurre il nostro impeto all’attesa, pur se siamo consapevoli che nulla giungerà. In questo testo, che corteggia il silenzio per rendere presente il nulla, noi constatiamo che Assiri ottiene comunque di circoscriverlo.
Ettore Labbate, da "Geografia", Manni 2010, con una nota di Rosa Pierno
(poesia)
non si dà
ragione e
misura
col verso il
ritorno
costante
di linee al da
capo del
testo
lo squilibrio
della parola
l’ubriachezza
che anche
stasera
sa già di
doversi bere
in anticipo
questo non
darsi mai
ragione
questo
misurare il
continuo
distacco di
ciò che non
combacia
da ciò che
non sa e non
sa
scrivere
perché non
può viverlo
ostacolo il
testo il suo
corpo
in quanto
tutto assorbe
e separa
Non si situa nel divenire e conseguentemente nella molteplicità inscritta in esso, Ettore Labbate con la sua raccolta poetica “Geografia”, seppure egli ci parli di un “continuare”. Un continuare che non ha un inizio, non ha qualcosa da cui cominciare. Un ricominciamento perpetuo e un ricercare inconcluso con “impossibilità quindi di poter finire”. Tutto appare statico e frammentato, impossibile da stringere persino con lacci. Meno ancora si potrà fare riferimento a significati unitari. Dall’immobilità dello sguardo di Labbate, però, si ottiene una descrizione particolarmente fissa, persistente, ossessiva, in cui la profondità non potrà essere solo una qualità adombrata. Lo sguardo sembra perforare le cose e andare oltre, ove l’oggetto fissato non è più visibile. Nell’astrazione dei segni, così raggiunta, eppure, nessuna geografia, nulla che valga come indicazione di direzione, nessun orientamento sembra possibile. Segni vagheggiano, vanno alla deriva, “nel tracciato / galleggiante / del loro / andarsene / qua e là”. Segni che hanno perso la loro capacità di porgere significati, ma è del tutto evidente che non sentire più i segni della primavera, o avvertire il risveglio della natura come ciò che non rinnova se non la morte, vuol dire tracciare una mappa in cui il soggetto non ha più gli strumenti per valorizzare ciò che vive. Il nuovo allora non potrà rigenerarsi insieme alla terra, la quale morirà con noi. Una cartografia finisce comunque col tracciarsi ed è di quelle costrittive, che non ammettono nemmeno di smarrirsi in essa: “non può più / seguire alcun / ordine o / regola // in lui e per / lui tutto si / spreca è / sprecato”. Ove solo l’ascolto della musica pare alleggerire l’esistere. Non a caso, una forma non linguistica.
Loredana Magazzeni, inediti da "Fragilità del bene", con una nota di Giorgio Bonacini
ritratto
se esce dall’ombra o entra nell’ombra
a rischiarare un tempo oscuro della conoscenza
come accade per chi guarda
la costruzione di un volto che non è mai definitivo
è paesaggio sublimato devastato dominato dal tempo
la mappa e il magma di se stesso
come avviene in un quadro dalle moltissime stesure
e si procede per tentativi e si va alla ricerca
di una lettura più attenta che arriverà alla tua icona
ma la nostalgia per quel momentogià determinato
fissa ciò che sei in un lampo dove potersi riconoscere
riconoscere il senso della propria presenza
in una storia che non riesci più ad afferrare
se non per fotogrammi che non puoi ripercorrere
ed è come se l’attendessi ed è soltanto un pretesto
i problemi sono di forma di luce d’armonia
**
Se viole un giorno seminasti per me,
mio giardiniere, ai piedi del tuo
tronco tardivo io ne raccolgo
le silenziose braci.
**
che eri la casa dell’ombra
che eri qualcosa di oscuro invisibile
che continua a fiorire a finire
che un ascolto placato dentro questo silenzio
che questo pretendere senso
che ogni oggetto che muovi in un senso lo cambia
che parliamo di cose normali vivendo
se un sudore mi lecca le dita
se ostinata come scintilla
mi accade vivendo
**
La grazia è in relazione all’amore?
E guarire è una domanda a una domanda?
Guarire è lacerare, irrompere,
interrompere la strada inevitabile,
paradosso di libertà fra ruderi
Sperduti e circondati da rovine.
Salvàti.
**
Meta, metà di me?
Dimidiata sostanza,
meta adocchiata,
sostanza di me medesima,
prospettiva spezzata:
metà per volta eletta, meta
insospettata: sostare, forse.
Di quando in quando.
Sappiamo che la poesia, anche quando deve parlare d’altro, ha sempre in sé la capacità di pensare al suo essere. Ed è proprio questa doppia valenza che permette di trasportare la propria lingua in una scrittura e una lettura che diffonde nel testo i segnali di significazione autonoma; segnali che evidenziano una poetica, o almeno una sua interpretazione. Ebbene, Loredana Magazzeni, mostra in queste poesie con quali sentimenti di forma, forza e leggerezza, e senza forzature programmatiche, sia possibile risignificare un mondo. Il luogo, cioè, in cui i versi vivono e a cui danno contemporaneamente vita, con un lavoro di costruzione e crescita che è simile a quello di un “muratore” o un “giardiniere” della parola.
Ma, con ancora più valore e precisione, il fare poetico viene definito, attraverso la metafora del “cucire”, una riparazione: perché questo è “il gesto più sapiente”. Riparare attraverso la poesia che intreccia i fili e ridà nuova forma e nuova vita. E in questo senso si comprende, leggendo i testi, quanto l’autrice sia consapevole che una forma di vita porta sempre con sé una configurazione di sensi: una diramazione che interiorizza il suo dire, ma che non si dà mai nello stesso modo, mai con la stessa certezza. Perché un movimento, un punto di vista, una percezione emotiva o intellettiva, in condizioni diverse (per tempi, stati d’animo, letture) cambiano inevitabilmente le modalità generative con cui la significazione si fa senso.
Ma in questi testi c’è di più, c’è un’attenzione posta sul fatto che in poesia, pur essendo questa materia di parole, la parola perfetta è impossibile e la sua ricerca, quando diventa una sforzo incessante, può portare a qualcosa che “ammala i nostri sguardi di afasia”. Ecco allora perché il concetto di “riparazione” (che S. Haeney ha elaborato in suo importante saggio), legato alla concretezza della lingua, fa sì che questa poesia anziché distruggere per ricostruire, si adoperi per ricomporre pezzi (di memoria, di corpo, di pensiero) già dati e portarli a nuova vita. Il risultato è vera forza immaginativa, che può anche curare il dolore o la difficoltà di comprensione delle ferite esistenziali che si aprono nelle nuove ricerche di conoscenza che la poesia pensa e vuole attuare.
E dentro a questo percorso si situa anche la necessità di dare visione a ciò che cerca di “rischiarare un tempo oscuro”; nonostante l’andamento non sia lineare, ma ondulato, ricorsivo, sinuoso e l’ immagine possa chiudersi in ombra o deflagrare in fotogrammi inafferrabili. Qui il senso è il modo del sentire: sostanziale alla parola poetica, in ciò che ci unisce o ci divide, ma senza una fine definitiva, nello spazio “che ci separa dal dolore dei morti”. Dove non sai se il dolore è quello provato dai vivi per i morti o dai morti per se stessi, in una oscillazione emotiva e concettuale che soltanto la scrittura può mettere in atto. Anche solo in modo provvisorio o instabile, ma sempre nella concretezza di una riparazione possibile per la “fragilità del tempo” che ci scuote e la “fragilità del bene” che si spezza.
Maria Pia Quintavalla, un inedito, "Trasmigrano", con una nota di Marco Furia
I
Trasmigrano i corpi, così l’amore
che mi sposta e muove
ali che si toccano sfilano appena
il collo gli occhi, più leggeri
nel sorriso. Sogno:
anse di nomi spinti da sonno cieco e
cani che riaprono l’alba
lui, lei che ricambiano
il cerchio del piacere,
dopo i cimiteri delle macchine là fuori,
e trattengono il cuore, lo smarrito
se balbetta il tuo nome,
o tenerezza.
Terra scoscesa e bretone,
nel verde
che disegna menhir in magnitudine,
parole come calvari in pietra -
Tra i nostri amori è l’acqua dove
una promessa sarà certissima
nel cuore,
colmo e con incerta mano
dai baci incoronata
la t u a voce.
II
Ha fede e ostinazione il mio diletto,
sparge il suo dire a coprifuoco
cerca mappe alle stelle -
per arrivare fino a me, la sera
una promessa, un rilevante sogno
in balbettii leggeri
esse-emme-esse che si sollevano
(deve essere già integro, discreto
lui, se lo capisce).
III
Il mercato è la regola
della circolazione delle merci,
e non dei sensi
che amplificano il regno -
Volessi io tornare al segno dove
l’anima e il corpo si fronteggiano,
si palpano da ciechi
un tesoro ai tuoi piedi io governo,
tu lo porgi
dal libro dell’amore inviti,
voli alto in dolzore
sopra le braccia poiché
il ragno della vita, la mia la tua
rinascano
in nuova c a s a.
Ti amo intanto, piccola
figlia nel bozzolo, mentre ti prende
il gioco della crescita;
ritorno un poco indietro, attenta
scelgo sedermi calma, cerco
la c e n a dell’amore vivo.
Con “Trasmigrano”, Maria Pia Quintavalla presenta un’intensa composizione articolata in tre parti.
Mi pare molto significativa la pronuncia:
“volessi io tornare al segno dove l’anima
e il corpo si fronteggiano”.
L’anima e il corpo, dunque, secondo la poetessa, si fronteggiano in corrispondenza di un segno.
Forse, s’intende, perché sono ambedue segni?
Come si potrebbe, altrimenti, ipotizzare siffatto rapporto?
Non si tratta, si badi, di un quesito ontologico riguardante l’esistenza dell’anima o del dualismo anima – corpo, bensì della consapevolezza dell’importanza dell’elemento linguistico.
Quell’anima e quel corpo possono fronteggiarsi soltanto nell’àmbito in cui, quali vividi paradigmi, esistono, ossia quello dell’umano idioma.
Felice il tocco di Maria Pia: i suoi versi si soffermano, efficaci, su simile importante questione con quell’elegante naturalezza propria di chi è teso a mostrare un sussistere senza pretendere d’esaurirne la spiegazione.
Talvolta, davvero, occorre non proseguire il discorso, poiché certi aspetti, taluni lineamenti, vanno osservati in maniera partecipe senza voler procedere oltre, provando feconda meraviglia di fronte a quell’enigmatico spazio in cui il silenzio non è più, mentre la parola, non ancora compiuta, è cenno, suggerimento, invito a continuare.
La poesia ci aiuta a vivere?
In questo caso, sì.
Silvia Rosa, prosa inedita "Corrispondenza (d)al limite", con premessa di Mara Cini
“che cosa resta di ogni parola sgusciata…”? Si prenda in mano una parola “sgusciata” e si avrà di questa parola la percezione più personale, spogliata dei significati correnti, riportata a un nucleo di identità sospesa fatta di memoria ed esperienza che la dilata. Ma ogni respiro, ogni sguardo, ogni soffio ha il suo inverso. Allora riappare il guscio che soffoca, nasconde, racchiude.
Ecco, dice Silvia Rosa, occorre lasciare la parola giusto a metà del palmo, al limite della sua esplosione o implosione, per donarla o serbarla.
Il limite, finalmente.
Ne sfioro il perimetro, ferendomi sull'orlo arrotato di gelo, io, che al gelo (non) appartengo.
Notte (epifania o della chiarità)
E dopo tutto a domandarmi ancora -muta- se sia stato più stupido giocare lealmente al tavolo (che sapevo) del baro, o aver accettato di partecipare a un gioco non mio (in qualità di giocattolo), nonostante facessi sul serio.
[S c a c c o, a prescindere. E l'impotenza del non (aver) detto]
Mi traccio intorno un confine di filo spinato: se sanguinare è necessario un poco a non perdermi esangue, che sia per impedirmi di superarlo di nuovo, quel limite oltre il quale c'è un baratro, specialmente nero di umiliazione.
Primo giorno
La voragine aperta dell'Assenza ha la forma di un sorriso scheggiato. Si scivola su qualche lacrima, rugiada di un dolore che si schiude ad ogni alba, ma si procede, a piccoli passi. In direzione inversa. Da lontano che sembra accanto, l'eco di voci amiche.
Secondo giorno
Con l'alfabeto della ragione misuro in lungo e in largo la lingua friabile del sentimento -al limite-, uno sguardo vigile sul precipizio, passeggio pensieri e mi interrogo. Come mai sono arrivata fin qui? Con la precisione dei geometri della mente riduco il confine a un grumo di terra, su cui ergo la logica asciutta, il rigore della consapevolezza.
Ho una chiave per liberarmi (?) invisibili catene, la stessa che apre i cancelli oltre il margine segnato d'inchiostro catrame. Nessuna distrazione nell'esercizio di analisi, mi concentro -uno sforzo dal vertice al suolo più sterile- e traccio la rotta dell'inversione.
Terzo giorno
Il vertice della solitudine è un chiodo, che ti fissa la carne al Nulla, è il freddo che abita il "Noi", quando l'Altro si fa trasparente, e scopri che era da sempre il non esserci, insieme. Il vertice della solitudine è uno spillo di luce, che ti svela il risvolto del Niente -Amore v(u)otato a perdere- appuntandosi al lembo più tenero (di te), che ti brucia d'offese.
Il vertice della solitudine è una piuma, che se la stringi abbracci te stesso, ti senti l e g g e r o -sul bordo del burrone indietreggi, nessuna vertigine-.
[Possiedi il tuo vuoto -per intero-, è nella mancanza -sola- che esisti]
Quarto giorno
Il tempo si è dilatato, i minuti respirano a lungo, e io prendo fiato con loro. Ma non è immobile questo restare sospesa nell'incavo spalancato tra secondo e secondo, questo virare lento dal nero alla macchia più accesa di rosso, questo scolorirsi leggero dell'ombra sfiorando la luce, attraversando silenzi che implodono gli occhi -li svuotano-. Attendo seduta sul ciglio (di me stessa) la rabbia. Quell'urlo che ho tenuto segreto, che precipiti al fondo e poi mi ritorni improvviso all'indietro, per sentirlo in un soffio, il verdetto i r r e v o c a b i l e la sentenza : Signori comprendo, ma no, non perdono Nessuno (tranne me stessa).
Quinto giorno
Che cosa resta di ogni parola sgusciata, se al centro il cuore di polpa -il significato- è marcito da tempo, un frammento cubico di una menzogna, un chicco spento bucato di noia, il verme del tradimento? Eppure si dovrebbe credere ancora che il Verbo possa dirsi (l')autentico, che possa coincidere con l'angolo vivo che pulsa annidato tra vertebra e costola, che possa segnare il battito esatto di ogni certezza, che pure nel dubbio si traduce in un interrogativo -qualunque- ma resta incoerente e se stesso. Al confine non vale ascoltare lo sgocciolìo sintetico che spiove tra i denti, l'aderenza di fede tra lettere e Amore: la salvezza dal baratro è in un gesto, in un passo all'inverso.
Che cosa resta di ogni parola sgusciata? Il ricordo della mano che l'ha fatta a pezzi, violandone il senso. Un gesto all'inverso.
Sesto giorno
Dove sono stata prima di affondare il respiro nel muro ovattato dell'orizzonte? Ho confuso la linea smerlata del cielo con una catenina di ruggine, annodata stretta alla carcassa del baratro, e a guardarla senza vederla davvero mi sembrava preziosa, un balocco dorato, con cui vestirmi bambina da sposa. Ma nel fondo scuro più fondo del fondo denso di ombre, ci sono solo catene che rendono schiavi e all'unico all'altare si arriva -annaspando in cunicoli bui d'umiliazione- come un'offerta, da sacrificare. Per Niente.
Settimo giorno
Possibile che di là dal confine non giunga nemmeno una voce, un alito tiepido di scuse? Possibile che ancora, nel lucore del limite che si apre scucito (un'asola) al bottone dell'alba, non si sappia credere a quel che si è visto -uno schizzo terso di vero-? Si attende, si aspetta qualcosa sprofondando nel centro più molle di un giorno (dopo l'altro), fino a sentirne il sapore di fango tra la fessura di labbra, fino a sentirsene parte, colmando la falda segreta che spurga il silenzio in acqua di sale. Aspetto me stessa, io, per smettere attese e mi abbandono, la pelle contro il recinto di ferro in cui pascolo oggi i miei giorni, al canto stonato di fede, al mio credere, credo che tutto quello che è stato -anche- Niente, per me è stato, e mi scuso, mi pento d'avere svenduto qualcosa che valgo, l'unica in cui credere ha senso. L'unica che ho rinnegato.
Un altro giorno
La conta dei giorni è una filastrocca, e io ho otto anni -da sempre- mi sento la stessa, e raccolgo innocente parole dopo parole dopo tutto chiedendo una culla -di quelle che pare ondeggiando che volino lievi- in una virgola, in un punto (di sospensione), la verità delicata parola dopo parola dopo Niente di una carezza perdendomi e invece [...].
Alla frontiera (terra di Nessuno) zolle di rovi, lembi seccati di polvere deserti, io interrogo il limite che mi appartiene e mi puntella lo scheletro di brividi e mi lega e mi tiene, ostaggio dietro grate d'insicurezza. Sto -da sempre- in questo luogo e peso le nuvole, sommo distanze di passi che mi portano dentro me che mi sfuggo, divido i fantasmi in pagliuzze di ombre, che mi lacrimano sguardi di tenerezze (inutili), e cancello con diligenza -in superficie- il fiore selvatico che sembra ogni segno, ogni mia cicatrice.
Un giorno a venire
L'inversione possibile è nello scatto obliquo dell'iride verso l'Azzurro, dal precipizio non si sfugge, il precipizio è il buco che coincide con la mia bocca, col mio ombelico, con la geografia di anfratti scuri che mi connotano - (il) Corpo- dentro fino all'atomo più piccolo di vita sfibrato, fino alla mia stessa origine. Il ghigno del baro fantasma carnefice è quella mia cicatrice, il ricamo di sutura con cui l'ho sottratta alla vista -al (mio) perdono- è la catena, che corre lungo derive -di resa- su cui (mi) sprofondo nel vuoto, nel buio senza appiglio pareti, nero su nero oltre il nero medesimo, dove non c'è niente io nemmeno.
Epilogo -qualsiasi giorno-
Non si va da nessuna parte. Si liberano fogli increspati di nostalgia -aquiloni che (non) volano, nella pozzanghera che cola d'arcobaleno indifferenza-, si fingono aurore improvvise, tramonti rivelati tra quattro punti -cardinali-, suggello di fine capitolo (chiuso per aprirne un altro uguale), si volta l'angolo e si ritorna a prima, si indugia troppo tra le parole -divaricandole- con le dita affondate nel Senso, a godere poi di che cosa? Di quel Niente che è (stato).
Aspetto me stessa, e spero che arrivi -al limite- d'io con la (mia) mano tesa: un'offerta di tregua, il pane caldo del perdono, uno spicchio di Cielo che non frani la Terra.
[-Stimmate- sulla linea interrotta della vita, a metà del mio palmo, il solco che resta].
Francesco Bellomi, musica, Handbook of nothing (03)
Convegno “Parola per parola”, galleria fotografica di Sabrina Valentino
Mauro Germani, da “Terra estrema”, L’arcolaio 2011, nota critica di Rosa Pierno
**
Lontananza che allontana.
Notte dentro la notte.
Danzano le ombre
al canto dell’Assenza
e già nel buio
si perdono i confini,
i nostri nomi incerti.
E non c’è più
non è più qui
il corpo ignoto
del mondo.
**
I tuoi occhi adesso.
E quanti anni nel corpo
quante domande
per dire noi
per dire senza.
I giardini nella piazza
e una promessa.
Un viso, un’ombra.
Il tuo nome una volta.
**
Scrittura d’ombra
e d’esilio,
capovolta aurora
di pagine perse.
Dov’è il vento
che chiama
le labbra,
il raggio bianco
che scuote
la terra?
Dov’è la voce
perduta
del sasso,
l’eco ammutolita
del cielo?
Tutto
si cancella
dove tutto
perdura.
Una frequentazione della filosofia che divenga combustile nella fornace della poesia è esperienza usuale, ove però di volta in volta, per singolo caso, è importante verificare il lavoro sulla parola e sulla sintassi e in ultima analisi il portato di tale investigazione. Ci pare che il lavoro di Mauro Germani, testimoniato dalla sua silloge “ Terra Estrema”, effettuando un prelievo terminologico dal contesto filosofico innanzitutto semplifichi al massimo la presenza del tessuto sintattico, quasi giungendo a un dettato elementare: “E’ questo solo / lo scandalo della carne, / l’enigma di ogni nome, / il pianto segreto / delle mie parole..”. In tale semplificazione, giocoforza acquistano maggior rilievo i termini presenti, monadi indeclinabili e non relazionabili, sui quali Germani sceglie di non attuare nemmeno una teatralizzazione dialettica. ”Non sappiamo il corpo / l’assoluta verità del sangue”: scissi i legami tra parole, esse paiono rilucere in un vuoto simulacro. In fondo, esse sono state private anche del loro bagaglio storico. Sembra che siano vicinissime a perdere ogni senso: “E non c’è più / non è più qui / il corpo ignoto / del mondo”. Che tale svuotamento sia progetto strenuamente perseguito ci viene dichiarato da Germani stesso: “Il passo che non ha sentiero /e scende nel cuore dell’ombra / solo / lungo il crinale del tempo. / Dov’è mai adesso? / Dove mai non c’è?”. L’auspicata presentificazione dell’essere forse non avverrà, non è che una speranza o una proiezione, e allora sarà “qualcosa come un respiro, / il nome perduto del mondo”. Di tutta evidenza che l’essere non appartiene che al regno delle parole per Germani: “E quanti anni nel corpo / quante domande /per dire noi /per dire senza”. Ma è appunto solo nella scrittura che si può tentare: “Scrivere sempre / il già / cancellato”.
Massimo Scrignòli, da "Vista sull’Angelo", Book 2009, con una nota di Rosa Pierno
**
E tuttavia
per uscire dal mondo dovremo
intuire
decifrare
tradurre
l’angolo minimo di tempo dove
il pane è una luce verticale.
Si passerà da una porta assente
che si può immaginare dietro
le scale, in basso, all’opposto
del rosso che occupa le ore
per tutto il giorno. Il vecchio guardiano
conosce ogni passo, i lati insidiosi
eppure ripete
“Entrate entrate, poi
scendete sette scalini a destra.
Il luogo della fenice è un triangolo
vi accorgerete subito dove
conviene arrivare dove
non si dovrà andare”.
Si entra nel triangolo
e non si pensa a come uscire
se mai si dovesse tornare, o a fuggire
anche se nessuno dice da che cosa
ma è certo che accadrà
in un’altra parte del giorno.
**
Il vento si muove e raggiunge i confini.
Entrando nel triangolo domanderai
se la vita è ancora viva.
Uscendo dietro la fenice chiederai
della sorte del deserto. E della sabbia,
che come rondine illusa
fruga tra le rose di sasso
la verità nascosta agli uomini.
Si direbbe che non esista una realtà autonoma, per Massimo Scrignòli nel suo racconto in versi “Vista sull’Angelo”, ma essa sia già un tessuto di segni e simboli da decifrare, attraverso cui orientarsi per effettuare passaggi, per percorrere comunque il labirinto. Non è via iniziatica, percorso formativo, non esiste gradualità verso la conoscenza. Vivere consiste in questo attraversamento in cui i segni sono falene, lucciole da cui lasciarsi affascinare per quel che valgono: “Se il sentiero del ritorno avrà un pensiero / sarà un’iscrizione vuota / dove forse è meglio perdersi / o inseguire il mondo quando si sposta / spinto da un vento che non riconosco”. Pertanto, nel riconoscere quanti più segnali si delinea la riuscita della partecipazione al gioco. La possibilità di arricchirlo senza sosta, di renderlo vieppiù rifrangente e ricco, poiché in questa lievitazione, in questa moltiplicazione risiede il piacere e la pienezza dell’esserci. Ma non è soltanto pacificata aderenza all’esistente. E’ anche strategia di sopravvivenza: “E come vedi / la verità si è fermata nel grano, là / tra la spiga e la macina risveglia / l’ansia di un destino infedele // trasumanar che rapisce la vista // e consola”. Alla prova è messa inoltre la capacità di interpretare correttamente. Poiché i segni servono anche a questo: a non ripetere gli errori della storia. Nostro dovere è evitare un’altra Auschwitz. Diviene importante cogliere le differenze, affinché si possa rilevare “l’imprevisto lascito di presenze”. E’ il lavoro della libertà, affinché sulla messe di segni si effettui la cernita, “utile a stanare dal fondo della vita / il canto d’amore di un ‘anguilla // o l’impazienza // del destino”. E che sia relazione pacificata tra lingua e oggetto o ardente lotta tra essi, la lingua resta enigma irrinunciabile .
Enrico De Lea, inediti da "La furia refurtiva", con una nota di Giorgio Bonacini
dalla sezione Serpe di Laconia
(introibo)
Risibili alle passioni del rapace
falcidiato volto,
la presa pur convinta della mano
e il mesto freddo della pietra
lavica, come di profilo
calcidese o messenio, mercatante,
profugo da un mare,
per cui levare l’acqua all’occasione
d’umiliato controllo, debito
all’occhio ionico, tra brume.
(prospettiva dell’ascesa)
Dentro, nel corpo di, nel calco di
calcaree divinità sostantive,
degne del lampo della sparizione,
si decide ora un vento,
la sua seta d’ascesa
da un arco di vicolo a tribona.
Questo, ovvero l’altro, sopravvissuto
monte dei dolori, il postumo
suo ciottolo si slega – era scalone –
all’aria prospettiva.
Dall’idea delle mappe qui si compie
la ventura inclinata dei muri
nella dimenticanza delle luci,
un’onda di diniego dai terrazzi,
specchi in frantumi tra fontane erose.
(la furia refurtiva)
La furia refurtiva
archetipo discorre, lo riscuote
muto bronzo dell’epoca,
tonante, tinnante, sempre
per manufatte lastricate
strade in pietra d’avi,
nell’infanzia del morente
si consolida, l’orante.
dalla sezione terra picta
I
S’accosta, da un’urgenza
di luce, nell’oscuro strappo
della volta, nel tremante
saluto della mano,
sul dorso un rossore
di nerbo, ustione, nutrimento.
V
Profili disegnati dalla marea –
è la visione delle ginestre in alto.
il vento dall’interno accatasta
barche e nuova smania
per la fuga. Al disfarsi dell’aria
un varco nel seccume
del greto ieri navigato.
Se è vero che una fra le caratteristiche proprie della lingua poetica è la destrutturazione e una diversa articolazione del normale sistema di significazione linguistica – nelle diverse forse sintattiche o semantiche – qui, nella scrittura di Enrico De Lea, si manifesta anche un altro operare: la sua scrittura sottopone il linguaggio a una concentrazione tale da non poter più dividere, nel suo andamento, la lettera dalla figurazione. La parola condensa al suo interno una lingua che aderisce in modo indissolubile alla cosa stessa di cui fa esperienza. Ci troviamo nel vivo e nel fondo della lingua dis-ordinaria delle cose, “dentro la “gola/ del cielo minerale”, dove il senso si prosciuga, smagrisce e quasi pietrifica. Ma questo non significa un impoverimento o una perdita del significato, bensì una sua riattivazione, a partire da un corpo essenziale, in direzioni indeterminate. Alcune sfuggenti, altre misteriose e oscure, ma tutte potenzialmente capaci di sprigionare il loro carico di sostanza concreta.
Questi testi sembrano non regalare nulla di già dato, di già conosciuto, sembrano scolpiti in se stessi e tesi a rappresentarsi per sé in ciò che hanno inglobato di esterno. In realtà è proprio in questo rapporto totale con l’esterno, che si manifesta il dovere e il desiderio (per chi alla poesia dedica il proprio pensiero) di apertura. Il lettore è obbligato a spaccare la scorza che ne ricopre la voce. E, paradossalmente, questo obbligo è un regalo, perché guardando dentro lo squarcio si trovano i semi di una passione di poesia. E così De Lea mette in atto la costituzione di una crescita continua “verso l’alto”, alla ricerca di un “rifugio/con percezioni d’altro”.
Ciò vuol dire che qui la parola non ripiega mai sull’io dell’autore; è come se si facesse da sé, come se ogni testo fosse già inciso in autonomia. Lo stesso titolo “La furia refurtiva” vive in un’ambiguità semantica in cui non si sa se ciò sia materia di furioso furto o oggetto di furia derubata. Il senso non propende né da una parte né dall’altra, e sembra quasi che l’autore non partecipi della sua scrittura, ma semplicemente mostrando ciò che è scritto. Infatti nella poesia eponima tutto si svolge “per manufatte lastricate/strade”. Ma in fondo a questa forma dura si muovono esistenze che provano a dire, a smuovere l’ammasso che li stringe, provano con le uniche armi possibili per la poesia: il suono della voce e il fruscio della scrittura. Ma ci vuole anche umiltà, consapevoli che spesso la lotta si fa con “derelitti fonemi”, strappando un pezzo alla volta nell’oscurità, balbettando, incespicando, ma sempre scrivendo, anche solo un poco, anche solo un niente.
De Lea, con la sua metafora concreta, ci restituisce un reale di purezza: senza fronzoli, senza ingenua innocenza, un reale tutto dentro le frasi come grumi calcarei, dove il formarsi di una crepa è una ferita all’umano pensiero di ogni tempo. E’ così, allora, che il sentimento che pervade questa raccolta di versi diventa qualcosa che può sgretolarsi come terra secca, o bruciare con uno sfrigolio continuo. Ma non c’è scelta, perché se gratti il “gelo di verità” che ricopre ciò che vediamo, ne risulta solo una “schiuma per le dita”, o soltanto “polvere senza peso”.
Sofia Demetrula Rosati, un inedito, "Il demolito è l’unica dimora del ritorno", con una nota di Marco Furia
Persefone esce dal Tartaro per reiterare l’annuale ritorno sulla terra. Demetra l’attende. Ade l’insegue. Sfinita dall’eterna divisione tra il desiderio di un uomo che la trattiene nel mondo delle ombre e una madre (doppio di sé) che la reclama alla vita, per far maturare i campi d’orzo, Persefone dimentica il suo compito. Il suo ventre nel mondo delle ombre rimane sterile, mentre quello della madre, doppio di sé, partorisce ogni anno, grazie a lei. Ella allora, prende coscienza del suo corpo sterile eppure fecondatore, del desiderio che la minaccia senza darle piacere. Il suo nome le dà senso e coraggio. Lei è pharo-phonos “colei che porta la distruzione”, niente più di questo. Il corpo-donna si ribella al mito e conquista uno spazio, una “no man’s land” tra la vita e la morte.
non esiste una vera posizione del piacere
il fiato sul collo è il mio
le mani sul ventre sono le mie
le dita nel mio utero cercano con misura
una piega tra la pelle rugosa
dove poter ancora resistere
ho dimenticato i semi di melagrana e
non ricordo più qual è il mio compito
quanta luce arde il sole
io cammino non ho memoria dei passi della fuga
il cemento ha distratto chi mi insegue
non comprendo altro ritorno che non sia demolizione
la dimora non emette suono
sono un mattino di fine giugno
perché mi chiamate sera d’autunno?
mia madre che ho generato
mi aiuta a partorire in
questa lunga giornata estiva
stesa nel campo d’orzo
sotto un sole di ferro arrugginito
ma non vedo uscire nulla dal mio utero
solo liquido amniotico che lei
asperge sul campo e una
placenta livida e maleodorante che lei
dà in pasto agli animali fermi sul
margine del bosco di pioppi bianchi
dov’è il mio frutto? il partorito?
nell’utero solo le mie dita
io sono ancora un mattino di fine giugno e tu
da me generata che mi chiami figlia
parli dell’autunno e del ritorno
mi dici che lì sotto questa terra che
stai fecondando con il mio ventre
lì sotto c’è la dimora
la mia dimora
ma il demolito è l’unica dimora del ritorno e io
ho dimenticato i semi di melagrana
chi mi insegue è lì con il viso
rivolto verso l’alto distratto dai lunghi
pilastri di cemento armato
i suoi occhi soffrono perché non conoscono la
possibilità della luce e non
sono allenati alla velocità dello
spazio verticale
con le mani come tettoia spera di trovare riparo
ma lucide lastre nere continuano a
scorrere sulla sua retina
il mio fiato sul suo collo gli dico che
il demolito è l’unica dimora del ritorno
le mie mani sul suo addome disperdo
lo sperma sulle mute macerie
con il ventre vuoto torno nel
campo d’orzo da mia madre
da me generata
trascorro le lunghe giornate estive
distesa tra secchi arbusti di paglia
l’orzo non è più maturato
gli animali se ne sono andati
in cerca di cibo altrove
l’estate è permanente e il sole
arrugginisce inutilmente
mia madre da me generata agonizza
chi mi insegue ha purificato la retina
dalle lunghe lastre nere e
trascorre il suo tempo
ad inseguire lo spazio in verticale
io ho dimenticato qual è il mio compito
Con “il demolito è l’unica dimora del ritorno”, Sofia Demetrula Rosati presenta una poesia la cui assidua cadenza allude a un quid in cui sembra, alla fine, precipitare:
“io ho dimenticato qual è il mio compito”.
Dico “precipitare” perché, a mio avviso, proprio di questo si tratta: le pronunce poetiche, ampie e precise, ricche di riferimenti alla maternità e, in generale, alla fecondità, compiono articolate volute per concludersi, in maniera repentina, con la suddetta dichiarazione.
Dichiarazione inattesa, poiché il corso dello sviluppo linguistico pareva tendere al raggiungimento di maggiore (responsabile) coscienza, anche se il verso che dà titolo al componimento risulta, senza dubbio, inquietante.
Bene, credo proprio che in questa presenza simultanea di dati costruttivi e di profonde inquietudini consista il nucleo di una poesia che intende mostrare, con coraggio, non concordanti aspetti.
Per riuscire a superare un doloroso contrasto occorre prima riconoscerlo in tutta la sua angosciante pienezza, con sincerità, senza riserve: appare questo il messaggio di una poetessa troppo coinvolta nell’esistenza per negare ogni possibilità di salvezza.
Salvezza nemmeno eccessivamente implicita in immagini certamente non usuali, per nulla conformi ai quotidiani canoni, in grado di porre in essere uno spaesamento non sterile, non fine a se stesso, tale da indurre a riflettere.
Immagini come
“mia madre che ho generato
mi aiuta a partorire in
questa lunga giornata estiva”.
Silvia Ferrari Lilienau, saggio d’arte, "La coda del Surrealismo", con premessa di Mara Cini
Ecco da Silvia Ferrari Lilienau un’ analisi delle forme artistiche del contemporaneo che mette il “fruitore” sempre più al centro della “produzione” e lo porta ad essere, in parallelo, anche critico di un’espressività che si presume “la coda del surrealismo”.
Ma non si pensi ad un Bréton invecchiato intento a rileggere ingialliti cadavres exquis, piuttosto a tipi alla Tzara e alla Duchamp che sfidano il caso via web in una mescolanza di reale e virtuale teso a mantenere “qualche dubbio percettivo”.
…a meno che non ci si distacchi dalle parole, dai tableaux e finanche dalla terra fino a credere nel vuoto, come l’insuperato Philippe Petit, surreale nel suo funambolismo vero (lui sì che prende per la coda - per la corda- l’arte).
Si provi a pensare all’arte tra l’inizio del Novecento e oggi come a una bilancia, i cui piatti in origine contrapposti tendano a una posizione di equilibrio solo temporaneo. Si immagini che sul piatto più alto sia collocato un generico concetto di arte, sul più basso un’idea altrettanto generica di vita.
Nell’osservare il mondo per riprodurlo, prima del Novecento l’arte si è sempre tenuta a debita distanza, come per meglio mettere a fuoco l’oggetto del suo desiderio. I confini dell’una e dell’altra erano stati fin lì piuttosto chiari, benché pare che il virtuosismo pittorico di Zeusi già anticamente avesse insinuato qualche dubbio percettivo.
Sono state le avanguardie storiche a favorire il progressivo livellamento dei bracci della bilancia, specie il Dadaismo, che all’imitazione del vero ne sostituiva l’introduzione diretta entro i margini dell’artificio, confondendo l’uno con l’altro, attribuendo anzi ai campioni prelevati dal quotidiano un coefficiente artistico che eludeva il tramite artigianale, e si connetteva direttamente alla sottigliezza dell’ideazione.
La successiva spinta discendente dell’arte verso la vita è stata determinata dal Pop, e dalla traduzione in arte del quotidiano massificato. Da lì la vita ha preso a fluire nello spazio artistico attraverso filtri sempre più esili, nonostante la strumentazione si sia fatta via via più sofisticata.
Superati gli esiti di partecipazione collettiva degli happening, e di sollecitazione visiva pubblica del graffitismo e della street art, l’identità tra quei concetti di arte e vita inizialmente assunti ha incominciato a circoscriversi entro margini autoreferenziali, per le mutate modalità conoscitive dell’osservatore.
Lo sguardo sovreccitato dalla multimedialità di ampio consumo raramente può ora rallentare per la contemplazione di opere isolate. Abituato allo spostamento rapido sullo schermo, sulla superficie di connessioni orizzontali che non rallentano mai, esso attinge alla pluralità di informazioni per selezionare quanto gli è più consono: il consumatore preleva e riconduce a sé.
La dimestichezza con le diffuse tecnologie ha anzi generato una frequente autonomia di impiego negli utenti, che si sono esercitati a produrre per sé emulando in tono minore le modalità operative degli artisti professionisti, ma appunto esautorandone la lezione, grazie alla presunta auctoritas conferita loro da una perizia tecnica di facile accesso.
I piatti della bilancia, dopo essersi brevemente sfiorati tendono allora al ripristino dello squilibrio iniziale, benché invertito, il concetto di vita proiettato verso l’alto, l’idea di arte diretta verso il basso.
Questo perché l’arte, che già aveva variamente deviato dal manufatto, ha infine deviato anche dall’artista per accomodarsi in grembo al nuovo spettatore, al quale si offre come occasione di autocoscienza. Obiettivo perseguito ispirandosi a certo spontaneismo creativo, che l’ampio successo ha ormai imposto come fenomeno di rilevanza sociologica, se non culturale.
I prodotti amatoriali per lo più assemblano tre ingredienti: immagini riprese con video o fotocamere, musica concepita come colonna sonora del filmato, diffusione dell’elaborato a un pubblico ampio e indistinto, specie tramite siti web. In tal caso, ricetta e applicazioni dipendono interamente dal gusto degli autori, gli spettatori si limitano a obliare o scegliere.
Anche nell’intervento artistico invece fondato si ripropongono due fattori del video dilettantistico: ambientazione e musica, resi imprescindibili dalla familiarità con i non luoghi individuati da Marc Augé, gli spazi anonimi come centri commerciali o aeroporti, in cui si transita per il solo completamento di un’operazione. Qui la variante consiste, però, nella partecipazione imprevedibile di un pubblico attivo.
L’autore – sia egli architetto o artista – concepisce ora la sua realizzazione come una sorta di videogioco animato dai fruitori, la cui coscienza del ruolo e dei modi incide sulla qualità dell’esito, ma senza la quale il risultato apparente permane, purché i fruitori si rendano anche solo istintivamente disponibili agli stimoli offerti.
Lo spettatore è impiegato dall’artista, non in senso didattico ma, con una punta di cinismo, per garantire animazione all’opera. Se la disponibilità è piena, l’opera ingloba lo spettatore nella sua interezza psicofisica, altrimenti riecheggia e conferma – solo variandone il tono – comuni riti quotidiani scanditi da muzak di sottofondo.
Esempio significativo è il centro di design Stilwerk recentemente realizzato da Jean Nouvel sul canale del Danubio, a Vienna: chi si sposta al suo interno può associare i tracciati prestabiliti alla visione di installazioni pensili di Pipilotti Rist, in competizione con il cielo; oppure – immerso nella musica filodiffusa e nei suoi circuiti mentali – limitarsi a salire e scendere le scale mobili, acquistare oggetti d’arredamento, sedere al ristorante. Senza pedine mobili al suo interno, il luogo ricorderebbe un flipper spento; il flipper si anima se le biglie rotolano, diventa un gioco quando esse reagiscono ai colpi variati delle alette.
Il valore dell’opera è dunque duplice: in superficie, esso consiste nell’installazione, effimera o permanente a seconda che si tratti di un allestimento di sapore scenografico o di un’architettura abitabile; a un livello più profondo, non propriamente quantificabile, corrisponde alla ridefinizione dell’orientamento fisico, emotivo e intellettuale degli spettatori implicati.
Sembra si possa ora parlare di un’arte bifocale, che è di assestamento del dato sulla distanza assunta dallo spettatore: impossibile ottenere un risultato univoco, il rischio è anzi l’accumularsi di momenti mai aggregativi, e la legittimazione anche di psicologismi di maniera: la musica che ascolto si coniuga alle immagini che in quel momento affollano la mia mente, ai gesti che compio; sono in una soggettiva cinematografica, conduco un monologo interiore in un set connotato in senso artistico.
Ci staremmo così confrontando con un’appendice postmoderna del Surrealismo, che sostituisce all’inconscio dell’artista il passo interiore del pubblico: l’arte attuale corrisponde forse a un esperimento di reinterpretazione di sé in segmenti di esistenza parallela, conferma e amplificazione dei frammenti autobiografici sparsi nella globalità delle realtà virtuali.
Kiki Franceschi, opere visive da "Décodages", con una nota dell’Autrice
Kiki Franceschi, note di poetica
Una lingua che re-inventa i segni intende accogliere la totalità del mondo, di quel mondo Enciclopedia sognato da Borges che è parte della grande Biblioteca dell’universo i cui libri sono la moltitudine dei mondi.
La vita del cosmo ci appartiene. E’ là che terra e cielo s’incontrano e cifre ritmi alfabeti quadrati magici, qualità delle cose destini degli uomini poteri degli astri dei pianeti degli dei chissà, s’intersecano e s’incontrano.
Ed è allora che sogno che gli abitanti del mondo non sono gli uomini ma le potenze stellari, dominate dal numero perfetto ed è allora che rifletto che il mito della caduta originale, causa della decadenza e del buio contro la luce, significano che il cosmo è ordinato e giusto mentre l’uomo è transeunte, disperato e triste. Ed è’ allora che mi sento un William Blake, eroico e folle e giusto.
La letteratura iconico- linguistica è un genere a sé nell’ambito sia letterario che grafico. E’ un genere che esiste dall’inizio della storia della scrittura che nasce come pittogramma, come traduzione visiva di un pensiero e di un’emozione. E permane anche dopo l’accettazione unanime della convenzione alfabetica. Se si va oltre il confine stretto della letteratura e dell’arte si entra nel campo libero del gioco,della magia e dell’artificio. I carmi figurati ad esempio combinano in una figura voluta le lettere alfabetiche, incrociano parole, gli acrostici e i calligrammi avviluppano le lettere discorrono il percorso diretto della trascrizione ordinaria, solleticano la curiosità, danno una spruzzata di magia alla pagina che li contiene. Voltaire sosteneva che la Scrittura è Pittura della voce.
Acrostici,anagrammi, forme delle lettere dell’alfabeto, palindromi e calligrammi sono assunti anche dalle pratiche magiche, si ritrovano nel pitagorismo, nel neoplatonismo, nella Cabala ebraica, nei tecnopegna medievali, nel Simbolismo di Apollinaire, nel Dadaismo, nel Lettrismo e nell’Inismo. Nelle più recenti correnti artistiche i segni alfabetici riproducono alfabeti fantastici che non rispondono a nessuna lingua naturale, sono pure invenzioni da osservare con gusto, come gli alfabeti di Paul Klee.
Far poesia oggi, dopo le esperienze delle avanguardie storiche di oltre un secolo, dai Simbolisti ai formalisti, ai Futuristi, ai poeti visivi, concreti e sonori significa cambiare il senso delle parole di sempre, come sosteneva G.Apollinaire, fare una rivolta contro la lacrima scritta
Il poeta obbedisce al proprio ritmo personale, usa un verso libero che fa parte di una lunga tradizione poetica: già lo usavano i poeti greci melici e Dryden, e Blake e Milton e prima ancora Chaucer.
Scriveva un grande poeta Dylan Thomas:”La poesia dovrebbe agire dalle parole, dalla sostanza delle parole e dal ritmo delle parole uniti insieme, non verso le parole.” Nella poesia contemporanea, c’è velocità,ci sono immagini, stacchi, dissolvenze, fotogrammi. La descrizione segue il processo del pensiero, è registrazione in atto, rappresentazione simultanea, va al di qua e al di là della parola. Ecco perché Breton arricchiva i testi di collages e rebus, alfabeti antichi e inventati, per lui la poesia era gesto, superscrittura invenzione, astrazione. Tout le reste est letterature aveva scritto Verlaine.
Francesco Bellomi, musica, Handbook of nothing (04)
Guido Caserza, da “Priscilla”, Oèdipus 2009, nota critica di Rosa Pierno
**
Al primo passo sei un manichino
senza ombra, un vestito di seta appeso fuori
dei miei occhi di madreperla: amore,
che interminabilmente ripeti te stessa, donna
che nasci dagli angoli della mia bocca, vecchia
stanca che appendi logori vestiti alle corde
del cielo, guarda: al tuo primo passo
la mia lingua è una vecchissima parola.
**
Il secondo passo, se nessun occhio
ti avesse visto, tu lo staresti ancora compiendo,
un usignolo beccherebbe indifferente la mollica
dei tuoi seni, avresti le ali
ma di duro diaspro,
accenderesti il fuoco ma senza bruciare,
le mosche si poserebbero sui tuoi occhi
di medusa e io non ti avrei mai amato.
**
Il quarto passo lo compi su una delicata
tovaglia di lino: incominciano gli amori
fra le meduse e tu cammini leggera
sugli occhi. Non ti sei ancora
staccata dalla mia ombra e sui calici
fai tintinnare i cucchiai del nostro amore.
C’è un diamante sotto la tua lingua
e tu sei così bella, ma che follia pensarti eterna.
**
Al settimo passo giaci distesa nel ventre
di una macchina e i tuoi occhi mi guardano, appesi
fuori della porta. Hai acceso i fanali
per illuminare le meduse a filo dell’acqua: quando
torneranno a riva ci saremo già detti addio
e le nostre spore, ancora una volta, si apriranno.
Nel vortice mnemonico/immaginativo che Guido Caserza innesca sulle pagine del suo “Priscilla”, l’amore non è un pretesto, è la condizione sine qua non dell’esperienza esistenziale. E’ in questo cilindro esplorativo/sperimentale che egli visualizza la vita con i suoi cicli, il rapporto della mente con il corpo, gli stati del proprio essere. Da cui non sono escluse le conoscenze scientifiche e filosofiche chiamate in aiuto non tanto per classificare, quanto per rendere più complessa e aderente al reale la lettura. Amore partecipa ai cicli vitali della natura: “nella mia mano ti cibi di mosche, mentre tra le fiamme / anche oggi un uccello disputa il tuo verme”. L’esperimento riuscirà quante più variabili potranno prendersi in considerazione e viene condotto scrivendo poesie: “e mentre mordevo / la bianca cera del tuo seno tu / piangevi cenere / ed ingannato io ti ingannavo”. Pertanto, falsificazione, incertezza non risolvibile, credenza, fede, dubbio, immaginazione, creazione sono sovrani nel gioco in cui l’amore non è mai riducibile ai due corpi che si uniscono, dove anzi persino i corpi sono eliminabili, dove il gioco può essere giocato anche dalle sole capacità mentali: “Priscilla, ciò che voglio dirti / è che tu non esisti, anche se esiste / il mio amore per te”. Senza, inoltre, lasciare fuori, anzi rappresentandolo con grande forza e veemenza, il sesso, e la rappresentazione virtuale dei corpi, le apparenze o gli inganni, e persino la fine, la quale non giunge a termine finché è pensata. Che sia pura creazione, l’amore, è esemplificato dalla sezione “Cornici scespiriane”, ove esso viene ricreato a partire dalla suggestione di una lettura, in cui, ancora, il tempo non è che un’illazione, una vuota scatola da riempire con la determinazione del sé, restituito dalla donna amata, e che è insieme esperienza dell’amore ed esperienza della scrittura poetica.
Roberto Ceccarini, inediti da "Tecniche di spaesamento", con una nota di Giorgio Bonacini
**
ci vestiamo con i panni degli altri, perduti nelle strade
degli altri. tra case anonime e bianche. a cercare un vincolo
un luogo della terra, un qualcosa da assomigliare
non per qualche muta libertà, per qualche piazza Tienanmen...
**
a volte sembriamo voler galleggiare,
muoviamo la testa come pendoli.
altre volte qualcuno trapassa,
qualcun altro nella mischia
getta un salvagente.
non so bene spiegarvi cosa
passa cosa resta...qui, di tanto intanto,
s’incontra un silenzio di luce
o qualcuno che tacitamente annega.
**
c’è una tregua segreta tra noi e loro
un parlottare trafelato quasi in punta di lingua,
un raccontarsi fitto di tutte le Guantanamo
che conosciamo e che ci hanno attraversato
come un odore scabroso e lentissimo di paura.
c’è un affidarsi comune a cose mai viste
un confondere le acque, un accartocciarsi
negli spazi degli altri e starsene all’aria
nutrirsi di lingue sconosciute, di terre
selvaggiamente spregiudicate.
siamo forse in cerca
di una colpa taciturna e lontana?
**
se vengono le parole
lasciale
cadere nelle mani
purché tutto appaia
dopo il volo
il lampo generato
dopo il calvario
i suoni delle cornamuse
non faremo altro che ascoltare
lo sfregarsi delle divise
i buchi dove guarderemo
saranno i nostri occhi
qui dove si cerca un battesimo
e ritrovarsi
è un domani che volevamo.
“Ci vestiamo con i panni degli altri”, con queste parole inizia la raccolta di Ceccarini e ci accoglie subito, con semplice linearità, l’ambivalenza del soggetto parlante: un io plurale che è parte del poeta e parte di coloro di cui parla. Ma questi sperduti, soggetti a vagare in un mondo non loro, in cerca di un luogo proprio, non sono anche ciò che la poesia ha quasi in obbligo nel suo scavo verso una conoscenza altra? Assistiamo allora a una fusione tra chi dice e ciò che dice, non per un’ingenua e trasfigurata auto-rappresentazione di un sentire esistenziale, ma proprio per la precisa posizione dello sguardo che va ad ancorarsi, con una lingua che respira e dà fiato e con una tensione umana di comprensione etica, alle vite che provano a sopravvivere. Fondamentale è l’immersione nell’ascolto di voci collettive, nella visione di figure spaesate per le quali, talmente tanto è l’abbandono, che diventa improprio anche il tragico. Più vicina a loro è la rappresentazione interiore di un dolore dentro “un silenzio di luce”, dove è possibile incontrare “qualcuno che tacitamente annega”. Un patimento estremo nel mutismo di chi non ho più parole, o sa che le sue non contano. Ecco, Ceccarini sa unire l’intimità della lirica con l’esteriorità di una poesia civile, attraverso una sensibilità speciale nell’uso della parola. E proprio perché la sua è una voce che si lega a una reale umanità di disperazione, tiene saldo l’andamento dei versi. C’è, la lucida consapevolezza di attraversare un deserto brulicante, una contraddizione che ferisce, con un sentimento di commozione che si raffigura in chi deve rischiare tutto per avere anche una minima possibilità di esistenza: anche bisbigliata, anche balbettata o solamente e marginalmente in “un brusio da quasi niente”.
E’ una scrittura avvolgente quella che si dipana in questi testi; una scrittura apparentemente piana, ma emotivamente carica di lampi che rischiarano per un attimo la solitudine di chi trova il proprio percorso – la proprio bussola – non in una seppur limitata precisione, ma in un turbinio; un movimento continuo – una bufera – , un’impossibilità di fermarsi che non da tregua. Ma l’autore è poeta che non registra semplicemente uomini ed eventi in processo di negazione del loro essere, ma attraverso la concretezza, il fare della poesia, costruisce il formarsi degli accadimenti con una leggerezza dolente, intrisa di infelicità, in cui però trova ugualmente spazio l’idea di un grande amore che si intuisce non solo nel sentire la grandezza del cuore, ma anche osservando “i processi della mente”, per credere ancora a una bellezza, anche piccola, anche trasandata, ma con “innocenza strepitosa”. E ancora di più va a fondo, con un’esplorazione empatica, la sua capacità di sintesi generativa, nel passare da un immagine quasi di allucinazione, di miraggio delle cose vere (l’insegna di un bar o un aereo ad esempio) che abbagliano quasi a profanare il cielo, alla folgorazione del lampo che nasce “dal calvario”: cioè dalla più personale sofferenza alla sua resa collettiva e universale. E dove tutto sembra ormai morto e sterile, e i patimenti rinsecchiti, c’è ancora forse una possibilità: un’utopia che viene dalle parole lasciate “cadere nelle mani”, un barlume nel precipizio di “un’altezza inutile” che sia possibile, prima che l’autunno si cementi dentro, dettare “un altro tempo”.
Roberto Bugliani, inediti da "Versi scortesi", con una nota di Giorgio Bonacini
Invece
La piazza è il luogo di nascita della democrazia, che per sua natura è partecipativa. In questo caso la partecipazione è data dal numero attivo. La democrazia rappresentativa è la forma politica mediata che subentra al numero attivo quando il sistema di rappresentanza provvede a trasformare la partecipazione popolare diretta in numero passivo e avoca a sé ogni legittimità.
Invece qui stoppati dalla nebbia non si scorge nemmeno l’ombra d’una guida o d’un passante caritatevole che ci soccorra indicando come da programma il percorso, il fiume infido per mulinelli d’inganni fa la sua parte siamo noi che incerti al bivio invano invochiamo misericordia di cartelli con località e distanze, per cui la strada da prendere ci appare ignota e oscura, e dubbioso il cammino disabituati da sempre ai rischi, alle rotte senza mappe, agli intralci imprevisti, né altro è dato all’insicuro passo che un viatico di inciampi e di sconcerti al tramonto inciso sui nostri volti d’ovatta, miserevoli ostaggi del sospetto che la strada possa avere una fine senza fine, un alt quando meno te l’aspetti. da Occasioni per tutti i gusti Senza titolo L’incellofanata vanagloria del dettato che il dettaglio agghinda a esclusivo beneficio degli addetti, quasi fosse il così-è del mondo, macerie comprese e il resto, tutto, viene in seguito come segugio dietro i passi del padrone come simmetria di rapporti causa-effetto come se la linea di volo fosse a priori circoscritta come singolo fattore quando l’insieme è dato come enigma di tramonti intrisi di macaia come questi versi a surrogato del vento. Si dice comunemente che la letteratura non cambia il mondo, e, in senso materiale, forse è vero, ma con la scrittura poetica c’è una possibilità in più, se si vuole, di considerare le violenze, le iniquità, le ipocrisie, le volgarità del luogo e del tempo in cui viviamo, sgretolandone in senso ideale i presupposti. Perché in poesia l’oggetto materiale esistente viene interiorizzato e ridefinito in forme e sostanze diverse, che possono non solo dire, ma forse fare (o far fare) qualcosa. Ciò non significa che la presa sul reale da parte della poesia sia dirompente, e di questo Bugliani è ben consapevole in quanto, come egli dichiara, “la vita nella sua contingenza quotidiana non ha giurisdizione nel verso che è, quando va bene, verità mediata.” Questo però non impedisce al poeta, quando decide di accettare la sfida con un pensiero che si opponga a una realtà obbligata e menzognera, di tentare l’opera usando una scrittura come uno strumento di antagonismo. E queste poesie sono un lucido esempio di partecipazione e contrapposizione etica a certo deleterio uso del mondo e anche di certa poesia, secondo l’autore, chiusa a contemplare se stessa. Infatti in questi testi, oltre a una voce di indignazione e di invettiva contro tutti coloro la cui ideologia dominante è fonte di sofferenza per coloro che il potere reprime e deprime, c’è un occhio di critica particolare per certa poesia lirica che tanto ha avuto e ha corso. E per questo Bugliani cita Rimbaud, per il suo smarcamento dall’io (Je est un autre) e Hölderlin a proposito dell’ impoetico che diviene poetico. Infatti nei testi di questa raccolta, l’andamento del discorso contiene sempre in sé una riflessione sul referente esterno e l’autoriflessione che la scrittura opera sul suo programma significativo e formale. E in quest’opera la dichiarazione di poetica è altamente esplicita e diffusa: la poesia deve stringere d’assedio la realtà, interpretandola non con languida, seppur bella e significante, fonìa, ma come se lavorasse nell’officina dell’essere e del mondo con precisa e personale idea e ferma volontà di cambiamento. Chi fa poesia deve rilevare l’impoetico e usarlo, anche con un po’ di ironia, ma con sguardo sempre attento, “nell’attesa che il testo faccia il gioco” e non viceversa, a far sì che il poeta (uomo immerso senza distacco alcuno in questa realtà corrotta), sia lui a proporre e a dire, e non a subire il propositivo e il detto potendo solo una reazione indotta.
Viviana Scarinci, un inedito, “genius loci (nullus locus sine genio)”, nota critica di Marco Furia
ascolta l’orizzonte dissimula lo slancio
che sbalza ricordo e premonizione
in superfici che si guardano appena
nebbie fanno albe fittizie
separata la memoria di ciò che resta da accadere
il vuoto torna suffragi:
che torni in un soffio
pure che niente lo immagini
lo chieda, lo ami
che torni niente dopo niente
e che si veda che cambi
che chiami che pianga soltanto una volta e poi
cresca a scoppiare cicala
a sparire formica
nella curva di un gorgo
a morire il soma
così non esiste dimenticarsi
rimane fin quando anche il luogo
sparisce l’oscillazione nel plesso di un bacio
e abitato articola fusi inquieti
una piccola talpa dissoda volumi di memorie
mentre mi porta il capo tra le mani
schienata la falsa riga dell’orizzonte
non saputa non vista affatto la forma dove confitto l’abbaglio
accostata e compulsa una sorta di catalessi sformava il buio
linee da presso sostenute le spalle, cunei inanimati, vincibili
eretti a sfondo, non siamo che giaciuti, questi corpi di mattino lieve
(inerpicata l’addizione i conati l’immobilità degli atti tristi le parole quiescenti le
empie le infrante i frantumi annidati la bocca spenta)
mima minacce non compreso, il presente, mima gridando tutti giorni solitudini
permeate a tutti gli oli, grida il lascito della sua convulsione fratta di segni canori,
grida i fiati sconnessi che fanno la pelle meno conosciuta
“piccola talpa, abbandona il mio quarto azzurro dividi l’osso che tralcio mentiva
d’esserci dopo che mai dopo che sempre c’ero stata un niente, l’inventario dei silenzi
le cose diradate spente. aperte, ci sono stanze,
il corpo apprende solo
l’istante che scaglia a ritroso il sangue
sulla soglia delle intenzioni”
in quel modo accorto di non amare, io pure non ho amato
sordo come a una fitta continua
il cielo rapprende in una stringa lunga una sola luce
lì tempra una forza amara
senza notte, un risvolto di fattezze inavvertite
una flagranza che non lascia
Con “Genius Loci”, Viviana Scarinci presenta una poesia in cui immagini, suoni, colori, paiono nello stesso tempo separati e fusi in àmbiti esistenziali accennati per via di profili linguistici davvero persistenti.
Dico “separati e fusi”, perché il tema dell’aspetto, della fisionomia, mi pare ben presente in una versificazione capace di soffermarsi, intensamente, sulla parte per alludere a un tutto che, secondo la poetessa, può essere detto soltanto così.
Un dire in cui la memoria svolge un importante ruolo: se gli uomini fossero privi di memoria, concetti come quelli di passato, presente, futuro, non avrebbero senso alcuno.
Ecco, dunque, l’importanza del ricordo quale elemento fondante della stessa idea di tempo, perciò del nostro stesso vivere.
Quella “piccola talpa” che “dissoda volumi di memorie”, insomma, richiama la nostra maniera di stare al mondo per via di un’immagine che sembra essere, nel contempo, prodotta da e produttrice di poesia, ossia indissolubile unione di segno e senso, di lingua e vita.
Occorre aprirsi nei confronti di qualunque aspetto, occorre rendersi disponibili al fascino dell’inedito non con l’arrogante intento di abbandonare gli usuali schemi, ma con l’attenta operosità di chi si sforza di illuminarli dall’interno per renderli maggiormente espressivi.
Questa poesia, insomma, ci invita a una migliore comprensione della nostra esistenza.
Ultima pagina, poesia visiva di John Giorno

Dicembre 2011, anno VIII, numero 15

Questo numero di “Carte nel Vento” è interamente dedicato al convegno Parola per parola, recentemente promosso da “Anterem” e dalla Biblioteca Civica di Verona, in occasione dei 25 anni del Premio Lorenzo Montano.
Per consentire una lettura ottimale, dato l’elevato numero di contenuti, uscirà frazionato in due parti. Nella prima, oltre al ricordo di Adriano Spatola, trovano spazio i testi commentati dei vincitori del 25° “Montano”: Paolo Donini, Mariangela Guàtteri, Giovanni Infelìse, Tiziano Salari. Questa proposta è l’ideale premessa alla nuova edizione del Premio, di cui è possibile scaricare il bando.
Omaggio ad Adriano Spatola 1: una testimonianza di Giulia Niccolai
Parola per Parola
Convegno internazionale di poesia organizzato
da Anterem e dalla Biblioteca Civica di Verona
Anteprima
La sera dell’11 novembre 2011, alla Biblioteca Civica di Verona, è stato organizzato dalla rivista “Anterem” e da Agostino Contò, un incontro per gli ipotetici settant’anni di Adriano Spatola, poeta, performer, critico e grande animatore della scena artistica dagli anni Sessanta fino alla sua morte nell’88. L’evento era coordinato da Flavio Ermini e Ranieri Teti.
Erano presenti cinque poeti fonetici, pubblicati nelle cassette dirette da Spatola per le edizioni di poesia sonora Baobab, di Reggio Emilia: Gian Paolo Roffi, Massimo Mori, Stefano Guglielmin, Mauro Dal Fior e Nicola Frangione e ciò che – secondo me – ha reso la serata estremamente piacevole, interessante e diversificata, sono state la grande spontaneità e naturalezza degli artisti anche nei momenti di stallo quando non funzionava questo o quello (registratore, microfono, luci ecc.) perché nessuno dei poeti è mai stato anche un tecnico esperto, e anzi, come ha fatto notare Mori, queste insicurezze, dimenticanze o gaffes organizzative fanno parte integrante della performance poetica: vivaddio!
Ma soprattutto è stato toccante e profondamente convincente l’intervento di ognuno: la voce di Roffi che accompagnava il CD registrato con Spatola (pochi mesi prima della sua morte), nel testo dal titolo Le pays natal, per la sua concentrazione e la sua partecipazione emotiva che l’ha trasformato in una specie di mantra o di preghiera, man mano che si snodavano i 7 minuti della durata del nastro.
La poesia di Spatola letta da Mori e poi da lui commentata o sottolineata dai brevi gemiti una sega che tenta di intagliare la barra di legno sulla quale la poesia è stata stampata. O gli splendidi movimenti del corpo di Mori, quasi al buio, che si muove con grazia e sicurezza nelle diverse posizioni del Tai Chi, con le mani infilate in guanti dai quali pendono, a ogni dito, lunghi listelli di carta scritta: le poesia, il testo come prolungamento delle mani e del corpo (della mente e dell’anima).
Stefano Guglielmin che legge una poesia giovanile di Adriano nella quale egli si interroga sulla vita, e una propria che si pone le stesse domande con lo stesso sconforto.
Mauro Dal Fior in una esilarante performance con una spatola, usata come racchetta e una pallina da ping pong che assieme producono diversi suoni, situazioni ed equilibri farseschi e che – come ha commentato Roffi – si identificava perfettamente con l’umorismo di Spatola.
Per finire, l’ottima interpretazione altamente drammatica ma al contempo comica di Nicola Frangione del testo di Adriano, La forbici sulla tavola , con le smorfie, le “a” allungate e sussurrate a bocca spalancata, i movimenti eccessivi, come di torsione e sofferenza di mente e corpo.
In una sala attigua Agostino Contò ha disposto in teche numerosi interessanti volumi - ormai d’antiquariato e introvabili - dalle Edizioni Geiger e Tam Tam di Spatola e dei suoi due fratelli, Maurizio e Tiziano, nonché testi del poeta usciti presso altri editori. E’ sfortunatamente mancata la presenza del fratello Maurizio che non è potuto venire per un’influenza.
Giulia Niccolai
Omaggio ad Adriano Spatola 2: l’apertura del convegno e la mostra nelle immagini di Sabrina Valentino
Carte nel vento n.15 - Galleria fotografica
Paolo Donini, da L’ablazione (La Vita Felice, 2010), con una nota di Rosa Pierno
La raccolta poetica di Paolo Donini “L’ablazione”, si presenta come un’investigazione effettuata tramite indizi, reperti, procedure, che spezzano e rendono problematico il flusso narrativo, sul ritrovamento di un oggetto che si situa in maniera indecidibile: esso è riferibile sia al campo dell’immanenza che a quello della trascendenza: “indizi / sparsi ad arte per credere e far credere / una morte sola, irrelata, a un presunto / capolinea della Storia, persino necessaria”. Al periodare vengono inflitti scarti di contesto continui: la vittima è definita sillaba, corpo battesimale, corpo alfabetico. E “in fondo / alla campagna si scorge delinearsi nettamente l’orizzonte del pensiero”. Tutto il reale coincide con il campo investigato, ma qui il linguaggio è strumento d’indagine e vittima al tempo stesso. Strumento intonso, ordinato nitido e al contempo lordo di sangue. Si colloca proprio fra oggetto reale e parola che lo nomina lo scarto, la ferita, quella che non può avere sutura. Anzi sarà proprio tale scarto a porsi come corpo del reato. In ogni caso in questo coesistenza di vittima e di carnefice, il linguaggio tende una trappola anche alla facoltà immaginativa, la quale è presa perennemente in questa oscillazione: “il tetto / di questa camera è trivellato, sta nel palmo / della mano la porzione di terreno edificabile / o lotto catastale al registro della tempia: un vano”. Mai sarà ripristinabile interezza, né individuabile origine, ma fra la realtà percepita e la realtà rappresentata linguisticamente, la scrittura poetica di Donini si accampa tessendo le maglie da cui restare a osservare il burrone sottostante: uno sconfinamento dall’uno all’altro dominio è possibile. Sconfinare si può. E proprio grazie al linguaggio. Rosa Pierno
***
Tu muori nel tuo simbolo, ti spezzi
nella bocca e cadi nella lingua deserta, il tuo
ciottolo riluce di lontano – a volte
in queste notti della specie, l’antico
osso sillabico risplende improvviso
sull’orizzonte basso, tra la fumea dei roghi:
l’anca della voce, il segno che tu ritorni, o disconosciuta,
e sei fra noi come un pane dato, sprecato nelle tetre fami – verrà
la peste che ti ha maculata, la febbre che arse
la fronte spianata del vocabolo, se ne andrà
la lebbra nell’acqua della fonte, il fango dagli orci,
la melma nel riso, il buio dalla fronte.
***
Sporgi nell’aria la testa tatuata, la faccia
tinta nel colore del silenzio, una guancia
azzurra, prima di sparire nel tuo prima – l’era
selvaggia del tuo dire ha sgocciolato sui sassi
il minio che ti annuncia: ti porta via
un nuovo nome macchiato sulla zona nevosa.
***
Hai sulla fronte il diadema dell’ablazione
quel lampo dietro te fratturato
da tutto il resto della vita, quel passo sbarrato
verso il giorno d’altri: tu vivi
protesa sul lembo, sfasato sempre un poco oltre
l’argine feriale, ovunque nei fossi, nei visi divenuti pazzi
fiorisce il tuo scandalo nella primavera in prosa della comunità.
Giovanni Infelìse, L’alfabeto sepolto, con una nota di Marco Furia
La cadenza infinita
Con “L’alfabeto sepolto”, Giovanni Infelíse presenta una sequenza di versi la cui vivida compostezza pone in essere affascinanti armonie prive d’inizio e fine.
Dove comincia l’arcobaleno? Dove finisce?
Si può soltanto prendere atto della sua rara, leggiadra, presenza.
Così, i versi del Nostro non iniziano, paiono seguenti ad altri, né finiscono, perché alludono ad altri che arriveranno.
Arriveranno o arrivano?
“Arriveranno” se ci fermiamo al punto, “arrivano” se immaginiamo una continuità ininterrotta.
Qualcosa induce a proseguire, a continuare: questo qualcosa è già poesia?
Sì e no.
No, se vogliamo restare legati al dato concreto, sì, se intendiamo non trascurare quel senso d’armonia che ci accompagna, che non ci abbandona.
Come la vita, la poesia può essere, certo, misurata, ma siffatta misura coglie soltanto
alcuni dei suoi infiniti aspetti: il poeta, mostrando certe inedite fattezze, apre immensi spazi in cui ogni individuo, anche se non scrive versi, può riconoscere se stesso e i suoi simili raggiungendo maggiori consapevolezze.
L’umana esistenza incontra limiti temporali, ma, quanto a profondità, a intensità, il campo è libero e immenso.
Giovanni, con pregnante compostezza, ci invita a esplorarne qualche parte secondo cadenze semplici eppure complesse, sempre memori di un “alfabeto sepolto” che spetta al poeta, come a chi lo ascolta, disseppellire con quella cosciente assiduità capace di non cadere mai nel solipsismo o, peggio, nell’arroganza.
Il buon poeta, insomma, è la sua lingua, ma anche quella di tutti. Marco Furia
L’alfabeto sepolto
Dividere in segni
le dune del corpo
sempiterne lune
a privarsi
di un carattere
a esibirsi affisse
a un sipario
a un colore
disabitato
a un inquieto
geroglifico
della mente
al suolo
di un buio immortale
alla traiettoria
di un volo
trafitto da mute lingue
da un eccesso
di sonorità
selvagge
dall’aria
di contrade malsane
dalle mani
avverse
di chi cadde dalla forca
senza l’abito
del proscritto
senza l’acredine
dello smemorato
sul cuore
che resta sedizioso
se resta
un insolubile dubbio
che una verità sia
a nutrire scritti e silenzi
da baciare al principio
lambendo
e disdegnando
il termine degli uni
e degli altri
fogli e fardelli
come fratelli
inchiodati al ventre
di una ballata
di un solitario
cane
di un’introvabile
coscienza
talvolta
di un legame
di un folle canto
che a spasso raschia
la terra aspra
umida di anime
– di chi era
la parola legata
all’oscenità
e alla bellezza
senza esistenza
né ombra?
Un desiderio di suoni
una prospettiva
e uno strumento
taglia figure
e concetti
di paese in paese
dominando luoghi senza
origine
un mare cifrato
di foglie
un pianto come
stecco
infisso in gola
parole
di una stanza eterna
ormai perduta
nell’insopportabile sete
d’amare.
L’eco ha un’infanzia
la solitudine l’età
di un destino antico
che piove polvere
dai righi accesi sui
lucernari
tra ferite e feritoie
oscure.
Una volta consumata
l’illusione
la morte
che commuove
porta con sé l’alfabeto
sepolto
le sue lettere
la sua quiete
il suo monito…
rem tene, verba sequentur
… lascito di una fine
che ha nello stillicidio
dell’acqua
l’eco di uno sguardo
recluso in una rambèrga
di incognite reali
che naviga
ormai naviga
senza rotta né brezza
né sillabe da intagliare
o dipingere sulla bocca
al termine del viaggio.
Mariangela Guàtteri, da Stati d’assedio, Anterem edizioni 2011
La premessa di Giorgio Bonacini
Incipit del libro “Stati d’assedio”
La postfazione di Federico Federici
Una nota critica di Paolo Donini su Mariangela Guàtteri
Energeia sull’asse d’assedio
postilla a Stati di assedio di Mariangela Guàtteri
In questo poemetto di Mariangela Guàtteri la voce poetica si declina lungo le assi di tre neurosi.
Il termine neurosi ha una valenza polifunzionale e complessa ma qui sostanzialmente sembra instaurare campi di forze, zone di tensione o frizione vibrante, crampi in cui la parola coagula e per intensificazione prende voce.
Il dettato poetico è visibilmente organizzato su uno standard, un pattern ripete in tre versioni la pratica di un’indagine modulare dal tratto pseudo-scientifico reiterata sui tre ambiti d’elezione: potere, piacere, dolore.
|
Potere |
[la detenzione di … |
Piacere |
[l’abbandono … |
Dolore |
[una linea … |
Questi tre ambiti paiono istituire gli stati dell’assedio.
E tuttavia la domanda iniziale nella prefazione di Giorgio Bonacini “Perché l’assedio?” lascia spazio a un’interrogazione consequenziale: chi o cosa è assediato?
*
La poetessa è anche performer e artista visiva, dedita a quello che definisce nomadismo mentale.
Prima ancora di leggere il testo occorre forse guardarlo, così come ascoltarlo nella lettura pubblica a viva voce è evento non accessorio ma rivelatore di coloriture interne e di emersioni nominali precise.
*
Il verticalismo della scrittura, organizzata sui pianali dei versicoli discendenti lungo la direttrice di lettura dall’alto in basso, allude come a un carotaggio, a una trivellazione in profondità.
La tri-partizione del lavoro lungo i tre stati d’elezione è scandita in progressione – dal primo al terzo – solo per la necessità tecnica della lettura progredente di pagina in pagina.

In realtà l’esito semantico-visivo di questa scrittura suggerisce un moto a elica.
I tre assi ruotano concettualmente fasciandosi a spirale
Non si tratta di tre steli discendenti in parallelo nella trivellazione conoscitiva ma dello sfaccettarsi di una spirale che si avvita in profondo, ruotando su se stessa, come la punta di un trapano.

La rotazione avviene a una velocità concettuale che lascia percepire il testo, ogni volta che ne mostra una faccia, come un corpo unico.
*
Il moto descritto dai tre assi avvitanti è quello dell’accerchiamento.
L’assedio è prodotto dal moto di avvitamento accerchiante dei tre stati.
In questo senso l’assedio è radicale.
Ovvero, come ogni assedio, è radicale in quanto circolare.
*
Domandiamo di nuovo: chi o cosa è assediato?
L’ipotesi che vogliamo argomentare è che assediato non sia qui un corpo, un essere, un’esperienza biografica ma l’asse centrale attorno a cui il testo si dispiega come moto accerchiante.
Restando poi da azzardare chi o cosa sia quell’asse centrale.
*
Il quarto asse, centrale, attorno a cui l’assedio si determina come avvitamento accerchiante dei tre stati disposti sulle facce del moto elicoidale, non è esplicitato nel corpo del testo.
I corpi testuali sono soltanto tre, e sono – intensificati entro i c(r)ampi di forza delle neurosi – gli stati dell’assedio, le facce ruotanti della vite potere-piacere-dolore.
Il quarto asse non partecipa della materia verbale e tuttavia la innesca e la regge.
Questo asse è un fenomeno pre-verbale: è l’energeia del testo.

L’energeia da cui il poema attinge il moto è la neurosi stessa nella sua fase non verbalizzata.
La neurosi, dichiarata nei tre stati, li precede come condizione pre-verbale in quanto fenomeno di frizione che produce l’energeia del testo, dispiegandolo come assedio.
Neurosi ed energeia sono due fasi dello stesso fenomeno silente (non verbalizzato).
La neurosi è la fase didascalica e funzionale dell’energeia che permane nell’indichiarato ma opera quale quarto asse attorno a cui (e grazie a cui) ruota l’avvitamento assediante.
Ad essere assediata è quindi l’energeia poematica del testo. La tensione dell’artista alla parola.
*
Merita un approfondimento la natura di questa energeia pre ed inter-testuale.
L’energeia muove (nell’accezione dantesca: move) la necessità del testo.
L’energeia si istituisce in asse portante in quanto necessità.
Il testo si dispiega dall’energeia necessaria.
L’aspetto a-lirico e pseudoscientifico di questo poemetto, reso nella centimetrata frammentazione versicolare, cela un motore rovente.
Il moto del testo è instaurato dall’energeia che mette l’assedio in rotazione concettuale.
L’energeia fa ruotare le tre neurosi descrivendo l’accerchiamento che la assedia.
Una simile forza compositiva, capace di dispiegare in atti verbali l’assedio che la chiude, non può che essere attinta dalla pura necessità. Da una necessità spietata.
La necessità coincide qui con l’urgenza essenziale in cui l’energeia si fonda.
*
C’è dunque un fenomeno che non partecipa degli atti verbali descritti dalle neurosi e non ne è preda dal momento in cui è esso stesso che li dispiega.
Eppure, dispiegandoli, comunica di esserne assediato.
Questo fenomeno, che abbiamo chiamato energeia, è il principio lirico di un testo programmaticamente a-lirico. La posizione pre-verbale dell’artista al lavoro.
Il lirismo del testo consiste in una fenomenologia della necessità di parola, inguainata nell’autocontrollo dell’assedio.
L’assedio è auto-posto e auto-validato dall’emergenza del testo ma se l’operazione poetica si limitasse a questa instaurazione saremmo in presenza di un corpo freddo, monumentale e concluso.
Invece il costrutto poematico vibra in moto grazie a un’energeia che non coincide con i suoi atti verbali perché mira a dispiegarli (per licenziarli).
Questa sconnessione segreta stacca dal testo l’afflato poetante e lo ribadisce come asse pre-verbale del poema.
Ad essere assediato, nella prova provata dei tre stati accerchianti, è l’afflato poetante che muove (move) il poema infondendolo di sé. Della sua necessità spietata.
Il testo verbalizzato è intriso di questa infusione necessaria.
A questo livello, l’assedio è crampo. Condizione come insostenibilità.
*
L’ascolto del testo nella lettura pubblica rivela l’emersione di lemmi dominanti, parole che emergono e si stagliano con forte e precisa impronta semantica.
[un luogo di preghiera]
alzami
[una punta per sbuzzare]
…
un inno
Ricorrono nel testo riferimenti cristiani:
Deus meus et omnis
…
Ogni giorno un rosario
Ogni giorno un digiuno
…
un’avventura di un peccato
compiuto in latitanza
…
La pratica del digiuno che polisce e avvalora il linguaggio salvato dalla chiacchiera è ribadita in nota.
A questo appello al lemmario religioso si alterna l’osservazione radente sull’irredenzione: l’immagine manzoniana della salma scempiata (un cadavere sformato), la registrazione unaria del montaggio pornografico, a tratti ingrandito sui particolari (singole parti, anche ingrandite); l’irriducibilità del dolore (uno stato in eterno ripetuto … un’intolleranza).
Questa oscillazione comunica l’assedio in quanto condizione in cui al più ricavare un luogo di preghiera, limitrofo all’orrore [la sepoltura di una testa]
Che altro sono questi aspetti – condizione e insostenibilità – se non le matrici traghettate e riadoperate del dualismo cristiano?
La prima neurosi – il potere – è l’accezione bieca, peccaminosa, degli altri stati assedianti; l’utilizzo modulare del pattern, nello standard conoscitivo, evidenzia la sostanziale identità consequenziale dei tre stati trattati e compilati nella tabella della ricerca.
Le tre neurosi concorrono a dimostrare l’insostenibilità.
L’assedio si acclara come condizione, aldiqua unario della materia.
L’indagine sull’irredenzione è necessariamente una porno-grafia.
Entro questo derma dell’assedio verbalizzato l’afflato poetico insiste come istanza orante di superamento.
Mantra incluso nella triplice guaina dell’irredenzione.
Il libretto contiene infilato nella sua elica l’osso smaterializzato di un residuale libro d’ore.
*
La valenza liturgica del poemetto si afferma in questo stadio centrale come fenomeno della preghiera in atto. Energeia orante entro la rotazione dell’assedio.
Al centro della triplice oralità del verbo – ripetiamo che la poetessa è anche performer e il testo appare nella sua completezza proprio nell’esecuzione orale – si colloca il fenomeno incluso di una orazione superante.
Questa preghiera va ascoltata nella risonanza interna della pre-verbalità, là dove l’artista è al lavoro, e si coglie pienamente nell’esecuzione orale.
La preghiera – orazione – è sempre orale e il poemetto è sensibilmente pensato (anche) per l’oralità.
La poesia a-lirica e pseudo-scientifica è avvitata al (dal) moto dell’orazione come energeia inginocchiata al centro dell’assedio.
La presenza di questo fenomeno orante emerge a tratti nelle zone scoperte del lemmario se non della citazione religiosi.
Ma soprattutto nella clausola dell’explicit a ognuna delle tre neurosi.
I moduli dell’indagine vengono sempre risolti dal verso:
e vince chi muore per primo
dove l’uscita dalla condizione in quanto insostenibilità è lapidaria: si vince morendo.
*
L’assedio nella sua radicalità esige come superamento la morte.
Ma la morte qui non coincide con la fine.
Questa morte non ha valore finitivo.
Dato che al centro del poema si sta svolgendo il fenomeno orante dell’energeia che muove (move) l’assedio ma non coincide con esso, il morire per primo non ha significato finitivo bensì (cristianamente) liberante.
A morire per primo è il principio che innalza il testo come prova provata del triplice assedio.
A morire per primo (in sé) è l’afflato orante dell’energeia che muore improntando di sé l’assedio, infondendolo fino a che, sospesa nel decesso puntiforme del suo rosario (del suo digiuno) dismette l’assedio stesso lasciandolo cadere nel verbo.
È l’energeia orante che pone l’assedio staccandosi al suo interno in quanto fenomeno senza rinuncia, mistica pre-verbale, flatus vocis che irradia la materia e sottraendosene la lascia cadere nel verbo, vince morendo, si libera.
*
E il lettore si porta via nella voce dell’artista questa salvezza inclusa.
23 e 24 novembre 2011 Paolo Donini
Tiziano Salari, Gioventù, con premessa di Mara Cini
Due pagine che alludono a una qualche formazione giovanile: una vicenda situata in una sorta di terra iperletterararia dove un autore/lettore lotta, fisicamente e psicologicamente, con stratificazioni di libri, situazioni, personaggi…
Il confronto, faticoso ma non spiacevole, sembra portare ad una condizione di “messa a nudo”, di solitudine, di sfasatura: il prezzo da pagare per far convivere il percorso della vita “esposta” e il percorso dei saperi più nascosti. Mara Cini
Tiziano Salari
GIOVENTÙ
To be, or not to be- levando la faccia alle raffiche di pioggia e rinchiuso dietro di me il cancello - that is the question, e poi proseguendo tutto inzuppato e incalzato alle spalle dal vento, se sia meglio per l’anima soffrire oltraggi di fortuna, intorno non un’anima viva, solo io e la mia rabbia, o prender l’armi contro burocrati e bottegai and by opposing end them? To die, to sleep; no more? Lungo la strada che scendeva al lago, dove si formavano rivoli d’acqua che i tombini non riuscivano ad assorbire, sguazzando nelle mie scarpe rotte, quasi diretto ad aprirmi un passaggio nel mare della pavidità universale Che imbecilli ve ne sono dappertutto, biechi, ottusi ed irsuti. Quelli. Mettevo in fila le carogne. Le abbattevo ad una ad una. Infine, di fronte allo scenario annuvolato, figgendo lo sguardo nell’atmosfera plumbea, dove si scorgevano appena le sagome oscure delle isolette, il morire, dormire, sognare forse, mi alitava nella mente l’onda ipnotica dell’intimismo e dell’asserragliamento.
Era un pomeriggio buio, nessun pescatore e nessuna barca sulle rive, nessuno solitario passeggiatore con l’ombrello,e neppure cani e gatti, ma laggiù, sotto la tettoia dell’imbarcadero, gente aspettava la corriera o forse solo si era riparata dalle sventagliate della pioggia. Possiedo, possiedo.Percorsi la scala buia nel fatiscente edificio della Fondazione. Così Edipo aveva assassinato il padre senza sapere che fosse suo padre e poi impalmato la madre, ma quello era il succo che da quell’evento aveva estratto Freud, mentre la lettura di Sofocle ti trascinava nella dimensione del tragico in quelle altezze dove si respira un’aria fine e gioiosa, pensavo alzando gli occhi socchiusi per cercare di calarmi a Tebe tra i supplicanti davanti alla reggia. Fernando mi aveva lasciato le chiavi di quello scrigno di tesori dove potevo andare a rifugiarmi ogni giorno e prendere tutti i libri tutto il sapere accostandomi a uno scaffale e poi aprire un volume sul lungo tavolo nella più assoluta solitudine per qualche ora del pomeriggio e finalmente avevo un rifugio che mi consentiva di vivere la mia doppia vita.
Il mio compito era lieve. La biblioteca apriva soltanto un paio d’ore la domenica mattina e rari erano i visitatori in quelle due ore che dovevo avere a che fare con gli scarsi lettori e anche quei pochi m’infastidivano, ma era il prezzo che dovevo pagare per tenere la chiave: assumere quel servizio domenicale dalle nove a mezzogiorno e segnare su un registro i libri che uscivano e rientravano.Avevo dunque uno spazio in cui raccogliermi e leggere e meditare e tenevo le imposte chiuse perché l’ambiente fosse ancora più nascosto e dentro, in quel pomeriggio tempestoso, vi ero io, come la perla in un guscio d’ostrica, ad esplorare la sapienza antica e moderna, che allora mi sembrava dovesse essere una questione di possesso. E pensavo inorgogliendomi: ho pronunciato il discorso di Antonio sul cadavere di Cesare e sollevato i romani contro Bruto e Cassio, sfidato Creonte insieme ad Antigone passeggiato per Parigi con Rastignac e Frédéric Moreau, mi sono esaltato con Zarathustra e passato con Dante attraverso inferno e paradiso: io possiedo tutto questo tutto questo è carne della mia carne sangue del mio sangue.
Mi tolsi la camicia strizzandola come uno straccio nel lavandino del bagno, rimanendo a torso nudo. E anche i calzoni avevano bisogno di quel trattamento, e me li sdossai per asciugarli, e così le scarpe, in cui le suole si erano alzate sul davanti come lingue di una bocca sdentata, e allineai tutto bene sul ripiano di un tavolo: camicia, calzoni, mutande, scarpe.Ero rimasto così, nudo, di fronte al sapere.Quando fui certo che i miei capelli non sgocciolavano più sulle pagine del libro, ripresi la lettura.Ed infallibilmente nasceva in me l’ansia.Non c’era dolcezza, non c’era pace, e non solo la mente, anche il mio corpo non era pacificato.Lasciai cadere un fuggevole sguardo sul mio sesso. Penna, quaderno.Ma nessuna parola mi soccorreva e neppure potevo invocare che qualcuno condividesse la mia solitudine.
Immobile, attesi che scoppiasse il tuono, dopo aver visto il lampo tracciare la sua spirale in uno spiraglio di cielo tra le persiane.Il boato fece tremare gli infissi e i libri negli scaffali. Oltre le parole doveva esserci la vita. Avevo di fronte a me i cinque tomi di cui ogni giorno leggevo venti pagine in ciascuno, e anche quel giorno tenni fede al mio proposito. Quando, all’ora di cena, mi rivestii con i panni ancora umidi, e mi affacciai al portone, il diluvio era terminato. Soffiava un venticello fresco e il sole era riuscito a trapassare la densa nuvolaglia e a irraggiare, tramontando, i picchi verdi dei monti. Mi avviai verso casa sulle strade ridotte a un pantano.
Una lettera del filosofo Renzo Lucca a Tiziano Salari su “Gioventù”
Grazie infinite per avermi inviato “Gioventù”.
È stupefacente pensare come poche righe possano suscitare nell’anima del
lettore emozioni così grandi. Fra le tante sollecitazioni, quella che più di
ogni altra mi colpisce leggendo le tue pagine, è la capacità del protagonista
di sospendere gli stimoli esterni, di spogliarsi di tutto ciò che è superfluo
(aphele panta) o di impedimento per accedere al mondo noetico, al mondo
intellegibile. Associazioni spontanee della mente mi risvegliano le poderose e
luminose solitudini di Eraclito e di Nietzsche, la tormentata irrequietudine e
l’accesa tendenza immaginifica di Giordano Bruno, la serena saggezza di Seneca
e di Spinoza, ecc.
Trovare in una piccola biblioteca la “cittadella interiore”, come luogo intimo
di raccoglimento, di concentrazione, di profonda elaborazione dei propri
phantasmata, rappresenta per me un chiaro messaggio che invita a vedere nella
cultura, nella costruzione logico–intellettuale, uno dei momenti più alti e
fecondi per realizzare la propria essenza di essere umani in quanto animal
rationale, zoon logon. Solitudine non come fuga dal mondo, ma come la più
grande strategia per aumentare la propria potenza di agire, per penetrare in
profondità, con l’intelletto, la realtà che appare ai nostri sensi solo come
superficie.
Inoltre, un'altro aspetto che trovo straordinario, e che mi fa pensare a un
capolavoro, è che nella ritrovata serenità gioiosa del protagonista si respira
fin dentro la pelle e nelle ossa, il senso tragico dell’esistenza.
È uno scritto che rileggerò periodicamente per ritrovare il senso profondo del
mio fare intorno al fascino e la bellezza della pratica filosofica.
Renzo Lucca
Il Concerto di chiusura: Programma di sala
BIBLIOTECA CIVICA DI VERONA
RIVISTA DI RICERCA LETTERARIA ANTEREM
CONSERVATORIO “F.A. BONPORTI” DI TRENTO E RIVA DEL GARDA
POESIA IN CONCERTO
S U O N O E P A R O L A
Musiche originali su testi poetici e filosofici
della rivista “Anterem” e dei vincitori del Premio Lorenzo Montano
a cura del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda
nell’ambito del Convegno internazionale di poesia
“Parola per Parola”
P R O G R A M M A D I S A L A
Biblioteca Civica di Verona, Spazio Nervi
Domenica 20 novembre 2011, ore 11.00
GLI INTENTI
Ogni dialogo è fecondo, creativo.
Soprattutto in fasi aride, appiattite dalla prepotenza di una cosalità che consuma e pretende consumazioni, quando la parola autentica sembra imprigionata e sostituita dalla chiacchiera presuntuosa e inconsistente, si avverte il bisogno profondo di un vocabolario alternativo.
Poesia e musica possono incontrarsi e riconoscere nel loro abbraccio dialogico l’energia generativa dell’inusitato.
Quanti compongono poesia e quanti compongono musica possono, come nel nostro progetto, sorprendersi reciprocamente e – per il regalo che nasce dal loro incontro – continuare a sorprendere il mondo.
Simonetta Bungaro, Direttore del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento
Il suono, la parola, l’ascolto. Nel suo accostarsi alla realtà delle cose, il compositore cerca di conferire al suono la proprietà esclusiva di provocare un insieme di reazioni: nelle cose stesse e in chi ascolta.
Quando tale gesto nasce dall’alleanza con il poeta, nel processo di formazione il suono giunge all’orecchio interno dell’interlocutore con credenziali molto allargate.
Quel suono non viene per dire qualcosa di concluso, ma per lasciar dire qualcosa a chi lo incontra.
In stretta connessione con la parola, quel suono si fa vicino all’essenza autentica di ciascuno, tanto da costituirsi come uno specchio dove ogni ascoltatore può andare a raccogliere frammenti di verità.
Flavio Ermini, Direttore della rivista di ricerca letteraria “Anterem”
IL PROGRAMMA
L’ablazione
per flauto, clarinetto, trombone, pianoforte, voce recitante
testo di Paolo Donini
musica di Raffaele De Giacometti
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto,
docente Mario Pagotto
PONGE POEM. Molto semplicemente l’orizzonte
per soprano, clarinetto, trombone, violino, pianoforte
testo di Francis Ponge
musica di Flavio Carlotti
Istituto Musicale Pareggiato “O. Vecchi - A. Tonelli” di Modena,
docente Antonio Giacometti
… lascito di una fine
per soprano, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte
testo di Giovanni Infelìse
musica di Fabio Conti
Conservatorio “F.A. Bonporti” di Riva del Garda,
docente Massimo Priori
Da “Stati d’assedio”
per soprano, chitarra, fisarmonica, violino, violoncello
testo di Mariangela Guàtteri
musica di Loris Sovernigo
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto,
docente Mario Pagotto
La pelle dell’anima
per flauto, chitarra, fisarmonica, violoncello. voce recitante
testo di Félix Duque
musica di Luca Borgonovi
Istituto Musicale Pareggiato “O. Vecchi - A. Tonelli” di Modena,
docente Antonio Giacometti
Gioventù
per pianoforte e voce recitante
testo di Tiziano Salari
improvvisazione jazz di Luca Poletti
Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento,
docente Roberto Cipelli
Improbabile dialogo
per flauto, trombone, violino, pianoforte, due voci recitanti
testo di Franco Rella
musica di Alessandro Fusaro, Valentina Massetti,
Raul Masu, Damiano Simoncelli
Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento,
docente Nicola Straffelini
Esecutori
Studenti del Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento e Riva del Garda
Flauto: Petra Arman, Luca Sozio
Clarinetto: Adriana Carrera, Daniel Rocha
Trombone: Davide Ventura
Chitarra: Errico Pavese
Violino: Mauro Mariño, Francesca Piazza
Violoncello: Giovanna Trentini
Fisarmonica: Fabio Conti
Pianoforte: Paolo Orlandi, Luca Poletti, Antonio Vicentini
Soprano: Erika Bonadiman, Elena Camocardi
Voce recitante: Raul Masu, Chiara Turrini
Direttore: Giovanni Giannini, Valentina Massetti,
Raul Masu, Mauro Marino
Recensioni di Marco Furia su Cara, Di Ambra, Gasparini Lagrange, Nakanishi, Tanabe
Marco Furia è redattore di "Anterem". Per la sua biobibliografia vedi "Chi siamo" nel sito.
Natsuyuki Nakanishi, La sorpresa dell’esserci
La sorpresa dell'esserci
Con "Back, White - edge VIII", Natsuyuki Nakanishi espone un articolato complesso di raffinate forme, differenti nell'aspetto e nel carattere cromatico, il cui elegante senso di movimento pare intimamente legato ad una nozione di staticità.
Dico nozione, perché il tratto cognitivo è tutt'altro che assente nel suddetto gioco di opposti.
Non siamo al cospetto, tuttavia, d'una sorta di mero ossimoro, bensì d'un vivido connettersi tramite cui l'artista riesce a far affiorare un delicato persistere.
Per nulla indotti a compiere il tentativo d'assegnare valenza di messaggio ai multiformi aspetti proposti, invitati ad osservare, sperimentiamo il contatto con una forma di vita in grado di mostrarsi davvero.
Una vita che dura, che continua, di cui non resta che prendere atto.
A questo ci chiama Nakanishi con la complessa articolazione d'un gesto artistico che non può tradire se stesso, poiché l'impulso creativo si colloca al di là del discorso logico senza possibilità di ritorno.
Occorre essere partecipi d'una dimensione di (estrema) purezza, tendente a coincidere con un ampio senso di libertà, per non concedere spazio al significato, per riuscire a percorrere non la via del logos, ma quella del semplice mostrarsi.
In queste delicate (tenaci) immagini noi non ci riflettiamo come in uno specchio, bensì andiamo alla ricerca di noi stessi, dopo avere scoperto la necessità d'un itinerario che sia in grado di restituirci ad un destino di rinascita.
Sotto tale profilo, "Back, White - edge VIII" può considerarsi raffinato (non sofisticato) invito ad una maggiore consapevolezza del nostro stare al mondo: è necessario compiere un cammino per arrivare ad essere ciò che già siamo.
Entrati in un territorio ritenuto inesplorato e poi scoperto nostro da sempre, ci sorprendiamo, così, nell'atto di risvegliare assopite energie.
Non oltre l'immagine, ma nell'immagine viviamo, in quelle forme prive di schemi logici e capaci di meravigliarci nell'offrire un'esistenza nel suo assiduo darsi.
Non superiamo, come l'indimenticabile Alice di Carroll, il confine d'uno specchio, ritroviamo invece in una cangiante superficie, anziché il riflesso di noi stessi, proprio noi stessi.
Siamo (anche) là, continuiamo ad esserci: questo deve pur dirci qualcosa.
Marco Furia
(Natsuyuki Nakanishi, "Back, White - edge VIII", 2007, olio su tela, esposto alla mostra "Isole mai trovate", Genova, Palazzo Ducale, 13 marzo - 13 giugno 2010)
Shin Tanabe, Vivide sequenze
Vivide sequenze
Con "INSCRIBED POEM", Shin Tanabe presenta sei immagini la cui elevata valenza estetica si manifesta sia nelle singole opere, sia nel loro progressivo succedersi.
Qualcosa, complice una pregnante raffinatezza, unisce le sei pagine che si susseguono secondo taciti, musicali, ritmi: il suono è anche figura, la figura è anche suono?
È possibile, sì.
Emergendo da uno sfondo scuro di cui sono enigmaticamente partecipi, le fisionomie di Tanabe tendono a raggiungere il primo piano e, perfino, in qualche modo, a superarlo: dal buio ad un chiaro sempre più brillante, per poi discendere verso un'ombra che non le risucchia, limitandosi a mostrarsi quale (muto?) àmbito.
Da notare, alla fine, alcuni lineamenti propri del quotidiano (un cerchio metallico, una pianta), tali da tradire il pensiero dell'artista: la sequenza, vivida, affascinante, comprende anche noi, il nostro stesso esistere, perché tra i molteplici aspetti del mondo non sono tracciati rigidi confini.
Una sorta d'iconica empatia è, dunque, il tratto essenziale di un atteggiamento poetico che non tende a trascendere uno stato di cose, bensì, con estrema eleganza, ad accettarlo.
Quanto al linguaggio, rimaniamo incantati di fronte ad una precisione di forme, ad un'esattezza, coincidente con il suo medesimo armonico movimento, ricca di una grazia per nulla fragile, anzi robusta, efficace.
Il gesto dell'artista ci proietta in dimensioni astratte nient'affatto aliene, profondamente nostre: riconoscerci in un'opera è riuscire a vedere meglio, ad illuminare parti del nostro essere rimaste in ombra, è, in ultima analisi, riflettere intensamente sulla nostra più intima natura.
Le immagini di "INSCRIBED POEM" attirano il nostro sguardo: osservarle con consapevole meraviglia ci arricchisce, ci rende capaci di attingere ad inaspettate riserve d'ulteriori energie, ci pone, in maniera inedita, in immediato contatto con noi stessi e con il mondo, provocando quei sentimenti di partecipe sensibilità che tendono a conciliare e ad unire, anziché a distinguere, a dividere.
Un'esperienza feconda, davvero.
Marco Furia
(Shin Tanabe, "INSCRIBED POEM", EDITIONS δ, Tokyo, 2010)
Marina Gasparini Lagrange, Aperti dedali
Aperti dedali
"Labirinto veneziano", di Marina Gasparini Lagrange, si presenta quale intensa scrittura in cui elementi tratti dal mito, nonché dalla storia dell'arte e della letteratura, incontrano propensioni poetiche in grado di metterne in evidenza i profili peculiarmente umani, rendendo il lettore partecipe di processi conoscitivi che non tendono a trarre conclusioni definitive, bensì a descrivere per cerchi concentrici, diffondendo atmosfere, sensazioni, emozioni, immagini.
Il titolo pare davvero appropriato: di labirinto veneziano senza dubbio qui si tratta.
Labirinto geografico, topografico, labirinto del tempo, dello spazio in senso lato, dell'anima?
Di tutto questo assieme.
Il lettore viene coinvolto in una condizione, in un destino dell'essere.
Sorge, allora, il quesito: se tutto è labirinto, nulla lo è?
Sì e no, pare la risposta corretta: non possiamo negare la sua presenza né la sua assenza.
Qualunque oggetto indica ciò che non è, pena non essere tale: distinguere significa identificare in una presenza un'implicita assenza o, meglio, il darsi d'entrambe.
Proprio da questa consapevolezza nasce la facoltà di descrivere la vita.
Descriverla in senso ampio, nei suoi aspetti fisici, anche minimi, nelle sue sensazioni ed emozioni, nelle sue idee, nei suoi pensieri: dedicarsi a descrivere l'esistenza è compito tanto affascinante quanto interminabile.
Autrice e personaggi si trovano assieme, distinti e nello stesso tempo uniti, nel dedalo d'una Venezia che, pur restando ostinatamente tale, è tutto il mondo.
Non sono soltanto casi d'empatia, si tratta, piuttosto, della capacità di lasciarsi chiamare in causa: più che identificarsi con Piranesi, Lotto, Brodskij ed altri, Marina permette agli elementi posti sulla pagina d'interagire il più liberamente possibile, di respirare.
Un respiro non monotono, ma intenso e multiforme, quasi volesse riferire delle differenti particelle d'aria inalate, delle diverse atmosfere in cui alterna le sue fasi, un respiro che, con lo stesso vario altalenante movimento, suggerisce come nessuna storia mai abbia inizio e fine, essendo la vita esposizione all'enigma.
Non è facile adoperare con tanta cura lo strumento linguistico fino a consumarlo e, consumandolo, anziché renderlo innocuo, consentirgli massima espressività.
Massima?
Nemmeno, perché il percorso aperto e circolare non consente l'uso di tale aggettivo nel suo significato più stretto: massima, tuttavia, nel senso che sembra essere stato raggiunto l'obiettivo di dispiegare, al meglio, certe (poetiche) capacità.
Se è vero che chi scrive si racconta soprattutto con le proprie opere, vi sarà un seguito, una prossima prova?
Di fronte ad una "perseveranza" intesa quale "altro modo di rivelarci a noi stessi", credo si possa bene sperare.
Marco Furia
(Marina Gasparini Lagrange, "Labirinto veneziano", Moretti & Vitali, 2009)
Domenico Cara, L’aiuto della poesia
Con "Le diagonali della psiche", Domenico Cara presenta un'intensa e complessa silloge la cui caratteristica precipua sembra quella d'essere sospesa tra natura, lingua ed emozione.
Natura, innanzi tutto:
"Gli olmi s'inalveano nello stile più tenero,
vegetale, dei sussurri quieti; recuperano
il conforto delle intese nella penombra,
e limitano il percorso dei loro allarmi".
Alberi, dunque, che non sono considerati quale riflesso dell'esistenza umana o, peggio, quale mera quinta scenografica, bensì vivono un divenire ricco ed articolato: il poeta dà loro voce ricorrendo ad immagini la cui peculiare valenza espressiva consiste proprio nel ritenerli esseri con piena dignità.
Entra, ovviamente, qui in gioco il problema del linguaggio.
Gli olmi non parlano ed è Domenico a farli parlare.
Responsabilità di cui egli è ben conscio e di cui si fa carico sino in fondo: la sua pronuncia chiara, priva di forzature, s'avvicina soltanto, poiché teme d'esaurire.
Per affrontare un argomento del genere non occorre soltanto una profonda sensibilità, ma anche la precisa intenzione di riuscire a dire, in maniera intensa, sfiorando con leggeri, ma decisi, tocchi.
Ne nasce un poetico essere assieme, in cui l'altro, nel caso la pianta, è in quella posizione d'assoluta parità che consente un rapporto in grado di superare il rispetto e lo scambio, per approdare all'empatia.
La lingua, si diceva.
"Poi, in pura estraneità, lasciò incauto
la casa, costruita per la sua quiete,
parola per parola"
L'idioma proprio, il più intimo, è una sorta di "casa" che ognuno costruisce "per la sua quiete, / parola per parola", una casa, tuttavia, che talvolta può essere utile abbandonare.
A quale scopo?
Allo scopo di aprirsi ad altri linguaggi in maniera da arricchire il proprio mondo, nella consapevolezza di come nulla vi sia d'assoluto ed ogni individuo abbia possibilità di decidere, di scegliere.
Lungi dall'essere segregati nei nostri schemi e paradigmi, possiamo ben comprenderne altri seguendo strade che nulla distruggono, ma anzi rendono sempre più ampio l'àmbito del nostro esistere: il prezzo da pagare, quello del disporsi all'ascolto e all'accoglimento, quello di comprendere che non stiamo, lungo siffatto percorso, perdendo qualcosa di noi stessi, ma che, al contrario, ci troviamo sulla via d'una maggiore conoscenza, il prezzo da pagare, certo, può talvolta essere alto e perfino, in casi estremi (ecco il perché di quell'aggettivo "incauto"), eccessivo.
La fiducia tuttavia non deve mancare, poiché le vie possono essere ardue, ma non pericolose: nulla impedisce di ricorrere, se necessario, ad una guida.
Una guida che può essere una persona fisica, uno scritto o anche soltanto un gesto, ma che non raggiungerà appieno i suoi scopi se verrà meno la parte più esposta di noi stessi, quella dell'emozione.
"Scendo tra lievi frammenti nel tuo nome,
dallo spazio più opaco della mia psiche,
per continuare una fiaba arcaica o diversa"
Continuare dunque, non procedere per strappi e lacerazioni.
Il dialogo è possibile, il ponte del discorso è gettato: sta a noi riconoscerlo e percorrerlo nel modo giusto.
L'emozione, se consapevole, se non abbandonata a se stessa, ci sarà di grande aiuto nelle scelte che s'imporranno: non si tratta davvero di confidare in fittizie (spontanee)
capacità intuitive, bensì di non trascurare un'importante parte di noi che, a ben vedere, non si trova in contrasto con il cosiddetto raziocinio, ma è di quest'ultimo inseparabile compagna.
Occorre, certo, impegno, consapevolezza, fiducia e, perché no, anche l'aiuto dei versi di Domenico.
Marco Furia
(Domenico Cara, "Le diagonali della psiche", Scrittura Creativa Edizioni, Borgomanero, 2010)
Raffaella Di Ambra, vivide scritture
Vivide scritture
Con "Scritture", Raffaella Di Ambra offre una breve raccolta i cui raffinati ritmi s'avvalgono di pronunce aperte ma succinte, effetto d'una tensione espressiva che nel verso pare trovare la propria naturale dimensione: spontanee scorrono le parole, trattenendo, senza sbavature, quanto occorre non lasciar sfuggire, mentre affascinanti tratti evocativi si diffondono a partire da costrutti verbali non incerti e, a modo loro, semplici.
La lingua di Raffaella ci viene incontro, ci coinvolge, pur rimanendo sempre ben distinta nella sua identità.
La presenza dell'autrice è assidua, tenace: non ci abbandona mai.
Evita di dirigerci, tuttavia: la sua è (feconda) tendenza a connettere, non a spiegare.
Mai abbiamo la sensazione, così, di seguire un itinerario stabilito, bensì avvertiamo d'essere via via sempre più partecipi d'intense atmosfere, sicché il percorso, pur esistente, non sembra attraversare un territorio, ma costituirne parte integrante.
Inevitabile la riflessione sul tempo: "Amo trovarmi fuori del tempo".
Certo, ad uno spazio privo di rigidi confini non può corrispondere un divenire sottomesso alla tirannia del cronometro.
Siamo invitati, insomma, ad abbandonare certi riduttivi schemi e a frequentare insoliti territori nel cui àmbito spazio e tempo sono entità intimamente legate, talvolta perfino indistinte.
Dove e quando, al di là delle indicazioni pur fornite, "La notte ha zampilli di freddo" o "piovono lacrime di farfalle" se non negli inediti intrecci verbali d'una poetessa ben consapevole del ruolo, nonché delle facoltà, dei propri versi?
Vigile, scrupolosa, capace di rendere sulla pagina lineamenti di carattere esistenziale dall'interno, ossia considerati all'origine nei loro elementi primari, non priva di (altrettanto controllata) vena espressionista e, soprattutto, attenta alla vita d'ogni parola, intesa quale grumo d'energia da utilizzare nella maniera più efficace possibile, Raffaella Di Ambra sembra porsi con naturalezza in una posizione, quella del poeta, per nulla comoda e facile da conquistare.
Coma l'ha raggiunta? Partendo da dove?
Sono questi gli intimi interrogativi che scorrono con intensa continuità nella sua poesia e che, refrattari a qualunque risposta, confluiscono, riconoscendosi, in un senso dell'enigma accolto quale nucleo ispiratore.
"Non posso rinnegarmi": per sua (e nostra) fortuna.
Marco Furia
(Raffaella Di Ambra, "Scrittura", "Testuale" n. 46 2009, Quaderno n. 12)
Marzo 2011, anno VIII, numero 14
Carte nel Vento
periodico on-line del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
“A ogni istante è come la prima o l’ultima parola, il primo o l’ultimo poema, imbarazzato, grave, senza verosimiglianza e senza forza, la fragilità testarda, la fontana perseverante; ancora una volta di sera il suo rumore contro la morte, l’accidia, la stupidità; ancora una volta la sua freschezza, la sua limpidezza contro il veleno. Ancora una volta l’astro fuori dal fodero”. Philippe Jaccottet
Ancora una volta, attraverso i finalisti e vincitori del “Premio Lorenzo Montano 2010”, tutti commentati dalla redazione di “Anterem”, in questo periodico viene proposta una rassegna di poesia italiana recentissima e prevalentemente inedita. Nel vivo delle ricerche in campo, trovano spazio anche prose e saggi brevi, espressioni del più giovane segmento di questo Premio, la cui 25^ edizione scade a fine marzo 2011.
Ranieri Teti premio.montano@anteremedizioni.it
Emidio Montini, prosa inedita “Lo scriba”, con una premessa di Mara Cini
Lo scriba di Montini mi riporta all’opera Deiscrizione (1972) di Claudio Parmiggiani: uno scriba ricoperto di scritte, simboli, ideogrammi e altri alfabeti, tiene sulle ginocchia una tavola bianca priva si segni. Di fatto la scrittura ancor prima di venire prodotta dall’uomo con intenti comunicativi si sedimenta sulla sua epidermide. “dirupi, forre, cortecce, coralli” sono iscritti, non scritti. E il “taccuino” diventa terreno o “tappeto di foglie” dove i segni linguistici sono tracce tra le tracce, a volte decodificabili, a volte tenacemente imprendibili.
Lo scriba
Dolorosamente candido, dolorosamente in lutto. Come può essere? Fuori squadro. Di fronte al mondo. Un sollievo. Le strade un tappeto di foglie. Questo taccuino un libro proibito. Un campo di battaglia per angeli e demoni, come al momento della nascita. Non sono un banchiere, non sono un mercante. Non devo ingannare nessuno se non me stesso. E questo lo faccio spesso. Sono un esperto. Dura da una vita. Ma ora basta. Perfino il crogiolo è stanco, di borbottare. Credo il ferro sia pronto. Una spada, un forcipe. Sto partorendo in casa. In casa sono nato. Una strettoia di valle. Un vecchio mulino. Cumuli di coperte. Sul davanzale a prendere il sole. Quando c'era. Ricordi miei o di altri? Non so. Grandi nebbie. A due anni andato via. Mai più tornato. Credo il torrente sia asciutto. Come i fiumi della terra. Ma a me è rimasta la sete. Una sete implacabile. Dentro. Un amore per le cose aspre. Dirupi, forre, cortecce, coralli. Abissi e sommità. Gli estremi sempre. E poi le stelle. Le donne. Imprendibili entrambe. Perché distanti le prime, perché amare le seconde. Iside morta con il suo Osiride. E la razza pure. Tutto nei mezzi toni del tempo. E l'eternità che langue. Che aspetta i suoi divoratori veri. La tavola non è più rotonda. Ora è fluttuante. Informe. Come le parole. Quella detta non è mai la pensata. Una maschera per ogni occasione. Un'occasione per ogni maschera. Il filo a piombo fa paura. Il cristallo di neve pure. Troppo semplici, troppo perfetti. Troppo colmi di fede. Troppo atavici. Per fortuna ci è rimasto il pianto.
Emidio Montini nasce nel 1954 in una valle del Bresciano fra le più laboriose e chiuse a tutto ciò che non ricada sotto la voce “tempi e metodi”. Forse, a condurlo ignaro verso quella vanità chiamata poesia, solo può essere stato quell'elemento, primitivo e sacrale, ereditato da parte materna. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni poetiche dal 1978 ad oggi: Poesie (La Voce del Popolo, Brescia 1987); A Colloquio con l'Angelo (Edizione del Leone, Venezia 1990); Mutamenti e Identità (Edizioni del Leone, Venezia 1992); Cassandra la Bella e altre cose (Edizioni Tracce, Pescara 2002); il romanzo breve Il Panico e la Grazia (L'Arcolaio Editrice, Forlì 2008); Uo-dishallo, Diario Africano (L'Arcolaio Editrice, Forlì 2009); La moneta a noi donata, Poesie (L'Arcolaio Editrice, Forlì 2010). Alcune buone recensioni su quotidiani e varie le segnalazioni in molti premi letterari.
Andrea Raos, da “Le api migratori”, Liquid Oèdipus 2007, con una nota di Rosa Pierno
Un libro congegnato, quello di Andrea Raos “Le api migratori”, per inglobare anche elementi eterogenei come l’immagine ( nei disegni di Mattia Paganelli), l’articolazione spaziale della pagina, sempre variegata e sorprendente (la quale invita a una costante dislocazione il lettore rispetto alla pagina) e il suono, elemento costitutivo della poesia, che viene però qui enfatizzato non solo da un’attenta autonoma valorizzazione dello stesso, ma potenziato, appunto, da una stimolazione percettiva del lettore attraverso la compresenza di tutti gli altri stimoli sensoriali, contemporaneamente attivi. Il volume, a questo punto, se è epico racconto - migrazione delle api equivalente alla migrazione degli atomi di lucreziana memoria e che avendo come soggetto uno sciame di api riecheggia anche le favole di Esopo – è anche libro-enciclopedia. Il racconto si snoda per metafore e allitterazioni, per progressioni continue. Infatti, avanza includendo intere porzioni della rete semantica (differenti ambiti linguistici) e letteraria (riferimenti ai classici): “tirata, tratta, stretta, terra, terramara / erra, rena, nera, nero, era” e “mentre esplode, dalla fiamma, lo sciame delle api trasformate, irrompe al mondo”. E che si tratti di favola morale: ““ma ne ho compiuto il male, che ricade, - ne ho toccata / nell’intimo natura, ho fatto il male.” / si dibatte, tenta, mentre invano cede” è presto confermato. Non si vuole in queste poche righe riassumere la posizione di rifiuto di Raos degli aspetti osceni della vita, preme piuttosto porre in nuce gli aspetti linguistici, sperimentali che agiscono nell’opera come distanziatori rispetto a un traguardo (la forma-libro) non raggiungibile in maniera compiuta e, altro aspetto non secondario, l’indefessa spola tra l’io e lo sciame in quanto l’introspezione soggettiva non rivela con incontestabile chiarezza il discrimine tra l’io e la collettività poiché entrambi presi in un movimento vorticante che tende a moltiplicare lo stesso soggetto percipiente.
Fuori dal laboratorio
La terra esplodeva, ancora una volta. Sono milioni di millenni
in piena, per completa frantumazione
si riversano per terra – esplode, esplosa:
“nella dolcezza, nell’amore,
né la dolcezza né l’amore
stanno – non sopporta più niente,
la vita, non sopporta niente”
“venite, attraversiamo” – traversando
“volo d’animali,
l’immenso il più disteso
non ho mai visto un altro fiume” – con l’amore
come l’acqua, com’è acqua,
colma di leggera, come fuga
a malapena, a stento volo, che non vuole,
che non prende il volo. Sprofondano dentro la terra,
cascate di roccia che la roccia, voragine che dentro la voragine,
da quella stretta che, dentro, alleva,
morso dalla morsa della pietra:
“trasvolando che sento, che cadrò”.
La roccia si solleva, esplode il suolo,
si fa lava, bolle, folle:
è trasvolando che cadendo, sciame dopo sciame,
tutto passa.
Ed ora che passato
passava tutto, intero, per intero,
e su ciò che diventa, si avventa:
l’orso piccolo strappato, che confuso, dalla madre,
alla madre, ombra,
l’orso da poco nato che spaventa
ancora il mondo (che da adulti rende muti senza spaventare, è lì e
basta, è cosa che succede, uccide),
che zampetta e uggiola un po’ debole, un po’ mite – è via
dalla madre
ombra, d’ombra
“ti ho sognata ma eri già morta,
ti ho sognata ma non eri niente, un agitare
di follicoli, estinzioni, di parentesi”
cosa, oh cosa di sangue e di niente, ad annerire ora,
cosa significa restare in vita?
che cosa strazia ora questa
mano, mano che non tiene? questa gola?
capivi che ne usciva suono, nel frastuono,
non perché la vibrazione arriva,
non vedi il battere
e ribattere laringe, strepito –
è il corpo intero che si chiude esplode,
ricontrae, riesplode, nel riaccelerare che il respiro,
per respirare, spira, che i polmoni,
nel vibrare, emettono, riemettere
con tutta la carne che li chiude
mentre, ancora (e come morde, come tremito, che trema)
e nuovamente, intanto,
affollano il nascere i morenti, si affollano, al disnascere, smorenti
- l’orso piccolo, già morto, muore ancora,
cosa nasce?
l’ape pazza che attraversa, il corpo,
cosa non nasce?
sono soli, ora, il vuoto, accerchia l’erba,
verso cui, già piega, verso dove
la terra serba il pianto che le spetta,
cosa nasce e non nasce?
allontana, l’allontanarsi altrove, il numero
di api-sciame, innumerevole –
cosa né nasce né non nasce?
“Non posso, pure, non passare, vero?”
Andrea Raos. Nato nel 1968, ha esordito con la raccolta Discendere il fiume calmo nel Quinto quaderno italiano diretto da Franco Buffoni (Crocetti, Milano 1996). È presente nel progetto ákusma. Forme della poesia contemporanea, (Metauro, Fossombrone 2000). Ha pubblicato Aspettami, dice. Poesie 1992-2002 (Pieraldo, Roma 2003) e Luna velata (cipM - les Comptoirs de la Nouvelle B.S., Marsiglia 2003). Ha curato l’antologia bilingue di poesia contemporanea italo-giapponese Chijô no utagoe - Il coro temporaneo (Shichôsha, Tokyo 2001). Presente nel VI Quaderno della rivista on line Poesia da fare di Biagio Cepollaro. Con Andrea Inglese ha curato Azioni poetiche. Nouveaux poètes italiens, in Action poétique, 177, settembre 2003 e Le macchine liriche. Sei poeti francesi della contemporaneità, in Nuovi Argomenti, dicembre 2005. È membro di Akusma e di Nazione Indiana. Suoi testi sono apparsi sull’antologia Il presente della poesia italiana a cura di Stefano Salvi e Carlo Dentali (LietoColle, 2006).
Antonella Doria, inediti da “Millantanni”, con una nota di Giorgio Bonacini
La poesia contemporanea, si sente dire, è talmente oscura da essere incomprensibile e perciò poco frequentata dai lettori non specialisti. Ma questo, noi crediamo, è un sentimento diffuso che parte da una premessa stupida (il senso deve essere evidente) e arriva a una banalizzazione totale: e cioè che la poesia debba essere comunicazione. I poeti sanno quanto ciò sia falso e quanto lavoro di scrittura e di pensiero ci sia in ogni singola parola. Ebbene, questo poemetto di Antonella Doria è un mirabile esempio di quanta ricchezza ci sia in una voce talmente concentrata da crescere in un testo che fa della sua opacità il suo gesto significante. E’ una poesia che misura la sua forza a partire dall’ origine di un pensiero che produce la forma linguistica della “cosa” prima che la scrittura si imprima, rendendo cosciente la sua sostanza poetica “a margine del verbo” e “a margine del senso”. Perché la parola poetica, anche se vive in trasparenza nel linguaggio, esce da un buio interiore e passa dal chiuso all’aperto in modo preciso o vorticoso, a seconda delle necessità che convengono e convergono per quel momento, ma ha sempre bisogno di uno sforzo per essere vista più che per vedere.
Entrando nello specifico vediamo che il poemetto di Antonella Doria si presenta come una composizione di testi concatenati: otto poesie/strofe che si legano l’una all’altra attraverso la ripetizione dell’ultima parola all’inizio della poesia successiva, e un prologo e un epilogo che si richiamano e racchiudono (e quasi riassumono) in una sintesi estrema quanto affiora dallo spezzettamento del corpo centrale. Ma questo insieme vocale non è qualcosa che viene prima della poesia che lo rappresenta, bensì è ciò che accade mentre la scrittura si fa. Non c’è un dato di realtà precostituita, non ci sono segnali o conformazioni note che portino a conoscenza la devastazione in cui tutti ci troviamo nel “tumultuoso gran fiume” dell’esistenza, ma è lo scorrere dei versi “oltre ogni possibili segno” a comporre il suo venir prima. E la scossa che dà il movimento sta nell’inganno e nella violenza del mondo, resi veramente significanti, e quindi corporei, da una parola che è al limite delle sue forze. Una parola dura e selvaggia che apre crepe e fratture, perché lei stessa nasce come voce spaccata, lacerata dal turbinio che genera sensi reali ma anche tesa a svuotare ciò che ancora non c’è. Perché se anche tutto e niente a volte si confondono e si fondono tra loro, la parola resta un segno che illumina in modo imprevedibile “il primo e ultimo/ conoscimento”.
Allora il fondamento di questa poesia, che raccoglie il dolore nell’oscurità di un’ ombra, sembra essere l’atto di conoscere attraverso la trasfigurazione dell’ esistente, con una capacità estrema che solo la scrittura può catturare. La percezione di un miraggio, di un caos, di un labirinto si incontra nel paradosso di una visione “dove capovolta/la terra sorgere/vedrai”. Immagine che apre e chiude un testo dove i luoghi di paura nemmeno alla fine sembrano attenuare la loro avanzata.
da Millantanni
Introibo
tumultuoso un gran fiume
verso l’inverno avanza
a piedi ciechi folli mercenari
di peste d’oblio appestati avanza
la notte inquieta nelle palpebre
una sola moltitudine
insegne menzogne portano
seguono inseguono in marcia
d’avvicinamento verso dove...
(forse tutto era niente)
a piedi ciechi molti
in marcia incatenati ronzini
ronzinanti tutti
danzanti tristemente
tumultuoso un gran fiume
(devastante inondazione)
incontro al raggioverde
all’orizzonte estremo incontro
dove capovolta
la terra sogere
vedrai...
***
pietre comporre
comporre parole
echi di una partitura
musica tuttita città
nuova (nuova Athenae
Troia o Carthago) sale
al monte d’Acropoli
serve pietre comporre
in cuore si quieta
l’inquietudine e sale
l’insieme di fiaccole
mani illumina macerie
illumina ogni notte
di cretto fascismo
o terremoto
un cuore selvaggio
ritorna riprende mani
e lingua dalla terra
alle viscere materne
ritorna matrici di
memoria
***
(forse tutto era niente...)
all’orizzonte sorge
la Terra capovolta
una nuova sola moltitudine
esistenza nuda di corpi
erranti
avanza verso l’inverno
a margine del senso
a margine del verbo
tumultuoso un gran fiume
Vedrai...
Antonella Doria, siciliana, vive fra Milano e la Liguria. E’ presente in diverse riviste e antologie. Ha pubblicato: Altreacque (1988); Mediterraneo (2005); Metro Pòlis (2008). Ha curato Poesia contro guerra (2000, 2007) con una nota di Dario Fo. È condirettrice de Il Segnale, Percorsi di ricerca letteraria, e redattrice di In Oltre, rivista di antropologia, politica e cultura.
Enrico De Lea, da “Ruderi del Tauro”, L’arcolaio 2009, con una nota di Rosa Pierno
Pare, leggendo la raccolta di Enrico De Lea “ Ruderi del Tauro”, di sentire sulla pelle il meriggio opprimente e arso di una campagna senza vento, in quelle ore lunghissime il cui il tempo si dilata fino a divenire un miraggio e le cose, perdendo il senso della contingenza, risultano irrorate dalla passione del percipiente che associa a ogni sostantivo un inatteso attributo volto a frantumare tale compatta ambientazione per innestarla con un’atavica memoria: “ Passio omiletica della cava / virtù, porge l’uovo della diruta / casa, passato l’oltre del padre / innervato, nell’asse del ciliegio”. In questo intarsio continuamente movimentato, nessuna parola ristagna o s’indurisce, ma immediatamente cede il passo a quella che segue pur se semanticamente distante. Se “nominare è morte e polvere”, pure parlare è sponda, è muro che si erge. Un continuo costruire e decostruire con le parole la propria visione morale. In una farandola di specchi che si frantumano e si ricompongono, variando continuamente il paesaggio contro cui s’inscena il soggetto, scopriamo che il ricordo risale dalla materia stessa, che è quello dell’intera umanità: è questo che crea l’alternanza della voci, il dialogo fra cultura e natura: “Avvalla nelle gole / il fuoco dei verbaschi / la dismisura dei morti”. Inevitabile sarà, allora, anche la sovrapposizione fra natura e corpo. Sarà come chiudere un cerchio per la religiosa lettura che, appunto prefigura una saldatura tra la natura umana e tutti gli altri elementi: “l’albero / dei mortali figurò la croce / al volto arso del morente, / quale eccessiva traccia del paesaggio”. Ecco, dunque, che la ricomposizione è stata raggiunta: che ogni cosa appare segno di qualcosa d’inesprimibile. Che se il linguaggio può solo mostrare è fra le sue pieghe che bisogna cercare. Una poesia densissima e barocca, nonostante la propria scabra e spigolosa apparenza.
dalla sezione Boschivo per le furie
(boschivo per le furie)
Ruga della grafia o del graffito
facciàle, brama lo scoramento
dell’ingresso – in giornate così,
che lo scirocco succeda al tramontano
e i gradi delle unghie
solchino il dopo-luce, il forno
dei barlumi. Pianta le spine
apprese al muschio, schivo
d’incenso scorteccia
l’argine del verbo – boschivo
per le furie...
(tramontana)
La formula impetrata del conforto
dona un lacerto del mondo riapparente
al pozzo-luce voce declamante
non di un suo serro estremo di borea
e di rena monastica trascorsa,
sì uguale seta all’occhio
fiume del danno e mare del consòlo.
(paesaggio lavico)
La concezione del fiore basaltico
non ammise alcun flettere
dalla vena millenaria
al fuoco terraneo – l’albero
dei mortali figuròla croce
al volto arso del morente,
quale eccessiva traccia del paesaggio.
(et in hora), 4
Arte della visione include l’artificio
acceso del volto noto nell’osceno sguardo,
verso l’alto della caduta, creatura.
Ordinanza notturna si dispone
all’austera furia, marchio a fuoco
dell’occhio e del rastrello ad un pietrame,
memoriale ingenuo
della sentìna dei corpi, senza gioia.
dalla sezione Invenzione della gloria
(adieu)
È disincanto del rintocco, campanario
squarta l’asciutto espianto della lingua –
dentro un paesaggio che lo pasce e nega.
Il debito che non s’estingue, la pingue
larva della catena – una coperta
che la terra tesse.
(l’ordine)
“degli anni e dei mondi” – per una convenzione
fissi al tempo, a un’ostensione della macchia,
sia fuoco d’artificio castellario e, dietro, notte
vuoto mestiere e mistero dell’inganno,
ché sia la detta materia della fuga.
Enrico De Lea (1958) è nato a Messina e vive a Legnano. Ha pubblicato nel 1988 Esercizi vitali e nel 1992 la raccolta Pause, Edizioni del Leone. Suoi testi sono apparsi sulle riviste “Wimbledon”, “Specchio”, “Tuttolibri”, “Atelier”, “Sud”. Cura il blog personale “da presso e nei dintorni”, www.delea.wordpress.com
Federico Federici, prosa inedita “Due prose unite”, con una premessa di Mara Cini
Certi alfabetieri un tempo si chiamavano Primo incontro con le parole o qualcosa del genere. Molti scrittori hanno raccontato con emozione di questo loro primo incontro infantile (Benjamin nella sua Infanzia berlinese, Canetti in La lingua salvata…). La scoperta dei segni alfabetici, il potere della scrittura, la complessa operazione della lettura in fondo mai appresa completamente (ci sono sempre alfabeti da decifrare) si rivelano essere “il filo teso tra due margini invisibili di vuoto”.
E’ “Uno sguardo che fa vibrare l’alfabeto” e propone al lettore un’ esperienza di continuo rinnovamento nel nominare le cose nel “prenderle” nella loro essenza di geometrica struttura linguistica.
Due prose unite
Non per arrivare a sapere qualcosa, ma solo per dire un nome si sono dunque inventate le parole? Ciò che sicuramente vorremmo toccare invece ci meraviglia, raccolto nell’oscurità della sintassi dei suoni, senza ascoltare quale sia la sua voce.
È bello vedere le frasi farsi discorso, sbocciare dai contorni alle cose, filare via convinte, migliori tra tutti gli altri che invece tacciono, libere da una calca di pensieri, mostrare le ragioni, certe come cifre stampate a un foglio, arrivare al punto, scavalcarlo. Si va dietro la prima, fatta per scherzo all’inizio, poi diventata più vera, vera all’improvviso, che ne ha chiamata un’altra a convincere gli incerti. Una frase sola all’inizio, che sembrava aprire e chiudere il discorso, ci ha scoperti invece, messi sotto gli occhi di tutti a sostenere una parte, fatta solo di parole e argomenti, proprio per quelle parole che ora non ci lasciano più stare.
Non ci soccorrono i fatti, perchénon ci sono mai stati. Tutto si riduce cosìper dire, come quando al racconto di una storia si aggiungono i dettagli, che la rendono diversa a chi l’ascolta e la prende vera e impara così come vanno le cose al mondo, sentendosele dire, imparando solo a mettere bene la lingua sui denti e pronunciare i nomi.
Ecco un’ansia metafisica: prendere la parola – una – tolta al mondo, senza paragoni spingerla sul baratro sola, sino a non sapere più se salva o vinta dalla sorte, metterla di fronte al suo silenzio, assoluta, abbandonarla. Aspettare con pazienza e ripronunciarla umana, più umana, e umanamente risentire la paura in lei di quel momento, di piombare nel suo buio non-significante, non più interrogata o trattenuta, anzi sfigurata nelle cose.
Non so – dire, scrivere di più di quello che non scrivo, di quello che a fatica taccio perché già più sottile, di quello che trattengo alla parola, perché mai dia di più o di meno, in attrito al silenzio.
– « Sii cosa, vera! »
A tratti uno sguardo fa vibrare l’alfabeto, come a un primo incontro, un peso, un tuffo al cuore per il salto in volo di un uccello, sopra il filo teso tra due margini invisibili di vuoto.
Sembra mano a mano manchi il tempo e che tutta la vicenda per destino resti muta, nell’agitazione brulicante, tutta gesti osceni e segni di chi non sa nulla.
– « Dove vai? Dove si va? »
Quale nome – immagine del mondo – nella tenebra ci chiama a luce?
Federico Federici (Savona, 1974) è ricercatore e professore di Fisica, traduttore (da tedesco, russo, inglese) e scrittore. Ha pubblicato (a proprio nome, o a nome Antonio Diavoli) raccolte di poesia e prosa, traduzioni, articoli di critica. Ha preso parte a incontri e letture in Italia e all’estero, a mostre di pittura, a manifestazioni legate alla videopoesia e al cortometraggio. Ha tradotto e curato la prima edizione italiana delle poesie della poetessa indiana Rati Saxena e il primo lavoro postumo della poetessa russa Nika Turbina. Nel 2009, con L’opera racchiusa, è tra i vincitori del “Premio Lorenzo Montano” per l’opera edita. Nel 2010 esce in Inghilterra il poemetto Requiem auf einer Stele (The Conversation Paperpress, UK).
Di prossima pubblicazione lùmina (archivio apocalittico farsesco) per La Camera Verde e la traduzione di Adage Adagio (di David Nettleingham e Christopher Hobday) con un saggio introduttivo sulla poesia civile per le Edizioni Polìmata.
Cura su internet lo spazio http://leserpent.wordpress.com
Tiziana Gabrielli, poesia inedita “Il cerchio oscuro”, con una nota di Marco Furia
In "Il cerchio oscuro. Trilogia dell'erranza", componimento, articolato in tre sezioni, di Tiziana Gabrielli, proprio l'erranza appare enigmatica entità con cui la poesia, nel suo svolgersi, s'identifica per via di calibrate successioni verbali volte a considerare il linguaggio medesimo quale proprio oggetto.
La pronuncia
"il senso
nel controsenso
di uno stare che è già un distare"
costituisce, con evidenza, attenta riflessione sulla natura dell'idioma.
Il discorso poetico, per così dire, inizia dal punto finale, ossia dal punto in cui la lingua sembra rimandare a se stessa: dobbiamo forse rassegnarci alla mancanza di vie d'uscita?
Non direi, perché i versi
"dove il silenzio
è vita"
chiudono il componimento con palese richiamo ad un'energia vitale che, pur non ancora lingua, è silenzio fecondo, intimo tratto umano non distinguibile dalla parola una volta che questa sia sgorgata.
Con un dettato conciso, secco, ma non schematico, determinata ad esprimere un'esperienza dell'enigma vissuta in modo particolarmente intenso, Tiziana Gabrielli mostra come ogni interrogativo, anche uno di quelli più preoccupanti, affondi le proprie radici nell'esistenza degli uomini e come la consapevolezza di ciò possa mitigare l'inquietudine.
"Il cerchio oscuro", insomma, può diventare più chiaro.
Il cerchio oscuro
I. Soglia
Svia
da te a te
il nome - il giusto nome -
la «frase ulteriore»,
l’oltre-misura
l’in-definito
la «terra mattinale del principio»,
grido dell’origine
a-venire
II. A traverso
Rifrange
da te a te
l’ultima eco
del viaggio verso
l’in-scrivibile
ombra, dall’ombra
all’ombra
tra-versata
tras-versale
che e-margina
il senso
nel controsenso
di uno stare che è già un distare
nell’incessante svanire
dell’att(im)o
III. In cammino verso il principio
Trasmigra
da te a te
il linguaggio senza dimora
né orizzonte
che linea lasci immaginare
e l’essere
custodire
nell’intermittenza perturbante
di un soffio
- primizia d’aurora -
nel buio lunare
oscuro stupore, oscura
lingua
dell’esilio
e la devianza
nuovo pensiero-stella
del cerchio infranto
dove il silenzio
è vita
Tiziana Gabrielli (1969), laureatasi (cum laude) nel 1996 in Filosofia presso l’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, si perfeziona presso la Scuola Normale Superiore di Pisa sotto la guida di Remo Bodei, professore presso l’UCLA (University of California, Los Angeles) - che le conferirà nel 1999 il “Premio di filosofia - Viaggio a Siracusa” (sezione Tesi di laurea) - e di Claudio Cesa, professore emerito di Storia della filosofia moderna. Nel 1997 l’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli le conferisce una borsa annuale di ricerca sotto la direzione scientifica di Xavier Tilliette, professore emerito presso l’Institut Catholique e il Centro Sèvres di Parigi e la Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Perfezionatasi in Bioetica presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma tra il 2003 e il 2004, consegue nel 2004 il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, collaborando contestualmente con la “Bayerische Akademie der Wissenschaften” di Monaco di Baviera e la “Schelling-Forschungsstelle” di Berlino e Brema.
Filosofia e poesia dialogano costantemente nella ricerca estetica di Tiziana Gabrielli, che si nutre delle più fertili contaminazioni con le arti visive, la musica e il teatro.
Attualmente i suoi studi sono orientati, per un verso, alle nuove emergenze dell’etica applicata e, per altro verso, alle più feconde declinazioni dell’estetica come polifonia
di forme, linguaggi e codici semantici ed ermeneutici da cui far germogliare l’impensato.
Le sue liriche sono presenti in numerose antologie e riviste ed alcune di esse sono state tradotte in spagnolo e in greco moderno.
Tra i principali riconoscimenti si segnalano: Menzione speciale per l’Italia al Premio mondiale Nosside Internazionale (2007); Premio Letterario “Sergio De Risio” (sezione poesia inedita) sul tema “Il pensiero poetante” (2008); Premio nazionale di Filosofia “Le figure del pensiero” (sezione Aforismi); Premio Letterario Internazionale Maestrale - San Marco – Marengo d’oro (sezione poesia in lingua) (2008); Concorso internazionale “Lettera D’Amore” (2010); “Trofeo della Cultura. Histonium alla Carriera 2010” conferitole dalla Giuria del Premio nazionale di Poesia e narrativa “Histonium” 2010; Premio “Parole 2.0 – Poesia in movimento” 2011. Finalista al Premio di Poesia Lorenzo Montano – sezione poesia inedita (2009 e 2010); finalista (sezione Poesia) al Premio Fabrizio de André “Parlare Musica” (2010).
Lorenzo Gobbi, saggio inedito “La rosa ultima”, con una premessa di Mara Cini
Focalizzato sulla parola rosa, sul messaggio che il simbolo della rosa rappresenta per Rilke (e per molta cultura occidentale) il testo di Gobbi allude in realtà a una rosa multipla dove ogni facoltà sensoriale è messa alla prova. Dove petali-palpebre si chiudono alla vista, petali-pagine si sfogliano con le dita, petali-mantra ci accompagnano frusciando. Petali che profumano o riposano dolci nei vasetti di marmellata.
Ma se penso a una rosa in forma di parola, alla rosa ultima, penso alla rosa canina con i suoi quattro petali , uno per ogni sua lettera: r o s a
La rosa ultima
Un uomo che pensa alla propria morte, spesso, vuole lasciare un messaggio preciso, benché più o meno cifrato. Per farlo, deve tentare una luce definitiva, netta, che dissolva ogni equivoco. Deve pensare a se stesso senza il tempo e senza la parola, al di fuori di ogni relazione: a un’essenza di sé.
La sera del 27 ottobre 1925, a Muzot, Rainer Maria Rilke scrive il proprio testamento, e lo invia all’amica Nanny Wunderly (morirà il 29 dicembre 1926, sul far del mattino). Chiede che gli sia tenuto lontano ogni conforto religioso; sceglie il luogo nel quale essere sepolto (accanto a un’antica chiesa, presso Rarogne). Vuole una vecchia pietra, dalla quale si cancelli ciò che è scritto e siano incisi un nuovo nome, lo stemma di famiglia e tre versi.
Rosa, oh contraddizione chiara, desiderio,
di nessuno essere sonno sotto così tante
palpebre1.
La malattia ha già intaccato un fragile equilibrio, o forse l’equilibrio spezzato ha chiamato a sé la malattia. Scriverà , venti giorni prima della morte, sempre a Nanny: “Le plus grave, le plus long: c’est abdiquer: divenir ‘le malade’. Le chien malade est encore chien, toujours. Nous à partir d’un certain degré de souffrances, sommes-nous encore nous?’’
Rilke sembra desiderare la metamorfosi: essere presto uno tra i morti. Lust: “desiderio”, più che “piacere, gioia”. La rosa è Rilke nella morte, nella sua morte. Sotto la palpebra della tomba, sotto le tante palpebre delle pagine che resteranno, egli sarà “sonno”. Nessuno dormirà là sotto: non ci sarà più nessuno. (E’ un fatto naturale, come l’arrovesciarsi degli occhi nel sonno: le palpebre chiuse li proteggono, e ne indicano insieme la presenza – ma essi non vedono).
La rosa è più che Rilke: è , in se stessa, reiner Widerspruch – un parlare che è reiner: “puro”, ma anche e soprattutto “chiaro”, sia nel senso di “limpido, luminoso, nobile”, sia di “comprensibile”. Il miracolo dei nostri giardini ha una logica propria, assolutamente cristallina: deve pur esistere un punto di vista dal quale abbracciarne il Widerspruch e trovarlo “chiaro” – cioè , comprenderlo fino a essere rosa in se stessi. (Reiner, la qualità del Widerspruch della rosa, è omofono di Rainer, il poeta che sarà sepolto).
Come l’occhio addormentato guarda al contrario, così la rosa parla al contrario. Già nelle Neuen Gedichte anderer Teil si incontra uno sguardo volto all’indietro, l’unico presente nel mondo – di un torso arcaico di Apollo: “là non c’è punto / che non veda te. Devi cambiare la tua vita”2. Il Widerspruch della rosa porta ad acconsentire alla trasformazione della vita: a comprenderne la necessità .
Sembra, questo, uno sguardo ultimo che scopre l’esistenza di un centro nella vita trascorsa: un unico sostare al cospetto di una verità semplice: ciò che il poeta potrà continuare a fare, per grazia, anche quando sarà trasformato nel “sonno di nessuno”.
Qual è la verità della rosa? Essa stupisce, sempre:
Dov’è per questo interno
un fuori? Su quale pena
lini come questi vanno a porsi?
Dentro, quanti cieli si riflettono,
nel lago chiuso
di queste aperte rose -3.
Infinito è lo spessore simbolico legato alla rosa nell’ambito della cultura occidentale. Ce lo ricorda l’epitaffio che Gertrude Stein dettò per la propria tomba, a Parigi: “Una rosa è una rosa è una rosa”- e il Paradiso di Dante non poté che apparire in forma di “candida rosa”. Nella mistica ebraica, “la forza apotropaica di šošannah [plurale di šošan, ‘rosa’] trovò una spiegazione ulteriore nella corrispondenza tra i componenti della corolla e le lettere del Tetragramma, yod, he, waw, he. […] lo ‘specchio opaco’ nel quale si riflette l’emanazione superna”4. In un apologo di Nachman di Breslav, rabbino del XVIII secolo, il Messia restaura l’ordine del cosmo attraverso un atto di pura comprensione: raccogliendo una rosa.
Non ci si stanca mai di guardare una rosa. Nelle poesie francesi di Rilke, scritte tra il 1924 e il 1926, per lo più nei periodi di ricovero per l’aggravarsi della malattia, una sezione s’intitola Les roses, e raccoglie 24 poesie: il sonno le cinge, le rose riposano in sé:
Se ti appoggi, rosa fresca e chiara,
contro il mio occhio chiuso, -
come avessi mille palpebre
posate una sull’altra
contro la mia, calda.
Mille sogni contro la mia finzione
sotto la quale vado errando
dentro il labirinto dei profumi 5.
La malattia mortale era già iniziata: Rilke se ne rendeva perfettamente conto. Un’infezione provocata dalla spina di una rosa, conficcatasi profondamente nella mano sinistra, ne accelerò il decorso.
In forma di parola, la rosa avrebbe vegliato sulla sua tomba: non credo che essa fosse concepita per i futuri visitatori del cimitero di Rarogne – non più di quanto una vetrata o una scultura, in una delle cattedrali gotiche di Francia tanto care al poeta, lo fosse per il popolo, o avesse una funzione catechetica: vi sono, sì , figure pensate a questo scopo, ma insieme se ne trovano altre troppo lontane, indistinguibili dal basso e necessarie, forse, nella loro pura presenza, al di fuori di qualsiasi utilità - perché vi fosse, nello spazio sacro, una raffigurazione di ciò che rappresentavano. Leggerei in questo senso la sintesi estrema dei tre versi, cifrati per sé e per la verità della rosa.
Eppure, qual è la verità della rosa? Perché desiderarla così presente, non in figura ma in forma di parola?
Lorenzo Gobbi, poeta, saggista e traduttore, è nato e vive a Verona. Per la saggistica ha pubblicato: Elogio del frammento. Rilke, Hesse, Benn, Celan, Verona 1995; Lessico della gioia, Qiqajon, Bose 1998. Gerusalemme. Nella memoria di Amos Oz, Unicopli, Milano 2006. Carità della notte. Il lutto e la separazione nella poesia di Paul Celan: una lettura personale, Servitium, Bergamo 2007. Lessico della gioia, 2^ edizione rivista, Servitium, Bergamo 2008. Le api del sogno. Per Emily Dickinson: una domanda sulla gioia, Servitium, Bergamo 2009. Elogio del frammento, nuova edizione rivista, Servitium, Bergamo.
In poesia ha pubblicato: Nel chiaro del perdono, con una lettera di Roberta De Monticelli, Book Editore, Bologna 2002; Nel centro del ricordo, Book Editore, Bologna 2004; Le rose più di tutto, Quaderni di Orfeo, Milano 2006; Luce alla mia destra, Book Editore, Bologna 2006. Testi poetici sono presenti in Poesie di Dio, a cura di Enzo Bianchi, Einaudi, Torino 1999.
Ha tradotto Biagio Marin, Rainer Maria Rilke, William Shakespeare, Ugo di San Vittore. Inoltre traduzioni da Novalis, Hölderlin, Schiller sono incluse nel volume La gioia tra le dita, Fondazione “Giorgio Zanotto” – Banca Popolare di Verona, Verona 2005.
Luca Salvatore, da “deadcityradio”, Arcipelago 2008, con una nota di Rosa Pierno
Viene da pensare ai limiti del linguaggio, percorrendo i meandri del libro di Luca Salvatore “deadcityradio” e meglio sarebbe dire affondando nelle sabbie mobili e aggrovigliandosi nelle liane presenti nella stratificata foresta “cultura”, forse vero soggetto della silloge. Tali percorsi linguistici potrebbero causare l’immobilità dell’incauto lettore, non fosse altro perché è una scelta non disperdere nulla, nulla lasciare alle spalle, tutto necessariamente richiamare in uso per tentare la totalità. Ecco, dunque, gli estremi che si toccano, ma non per annullarsi l’uno nell’altro: “E’ il Niente che dalla vena rotta offre in soluzione / il Leviatano, il concreto farsi razionale a rimpasto”. La scelta è quella di creare una tensione irrisolvibile, di lasciare che tutto si fronteggi instancabilmente, di non lasciare riposare l’idea che esista il nulla rispetto alla totalità. Se dal linguaggio non si esce vuol dire che nulla esiste al di fuori del linguaggio e che all’interno del linguaggio nulla vi è a cui sia possibile rinunciare, errori compresi: “L’essenziale è saldo alla presenza non all’evidenza /differenziata della parola, obbligarsi allo sfinimento / all’umor fumistico; è riportare tutto all’incoerenza / della messa in opera, dei fondi resi a medicamento”. Seguiamo Luca Salvatore, il quale indossando un mantello da officiante assume il ruolo di castigatore e di commediante insieme: “Per noi suonatori della tanto singolare canzone, / per puro amore della forma, nel pieno d’agonia / la muta ostinazione si fa bestemmia e derisione” e volentieri accettiamo di assistere alla messa in scena di uno spettacolo rispetto al quale egli stesso ha provveduto a fornirci l’antidoto. Non sarà un’esperienza inutile rituffarci in acque mosse e vorticanti, perlustrare orizzonti inattuali e familiari insieme: ciascuno di noi ne emergerà con qualcosa di utile e di dimenticato, di nuovamente utilizzabile.
Vorresti?
Dead City Radio va avnti fino allo scadere suona
ancora la tua ora per chi s’è dannato lucidamente
jazzando Mexico City Blues, Coney Island della mente,
per chi dà fondo alla vita fino alla trama e sragiona
senza potere vederci chiaro e sempre barcollando,
sicuro che esser nati sia già un castigo sufficiente;
per chi s’è pentito di tutto solo alla fine cercando
la maniera giusta di rifarsi la bocca, torbidamente!
suona ancora per gli obbedienti a tutto e i dissoluti,
per tutti i pazzi esilarati tornati ai vecchi trascorsi
chiudendo il becco a morti traboccati ed Assoluti,
per noi veri metodici d’osteria sempre ai ferri corti.
Dead City Radio suona l’ora, senza accordi e difetti,
per chi èa pezzi e sa ogni strazio vero e tormento,
per quelli tutti d’un pezzo, i nutrimenti che vorresti,
e chi, perso il sesto senso, se la gode solo a stento.
A la morgue!
Rimonta alle origini, riempi tutto di nessi causali
con sistemi all’appello e il tuo istinto proverbiale,
rimescola a piacimento arcani e piani Universali,
dissezioni e ricalchi d’ultimo rango andati a male.
Avrai ancora di che divinare in segreto, e piegare
avventori di genealogie, di contraltari e falsi idoli,
miasmi esistenziali, peccati alla ribalta da espiare
con delle solide diete di nulla nei secoli dei secoli.
Dopo aver retto a forza con punte e rialzi l’ignoto,
che la bilancia avràfinito col pendere da un lato,
ci saranno ordini costituiti calati a basso degrado
da imporre al farsi imminente dei ricorsi a vuoto,
e solo anticipi contanti sulla merce alla consegna:
gabbi ardenti di tortura, manuali di retorica bruta,
da passare quel che sembrano organi in rassegna,
la grande opera di pennello finalmente compiuta!
Kurt and Courtney (the day Seattle died)
Ricordo fughe da fermo, gli amori appena sfiorati,
l’originale di com’eravamo, la solitudine messicana,
gli armstrong – riascoltando vecchi nastri registrati
al bianco e nero dei contrasti, attenuati in filigrana.
Venus in furs e a mille nella testa spettri meridiani,
sbronzi pensosi, ragazze scaltre e micragne penose
rincasati alla berlina e stanchi la mattina sui ripiani
di certami sbiaditi, a splendori ancora senza nome.
Allo Scalo dei trapassati colavano vodke dozzinali,
la radio suonava be-pop sotterranei, anfibi e flanelle,
“the needle & the damage done” di tossici abituali
su tutta la notte e tutti presi a cercarsi sotto la pelle.
Ricordo cocaine rodeo, i ci rifaremo all’altro mondo,
i “potesse tornare ancora il vecchio tempo andato!”
e quando in una sola notte ce ne andammo a fondo
dopo aver speso la Vita come sui banchi dell’usato.
Luca Salvatore è nato a Potenza nel 1978. Ha pubblicat Fumisteria ermeneutica (Joker 2006). Collabora con riviste e quotidiani on-line. Ha tradotto dal francese Tristan Corbière per le Edizioni del Foglio Clandestino. www.deadcityradio.it
Vincenzo Guarracino, saggio inedito “Interrogare la notte”, con una premessa di Mara Cini
Poeti di fronte alla notte, artisti sul bordo del precipizio, solitarie figure alla Caspar David Friedrich nel ghiaccio blu dell’immenso. C’è una natura del grande infinito impossibile da conoscere, da percorrere, da abitare, che dà all’uomo “la consapevolezza della sua umana fragilità”. E c’è una natura del quotidiano, vicino, possibile, da toccare – ginestre, siepi, eccetera - che racchiude in forme più familiari e composte tale fragilità.
Ma libro del mondo è comunque inquieto, più inquieto ancora sotto lo sguardo delle parole. Quando si attua quello che Guarracino chiama “un’effervescenza energetica del sapere”. Sì, possiamo intuire di cosa si tratta, qualcosa che resta dietro di noi anche quando ce ne andiamo.
Interrogare la notte
C’è un’immagine, in limine al De rerum Natura lucreziano (I, 136-145), che colpisce per la sua carica di disarmante e autobiografico titanismo, la prima e l’ultima volta di tutto il poema, ed è la dove il poeta, dopo aver confessato l’ardire del suo proposito di trasferire “in versi latini” obscura reperta, “le oscure scoperte” del genio greco, si rappresenta a noctes vigilare serenas, “a vegliare nelle notti serene”, a interrogare il gran libro della Natura per carpire al suo silenzio il segreto delle cose e clara…praepandere lumina menti, “trasmettere alle menti una luce scintillante” di verità.
E’ su questa immagine che mi preme soffermarmi, per gettare un minimo di luce da una diversa prospettiva sui complessi rapporti tra Lucrezio e Leopardi, tra due poeti cioè accomunati della più tragica oltranza interrogativa sul limite di un disagio storico e di un’essenziale disarmonia: un’immagine che si pone come l’emblema stesso della loro ricerca, per la sua urgenza allegorica e per l’orizzonte etico e gnoseologico che delinea.
Interrogare la notte, come dire interpellare e sentirsi interpellati dal mistero delle cose sul teatro dell’essenziale solitudine, che racchiude il corpo del soggetto poetico: Lucrezio (“tu mihi supremae praescripta ad candida calcis / correnti spatium praemonstra, callida musa, “e tu, nel momento in cui mi slancio verso la bianca linea che segna il termine della mia corsa, / mostrami la via, o musa ingegnosa”, VI, 92-93) e ancor più esplicitamente Leopardi (“Chi teme, canta”, Zib.3527) hanno coscienza che è in questo spazio che la parola poetica, sovraccaricata di una chiara intenzione di rassicurazione e seduzione, si incontra col ritmo di un pensiero dalle domande inesauribili per trasformarsi in un movimento che trova nell’infinito (o meglio, nell’indefinito) la sua figura essenziale, chiamando in evidenza e trasparenza le intime fibre dell’ombra, simulacra modis pallentia miris, “i pallidi simulacri di un pallore alieno” (123) non meno dei “mille vaghi aspetti / e ingannevoli obbietti” (Il tramonto della luna, 4-5), i fantasmi cioè della propria inquietudine, senza riuscire a vincerli ma anche senza restarne annichilito, in virtù di una eroica volontà di conoscenza.
Si tratta di un faticoso processo che per entrambi, pur per diverse vie, verte ad un unico risultato, quello di dare all’uomo la consapevolezza della sua umana fragilità.
In Lucrezio, si innesta e corrobora fin dall’inizio in un’ansia conoscitiva senza ipoteche e protezioni metafisiche, per approdare ad una visione dell’uomo difeso dalla corazza di una ratio capace di offrire finem…cuppidinis atque timoris, “un limite al desiderio e al timore” (VI, 25), una volta indagate e penetrate res occultas penitus, “i segreti più profondi della natura” (I, v.145), e di procurare un sollievo ai mali che affliggono la coscienza nella visione del triumphus Mortis del libro VI.
In Leopardi, matura per gradi, attraverso il progressivo rigetto di ogni mistificazione spiritualistica, fino a trovare sullo scenario lucreziano per antonomasia, le pendici del Vesuvio della Ginestra, il luogo dell’approdo e dell’emblematica conferma e consacrazione (“Dipinte in queste rive / son dell’umana gente / le magnifiche sorti e progressive”, 49-51) in toni di vibrante polemica nei confronti del “secol superbo e sciocco”(v.53).
“Nam cum suspicimus magni caelestia mundi / templa super stellisque micantibus aethera fixum, / et venit in mentem solis lunaeque viarum, / tunc aliis oppressa malis in pecora cura / illa quoque expergefactum caput erigere infit (“Quando, alzato il capo, contempliamo gli spazi celesti / di questo vasto mondo, e le stelle scintillanti fissate nelle altezze dell’etere, / e il nostro pensiero si porta lungo i corsi del sole e della luna, / allora ci sorprende un’angoscia, soffocata sino a quel momento sotto altri / mali, e comincia a farsi sentire…”, V, 1204-1208).
Come resistere o reagire a questa cura, all’angoscia mista a stupore di un qualcosa di incomprensibile, se non disponendosi al miraculum delle cose, all’invenzione di un pharmakon di saggezza affiorante all’improvviso dalle cose più neglette, dal tempo fatto cenere e dall’oro dei roghi immensi e distruttori dei boschi primigenii, di cui non a caso Lucrezio parla subito appresso al brano citato (1241-1280)? E’ “dall’ombra e dal disprezzo” (e contemptibus, 1278), che può sbocciare, fecondato dall’ambrosia di una ratio tutta umana, il fiore della poesia, la parola capace di dar voce alle domande più profonde, esorcizzando ogni paura nel canto (requies hominum divumque voluptas, “riposo degli uomini e piacere degli dei”, VI, 94).
“Sovente in queste rive, / che, desolate, a bruno / veste il flutto indurato, e par che ondeggi, / seggo la notte; e su la mesta landa / in purissimo azzurro / veggo dall’alto fiammeggiar le stelle…”: sono versi centrali della Ginestra (158-163), in cui l’esperienza indefinibile dell’io, consegnata all’emblema di una fragilità resa onnipotente dal sentimento dell’umano e dalla consapevolezza della propria mortalità, acquista conforto e consistenza in virtù della perentorietà dell’interrogazione, dell’acutezza dello sguardo, portando sulla scena della lingua un’effervescenza energetica di sapere, a dispetto del silenzio e dell’avvolgente tenebra circostante, a dispetto della Notte e della terra ridotta a “flutto indurato” dalla cieca indifferenza della Natura.
In questi termini, a prospettarsi ècosìun orizzonte davvero nuovo e straordinario di lucidità e saggezza, in cui il dialogo del pensiero con il “solido nulla” (Zib. 85) di cui è allegorica figura l’indistinto notturno, connota l’intrepida energia di chi la sua battaglia esistenziale e morale sa di doverla combattere giorno per giorno attraverso la scrittura, con dialettica determinazione, fissando fieramente in faccia il proprio destino, “erta la fronte, armato / e renitente al fato” (Amore e Morte, 110-111) e disposto per essa “a sostenere ogni fatica” (quemvis efferre laborem, I, 141), nonostante il destino di sparizione di ogni vivente.
Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte e traduttore, è nato a Ceraso (SA) nel 1948 e vive a Como.
Ha pubblicato, in poesia, le raccolte Gli gnomi del verso (ER, Como 1979), Dieci inverni (Book Editore, Castel Maggiore, 1989), Grilli e spilli (Fiori di Torchio, Seregno, 1998), Una visione elementare (Alla Chiara Fonte,Viganello, Svizzera, 2005); Nel nome del Padre (Alla Chiara fonte, Viganello, Svizzera, 2008); Baladas (in lingua spagnola, Signum, Bollate, Mi, 2007); Ballate di attese e di nulla (Alla Chiara fonte, Viganello, Svizzera, 2010).
In prosa, ha pubblicato L’Angelo e il Tempo. Appunti sui dipinti della chiesa di Ceraso, Sa (Myself, Como 1987).
Per la saggistica, ha pubblicato Guida alla lettura di Verga (Oscar Mondadori, Milano 1986), Guida alla lettura di Leopardi (Oscar Mondadori, Milano 1987 e 1998) e inoltre presso Bompiani, Milano, le edizioni critiche di opere di Giovanni Verga (I Malavoglia, 1989, Mastro-don Gesualdo, 1990, Novelle, 1991) e di Leopardi (Diario del primo amore e altre prose autobiografiche, 1998), l’ Appressamento della morte, il carteggio Leopardi-Ranieri (Addio, anima mia, Aisthesis, Milano 2003), il romanzo di Antonio Ranieri, Ginevra o l’orfana della Nunziata (Aragno, Torino-Milano 2006).
Presso le edizioni della Vita Felice, Milano, ha pubblicato recentemente le novelle di Verga Per le vie, 2008, Libro delle preghiere muliebri di Vittorio Imbriani (2009) e Amori di Carlo Dossi (2010).
Per l’Editore Guida (Napoli) ha pubblicato Lario d’arte e di poesie. In gita al lago di Como in compagnia di artisti e scrittori (2010).
Per la Fondazione Zanetto (Montichiari, 2010), ha pubblicato una biografia di Antonio Ranieri, Un nome venerato e caro. La vera storia di Antonio Ranieri oltre il mito del sodalizio con Leopardi.
Ha curato le traduzioni dei Lirici greci (Bompiani, Milano 1991; nuova edizione 2009), dei Poeti latini (Bompiani, Milano 1993), dei Carmi di Catullo (Bompiani, Milano 1986 e Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005), dei Versi aurei di Pitagora (Bagatt, Bergamo 1988; Medusa, Milano 2005), dei versi latini di A.Rimbaud, Tu vates eris (Bagatt, Bergamo 1988), dei Canti Spirituali di Ildegarda di Bingen (Demetra, Bussolengo, VE, 1996) e del Poema sulla Natura di Parmenide (Medusa, Milano 2006).
Ha curato inoltre le antologie Infinito Leopardi (testi di poeti contemporanei, Aisthesis, Milano 1999), Il verso all’infinito. L’idillio leopardiano e i poeti italiani alla fine del Millennio (Marsilio, Venezia 1999), Interminati spazi sovrumani silenzi. Un infinito commento: critici, filosofi e scrittori alla ricerca dell’Infinito di Leopardi (Stamperia dell’Arancio, Grottammare, AP, 2001), l’antologia Caro Giacomo. Poeti e Pittori per Giacomo Leopardi (Edizioni di Cronache Cilentane, Acciaroli, Sa, 1998) e Giacomo Leopardi. Canti e Pensieri, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2005. Recentemente, una antologia da lui curata della poesia leopardiana, tradotta in spagnolo da Ana Marìa Pinedo Lòpez, El infinito y otros cantos, è stata pubblicata da LietoColle (Faloppio, Co, 2009).
Ha curato le antologie Poeti a Como DialogoLibri, Olgiate Comasco 2002) e L’AltroLario (Editoriale Como, Como 2004) e inoltre Ditelo con i fiori. Poeti e poesie nei giardini dell’anima (Zanetto Editore, Montichiari, Bs, 2004) e Parliamo dei fiori (ibidem, 2005).
Ha curato per Book Editore (Ferrara 1995) l’antologia delle poesie di Roberto Sanesi L’incendio di Milano e per La Vita Felice (Milano 2009) Dieci poemetti dello stesso autore. Nel 2010 ha curato l’antologia delle poesie dell’artista Agostino Bonalumi, Alter Ego (Ferrarin Incontri d’Arte, Legnago, VE).
Per la critica d’arte, si è occupato dell’opera, tra gli altri, di Luca Crippa (Castelli di carta. Tra disegni, collages e polimaterici di Luca Crippa, 2002), di Giorgio Larocchi (Sulle tracce di un “disegno perduto”. Giorgio Larocchi pittore, 2007) e di Mario Benedetti (In un regno notturno e labirintico, 2008).
È inoltre autore di una monografia sul regista e drammaturgo Bernardo Malacrida (Il teatro tra passione e missione, 2008) e della biografia di Antonio Ranieri (Zanetto Ed. Montichiari, Bs, 2009).
Nel campo dell’editoria scolastica, ha curato l’antologia latina per i bienni delle Scuole Superiori Giorni e sogni latini (Ediermes, Milano 1994, poi Zanichelli 2000), la storia della Letteratura Latina Litterae (Minerva Italica, Milano 1996) e l’edizione commentata dei Carmi di Catullo (Signorelli, Milano 2006).
È stato direttore della collana dei Classici Tascabili dell’Editore Bompiani. È Presidente del Comitato comasco della Società dante Alighieri. Collabora, come critico letterario e d’arte, a quotidiani e periodici.
Albino Crovetto, poesia inedita da “Cinque giorni”, con una nota di Marco Furia
Un necessario dire
Capita talvolta che un verso, come ho già avuto occasione di notare, riveli l'intima natura di un componimento: per quanto riguarda "Cinque giorni", di Albino Crovetto, credo che
"Hanno angoli e piani, esatte profondità"
possieda tale valenza.
Quest'assidua, raffinata e compatta versificazione si fa apprezzare per un'esattezza profonda, quasi un orologio battente un tempo tutto poetico ne dettasse il ritmo.
L'autore non ci abbandona mai, né si lascia dimenticare: è lì, assieme ad ogni pronuncia, ad ogni parola, ad ogni segno d'interpunzione.
Assieme, non dietro.
Non si tratta di una sorta di voce fuori campo o di una fantasmatica presenza, bensì di un'originale, genuina, attitudine ad esserci.
Per opera di una spontaneità naturale quanto costruita nei felici esiti poetici, emerge un complesso, elegante, fluire di versi i cui toni delicati (ma risoluti) sorprendono:
"Questa piazza non accoglie"
è contemporaneamente immagine topografica ed emotiva nella forma di una presa d'atto misurata e ferma, tale da non consentirci di dubitare dell'esattezza di un'espressione verbale così ricca d'energia.
Crovetto confida nel suo dire, non esita: una non comune propensione alla franchezza conferisce carattere al suo linguaggio.
Un individuo puòsentirsi quasi costretto a scrivere versi?
Sì e in questo caso per nostra fortuna.
da Cinque giorni
Sera del quarto giorno
Una moltitudine di luci,
una città verticale di morti.
Pulsano le luci, respira forte un animale,
s’inarca nel cemento.
Il balzo è assente:
a ritroso è carne rovesciata
il dentro fuori
trattiene slanci, chiude arterie.
Guarda i resti di un incendio
e sorregge tronchi.
Il nero verso l’alto
è in basso,
la corteccia bruciata è la sua pelle.
Quinto
In questi scaffali le cose
si sono alzate
con una forma simile al mattino:
un bianco liquido di sbarre dietro agli occhi.
Il richiamo che ho inviato
niente lo sorregge,
e se viaggia con l’aria
giunge
d’un tratto al fianco
di persone
mischiate dentro una stretta
di strade e di cancelli.
In basso una sequenza di fatti.
Questo fiume mostra le sue pozze:
argini nudi, una vertigine di bianco.
Un frutto spaccato i semi trascinati.
La pioggia scende
battendo colpi ripetuti,
teste distorte.
La nuca si contrae fino alla notte e oltre.
Albino Crovetto (1960) è nato a Genova, dove vive e lavora come fotografo e grafico. Compreso in antologie e riviste quali “L’erbaspada”, “Origini”, “Poesia”, “Arca”, “Frontiera”, “Il posto delle fragole”, ha pubblicato l’antologia La letteratura ligure (Costa & Nolan, 1982) e il volume di poesie Una zona fredda (Niebo/La Vita Felice, 2004), vincitore nel 2005 del Premio Lorenzo Montano per l’edito. Ha tradotto Arie di Philippe Jaccottet (Marcos y Marcos, 2000).
Guido Turco, inediti da “Qui non è più adesso”, con una nota di Giorgio Bonacini
La scrittura di Guido Turco, che è prosa e poesia insieme, manifesta il suo tratto distintivo nell’andamento meditativo e meditabondo che sorregge il girovagare del
pensiero e del vedere. E’ come se l’autore, in cammino dentro e verso luoghi non ancora circoscritti, portasse la parola alla scoperta di un paesaggio di “cose prima che queste usino tanti nomi”. E ciò che la fa avanzare è la percezione dell’esterno che emerge da un’interiorità fortemente, ma lentamente, disarticolata e poi riannodata con i nodi che una lingua (usata per produrre realtà e non per farsene trasportare) è capace di fare e sciogliere.
Per Guido Turco la creazione di un mondo scritto avviene con la ricomposizione di una frantumazione di particelle, di molecole all’interno di una nebulosa percettiva che vede raggrumarsi “l’immaginazione per capnomanzia”. Il fumo, dunque, le sue conformazioni che portano a riconoscere e a ricostruire continuamente la propria capacità di osservare; e in questa visione ciò che si scrive è propriamente ciò che la mente di-segna in scrittura. Prima nella virtualità e nella lucidità del pensiero, poi concretamente con la durezza dell’alfabeto.
Possiamo allora dire che l’autore operi in una direzione di introspezione, attraverso una narrazione senza eventi e, deliberatamente, “eventuale”. Ossia, ciò che accade prosegue il suo viaggio nei meandri di un percorso mentale che si ostina “a chiamare in modo differente una stessa realtà”. Ma il valore di raffigurazione (pur distorta e anamorfica) che questa poesia narrante dimostra è anche un’operazione di ispezione (specialmente nella seconda parte del testo) su colui che pensa e scrive. Un soggetto consapevole di non riuscire compiutamente a dire, ma lo dice ugualmente: con fratture di senso, polisemie significanti, allusioni conoscitive e forse illusioni di sapere o di cercare qualche dimestichezza con un reale inafferrabile.
In questi testi si concentrano due modalità dell’esperienza sensoriale: un punto di vista e un centro di visione. Il primo permette di scegliere una possibilità di vita per compiervi dentro le proprie peregrinazioni poetiche, con la sapienza propria della scrittura che ci si è dati; il secondo, più congetturale, impone la sua capacità di metamorfosi per ricreare e unificare il dentro e il fuori, attraverso lampi di saggezza “tra l’infinito e i suo ausiliari”. Ed è proprio l’interconnettersi e l’alternarsi di queste due modalità percettive che permette all’autore una consapevolezza precisa: la scrittura (prosa o poesia qui sono indistinguibili) congiunge, con la materialità del suo fare, la distanza visionaria e intellettiva (l’infinito) e le sue materiali delucidazioni discrete (gli ausiliari). Vista e visione, sapienza e saggezza, sono dunque i percorsi (labirintici, frastagliati, nebbiosi quanto si vuole) entro cui si svolge un lavoro pensante che prova a cogliere, a raggiungere, a svelare qualcosa muovendo parole.
da Qui non è più adesso
***
A me interessa la linea di tensione, gli inciampi, le stasi, le occasioni di trasformazione, il passaggio da una fase all’altra, noi dobbiamo rinunciare alla presa di posizione, stare presso i volti che possiamo fare, ora non appare niente, ma una smorfia filosofica rompe improvvisamente une regolarità stabilita, incolla e rende elastica questa tiritera, la fa risuonare, me la lega al dito, sul taccuino delle sconclusioni, perché non invecchiamo onestamente come le foglie, incessantemente aggiornati possiamo suturarci con il nostro divenire, di ogni cosa diventata solitaria seguire gli improvvisi srotolamenti.
Corpi conduttori
Viene nel seguito una descrizione del rallentamento dell’atto di andarsene le molte analogie con le frane di questi così inutili versi metafore già contenute nel diminutivo latino Lucilla una voce piena dei suoni della giungla città che fuggono perché non dormono ogni successiva rinascita una sfumatura di risveglio quel che basta per simulare la maga che trasforma i compagni in porci e salva dall’indistinto le più piccole pietre del destino dall’infanticidio l’immagine di una rosa ma non il suo profumo quel sorridente distacco che nasce dal lasciare le cose prima che queste usino tanti nomi e non si riesca ad apprezzarne la spogliazione.
After suffering a blood disorder
1
L’uomo che avevo sospettato di essere non dava a sapere cosa avrebbe voluto lasciare vissuto a farneticare davanti a un cartellone pubblicitario a esaurire quanto il genio più sublime sapesse esprimere in fatto di dolore angelico e femminile come di fierezza e compiacenza notti dal finale sfuggente ogni pagina trasformata in una farfalla tremolante del calore emanato dalle erbacce sassi e rovi chicchi sfarinati verdure selvatiche con il potere dell’ombra a riproporre la profondità appiattita del pianoro. Domandò ad altri la soluzione ma raggiunti i limiti parve meglio tacere, lasciare irrisolto l’irrisolvibile.
2
Conduceva indagini eccentriche. Ne otteneva un lampo che acceca e non dice nulla, squarcia e allude alla paranoia del sapere che non si potrà sapere, conoscere nulla di come viene trattata la propria vita, ecco tutto è detto e cancellato cantato urlato scomparso dentro il congegno. Manteneva l’illusione che tutto quello bastasse per registrare autentici capolavori. Deambulava nelle immagini come fossero gesti secchi, fotofinish.
6
Anche i temi della guerra avevano un certo risalto, corrispondente grosso modo a grida di scorreria, canti di trionfo e canti di gioia. Combinava volentieri questa polifonia con armonie aggiuntive e assemblava vari temi tra cui quello sulla notazione del vivere secondo il carpe diem, questioni relative alla fiducia nella scienza e, forse l’eccentricità, forse il disprezzo e l’indifferenza per le cose. La vita ci perseguita per sempre con i sacramenti di supposti anni felici, il ricordo che ci fosse un albero che stormisse e che avesse già cominciato a piovere, armi bianche che bisogna istruire cercando di colpire le api della disperazione nel ventre, le loro abitazioni fatte di gambi di asfodelo e di giunco. Si fece un tatuaggio dei due protagonisti della storia, impegnato affinché la voce che graffiava il cuore non citasse nessun personaggio. La luminosità s’attenuò ancora.
Guido Turco (1959) vive in Francia. Nel corso degli anni, insieme a raccolte di poesia (Le Traduzioni dal Mondo, 1993; L’Indizio della Grazia, 2002; La Musa Estinta, 2004) e al saggio su Poesia e paesaggio (Lietocolle 2006), ha proposto lavori come combinazione di scrittura e immagine, i cui esiti sono confluiti in diverse esposizioni.
Alessandro Assiri e Chiara De Luca, da “sui passi per non rimanere”, Fara 2008, con una nota di Rosa Pierno
Non esattamente un dialogo a distanza e anzi nemmeno un dialogo, pure se le poesie di Alessandro Assisi (sulle pagine pari) e di Chiara De Luca (sulle pagine dispari) si fronteggiano. Potremmo certo pensare che è solo la comune passione ad averli spinti verso un comune progetto. Anche se proprio la lettura dei due rispettivi modi poetici ci dà la possibilità di verificare un’ulteriore affinità nei modi trasversali e lacunosi che queste due originali forme di scrittura possiedono. Una tramatura: come se la poesia fosse una rete che ci consenta di afferrare e di perdere insieme, ma facendoci rendere conto, come attraverso una bilancia, di ciò che tratteniamo e di ciò che invece ci è sfuggito. Se in Assiri, infatti, c’è un costante senso di perdita - siano riferimenti o oggetti, sentimenti o certezze razionali - che sembrerebbe colpire persino lo spazio e il tempo: “ disperarsi a pochi passi da casa / dove il tempo non è pieno / ma solo arrotondato per tornare”, in De Luca c’è uno sgomento rispetto al potenziale uso del senso “a tradire che il messaggio l’avevamo / con gli occhi al buio forte decifrato, / sfatto in sillabe da sciogliere nel vento / per ricondensare a caso un senso”. Certamente un malessere di fronte all’infondatezza o alla fondatezza relativa o una sensibilità troppo acuta dell’inutilità del comprendere, eppure l’ineludibilità dell’atto è apertamente dichiarata: non si smetterà per questo di cercare e di scrivere poiché nella rete qualcosa resta e serve. Infatti, al fondo di questa miracolosa pesca, seppure non si ricomponga per Assiri la figura cercata disegnando (“come ti immagino vivi / bagnata così come ti dipingo”) e se per De Luca si tratti solo di un’operazione di dissimulazione, quasi uno stato perenne di difesa (“sono tinte forti che fingo / aver perduto, cose ) pure resta forte un ancoraggio a uno zoccolo duro di realtà da cui prendere le mosse o a cui tentare disperatamente di far ritorno. Poesia serve a reinventare la vita.
da sui passi per non rimanere
***
Il tempo ha evacuato la terra dei fantasmi
snudato le lunghe lance della luce
che sfiora il tocco lieve dell’aria,
mentre si allungano ad accarezzare
insinuando la punta sul tavolino
per raddoppiarmi d’ombra le mani,
cammino dove più non potevo,
è solo chi il buio l’ha sceso
a vedere dove viene l’amore
come un fuoco dentro distante
in sentieri che non hanno riparo.
Chiara De Luca per non rimanere
***
sono sui passi per non rimanere
come ieri, o era un altro magari
un viaggio che si adatta
al non essere più vero
di questo silenzio sceso
su chi non ti usa
su chi non ti chiama casa
per restare a bocca chiusa
Alessandro Assiri sui passi
***
Nel tempo s’impara a migrare internamente,
per cambiare casa non occorre traslocare:
sbiadiscono le voci come stanche foto
non danno nostalgia paesaggi già sommersi,
s’incartano i ricordi belli per riporli
come ciò che del vissuto è stato risparmiato.
E’ una musica l’assenza che sfuma intensamente,
siamo note nel vuoto a cercare uno spartito
e non resta bianco all’infinito il pentagramma.
Chiara De Luca per non rimanere
***
vedi torniamo a esser deboli
in ogni giorno che al futuro assomiglia
in un posto speciale dove
tragicamente
disperarsi a pochi passi da casa
dove il tempo non è pieno
ma solo arrotondato per tornare
Alessandro Assiri sui passi
***
Forse per aver svestito a lungo le parole
immobile spiato dietro vetri inesistenti
premuto forte porte aperte per scoprire
nessuno a sporcare il bianco dell’attesa
l’urgenza segna adesso l’andatura
di un dire che non ha piùil tempo
di bussare
Chiara De Luca per non rimanere
***
derivare è provenire
galleggiando dal fiume
prosciugato dalle pietre
levigate agli angoli
smussate
derivare è proseguire
tirar dritto verso il mare
Alessandro Assiri sui passi
Chiara De Luca, nata a Ferrara, scrive poesia, narrativa, saggistica e per il teatro. Traduce da inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Ha pubblicato con Fara i romanzi La Collezionista (2005) e La mina (stra)vagante (2006). Per la poesia, La corolla del ricordo e animali prima del diluvio, entrambi nel 2010 con Kolibris Edizioni.
Ha creato le Edizioni Kolibris, dedicate alla traduzione e diffusione in Italia della migliore poesia straniera contemporanea: www.edizionikolibris.eu
Alessandro Assiri è nato nel 1962 a Bologna. Si occupa di arte e di promozione culturale nel territorio. I suoi ultimi volumi di poesia sono Quaderni dell’impostura (Lietocolle 2008) e La stanza delle poche righe (Manni 2010).
Carlo Invernizzi, da “Secretizie”, Mimesis 2009, con una nota di Rosa Pierno
Collocarsi tra due mondi stando in bilico su una parola: parlare di scienza o, almeno, utilizzare il vocabolario relativo all’attività scientifica per virarne subito il significato costruendo un’immagine come se si stesse osservando un quadro, è l’operazione da equilibrista che Carlo Invernizzi nel suo “Secretizie” attua. Ma è, in qualche modo, anche reclamare al proprio ruolo poetico una capacità di rappresentare che non è immediatamente visibile negli astratti bollettini che rendono la conoscenza scientifica una pura registrazione di eventi. Nella poesia di Invernizzi, gli ioni infigurabili vengono di fatto rappresentati con uno sciame di parole: pertiche luce, stambecchi luce, schidieluce e ricevono una colata di verbi che s’incaricano di raccontarne l’esistenza: allampano, fiammeggiano, s’avventano, arrambano, s’infugano. Ma ancora più frequenti sono i versi in cui il soggetto e il verbo vengono a mancare e quello che si consuma nel buio è pura luminosità: “Frammentità diafane / invano apparibili / nelle specole d’illuminio / dell’infosco indistinguibile”. Il passo è breve e notiamo che sul foglio vengono convocati tutte le parole con cui si indica l’inesprimibile: immanifestabile, imprevedibile, invisibile, inlimite, inconoscibile, impenetrabile, inesplorabile, indistinguibile. Quasi un controcanto al fuoco pirotecnico linguistico messo in atto per rendere l’inesprimibile un oggetto descrivibile. Siamo sull’orlo del paradosso, ma d’altronde anche di un esercizio portato a termine: l’irrappresentabile è di fatto reso vividamente dinanzi ai nostri occhi, diremmo, per la capacità di Invernizzi di rendere visibile la sua pagina, di renderla comunicativa come una superficie pittorica animata da colori e da moto, da luci e da pesi, in un tour de force che tende le parole, le deforma, le stravolge e dona loro una persistente scia.
da Secretizie
***
Chi sa d’entropia
non ignora l’instabile
informe
movimento di molecole
che in polimeri s’aggrumano
derivano in trame inquiete
s’aggregano in macchie bilenche
erratiche
che brulicano
sui picchi della mente.
(1983)
***
In fluttali altitudini
perpendicole fuggitive
di abbaglio in abbaglio
tra luminanze stigie
di là dal vuoto che remiga
dell’escluso confine.
(1988)
***
(I colchici)
Esangui
eppure risplendenti
questi colchici sulle chine
lustri di gelobrina
impettiti nel loro niente
già in dissolvo
nel vortice senza fine.
(1996)
***
Nel ventre del niente
viscere vortici
infoco di stelle
s’incende la vita
arsa
risplende invano al nascimento
ventoluce insazio d’incenero
in catastrofi senza fine
d’annichilo.
(2001)
***
Nell’insecco
stremato da arsura
d’un tratto m’incolsero
nell’oscurità
allampi d’annaspiluce
scintillanti in vortico
sanguerossastri
sull’invertico di sprofondi tetri
in vano abbranco
troncati di baratro in baratro.
(2008)
Carlo Invernizzi vive e lavora a Milano e a Morterone. Fa parte del gruppo “poiesis” fondato da Maria Vailati. Pubblicazioni recenti: Carlo Invernizzi. Natura naturans, Milano 2002; Canto silente, Morterone 2006; Pura eco di niente, ivi, 2008; Ingrumolita, Roma 2008.
Marinella Galletti, poesia inedita “Soloacqua”, con una nota di Marco Furia
Un dinamico dire
Con "Soloacqua" Marinella Galletti presenta un agile componimento dall'intenso dinamismo.
Un mondo d'acqua, di mare, di scogli, di sabbia, non privo di tratti esistenziali, prende forma nelle cadenzate successioni di una poesia che si offre come immagine, come affascinante scaglia di vita la cui peculiare caratteristica pare appunto quella di un assiduo, elegante, movimento.
Marinella corre assieme ai propri versi, quasi le sue parole, pur impresse sulla pagina, tendessero a fuggire ed occorresse un'ulteriore, vigilante, energia per tenerle assieme.
Non si pensi ad un imperfetto controllo del linguaggio: al contrario, intendendo comunicare certe impressioni, l'autrice costruisce attentamente lo strumento idiomatico adatto per via di ritmici passaggi che propongono lineamenti esatti, precisi.
Le immagini scivolano l'una sull'altra, ma sono definite, mai ambigue, esito di scelte poetiche volte ad un dire per nulla incerto.
Ricordo i versi
"Vie profonde e lontane."
e
"Molte acque in mare."
Si tratta di pronunce concise, concluse dal punto fermo, in grado di ben rappresentare un vivido senso di continuità: quei punti non fermano, non costituiscono, a ben vedere, nemmeno pausa, bensì rendono testimonianza della necessità d'aspetti utili a proseguire un certo discorso.
Il discorso inedito ed affascinante di questa poesia.
Soloacqua
Dal mare allo scoglio.
Nel già bruciato corso
inesplicabile del tempo
un giorno prima atteso
entro luoghi compressi
solo i mari posati sulla
riva solo ramo disteso
che ho trascinato sullo
scoglio non voglio che
anche tu ora incontrato
sia del giorno sia finito.
Solo d’acqua il giorno.
Più giorni sono trascorsi
come lampi come corse
lungo rive e poi discese
mi ricordo mi rivedi steso
un velo sulla spiaggia la
tua acqua le mie braccia
in confini destinati oltre
linea d’orizzonte senza
cielo solo acqua solo a
braccia dentro l’acqua.
Sassi come cuori e luci.
La via del primo giorno
un luogo che non sia del
tempo l’immagine né
il fuoco il centro il perno
ma il mare il mare eterno
ovunque sia che corra e
sia imprendibile l’acqua
tra le pietre in luci mosse
sopra il diedro legno arso
in cielo il sole è apparso.
Vie profonde lontane.
Prospettive del giorno
il cielo s’apre al mare
e a conchilifera sabbia
calamita d’orme forme
gridi e ombre di stormi
quale finestra e sfondo
di salite ed immersioni
e di più lontane strade
oltre lo schermo piano
del cielo a cui miriamo.
Molte acque in mare.
Basteranno questi lievi
giorni senza notti sugli
spalti di cemento dei
moli sotto i venti acque
gettate oblique scrosci
varie spume orizzontali
su noi due fatti animali
scaglie sulla nuda pelle
abitiamo come l’acqua
come il vento risaliamo.
Marinella Galletti (1957), autrice di opere di narrativa, poesia e arte visiva, si occupa di “arteterapia”. Sintesi della sua ricerca letteraria e artistica, “la modularità”: parole e dipinti come cellule di un racconto visivo. Nata a Casalecchio di Reno (BO) nel 1957, insegna Disegno e Storia dell’ arte al Liceo Classico “Cevolani” di Cento (FE), dove vive.
Tra i Musei e le Collezioni in cui compaiono sue opere d’ arte, vi sono CSArt Reggio Emilia; WORLD MUSEUM Cesano Maderno (MI); MUSEO MAGI900, Pieve di Cento (BO); GALLERIA D’ARTE MODERNA BONZAGNI, Cento (FE); CASSA DI RISPARMIO, Cento (FE). Tra i più recenti riconoscimenti letterari, nel 2006 è vincitrice del Premio LORENZO MONTANO “Raccolta Inedita” con pubblicazione dell’ opera “Dentro alle fonti”, Anterem Edizioni (VR), opera che risulterà finalista nel 2008 al Premio CITTA’ DI CASTROVILLARI per il “Libro Edito”. Pubblica nel 2008, con Ennepilibri (IM), la silloge finalista al PREMIO GIORGI 2000, “UN comunque PAESAGGIO”.
L’ opera d’ Arte Visiva e Poesia “EVA E ADAMO Percezione dell’ esperienza d’ amore” Nuovecarte (FE) 2008, è segnalata, ancora inedita, nel 2007 da FARA EDITORE, e nel 2008 al Premio LA CITTA’ DEI SASSI (MT). Vincitrice del Premio CITTA’ SANT’ AGATA DI MILITELLO 2006 per il “Racconto Inedito”, è finalista nel 2008 al Premio Città di Forlì FOSCHI EDITORE per il “Romanzo Inedito”.
Nel 2009 riceve menzione di merito al Premio L’ AUTORE che ha curato la pubblicazione e uscita editoriale del romanzo “Gli stormi nel cielo”, MAREMMI EDITORI FIRENZE LIBRI nel 2011. Nel 2010 è finalista al Premio Lorenzo Montano, per la “Poesia Singola”.
http://marinella.galletti.literary.it
http://marinellagalletti.oneminutesite.it
Camillo Pennati, poesia inedita “Pino marittimo”, con una nota di Marco Furia
Un poetico fare
Nell'aprire "Pino marittimo" con le parole "A fare", ripetute all'inizio del secondo verso, Camillo Pennati pone in essere un nucleo d'energia idiomatica capace di conferire peculiari caratteri a tutto il componimento.
A fronte dei molteplici significati attribuibili a simile replicata pronuncia, importa, in questa sede, richiamare l'attenzione sull'emergere di un lineamento linguistico ricco d'originalitàespressiva: quel "fare", labile e, nel contempo, tenace, sembra alludere all'accidentalità d'ogni possibile frangente della vita.
Si è in presenza, insomma, di spiccate valenze evocative: viene mostrata un'immagine proiettandola su uno schermo così vasto da renderla immensa.
Non incerta, si badi, bensì estremamente ampia.
L'elemento attorno al quale ruota il fluido scenario è costituito da quel "pino marittimo" che dà titolo alla poesia.
Un albero si staglia, alto, "contro il cielo" accanto a (contingenti) situazioni specifiche dell'umano esistere: non si tratta di simbolismo, ma di un esserci nel medesimo tempo.
Il paesaggio (spiaggia sabbiosa, battigia), ben lungi dallo svolgere il ruolo di quinta scenografica, è presente, in maniera vivida, accanto a complesse condizioni esistenziali nel cui ambito due individui sembrano rispecchiarsi secondo rapporti tanto distinti, quanto privi di rigorosi confini.
In chiusura, al doppio richiamo dell'incipit fanno da contrappunto riflessi acustici ("quel sopraggiunto risuono") non certo volti a porre per sempre termine ad un'affascinante successione di versi che tende a restare aperta, a non finire.
Con l'intimo, assiduo, ritmo di chi riesce nell'ardua impresa di costruire linguaggi davvero originali, Pennati offre al lettore sequenze repentine e armoniche, intense e leggere, raffinate e non artificiose.
Un'ulteriore prova di consapevole dire poetico?
Sì, senza dubbio.
Pino marittimo
A fare nell’immaginare sconfinato un blu spaziale
a fare sulla pelle lo sciacquio del mare
e della sabbia i corpi là adagiati a contornare
in quel residuo bagliore primordiale
basta un pino marittimo
che svetti contro il cielo la sua chioma
e il tronco nell’avvolgente volume dell’aria
al tuo attratto guardare
anche da qui in una lontananza del sostare
da una battigia che risuoni quel lambire
se adesso non ne cogli il rapinoso
palesarsi della sgombra visuale
da allora nel trascorrere da quando in te
l’esistere e la vita l’uno nell’altra
non erano mentr’erano per singolare consistenza
quella distanza apparentemente tanto
e non così di sua parvenza irreale
anche se sempre d’illusorietà consustanziale
nell’eco di quel sopraggiunto risuono.
Camillo Pennati è nato a Milano nel 1931. Ha pubblicato Una preghiera per noi (Guanda, 1957); L’ordine delle parole (Mondadori, 1964); Erosagonie (Einaudi, 1973); Sotteso blu (Einaudi, 1983); Di sideree vicende (Anterem, 1998); Una distanza inseparabile (Einaudi, 1998); Modulato silenzio (Joker, 2007). Vive a Todi.
Carolina Giorgi, inediti da “Leggendo Emily Dickinson”, con una nota di Giorgio Bonacini
All’apparenza, questa raccolta di Carolina Giorgi, si presenta come una personalissima scelta di poesie di Emily Dickinson tradotte. E indubbiamente lo è. Ma entrando più a fondo, come si conviene davanti a versi così speciali, ci si accorge che l’autrice scrivendo, e accogliendo in se stessa e smuovendo le pulsioni che stanno nei versi letti, crea qualcosa che potremmo definire un oggetto d’arte interiore.
Di chi sono le parole di questa raccolta? Di Emily Dickinson o di Carolina Giorgi? Sembra una domanda retorica, una fantasia emotiva, ma non lo è se disponiamo il nostro sguardo in modo non usuale, e con un preciso angolo visivo che ci permette un’interpretazione e forse una comprensione. Vediamo infatti che l’autrice portando a sé e costruendo (nel senso del fare che attiene alla poesia) con parole altre una sua opera, non sposta semplicemente la scrittura da una lingua all’altra, ma riesce a dare forma, pensiero e materia a una sua poesia autonoma. La poesia, in generale, inizia sempre da proprie scelte paradigmatiche (una visione, un pensiero, un’ immagine, uno sguardo, una cosa, ecc.) che, nel caso specifico confluiscono tutte in una preferenza per altre parole. Ma per Carolina Giorgi, probabilmente, ciò che è veramente importante è la singolarità dell’esistenza di queste poesie dell’autrice americana: poesie scelte una ad una e riconsiderate nelle parole di un proprio sentimento linguistico. E non si discute qui di un esito mimetico, ma di come, a partire da una lettura poetica, si dia altra poesia.
Possiamo certamente leggere i testi della nostra autrice confrontandoli con ciò che li origina, oppure in modo autonomo come rinascite personali, ma crediamo sia più vitale un punto di vista diverso. E’ come guardare il paesaggio da un vetro: si può focalizzare il paesaggio o il vetro, ma una percezione ricca di sensi si ottiene nello spazio visivo che mischia vetro e paesaggio, con una continua alternanza della visione. Si potrebbe dire allora che è lo spazio presente fra le due autrici, la sua trasparenza, a raccogliere le vibrazioni delle voci e ad accoglierne il richiamo che genera e rigenera i versi.
In questo senso la poesia è sempre traduzione: portare altrove il proprio dire, ricombinare le significazioni, incorporare un suono e riportarlo a nuova voce. E l’andamento della voce in Carolina Giorgi è fondamentale per assorbire i tratti distintivi che, nella sua traslazione, caratterizzano l’opera di Emily Dickinson, e di rimettere nuovamente al centro della sua esistenza la parola che è riuscita a trovare: il fulcro poetico che dice la cosa e la trasforma. E’ questo il tragitto che si compie dentro una riflessione linguistica e sensoriale: lì dove il poeta (ma anche ogni lettore quando è in cerca di senso) trova, o rende necessario trovare, molteplici direzioni e spesso oscuri passaggi.. E in questo modo il pensiero non può non diventare, pur nella costante consapevole precarietà di chi scrive, un momento insostituibile che “ci coglie a trasalire -/noi - di un attimo/immortali ”.
da Leggendo Emily Dickinson
[1674]
Not any sunny tone
From any fervent zone
Find entrance there –
Better a grave of Balm,
Toward human nature’s home –
And Robins near –
Than a stupendous Tomb
Proclaming to the Gloom
How dead we are –
Nessun nodo di sole che
da qualche dolco luogo
possa entrarvi –
vorrei rupi di resina
con rondini e dell’uomo
ancora accorte –
non arnie d’urne splendide
che adornino di oscuro
la mia morte –
[391]
A Visitor in Marl –
Who influences Flowers –
Till they are orderly as Busts –
And Elegant – as Glass –
Who visits in the Night –
And just before the Sun –
Concludes his glistening interview –
Caresses – and is gone –
But whom his fingers touched –
And where his feet have run –
And whatsoever Mouth he kissed –
Is as it had not been –
Verrà d’argilla un ospite –
che al fiore arando affini –
a farne statue – la
corolla – e vitree trine –
che – all’albino effuso – stinga il
verboso scintillio –
e di levità sfiorando
il buio – vada via –
ma chi di un tocco alle sue dita –
e luogo – al passo –
e bocca al bacio arrise –
da ora visse –
[536]
The Heart asks Pleasure – first –
And then – Excuse from Pain –
And then – those little Anodynes
That deaden suffering –
And then – to go to sleep –
And then – if it should be
The will of its Inquisitor
The privilege to die –
Dapprima gioia –
poi – dal rogo si assolva –
poi – a tregua dal buio
uno scudo di malva –
adesso – infine
chiede il cuore – l’agio al sonno –
e – se concesso –
il privilegio di morire –
[761]
From Blank to Blank –
A Threadless Way
I pushed Mechanic feet –
To stop – or perish – or advance –
Alike indifferent –
If end I gained
It ends beyond
Indefinite disclosed –
I shut my eyes – and groped as well
‘Twas lighter – to be Blind –
Al vuoto – elude il dove –
inducendosi il mio passo –
se avanti – disavvede –
se innomade –
se muore –
avessi fine e infine,
infinitezza!
celo gli occhi
e incedo
meno cieca –
[217]
Father – I bring thee – not Myself –
That were the little load –
I bring thee the departed Heart
I had not strength to hold –
The Heart I cherished in my own
Till mine – too heavy grew –
Yet – strangest – heavier – since it went –
Is it too large for you?
Padre – di me stessa
il dono è poca cosa –
ti offro il cuore avulso
di cui mi vinse il peso –
reco il cuore che fu prole
del mio finché lo ressi
che – perduto – mi è più greve –
è d’improba grandezza? –
Carolina Giorgi è nata a Mantova il 18 novembre 1973. Dopo gli studi classici, si è laureata al Dams con una testi sperimentale in Semiotica dello spettacolo (La comprensione dello spettatore). A Bologna ha effettuato alcune collaborazioni in ambito teatrale e musicale. Giornalista pubblicista, ha collaborato con il settimanale La Cronaca di Mantova e con il mensile nazionale A tavola. Una raccolta di sue poesie è stata pubblicata nel volume Hemeros (Verona, 2004), è quindi entrata a far parte del consiglio editoriale della collana Opera Prima. Suoi testi poetici sono apparsi sulle riviste Poesia, Hebenon e sul webzine Transfinito, e citati su Il segnale.
Ha pubblicato il romanzo Le spine di Venere (Firenze, 2005), medaglia d’argento al Premio Letterario Internazionale “Maestrale - San Marco” (Sestri Levante). Nel 2007 è stata nella giuria del concorso di scrittura erotica indetto da Loveline, talk show di Mtv Italia. Autrice di prefazioni a testi poetici e antologie artistiche, è oggi impegnata a tempo pieno nella scrittura.
Sebastiano Aglieco, poesia inedita “La resa delle foglie”, con una nota di Marco Furia
La lingua delle foglie
Con "La resa delle foglie", Sebastiano Aglieco presenta una composizione in cui elementi tratti dall'ambiente naturale si connettono alla sua stessa vita: il verso
"Se potessi fermare il vento con le mie parole"
pare emblematico.
Il poeta ipotizza addirittura di riuscire a trattenere il vento con le sue parole, ossia di poter adoperare con profitto lo strumento linguistico oltre la dimensione umana, in maniera semplice, diretta, non per via di scienza e tecnica.
Questo è il punto.
Perché gli alberi, gli uccelli, le nuvole sono insensibili al nostro idioma? Perché non parlano?
E' banale rispondere che la lingua, tipica dell'uomo, estende le sue facoltà, in maniera ridotta, ad alcuni animali domestici o addomesticati: è banale, senza dubbio, ma proprio su questo il Nostro s'interroga.
Certi mutismi a lui dicono qualcosa.
Dicono, se non altro, delle vicende di un'umanità che accanto al mondo pone modelli, schemi, paradigmi, in maniera incessante, talvolta perfino eccessiva, dicono, insomma, di un ambiente dal quale non siamo separati da rigidi confini:
"Le nuvole calme vedono il mio quaderno".
Le "foglie", così, sono "sorelle" imploranti un perdono dovuto perché l'empatia o, meglio, la compassione coinvolge ogni aspetto dell'esistente accomunando in una visione generale noi stessi e tutto quanto ci circonda.
Con pronunce chiare, articolate in cadenze la cui musicalità pare a tratti celarsi in una sorta d'espressionismo sonoro implicito ma efficace ("rimanere tra una pausa e / il canto della voce oscura!"), non alieno da propensioni descrittive né da improvvisi impulsi visionari trattenuti entro trame poetiche coerenti, Sebastiano Aglieco mostra come un intenso desiderio, pur consapevole dei propri enigmatici aspetti, possa continuare a sussistere in maniera proficua.
L'enigma può essere d'aiuto, davvero.
La resa delle foglie
Ogni tua parola ripetuta
è aperta nella bocca e battezzata
alla luce dei vivi. E’ per sangue
che mi spargo, per lasciarmi
attraversare dalla tua mancanza.
Dammi, ora, ciò che mi spetta
lascerò la casa del padre
con la lama puntata dritta
alla mia destra e verrà la notte
dai fondali, un mantello di rose
che hanno la bocca misteriosa delle favole.
Saremo amati nella chiarezza
avremo una voce per pane
nella campana della sera.
Cala improvvisamente il vento.
Il figlio suona una canzone
che tocca le foglie
il serpente si affaccia dalla sua contaminazione
adesso puoi ridere di me.
Se potessi fermare il vento con le mie parole
guardarti con l’amore e
le braccia che non conoscono
toccare il suono pulito che
dorme nella tua testa
rimanere tra una pausa e
il canto della voce oscura!
Cerco una musica in me
una storia consegnata per anni
a questa pelle sottile
cerco la semplice resa e la bocca
nel punto in cui, improvvisamente
nella misura del pane, siamo felici.
Le nuvole calme vedono il mio quaderno
forse lo sguardo del mondo si consuma
nel fiato delle nostre piccole bocche.
E siete qui, sorelle foglie
case dai tetti affacciati come braccia
implorate il perdono che i fratelli vi devono
aprite questo sguardo ai campi arati, in pendìo
tra le pieghe delle nostre sere!
e tuccàti, sulu tuccàti sti me paroli
e rusicàtili, spalancàtili o nenti.*
*e toccate, semplicemente toccate queste mie parole
e corrodotele, spalancatele al nulla.
Sebastiano Aglieco è nato a Sortino (SR) il 29/01/1961. Ha pubblicato diversi libri di poesia. Gli ultimi sono: Giornata, La vita felice 2003; Dolore della casa, Il ponte del sale 2006; Nella storia, Aìsara 2009; e il libro di saggi Radici delle isole, La vita felice 2009. Insegna nella scuola elementare.
Il suo blog : Compitu re vivi (miolive.wordpress.com)
Daniele Mencarelli, da “Bambino Gesù”, Nottetempo 2010, con una nota di Rosa Pierno
C’è una sorta di pudore, necessario e ineludibile, quando si tratta di descrivere il dolore che i familiari provano per la malattia dei propri bambini. D’altronde, va subito detto che l’autore, Daniele Mencarelli, nel suo “Bambino Gesù”, dà voce a un operatore dell’ospedale, non è un parente direttamente coinvolto e pertanto solo da questa distanza, si può tentare di dirne qualcosa. Come, infatti, descrivere un tale dolore se non da una posizione esterna, quando non ci sia una distanza temporale a fare da diga e filtro. E, dunque, con un linguaggio piano, quasi scolastico, in presa diretta – linguaggio che Mencarelli utilizza anche per le due altri parti della sua silloge che trattano temi legati alla memoria e alla descrizione di paesi – avviene la registrazione del dolore altrui: “La tua voce l’ho sentita questa sera / tremenda come il tuono che preannuncia, / ed è arrivata mostruosa la tempesta / un uragano di lacrime e delirio”. Nel luogo in cui si concentrano fisicamente i corpi investiti da tale funesto evento, quasi un paese l’ospedale, Mencarelli cerca di disegnare una piantina di orientamento, di rendere familiare ciò che ripugna, di condurre a mansuetudine l’orrido ambiente. Esiste una condivisione del dolore fra chi soffre e chi vede la sofferenza altrui, qualcosa che travalica qualsiasi altra differenza, che può servire da puntello per sopravvivere, come esiste una naturale difesa di chi non è coinvolto direttamente, ma ne condivide lo spazio e vuole allontanare da sé le visioni di bambini morenti e di madri che paiono fantasmi. Parla, in relazione a sé, di abitudine alla frequentazione, al pianto delle madri, ma forse in un modo in cui trapeli che stia mentendo: non è mai possibile essere estranei a un tale dolore. In una sorta di elenco di tutti i possibili comportamenti, di tutti i possibili modi di affrontare la pena e il disgusto, Mencarelli non è un osservatore scientifico: passano attraverso le sue parole i sentimenti di chi si sente parte in causa e le sue parole raggiungono anche il lettore, irretendolo nella medesima rete di dolorosa partecipazione.
dalla sezione Bambino Gesù ospedale pediatrico
***
Ed è da quando ti ho incontrato,
“Bambino Gesù”, ospedale pediatrico,
che il pregarti quasi mi vergogna,
io come altra fortunosa umanità
a invocarti per la piùvana delle miserie,
ignari di quanti nel pieno del supplizio
cerchino tua voce col poco fiato rimasto
o i tuoi lineamenti nel buio della stanza.
Se valgono questi versi una preghiera
dai giorni, anni, a questi uomini futuri,
ora bambini che forse non vedranno
la fine di questa sera di settembre.
***
(padiglione S. Onofrio)
Lode al più grande artista vivente
al suo genio alla sua opera immortale,
lode a quel ragazzino o ragazzina
che ha trasformato in arte pura
gli strumenti della quotidiana sua tortura,
un cielo fatto di azzurre mascherine
le nuvole di garza e ovatta idrofila,
le verdi chiome degli alberi
con il cotone della camera operatoria,
creati con tubicini trasparentie colorati
gli uomini le case gli steccati.
Lode a te che davvero patisci la tua arte
non nei pensieri ma nel male della carne,
il tuo capolavoro è appeso fuori la cappella.
dalla sezione In marcia
***
A Giovanna Sicari
Roma è arterie gonfie, gente
in marcia, congestione di vita dietro vita,
e pensare che qui abbiamo amato l’infanzia
mischiati nel tempo come forestieri.
Forse, tra i banchi di piazza Vittorio
o d’estate a Ostia nel mare degli umili
io e te ci siamo visti e sfiorati
sorrisi e ringraziati, te ragazza in fiore
io bambino appena, ci siamo visti
e per un attimo amati, non importa per cosa.
***
A Raymond Carver
Certo di dettare il passo
chiedi strada nessuno ti resiste,
l’occhio inquadra meccanico lo specchietto
dietro di te una macchia lontana,
torni con lo sguardo alla strada
giusto il tempo d’accordare le tue ruote
alla curva larga senza freni,
alle tue spalle quella macchia ha preso forma
rossa appuntita ad un palmo dall’asfalto
voce purosangue d’acciaio e carbonio
perfetta opera d’uomo a Dio gradita,
senza bisogno di chiedere permesso
sposta la tua marcia al centro della strada.
dalla sezione Guardia alta
***
Cose bellissime questi occhi vedono
assolati paesi sotto il gelo dell’inverno
riposano nella mattina di domenica,
invita l’Appia deserta a Roma lontana,
ed eccola nitida la città grande
fino alla cupola piùalta si presenta,
brilla un confine di mare dall’altra parte.
La mia casa è fin dove arriva lo sguardo,
questo palmo di terra, tutta mia vita.
Daniele Mencarelli (Roma, 1974) ha lavorato come operaio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e da diversi anni si occupa di fiction alla Rai. Ha pubblicato le raccolte di poesia I giorni condivisi La Nuova Agape, 2001) e Guardia alta (La vita felice, 2005).
Mario Fresa, inediti da “Aura”, con una nota di Giorgio Bonacini
La scrittura che si costituisce in poesia vive una duplice natura: può essere sfuggente e in costante disequilibrio e, nello stesso tempo, è concretezza che diventa, in modo indissolubile, ciò che dice nel modo in cui lo dice. In questo senso, il testo diventa una cosa. La poesia, allora, non è più solo se stessa in parola, ma si trasforma in un oggetto in cui non è possibile distinguere (se non si vuole svilire la sua significatività) la materia che la dice - la lingua -, dalla sostanza detta - l’opera -.
In queste pagine, Mario Fresa, ci dimostra che la sua scrittura si presenta da subito come “un fiore, un nome, un sacrificio”, dunque in un costante tentativo di costruirsi la sua validità (l’autore, in modo più etico, dice “la dignità”) che abbaia il senso di un libro. E quando questo accade, la voce che ne dà consistenza non ha più alibi, non può più sfuggire a un destino, prima impreciso (quando è in atto il solo pensiero), poi indicato (quando la voce comincia a darsi parola scritta) e ora segnato (quando l’opera si incarna in sé), dove tutti i sensi si originano e tutte le trasformazioni possibili di un reale contemplato o sognato diventano, oscuramente o limpidamente, ciò che sono in se stessi. La parola, che per Fresa vorrebbe essere, ma ancora non è la realtà, è “un sonno non respirato ancora”, ma quando il suo fiato, prima flebile poi deciso poi ansimante, prende corpo, scatta ciò che chiamiamo poesia, che è realtà del mondo e di se stessa.
E’ la mente sonora a imprimere andamento e direzioni a un linguaggio dalle significazioni estese: a tal punto da abbracciare, nelle proprie estensioni, anche la frammentazione “come una miniera”, uno smembramento di sé che la scrittura produce sfigurando e ridisegnando il dicibile. Nella lingua del nostro autore il lessico distingue fortemente i sensi dalla falsa precisazione ordinaria: in questi testi ogni sinestesia è possibile (si tocca la luce, si annusa l’attrito, si vede la musica) affinché il corpo della poesia sia il suo proprio corpo e non quello del linguaggio che lo crea. Ma la parola, così immersa e così tesa, presa in un vortice di sensi lievi e duri che ne ricostruisce i significati (anche all’interno di una singolarità sintagmatica spesso ossimorica), lascia affiorare la sua necessità implicita: una sensualità che tocca la punta di un paradigma quasi mistico. Non in senso religioso, ma per la sostanza d’ombra e di accecamento che produce vibrando.
Fresa, però,èconsapevole che la sua parola non ostenta, né richiede, né desidera assolutamente la presa di uno sguardo esteriore, perché “la parola non vuole nessuna visibilità”. La voce e la scrittura poetica devono resistere al disvelamento e concentrarsi, fare deserto intorno per suggerire e riaccendere il senso, perdere e ritrovare e così separare “l’autentico durevole dall’apparente”.
da Aura
5.
Noi parliamo concludendo le menzogne luminose: su
questa strada gonfia di rose, di fiammiferi, di gridi.
Ma fuori s’immaginano i cibi (e i tuoi vestiti; e la mia
pelle). Attorno a questo piccolo mantello sia fatta
luce e infanzia.
Le penombre che s’incrociano col bianco delle forme
stabiliscono per sempre: rinuncia e seduzione.
La sua vera tristezza mi richiamava allora con un
pudore, con una fame priva di dominio.
Perciò difendimi: èproprio questo il puro desiderio
che decide la ritrosia, l’arrivo dei serpenti.
Non si vede chiarore: perciò gli tocca l’orlo del
vestito. Ora ripete: proviamo due o nessuno.
Quello è il segreto vero – ah, labbra, figura,
sfinimento – e quello è il suono dell’acqua, l’attesa
che ti prepara le dolci sbarre, la quiete, la sorpresa.
Ora lui si domanda e chiude la parola; lui sa bene,
ma non sa mai ridire.
Io ti accarezzo, allora: difendimi, difenditi.
8.
Poi tu – e le tue frasi gravi: quel fiore è un fiore; perciò
mi sono persa – non fai che dichiarare un beneficio
questa nuova, incalcolata sparizione.
La fortuna ora passeggia sulle industriali forme
delle rovine: è dunque un beneficio sopra il viso che
obbedisce a una furiosa festa, quando ritardi a
tanto, quando ritardo?
Senza dubbio lo è stata. Il dio si mostra errante:
diventa pensiero di pensiero. Là dritti, poco precisi.
Tagli, sospiri, sovvertimenti.
Non si può dimenticare un libro: se lo scriviamo,
infatti, non ci appartiene piùdegli stessi oggetti –
penne, scaffali, tavoli, schermi – e niente si definisce
libero e costante.
Non si può desiderare quest’azione: privilegio del
servire.
La traduzione va riscritta, docilmente, senza rima,
senza alcuna compiacenza; quindi germogli, slancio,
ferita; quindi ricerca, impulso.
C’è una sembianza che prepara un’alleanza
sconosciuta e una solenne
capacità d’intesa.
10.
Tu sei arrivata, intanto, alla parte più difficile e
curiosa: da uno a dieci, scegli.
Laggiù, tutti avvinghiati (ma sempre estranei l’uno
all’altro). Quello, perciò, risponde: se per caso lo
facessimo anche noi? Qui, da quest’angolo nascosto,
allora, ti osservavo con segreta ammirazione.
D’improvviso ricordavo, a intermittenza, l’ombra
bizzarra e informe, la piega bruna, le morbide
ginocchia, lo sforzo della lunga camminata.
Ma noi tranquilli sempre; toccandoci per bene, e
rimandando continuamente il termine del gioco.
11.
e intanto l’aria si trasforma in un audace furto,
e vuole tutta entrare.
Mario Fresa è nato nel 1973. In poesia ha pubblicato Liaison (2002), L’uomo che sogna (2004), La dolce sorte (2005), Il bene (2007), Alluminio (2008).
Ha collaborato e collabora alle riviste “Paragone”, “Nuovi Argomenti”, “Almanacco dello Specchio”, “Caffè Michelangiolo”, “Gradiva”.
Ha scritto con Tiziano Salari un libro dialogico sulla poesia, Il grido del vetraio (2005) e ha curato, sempre in sodalizio con Salari, due volumi di indagine
critica: Le tentazioni di Marsia (2007) e La poesia e la carne (2009).
Erika Crosara, da “Ius”, con una nota di Giorgio Bonacini
La poesia di Erika Crosara si presenta alla lettura con un dato lampante e inequivocabile: una perentoria forza di dislocazione che la sua scrittura attua, non solo semanticamente o nella costruzione del sintagma, ma attraverso un vero e proprio spostamento dei paradigmi concettuali e percettivi. E questo crea una forma di disequilibrio significativo, tutt’altro che negativo, che fonda e rifonda costantemente l’oscillazione del senso.
E’ vero che in poesia non si dà mai comunicazione ordinaria e ordinata, ma qui, grazia “alla caduta di ogni sillaba”, e senza frantumare l’impianto lessicale, ciò che si ricrea in modo vigoroso è il senso della realtà. O meglio, la convinzione e, di fatto, la possibilità, che i suoi svariati punti di vista possano essere rifondati (anche in modo oscuro o elusivo) attraverso il fare della lingua. IUS, il diritto, sta allora dentro la necessità e la volontà di assumersi la responsabilità della scrittura: dei segni e dei suoni che puntano alla concretezza, che provano a “rompere un pane e le pietre” con un aggancio, evidenziato in vari momenti, alle cose del mondo talmente forte da ren- derlo quasi impraticabile al normale sguardo, ma non a quello di una poesia capace di ri-conoscere e ri-collocare l’esperienza, fuori da ogni ingenuità o realismo.
In questi testi la consapevolezza di ciò che si può dire e di come dirlo è esemplare: “pensava in ogni occasione al marchio dell’inizio, al/marchio della fine”. E in questo percorso meditativo quello che, secondo noi, è veramente rilevante è “il marchio: cioè la possibilità di imprimere un andamento, un transito alla propria voce che possa scavare e creare un solco vitale. La parola di Erika Crosara è materia che spinge e punge con un ritmo a scatti, a rotture, a frangimenti dentro il mare indistinto della vita, dove prendono rilievo “la forma del piatto”, “un suono di piccoli animali”, “un monticello di pietà” a dar corpo a un ascolto che riverbera la parola con un atto di rilevanza estrema: liberare il poema risolvendo, anche in solitudine, il suo essere contemporaneamente oggetto e soggetto del proprio farsi o frammentarsi. In tutte queste pagine si respira il diritto che la scrittura ha di costruire poesia. Non solo come mero atto materiale (seppure anche questo importante) ma, grazie al “tropo delle meraviglie”, riesce a rifinire e trasfigurare un discorso, per l’autrice, cruciale: ciò che avviene va detto dall’ interno, ancorandolo alla pelle e contorcendone la linearità apparente per significarlo nuovamente e veramente.
Il suono di questa poesia, allora, non ammette filtri che ne abbassino il grado verso una normalizzazione, e l’autrice è sempre attenta a far sì che il gesto vocale e fisico continui a distinguersi, rimodulando gli echi per “dire cose” mai guastate da un significato molle o non incuneato in un’esistenza vera: non solo verosimile, non soltanto veritiera. Perché la parola in poesia può arrivare anche per caso, ma non è mai casuale dove va a situarsi. Dove il poeta cerca il sentiero, il comporsi del testo in forma di sostanza linguistica ne determina il suo divenire - infinito o sfinito, non importa - e fa sì che quella parola, quella voce, quel suono possano essere solo quelli, in quel dato luogo e in quel preciso istante. E, paradossalmente, questa precisione, che può essere anche “un’identica furia”, è ciò che nei versi di Erika Crosara disorienta, per certi richiami interni, certi riavvolgimenti linguistici che ricollocano i sensi in un’interiorità che taglia le immagini e segna le visioni, dove qualcuno può arrivare anche ad ammalarsi per un canto di uccello. E non è poco riuscire a dirlo così, senza patetismi o forzature, ma con fermezza e leggerezza.
dalla sezione Dis
(blu)
perché cadono: per i giusti termini dello sfinimento.
però cadevano del tutto a metà, e il resto del resto
in piedi su vetri svuoti, rifranti, con filigrane davanti.
si dice che prema i moti alle masse, che duri sulle
cartine votive sui cerchi di un piccolo vento, spinto,
l’uomo che credi non caduco, le mille bocche.
dalla sezione Ius
***
“che paura disse che ho quando dalle sedie o dagli
altari vedo il rimorchio, gli uomini piccoli in spanne
con fori di ardimento. fa un monticello di pietà ciascuno,
un triangolo visivo inadempiente”.
***
per la scena delle scene avrebbero vestito un
congegno mutabile, una macchina di legno e gesso
capace di passare da parte a parte il ciclico,
lo statico. divisioni discrete di soggetti confluivano
e un amanuense.
dalla sezione Pais
***
aveva contato per due durante le prime ore, contato
per tre, aveva contato ma presto rinveniva il pentimento
se non era buono il umero tenuto, saperlo sortire.
invece il grado di bianchezza, di pelle nevicata e lasciata
andare, diceva che l’ordina alla degnità era fiorito, che
oramai prendeva tutta la casa ovvero le care stanze, della
più vecchia tra i vecchi, l’intero piano di sotto.
***
forse diventava grande l’ingombro, o forse
lo era. i ganci assaltati e le maglie non coprivano
abbastanza. una questione di fili non ha modo di
essere detta? c’era per ogni amorevole casa la cura.
(siamo rimasti senza regali: la selva e i nastri
bianchi senza vederci dentro un fondo. il pudore
in perpetuo ridotto a giglio, a saluto con salto).
per daniela s.
Erika Crosara è nata a Vicenza nel 1977. Laureata in Conservazione dei beni culturali, vive in provincia di Udine. Suoi testi poetici sono ospitati in antologie, riviste e blog letterari. Ius è il suo primo libro di poesie, pubblicato da Anterem Edizioni come vincitore del Premio Lorenzo Montano per “Raccolta inedita”.
Alberto Mori, inediti da “Financial”, con una nota di Giorgio Bonacini
La poesia ha origine in una scrittura dal movimento bipolare continuo: dall’ interno all’esterno e viceversa. In modo tale da generare un senso inafferrabile, ma nello stesso tempo, data la multi direzionalità dei significati, a tratti o a frammenti, comprensibile. E’ ciò che propriamente accade leggendo questi testi che hanno come referente le transazioni finanziarie.
Mori ha scelto l’argomento forse più ostico da indagare in poesia: perché si tratta di un bene ipermateriale, il denaro, ma anche il più astratto nei suoi camminamenti socioeconomici. Ma l’autore non usa la performance poetica per descrivere o esprimere il suo pensiero in un’ indagine sull’argomento, egli, consapevole della struttura e del valore ramificati della scrittura, prova a recepire gli umori dell’oggetto per ritrasmetterne i rumori. La poesia di Mori, infatti, non esaurisce il suo percorso sulla pagina, ma scandisce il suo ritmo con l’esecuzione del corpo fonico intrinseco alla versificazione. E ciò permette una figurazione a zig zag che apre la significazione “finanziaria” ad una direzione che riporta, anche in modo non lineare e con fraseggi ellittici, alla poesia stessa.
Vediamo nel concreto un verso: “Password con atonalità dodecafonica di riconoscimento”. Si parla di una cassaforte homebanking, ma l’evidenza può ingannare. Se interpretiamo attraverso paradigmi poetici (e Mori è talmente attento e padrone dell’arte linguistica da esserne certamente consapevole), vediamo che la frase può essere letta come una definizione metaforica di ciò che è, o può diventare, una scrittura non ordinaria: parola dalle modulazioni interne non univoche, ma riconoscibile nella sua specificità di arte. Può sembrare una forzatura interpretativa, ma leggendo la raccolta si comprende quanto forte sia la capacità di disarticolazione dell’oggetto sociale in questione: tanto da incorporarlo nella scrittura, non come significato esterno univoco, ma frantumato e reso quasi inconoscibile rispetto alla lingua specifica che lo dice. Nel testo sono tanti i luoghi dove questa trasfigurazione si manifesta: apparentemente appoggiata al soggetto che dà il titolo e tira le fila, ma ancorata liberamente alle capacità artistiche di cui Mori è maestro. Come la visualità che traspare in alcuni testi, accanto a un’altra caratteristica portante di queste poesie: il tocco di leggerezza e di lucidità che le tiene, come se fluttuassero in aria, ma con lo sguardo verso il basso, dove l’umanità c’è e il “conto delle spese mensili sussidiarie/illude e disillude”.
Ma bisogna anche pensarli a voce questi testi, perché nella concretezza del suono il senso viaggia e prende spessore, fa attrito in una visione fulminea di povertà che è il corollario maligno dell’attività finanziaria. Oppure in un’immagine quasi soave, quasi un dipinto zen dove un euro è appoggiato “sopra il limone” e l’immagine sotto è quasi di un giardino “cosparso di monete”, come una via di fuga su cui scommettere per resistere e per dissolvere la quotazione di ciò che mercifica e dà un prezzo alla parola sudata.
da Financial
***
I volti abbassati sulle agende
Chi prenderà la parola
traccerà la fine dell’oscillazione
Le mani si allargano
appoggiano sulla tavola
Le liquidazioni avvicendano
Gli occhi cercano punti distanti
Li ravvicinano
All’adunanza creditori
iniziano a dismissionare
***
Affioca l’executive dell’investimento
Luce polarizzata ora
soltanto dal debito acceso
e l’azione smorza
deflatta disinnesca
bassa percentua
***
Dow Jones siede
Appoggia la mano sul tavolo
La rovescia lentamente aprendo il palmo
Poi richiude tutte le dita
Struscia il dorso fino al bordo
Sull’indice ritto improvvisamente verso pavimento
passa luce subitanea
Resta indicante
mentre immagine dissolve
***
I diagrammi del mercato azionario intrecciano
sulla curvatura dolcissima degli schermi alto parietali
Emettono quote simultanee ad orografie luminose
Spezzano percetti di tracce fluorescenti
***
Nella luce aurea sulla pelle
il bilanciamento differenziale delle spese mensili sussidiarie
illude e disillude
sul crinale contabile della pendenza
ed assesta
ad estensione delle braccia
in attesa del passaggio equilibrante
Alberto Mori, poeta, performer e artista, in più di vent’anni di attività ha costruito e alimentato una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando di volta in volta altre forme d’arte e di comunicazione, dalla prosa alla performance, all’installazione, al video e alla fotografia. Nello stesso tempo, ha collaborato con molti fra i più noti poeti contemporanei, italiani e stranieri, per la realizzazione di letture pubbliche, manifestazioni ed eventi dedicati alla poesia. Ha all’attivo numerose pubblicazioni. Nel 2001 Iperpoesie per Save As Edicion e nel 2006 Utópos per Emboscall. Peccata Minuta sono stati tradotti in Spagna. Più volte finalista al Premio di Poesia Lorenzo Montano.
Website: www.albertomoripoeta.com
Marica Larocchi, da “Solstizio in cortile”, Puntoacapo 2009, con una nota di Rosa Pierno
Che una descrizione così sonora e raffinata possa avere ragione anche di un argomento triviale, o semplicemente banale, del tutto insignificante come la visione di un camionista in panne visto per qualche secondo mentre si percorre un’autostrada, riporta immediatamente l’attenzione sulla pura forma, come in un esperimento che voglia isolare solo alcuni elementi all’interno del fenomeno poetico, dove la visione sia strumento dichiarato d’indagine che attesti di un atto poetico che fonda la propria certezza quasi in una ripresa di cartesiana memoria. Se a questo si aggiunge un dichiarato riferimento al segno, il quale è innestato nel linguaggio utilizzato da Marica Larocchi come pietra preziosa che nel linguaggio non si dissolve, ma funge da elemento aggregatore, elemento boa, allora siamo di fronte a una dichiarazione di poetica talmente limpida che il suo significato a questo punto non può che risiedere nel flusso poetico che si dispiega ininterrottamente e imperiosamente richiamando la nostra attenzione al senso sonoro dell’ascolto: “bensì, nel vario / itinerario imposto / dal nume locale, segni / stinti d’ascesi / o parapetti d’anabasi / indiscussa”. E che tutto diventi segno sotto lo sguardo di Larocchi indica la metamorfosi che ha luogo sul foglio: “Ed ora / non ti avvedi del / timbro ammalorato / su questa cute / di voli tatuati”. Suono e senso non si confondono, né si uniscono, ma coesistono nella loro doppia esistenza, rubando continuamente l’attenzione del lettore, imponendo un’autonomia che non può essere dissolta, nemmeno nella considerazione di un ordine superiore. Pare che nessun residuo resti, che realtà, per quanto piatta, insignificante, forata, discontinua sia, venga senza sosta e immancabilmente sottoposta a un processo attraverso cui debba assumere necessariamente un senso. Di questa immaginifica visione, incantatrice pagina, colma di sonorità e di senso come può esserlo una fonte da cui sgorghi continuamente una rapente immagine per gli occhi, Marica Larocchi è straordinaria fautrice.
Solstizio in cortile
1
A lungo ho sperato
che fosse un volo
lasco e poderoso
sopra l’immenso
brulichio di larve.
Invece è questo
tuffo molle
di starna, d’anatra
muta o di svasso
in parata dentro
i crepacci della memoria;
e che riemerge adagio
con l’infanzia nel becco.
2
Pensieri a sciami
sono alla cova
tra i licci di
un’antica fame;
già pronti a divorare
accenti e toni.
Oggi mi accoglie
soltanto la cinica
risacca d’alghe
riepilogative,
se l’oracolo
mentitore
impone ai presagi
di sprangarmi il cielo.
Restano poche
spine nel crampo
della luce.
3
Ecco la poiana
dei vaticini
appesa al ramo
in cortile,
avida persino
di un’indagine troppo
fatale.
Ma sul collo scalzo
dei tetti la sua
invettiva inciampa
nel nido degli incontri
sonnambuli che lo
spiedo della mente
infilza senza colpo
ferire.
da La linea della vita
2
Né ascisse né ordinate
per l’insolita adunata
dei segni, ma solo
un rimpianto che albeggia
adagio dall’orlo
un po’ scheggiato
della guida
quando, scissa
dai suoi tutori, anche
l’angoscia cade
nel suo astuccio
di trepide astine.
6
C’è nell’inchino
esperto della vela
la presunzione di approdi
e bonacce;
ma è sempre una
folata estrema a
declinare nel taglio
scogli ed ormeggi.
Perciò ne conservo
la rotta collaudata:
fulva e sottile
linea della vita.
Marica Larocchi, lombarda ma di madre slovena, è poetessa, narratrice, traduttrice e saggista. Tra le sue raccolte poetiche: Lingua dolente (Milano 1980), Fato (Milano 1987), L’oro e il cobalto (Bologna 2001), Le api di Aristeo (Bologna 2006); tra le opere in prosa, Il suono del senso (Verona 2000), Carabà (Lecce 2000), Rimbaud, Un racconto (Lecce 2005), Il tavolo di lettura (Lecce 2007), Luogo e formula (Lecce 2009); ha tradotto Rimbaud, Flaminien, Radiguet, Jouve e curato un’Antologia dei poeti parnassiani (Oscar Mondadori, 1996). Vive a Monza.
Marco Ercolani, prose inedite “Turno di guardia”, con una premessa di Mara Cini
Le prose di Ercolani affermano, in piena consapevolezza che èla forma di ogni opera, dispiegata attraverso il suo specifico linguaggio (segno, immagine, suono…), ad essere significativa – non certo, non del tutto, le eventuali, descritte, “emozioni” che pure fanno da trama, come si conviene, alle pagine.
E’ innegabile però che questi testi (i testi di Turno di guardia) si pongono in equilibrio tra letteratura e analisi situandosi su un crinale dal doppio orizzonte dove lo sguardo prende le misure al racconto e, pacatamente, continuamente, ne rinnova approcci e distanze.
Turno di guardia
estate 2009 – estate 2010
Questa esistenza demonica,
questo vivere in estrema vicinanza con l’assoluto,
in beatitudine e orrore,
sfugge all’alternativa salute-malattia.
Karl Jaspers
Corsia notturna
Durante il giorno mi riferiscono deliri malinconici o magiche visioni del mondo. Mi raccontano crimini inesistenti, ingiustizie spietate, desideri favolosi. Parlano e parlano. Commentano, delirano. Ma, a notte alta, quando dormono nella corsia, vorrei spiarli con una piccola pila, attento a non fare il minimo rumore, vorrei capire se la sofferenza di poche ore prima ha lasciato una cicatrice reale nella loro pelle. Immagino occhi scuri, palpebre pesanti, labbra semiaperte. Oppure volti deformati da accessi di collera e pianti clamorosi che riposano come se nulla fosse accaduto, smemorati, immersi in un silenzio collettivo. Ma quella pace non mi appaga: è generica, vuota. I folli, svegli o dormienti, non sono mai simboli. Non voglio camminare accanto ai loro letti. Torno nella mia stanza di guardia, mi addormento. Comincio a scrivere di loro.
Mi chiedo se sono spettatore delle loro voci o tutore delle loro furie. Se sono un veggente passivo o un poliziotto attivo. Chi è veggente spalanca porte, intravede misteri, aggiunge disordini. Chi è poliziotto tappa bocche, lega corpi agitati, intima ordine. Ma non si è mai una cosa soltanto. Si è sempre altro da sé. C’è un’isola borderline tra l’essere troppo liberi o troppo prigionieri, una zona della mente dove avere visioni non significa necessariamente perdere la ragione, un luogo dove, nell’attimo in cui tutto crolla, si sostituiscono a quella distruzione dei paesaggi immaginati ma reali.
Oscillare senza cadere
Quando ascolto un ‘matto’ delirare, ogni sistema logico diventa instabile, come se io e lui fossimo su una passerella oscillante. Ma, nell’attimo stesso in cui io e lui ci mettiamo a parlare tutto ritorna stabile e c’è una via di scampo. Io vacillo e lui sprofonda. Ma, vedendomi vacillare con lui, sprofonda di meno. È felice che io barcolli, che sia simile a lui. Sa che io, essendo psichiatra, non sprofonderò. Sa che lui, in quanto matto, può farlo. Ma sente che, se ha una possibilità di salvarsi, deve imitare la mia strategia. Oscillare senza cadere.
Da psichiatra verifico nelle furie della follia la mancanza di una forma. Da scrittore sento nella forma dell’opera la fine delle furie. Due verità opposte: il destino deforme del ‘matto’. Ha voluto sciogliersi dalla forma che lo imprigionava e ha fallito. Mi carico di quel fallimento per osservare nodi che appartengono a me e a lui. Conquisto una distanza che è già reciproca via di salvezza e di avvicinamento al mondo parallelo che, da quei nodi, inventa nuovi universi.
Se il mio compito come lettore e interprete della malattia, è decifrarla e trasformarla in qualcosa di altro dal sintomo, il mio compito come scrittore è lavorare su una scrittura che renda impossibile e altro il linguaggio. Chi, come lo psicotico, non ha niente da perdere perché crede di possedere tutto, ha come suo doppio l’artista che non ha niente da perdere perché non ha e non vuole avere nulla.
Racconti di fate
Durante il mio turno di guardia sento sillabe ripetute, urla stereotipate, cantilene. Niente di drammatico o di poetico. Chi soffre non ha nessuna voglia di rappresentare la sua sofferenza e se ne libera o con una nenia o con un grido. Bisogna rispettarlo. Conosco un ex ingegnere nucleare che, nelle fasi deliranti, si crede un Agente dei Servizi Segreti. È un uomo intelligente, consapevole della sua malattia. In un recente colloquio mi dice di aver scritto dei racconti e mi invita ad entrare nel suo sito web. Lo faccio, incuriosito, sperando di trovarvi qualche suggestiva allucinazione. Invece leggo raccontini che parlano di bambini, fiori, animali, regali natalizi. Cosucce graziose. Per un attimo sorrido, provando pena per quel prodotto mediocre, ma poi me ne vergogno. Un uomo come lui, ossessivamente consapevole della sua sofferenza psichica, non ha nessuna voglia di rappresentarla – e quindi di riviverla – nei suoi racconti. Che invece, nel tentativo di respingerla ai margini dell’io, simula lo stato di grazia di un paradiso infantile. Senza valore per chi frequenta le bellezze della letteratura, ma essenziale per chi percepisce la scrittura come evento psichico. Così, per disinnescare le loro follie violente, Robert Walser scriveva racconti ossequiosi e gentili e Friedrich Hölderlin firmava con il nome di Scardanelli tranquille quartine paesistiche. Solo chi non sta troppo male può ancora parlare del suo inferno. Chi è sprofondato nei sintomi fino al collo ha bisogno di sollievi semplici – musichette, isole dei famosi, racconti di fate. Ricordiamo che Proust non sdegnava le canzoni mediocri, suscettibili di scatenare imprevedibili madeleines.
Mulini a vento
Un giorno cercai di persuadere un uomo di trentasei anni, in preda a un delirio megalomanico in cui credeva di essere Gesù, Budda o Gandhi, a raccontarmi ciò che provava, a scriverne su un taccuino. Lui mi guardò con sospetto, poi disse: Io non scrivo, io sono. Aveva già tracciato, per i giorni a venire, il suo programma: dimostrare di avere ragione contro chi gliela negava, e pagare il prezzo di questa lotta. Il segno più evidente della psicosi è che ogni parola pronunciata non appartiene alla sfera del linguaggio, e tantomeno all’universo della metafora, ma è verità rivelata. Chi si sente messaggero di questa verità guarderà con sospetto sia i funzionari di potere – poliziotti e psichiatri – che lo invitano a tradirsi, sia i compagni di follia che enunciano verità diverse dalla sua. L’uomo di cui parlo ha sofferto per mesi di un’infezione alla gamba sinistra che solo per caso non si è trasformata in cancrena. Per mesi, pur zoppicando, ha negato la realtà di quella ferita. Non lo considerava un problema. Lo avrebbe risolto quando avesse voluto. Poi il dolore è cresciuto; lo ha spinto, suo malgrado, a farsi curare.
Il ‘matto’ intraprende sempre una lotta ostinata contro le convenzioni della sofferenza, del pensiero, della percezione: una lotta grandiosa, destinata al fallimento. L’esagerazione, maniacale e donchisciottesca, è comune, in campi diversi ma contigui, anche all’arte. Se non si esagera lottando con i mulini a vento contro una uniforme pianura noiosa, se non si vive fino in fondo quell’“energia dislocante della poesia” di cui parla René Char, accettare le regole della vita e del linguaggio è solo un debole atto di sottomissione a codici già scritti, una sconfitta umiliante. La speranza nasce quando – parzialmente sani – cerchiamo di sfruttare, tra affanno e pazienza, l’energia vorticosa dei mulini.
Guarigione, scrittura
Francis Ponge scriveva: “Gli uccelli di Braque sono molto più pesanti dell’aria, come sono realmente gli uccelli, ma volano meglio di tutti gli altri perché, come i veri uccelli, partono dal suolo, ridiscendono a nutrirsene e ripartono in volo”. La metafora di Ponge è perfetta per l’arte della scrittura ma anche per la fatica di guarire. Ridiscendere, nutrirsi e ripartire in volo, mi ricorda il compito dei traduttori e degli interpreti, che si confrontano con i dolori e con le opere degli altri. Io, non avendo una vita che potessi dire mia, sono diventato ventriloquo e interprete di vite e follie altrui nelle quali rispecchiarmi e delirare.
Lo chiedo spesso ai miei matti: abbiate cura del vostro delirio. Ma hanno paura. Non sanno orientarsi. Dicono che devono vivere con cautela o saranno travolti dalle loro allucinazioni, confusi, ricoverati, fuori dal mondo, senza diritti. Solo pochi di loro, come il postino Ferdinand Cheval, a Hauterive, hanno rappresentato con ferrea pazienza e ostinata chiarezza il loro delirio costruendo, giorno dopo giorno, pietra dopo pietra, uno stregante e onirico sacrario come il Palais Idéal. Se il folle descritto da Elias Canetti presenta un’atrofia della metamorfosi, l’artista, al contrario, soffre un’ipertrofia della metamorfosi. Coltiva la sua ossessione.
Buio in sala
Se dovessi scegliere un’arte fra le altre, sceglierei il cinema. Il cinema offre lo scenario di una riorganizzazione del mondo attraverso forme in movimento. Lo spettatore, immerso nel buio della sala, si fa invadere dalle immagini che scorrono sullo schermo. Stare nel buio e poter vedere solo quelle immagini nella tela bianca non è il simbolo dell’informe oscurità intrauterina e amniotica, ma la condizione privilegiata di spettatore delle visioni che il regista-demiurgo inocula in lui, grazie al suo stato di temporanea passività. Lo spettatore, nell’oscurità della sala, è in una condizione diversa dal lettore di libri o dallo spettatore di quadri, perché non può distogliersi dall’incantamento che emana dalle immagini dello schermo se non chiudendo gli occhi o tappandosi le orecchie.
Come il folle, a causa delle sue paure e della sua intransigenza, si autonomina demiurgo e organizza in prima persona la realtàdegli eventi e la direzione degli affetti, cosìil regista, stimolato dalle proprie visioni, può costruire un mondo parallelo che si impone allo spettatore non appena nella sala si fa buio. Quando una storia si trasforma in fatto ottico, l’attenzione è assoluta come quando sprofondiamo in un sogno. “Ogni uomo – scrive Bion – deve poter sognare un’esperienza proprio mentre gli capita, sia nel sonno che da sveglio”.
Questa non è la mia casa
Turno di guardia. Consulenza in Medicina. Reparto.
L seduta sulla sedia bianca.
Non ècasa mia, voglio stare a casa, con mio marito.
Suo marito è morto, signora.
Questa èuna sedia bianca, un letto bianco. Non conosco questa sedia. Non conosco questo letto. Voglio tornare a casa.
L grida per ore. Sono le due di notte. Fuori la luce del corridoio è bluastra. Si addormenta e si sveglia, mi racconta un sogno.
Un ramo pieno di limoni, sull’erba del prato. Una luce mite, quasi estiva. Il sole è nero, basso. Vicinissimo alla terra.
Ride.
Forse è immerso nell’acqua. Io cosa ne so? Una sedia bianca, un letto bianco! Non è la mia casa, non è la mia casa.
Si calma, accetta la terapia, smette di gridare. Scendo le scale del reparto. Le tre di notte. Suona il cellulare. Mi richiamano dal Pronto Soccorso. Un uomo di sessant’anni. Dicono farfugli, deliri. Vado. A me sembra tranquillo, felice di parlare. Dice che ascolta solo musica di Frescobaldi, sempre al clavicembalo.
Ma l’organo non va, non suona bene nella mia casa, è piccola, un buco, la vedesse. Vivaldi è superficiale, Bach sontuoso, ma la leggiadria della scuola francese! Couperin!
Vuole un farmaco per l’ansia?
Per favore, sì.
Prescrivo quindici gocce di En, mi allontano. Ha un sussulto di paura, mi implora di tornare. Non vada via, dobbiamo parlare di musica. Non mi lasci qui! Torno, gli ripeto. Ora è lui a sorridere, mi stringe la mano, sorride ancora.
Dove ho messo i rifugi
Che il genere umano esploda pure, ma lei mi è simpatico! Le dirò dove ho messo i rifugi.
L parla a lungo, sessant’anni, si muove con ansia sulla sedia.
Io dipingo perchémi sento in pericolo, sussurra, le foreste che disegno sulla carta, le foreste che bruciano sul foglio, mi salveranno dall’incendio di domani, nessuno mi regala un accendino, sbattono le nocche alle porte, le sbattono forte, forte, vogliono uccidermi.
Si calmi, come si chiama?
Non risponde. Parla del timbro violento delle voci, delle materie che gli rimbombano come acciaio nella testa. Lo lascio, prescrivo una flebo di Valium. Salgo verso il reparto, faccio cinque passi, mi richiamano, torno in Pronto. Vedo un ragazzo della Costa d’Avorio, immobile, sulla sedia bianca.
Sto fermo per salvare i morti del mio paese, nome per nome: resterò fermo tre minuti per ogni uomo scomparso e svolgerò per intero il mio compito, dovessi morirci.
Ma servirà?
Servirà.
Allora venga su da me: potràrestare immobile quanto vuole.
Sì.
Ordino il ricovero. Prima mi fissa con odio, poi acconsente. Salgo stanco nella stanza di guardia. Mi tolgo le scarpe, mi addormento di colpo.
Marco Ercolani (Genova, 1954). Tra i suoi pensieri dominanti: la scrittura apocrifa, la poesia contemporanea e il nodo arte/follia. Pubblica, per la narrativa: Col favore delle tenebre, Vite dettate, Lezioni di eresia, Il mese dopo l’ultimo, Carte false, Il demone accanto, Taala, Il tempo di Perseo, Discorso contro la morte e A schermo nero. Per la saggistica: Fuoricanto, Vertigine e misura e L’opera non perfetta. In coppia con Lucetta Frisa scrive L’atelier e altri racconti, Nodi del cuore, Anime strane e Sento le voci. Nel 2010 pubblica il suo primo libro di versi Il diritto di essere opachi.
Alessandro Ghignoli, da”Amarore”, Kolibris 2009, con una nota di Rosa Pierno
Non chiusa la costruzione frasistica, le proposizioni restano in sospeso, aggettanti, sporte nel vuoto creato dal mancamento non solo della volizione, ma della stessa possibilità di costruire definizioni, mentre realtà di conseguenza resta altrettanto drammaticamente sfilacciata. E’ naturale che una simile forma utilizzi costrutti ipotetici, gerundi, ripescaggi lessicologici, tempi verbali genericamente non accordati al soggetto, i quali solo stratificandosi costituiscono la pur solida base d’appoggio con cui affacciarsi nel baratro. E così ecco individuato immediatamente anche il soggetto della silloge “Amarore”, Kolibris Edizioni, 2009, che Alessandro Ghignoli ci consegna: il linguaggio. Indagare il linguaggio attraverso il linguaggio non ci appare certo paradossale. Già Wittgenstein ci aveva avvisato: dal linguaggio non si esce. E, dunque, il lavoro di Ghignoli si pone su questo illustre binario. La ricerca di altre modalità di dire, che si aprano alla complessità, che accolgano il paradosso, che non fuggano dinanzi all’impossibilità di chiudere il cerchio con un pensiero lineare, pur senza eludere il tentativo razionale di fissare possibilità e limiti dello strumento linguistico, costituisce l’essenza del testo poetico di Ghignoli. Vi è, comunque, un sapore amaro, che fa virare anche il senso primario nel titolo, a dirci che l’operazione non è indolore e forse non ha nemmeno un esito ascrivibile pienamente all’area del risultato positivo: “delle immaginazioni dove la lingua s’affatica / dove la fine è già avvenuta”. Certo, il dubbio s’installa insieme al rimpianto e all’inefficacia delle proprie azioni. Inevitabile stallo per chi rifiuta così strenuamente balaustre e appigli fino a dubitare persino del linguaggio quale strumento veritiero e rispondente per costruire la propria moralità. Il balbettio del dire, c’è poco da fare, è comunque l’unica cosa che almeno possiamo registrare e consegnare a noi stessi e agli altri.
dalla sezione Tristizia
***
si potrebbe pensare e detto questo
è già in ritardo la parola il suo valore
oramai di ragionare di questioni
di mirabili cose di mancati incontri
di tutto il procedere normale dal principio
al principio ancora per dire ciòche il coraggio
dubita di una partita tua di un gire nostro
per le strade de la mente nell’incontro
delle immaginazioni dove la lingua s’affatica
dove la fine è già avvenuta
***
nella verità si nasconde la cancellatura della frase
nel davvero della parola quasi pronunciata
il richiamo per conoscere l’intenzione il cercare
per vedere i piùpiccoli movimenti delle labbra
sul fiato è spento il perdono il suono
la vocale scivola piano
senza emettere nota o dono musicale
***
di viaggio si tratta alla resa dei conti
alla fine superare i dove le luci
tra taverne e fantasmi all’incrociare
occhi parole usanze tralasciamo
le critiche sentenze le minime pagine
nell’altrove trovando un vantaggio ora
nell’ora che pianamente ricovero al ricordo
al rimpianto al poco mio aver dato
dalla sezione Amaritudine
evento 5
tutto di tutto sento e in tutto mi pento
dalla rabbia dal pensare che non èricordo
ché memoria non èstoria forse sabbia
dentro il dentro un foro da dove da come
ogni tanto ogni quanto èconcesso errare
nell’evento sul bordo o solo da solo nel centro
perché di presenza presente ne la rinuncia
rasento il passante pendente paesaggio
in chissàquale coro quale ovunque
mi credo altrove anche fuori
anche fosse ancora
dalla sezione Predicamento di me
prima descrizione
delle infinite volte a me dicendomi
di parlare l’italiano senza accento
e lasciare il dialetto da me usato
soggiogato da un io al mio volere
creduto di saperne di lettere di plurali
di subientivo e gerundio e coniunzioni
e tutti i resti d’avverbi che di mia vita
mi feci in costruzione o mi disfeci
Alessandro Ghignoli è nato a Pesaro nel 1967. Ha pubblicato le raccolte di poesia La prossima impronta (Gazebo, 1999) e Fabulosi parlari (ivi, 2006). Ha curato e tradotto numerose edizioni di poeti spagnoli, ispanoamericani e portoghesi all’italiano. Codirige i “Quaderni di poesia europea” (Orizzonti meridionali, Cosenza) ed è redattore della rivista “L’area di Broca”.
Cristina Annino, da “Magnificat. Poesie 1969-2009”, Puntoacapo 2009, con una nota di Rosa Pierno
Non è in una trentina di righe che si può parlare di un libro che raccoglie 40 anni di poesie, qual è l’antologia di Cristina Annino “Magnificat. Poesie 1969-2009” e, dunque, va da sé che soltanto si può riportare qualche nota che abbia più fortemente colpito durante la lettura: anzitutto la registrazione di un’intelligenza tanto lucida quanto sarcastica, ironica quel tanto che serva a puntualizzare che la responsabilità è di come stanno le cose, delle persone che si sono incontrate e si sono amate. Da qui la catastrofe, poiché ciò che è perfetto diviene corrotto, retrocede contro un melmoso fondale di fango, mentre il soggetto della poesia è costretto almeno al reclamo della soddisfazione dei bisogni più elementari, anzi ancora più aggressivamente pretesi. Non si rintracci la mancanza di normalità o di equilibrio nell’autrice, ma nelle relazioni che si sono venute a instaurare con l’altro: lo si evince dal fatto che la scrittura è di quelle che testimoniano di una sensibilissima capacità di cogliere sentimenti e motivazioni sia in sé che nell’altro e di denunciare lo scarto dall’equilibrio: “Ogni giorno, /farlo per farlo, si / spara nel circo del petto / a nobile distanza. Poi perderà. Sia come / sia, salutiamola con riserbo. Gli / stan fumando il mondo dal / naso” a riprova della sua consapevolezza e della sua partecipazione a un gioco di cui non può stabilire le regole. E, allo stesso modo, quel passaggio dal femminile al maschile per parlare di sé sembra più una capacità di assolvere a più ruoli, di saper giocare in più sembianti, in poche parole di essere il giocatore che ha sempre più assi nella manica di quelli che il caso le fa giocare, e a cui, comunque, deve sottostare. Questa capacità metamorfica, questa potenza nella lettura del reale, è anche l’aspetto forse più prezioso che la stessa Annino ravvisa non solo in sé, ma anche negli altri ( e quale festa quando ciò avviene). D’altronde, ci pare che sia saldissima la presa formale delle sue poesie: l’abilità di partire da un’immagine istintiva, appena un la, un accordo di partenza, per sviscerarla fino nelle sue interiora più riposte e sorprendenti. Reale, in fondo, può ben poco di fronte a una simile artefice!
da Ritratto di un amico paziente (Gabrieli, 1977)
Ritratto per Casorati
Come Gustav Mahler che ascolti
e ne invidi la morte, i compimenti,
io dopo ti vedo
nostalgico, lento
non più uomo né donna,
importa
quel solo giallo acuto delle labbra,
che ancora lasci in Mahler la ragione
parlando fumando senza volgarità.
La vena arrossata
tra i capelli gira
indietro come un laccio.
La gran pena di tutto il mondo
per te
è questi atti, suoni, persino
muori,
allungando il tuo braccio
arancione sulla sedia.
da L’udito cronico (Einaudi, 1984)
L’udito cronico
Le poesie d’amore le do
in appalto ai droghieri. Io
inseguo pensieri su cui
casco, è vero, in rime toniche.
Anche a me succede; ma in genere,
è un fatto, sto in piedi.
Ed ho
un bell’udito cronico
per la vita, o meglio
per la testa impazzita
dell’uomo che ragiona, e gli sale
accanto in due, divisa
fino all’occhio glaciale.
da Madrid (Corpo 10,1987)
Tutte le conseguenze sono state fatte
Ormai l’accetto da molto tempo. Lei
è scesa davanti a me, mattone dopo mattone come una
casa, dall’autobus bella e quale un evento
eccezionalmente pesante. Chi fa
per me pensandomi, vale a dire decidendomi, come
dire il destino o gli altri sulla mia testa, hanno
la lunghezza misurabile e il clima breve di quel pezzo di strada. Mai
ho il senso della fine quanto percorrendola. Potrei
stare senza: nel sonno imparo cose del mio
corpo non facendo niente, e mezzo mondo èsotto
il sole stupido. Ma le
faremo alla fine lo stesso le
scale, l’acquaio, la fame, le stanze. Con calma. E che
bontà almeno non parlare mai di Ritsos.
da Magnificat (inediti)
***
Parlando
evaporava, s’aggiustò la
frase su
qualche organo; cresceva
così l’albero. E’ il triste
spirito che
l’ossessiona, col mento
liscio sopra i binari. Quel
che non
vede: mangiare sé
senza far ridere, per
esempio, era
quello. Tirar via la
creatura da sé, viva
ancora, e con furia
strafusa mandarla lei
stessa al macello.
Magnificat
Tinto fino alle gambe d’un
combusto odore di gas, l’occhio
sinistro rigido di pensiero
mescolato a formiche.
E’ tanto
sfatto di sé, pieno, vuoto
stanco con
spartiti nello spazio
minimo. Vorrebbe
farla finita, ma prende in
mano- biglietto d’ingresso
o tessera del pane- il
talento che ha e lo
mostra nell’intento
carnivoro di mangiare. Mangia.
Ché
di più credendo, con
barbara fedeltà al
l’Altezza,
qualità dei reni o
massa musicale, a quanti
ottoni ancora lo
percuotono dentro come
tegami di casa sua. Con tale
elastica facoltà da
pompiere senza
pompa, anche non volendo
lo fa (ma chi tira le
redini qui?) vola lui su con
l’asta, poi entra- nota per
nota- nel
magnificat stato della
mente. Lo vede. Si
scuote insieme ogni
stanza, suola in su, che
nuota senza rete anche
l’acqua. Tale
fascia sonora, ossessione! la
ferma inutilmente per un
po’ con le mani. Poi indietro,
lui casca.
Cristina Annino è nata ad Arezzo vive e lavora a Roma. Si laurea in Lettere moderne a Firenze, dove frequenta i caffè letterari Pavskoski e il caffè San Marco sede allora dei giovani del Gruppo 70. Entra in contatto con Franco Fortini, Giovanni Roboni, Elio Pagliarani e altri. Esordisce nel 1969 pubblicando da allora 10 raccolte poetiche e un romanzo, oltre a numerose plaquette, tradotte anche all’estero. È presente in numerose antologie, sia italiane che straniere. Collabora con diverse riviste in Italia e all’estero soprattutto tedesche, spagnole, messicane. Da alcuni anni si dedica anche alla pittura ed ha al suo attivo mostre personali e collettive. Fa parte dell’agenzia d’arte spagnola Artelista.
Giovanni Turra Zan, da “Le costrizioni”, con una nota di Giorgio Bonacini
Chi scrive (e in particolare chi scrive poesia) sa che ciò che fa si genera e si rigenera continuamente, nello sforzo per aprirsi una via verso il senso. La strada non è mai aperta e il percorso è sempre accidentato, ostruito da condizioni materiali e formali che devono essere affrontate, mai aggirate, se si vuole veramente stare dentro il pensiero e la vita della poesia. E’ in quel preciso luogo che stanno le costrizioni che danno il titolo a questa raccolta. Turra Zan è un autore consapevole che le asperità e le difficoltà non possono essere diluite o evitate; anzi, bisogna rendere libera, e qualche volta necessaria, l’accoglienza di ciò che si scrive sotto gli obblighi che la lingua, che è “l’altalena dei costretti”, impone. Cioè una concretezza di pa- rola che prende sostanza da una difficoltà che il poeta ha ben presente: coniugare nella significazione il respiro ampio della voce con il soffio stringente della vita.
Non si tratta naturalmente di descrivere, in modo ingenuo felicità o patemi soggettivi, ma di portare a compimento (anche solo per quell’attimo di concretezza sonora che la pagina riporta), la capacità di uno sforzo esistenzialmente linguistico: quindi fisico, dove corpo e pensiero sono visibilmente testuali, presenti e interdipendenti. Il tutto dentro una scrittura che rifiuta la linearità semantica per coagularsi in un andamento di vuoti e di pieni quasi surreale, ma capace di far vedere e far sentire ciò di cui l’autore soffre o gioisce. Si tratti della propria solitaria presenza nel mondo o di una crisi affettiva, Turra Zan non dimentica mai che le tensioni emotive vanno risolte nella scrittura, con un desiderio sommerso e strozzato che “vorrebbe si udisse/il verso delle vongole a spurgare.” Parole esemplari in cui la quotidianità di una pietanza in preparazione si trasforma in una richiesta che renda percepibile il dolore di un essere, qualunque esso sia. E chi legge queste poesie si rende conto che forse, in momenti indefinibili, ciò è possibile.
Bisogna però disporsi anche con le proprie costrizioni di lettore a comprendere il modo il cui l’autore smuove la sintassi, stringe i suoni, organizza grumi di senso che stanno in parole apparentemente contraddittorie e indecifrabili. In ogni caso le costrizioni di Turra Zan, esplicitate in numero di tre in una poesia specifica, pur dentro un quotidiano che sembra tenere oscura la lingua che lo dice, portano a un moto di sovversione contro l’assuefazione al dolore. Perché dove c’è stata distruzione qualcosa rinascerà e bisogna dire “basta, stringete ogni lamento”. Ma bisogna dirlo con la coscienza di una lingua che è sì sfilacciata, a volte incongrua per orecchie e occhi scarsi, ma che in realtà è l’unica capace di prendere su di sé gli eventi che accadono e costringono il poeta (e tutti noi) a scegliere se andare o stare.
da Le costrizioni
***
La camminata è un taglio
alla pianta del piede che sanguina e lascia
il maledire sull’asfalto. Stanno accanto
ma pensano al prossimo allontanarsi come
a cadenza di un’assenza che sfaldi.
Potranno scrivere i loro versi su stampelle,
costruire gabbie di cui vestirsi.
E prescrivere orazioni dove
sia presente ad ogni stanza un’ostia
claudicante; dove l’aggrapparsi ai difetti
sia già dato
ai progetti mai portati a compimento.
Oh velo di fine inverno, riposa
sul sudore dei santi infedeli,
fino al peccato dell’ingoio
di carne da macello.
***
E per la sua nervosa adiacenza
si china a sfiorarne i piedi, accanto
all’orto dei perdoni.
soffia la sillaba madre
che fascia costole
come stretta di corde
e ramaglie da cui non sa liberarsi;
la libertà dicono sia quello strascico
delle reti infette; quel ruminare
di cartilagini nella ganascia.
***
Da sopra la barella tieni le tempie
al buio, nel bianconero del tempo
rileggi alla luce i termini di una
fuga dagli affetti e i ricordi, i ricordi
per orificium exit
dovuto dicevi a vasocostrizione,
alla riduzione del lume nelle vene;
e senti la contrazione che si elastica,
la pressione che ti irrora il latte
andato a male per l’incuria.
premi ad ogni ferro il collo al basso,
al lento piegarsi a ritmare
il battito del pube, fino
allo sporgere dell’osso.
Giovanni Turra Zan è nato a Vicenza nel 1964. E’ laureato in Psicologia dell’Educazione e diplomato al Conservatorio Musicale di Vicenza. Ha pubblicato Senza presso Agorà Factory nel 2005 e il volume Lavoro del luogo” con Fara nel 2007. Ha vinto il Premio “Poeti per posta” indetto dalla trasmissione radiofonica di Radio Due “Caterpillar” e da Poste Italiane nel 2005. “Le costrizioni” è uscito come e-book, reperibile in rete.
Enzo Campi, poesia inedita “Per disunite latenze”, con una nota di Marco Furia
Unibili latenze
Con "Disunite latenze", Enzo Campi presenta un articolato componimento che, con raffinatezza, coglie appieno l'enigma dell'umano esprimersi.
Riuscire
"a urlare il senso dell'attesa"
sembra, più che un traguardo da raggiungere, un desiderio insoddisfatto.
Il ripetitivo linguaggio quotidiano e l'immediato urlo entrambi falliscono?
Il tono complessivo induce a propendere per una risposta volta a porre in evidenza se non proprio l'ineluttabilità, almeno la ricorrente possibilità di tale fallimento: la sconfitta appare perciò all'ordine del giorno.
Oltre all'idioma quotidiano e all'urlo, tuttavia, esiste un'ulteriore forma di comunicazione, quella poetica: a quest'ultima pare appellarsi il Nostro per via dello stesso svolgersi di un ritmo che richiama con assiduità un quid facendolo vivere quale esigenza insopprimibile.
Facendolo vivere, dunque essere, tramite una lingua intensa, molteplice nei suoi aspetti, capace di porre nel giusto risalto non insignificanti echi e riflessi di certe "disunite latenze", in grado, insomma, di risultare all'altezza di ardui compiti espressivi.
"Quali fasci di fibre slabbrate
dobbiamo ancora immolare
al peso del verbo?"
resta un interrogativo privo di risposta logica che Enzo Campi riesce, se non a sciogliere, ad avvicinare, con accostamenti sensibili, partecipi, volti ad aderire a una condizione, più che a tentare di spiegarla.
Una feconda tendenza a rapportarsi all'enigma, davvero.
Per disunite latenze
Quali ibridi di sema
laviche implosioni e disincanti
si aggirano circonvolando
i margini di questo bianco
da cui tracima il seme
della programmata apocalisse?
Si direbbe perpetuo
il moto della sapida spuma
che deterge e ricopre le nude caviglie
nell’andirivieni delle alghe
che narrano di un mondo sommerso
in cui rendersi all’evento del silenzio.
Si direbbe immoto il passo
che si offre al circolo
e cerca l’algida pietra
espunta dall’arco primigenio
che un tempo designava l’accesso
per carpirne la radianza e il riflesso.
Per quanti ascessi
dobbiamo ancora differirci?
Quali fasci di fibre slabbrate
dobbiamo ancora immolare
al peso del verbo?
Quante sfumature di luce
da attraversare
prima dell’abbacinamento?
Si difetta la parola
e giunge tronco il suono
l’occhio cieco
si consegna all’erranza
e guida la mano
a incidere il segno
dell’amigdala
nell’incauto solco
che divide la duna
dall’oasi in cui vanirsi
all’avvento dell’inconosciuto.
Non è viltà
quella che mi spinge
a praticare le anse al limite
non èfollia
frequentare ambedue le rive
dell’aporia
né ribadire carta su carta
e rilanciare tre volte la posta
in fiumi d’inchiostro
può alleggerire la soma
delle bordature
in cui inscriversi e quietarsi.
Se l’eco dell’utopia si affievolisse
se le formiche cessassero
di sfilare in processione
sul nudo costato
tatuato dall’incedere del tempo
se la violenza d’una lingua
che non può appartenere
all’incoscienza dell’immediato
urlasse la sua innata mancanza
se la foga del nostro inesausto girovagare
ci costringesse al riposo
sotto quell’arco di duro granito
riusciremo forse
a urlare il senso dell’attesa
soffiandone l’essenza
come un grano di sabbia
dal palmo di una mano
che svanisce nel momento stesso
del suo più intenso splendore.
Enzo Campi. Nato a Caserta nel 1961. Vive e lavora a Reggio Emilia dal 1990. È presente in alcune antologie poetiche. È redattore dei blog letterari La Dimora del Tempo Sospeso e Poetarum Silva. È autore del saggio filosofico Chaos Pesare-Pensare scaricabile sul sito della compagnia teatrale Lenz Rifrazioni di Parma. Ha pubblicato per i tipi di Liberodiscrivere Edizioni (Genova) il saggio filosofico-sociale Donne – (don)o e (ne)mesi nel 2007 e il saggio di critica letteraria Gesti d’aria e incombenze di luce nel 2008. Nel 2009 ha pubblicato per BCE-Samiszdat (Parma) il volume di poesie L’inestinguibile lucore dell’ombra. Sempre per lo stesso editore ha curato una postfazione in Collezione di piccoli rancori di Lara Arvasi e l’antologia di prosa e poesia Poetarum Silva. Nel 2010 ha curato una postfazione in Di sole voci di Silvia Rosa (LietoColle – Como) e pubblicato il poemetto ipotesi corpo (Smasher – Messina). Dal 2011 dirige la Collana di letteratura contemporanea Rasoi e cura il Premio Letterario Ulteriora Mirari per conto delle Edizioni Smasher.
Febbraio 2011, anno VIII, numero 13
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
quali città, quali metropoli stranite o suburbia
quali silenzi a crepitare, quali sussurri
delle vene che non ci hanno tenuto
di un accordo fra lo sterminato e un suo lato
introvabile tessitura delle cose perdute
sta fra il passato e il niente
reincarnarsi nella penna, per volare
al vano che rigenera l’ignoto
In questa sorta di “cover per frammenti”, o poetico mosaico, è ripreso un verso per ciascuno degli otto poeti (Enzo Campi, Alessandra Cava, Marianna Marino, Luca Paci, Luisa Pianzola, Stefano Piva, Michele Porsia, Marta Rodini) compresi nel presente numero di “Carte nel vento”, scelti tra i concorrenti per le sezioni di inediti del XXIV Premio Lorenzo Montano.
Non c’è fermata nell’incessante lavoro sulla poesia di questo Premio, nella continua ricerca e proposta di valori poetici, oltre gli esiti.
Grazie alla novità della scorsa edizione, “Una prosa inedita”, possiamo qui leggere i saggi di Sebastiano Aglieco, Sandra Morero e Viviana Scarinci, nonché le prose di Evelina De Signoribus e Matteo Vercesi. Le immagini sono di Alberto Mori, poeta e artista più volte in finale nel corso degli ultimi anni.
La nuova, 25^ edizione del Premio Lorenzo Montano, scade il 31 marzo 2011: invitiamo alla partecipazione per continuare a mettere in circolazione altra poesia, altri saggi, altra prosa.
Scarica il bando [pdf 84,05 KB].
Ranieri Teti premio.montano@anteremedizioni.it
Evelina De Signoribus, “Trasalimenti”, racconto inedito
Trasalimenti
In alcuni casi non ci accorgiamo quando le ferite si aprono perché non sempre fanno subito male. A volte il sangue che fuoriesce sembra inarrestabile e prende una consistenza che spaventa e annebbia la vista… Altri si accasciano, senza segni apparenti di violenza, in una terra che diviene sconosciuta...
Così mi càpita, sempre più spesso. E quando mi riprendo cerco di pensare una cosa alla volta. Mi devo muovere lentamente per organizzare meglio lo spazio intorno a me, per passare inosservata e camuffare il disagio.
Credo che tu sia uscito stamattina presto. Ora anche io mi dirigo a stento verso l’appendiabiti, prendo il cappotto ed esco senza indossarlo. Non ho né caldo né freddo. Arrivo in strada e la ragazza del bar di fronte mi fa cenno con la mano di avvicinarmi, vuole offrirmi un caffè. Ci siamo conosciute un giorno che io ero sola. Parla tanto e non capisco tutto quello che dice. Ma mi piace stare seduta e ascoltare. Entrano due clienti, sembrano molto indaffarati, forse devono ancora fare pranzo. La ragazza è agitata e io giustamente non esisto più e torno in strada…
Mi chiedo quanto conti la mano tesa verso l’altro. La sempre più rara tensione dell’arto in procinto di aiutare. L’accoglimento di quel gesto che può essere incondizionato o perplesso. Invece vince sempre il vuoto degli sguardi. E l’impossibilità della parola, la fine del linguaggio, l’amnesia del tatto, preannunciano l’ennesimo boato.
Ci scompigliamo, scappiamo o ci buttiamo a terra.
Ho camminato tanto e non so più dove mi trovo, tutti vanno avanti e indietro e io mi sono perduta, non conosco bene questa città, si sta facendo notte e le luci delle auto quasi mi vengono addosso. Mi trapassano e finiscono fin dentro le case, o esplodono dentro gli occhi e accecano.
Potrei aspettare anche qui, dove sono finita, se tu venissi a prendermi.
Senza muovermi, mi accuccio e non darò nell’occhio. La gente non si cura più tanto di quello che fai e non ti dovrai nemmeno vergognare di me. Se non ti vedo e mi vedi tu, per primo, chiamami, così che mi alzo e ti vengo incontro e ti chiederò scusa perché non sarei dovuta uscire. Ma forse avevo un’oscura ragione per uscire…Forse sono scappata per gli incessanti bombardamenti… In questo posto, dove mi trovo, non so darti un punto di riferimento, mi sembra tutto uguale, un luogo raso al suolo. Non vedo più le case.
Per terra non ci sono né formiche né foglie, qualcuno le avrà spazzate prima del vento. Mentre mi riporterai dove abitiamo, vedrai che indosso il cappotto verde scuro. Mi perdonerai se non sono brava a orientarmi ma a casa ogni cosa l’ho lasciata al proprio posto.
Mentre aspetto provo a pregare come faceva mia nonna. Ma non so bene come si fa, quello che si deve dire. Per molto tempo ho pensato che non sarebbe mai stato necessario, che mai mi sarei ridotta a quel mistero. Lei bisbigliava qualcosa tra i denti che tanto mi incuriosiva ma che non riuscivo a percepire, teneva una corona in mano e la passava e ripassava tra le dita. Se ne avessi una, con me, adesso, potrei stringerla anche io tra le mani e forse mi verrebbe in mente qualcosa da pronunciare. Non ho catenine al collo. E non conosco i santi di questa città. I loro giorni, le loro feste, i loro martiri. Qui conosco solo te.
Allora è questa la guerra? Quella che mette nelle condizioni di non poter dire e fare nulla? Mi sembra di avere, in questo frangente, un attimo di lucidità. Eri tu che mi parlavi spesso della guerra e se ne parlavi, mi domando, la conoscevi? Avevi messo da parte delle armi per difenderti?
Poi vedo il nero più profondo nella notte dichiarata.
Dammi il consenso di ritornare a casa, te lo chiedo in segno di resa. Non pensare che sia troppo, non vederla come un’intromissione. Non fare un mistero dei tuoi averi. Un barbone, uno sbandato, un parassita… non credere che sei, tu, un dio, quando lanci una moneta. Quello non è un segno di carità e tantomeno una conversione. Chi ti ha creduto è disperato, così come chi non ha mai pensato alla tua esistenza. Quanti postulanti vedi ora in più ai tuoi piedi? In ogni caso siamo tanti… per questo, quando ti tendiamo la mano, hai l’imbarazzo della scelta? Avere la possibilità di scegliere significa essere libero e non sacrificato. Sei vestito e corazzato e potresti salvarmi.
Mi assopisco e quando riapro gli occhi mi rendo conto che è da te che dovrei fuggire, dalla tua guerra. Vorrei quasi costringermi ad attraversare la strada, a muovermi. Qualcosa ancora mi trattiene. Ma nessuno ha luce e anche nel tuo esercito sono in troppi a gridare.
Evelina De Signoribus è nata nel 1978. E’ laureata in Letteratura Italiana Contemporanea a La Sapienza di Roma. Alcune sequenze poetiche sono apparse su “Nuovi Argomenti” (n. 36, 2006), “Il Caffè illustrato” (n. 34, 2007), “L’immaginazione” (n. 233, 2007) e nelle antologie 12 Poetesse italiane (Nuova Editrice Magenta, Varese 2007) e Jardines secretos Joven Poesìa Italiana (trad. di Emilio Coco, SIAL Ediciones, Madrid 2008). Nel 2008 ha pubblicato il quaderno di racconti La capitale straniera (questipiccoli, Ascoli Piceno). La sua prima raccolta di poesie si intitola Pronuncia d’inverno (Canalini e Santoni, Ancona 2009).
Alberto Mori, immagini, “Ferro & ombra”

Ferro offre bianco e nero in energia neutra
Ombra astrae ad altra dimensione
Le linee ad intrecciare la fuga proiettiva del sole




Alberto Mori, poeta, performer e artista, in più di vent’anni di attività ha costruito e alimentato una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando di volta in volta altre forme d’arte e di comunicazione, dalla prosa alla performance, all’installazione, al video e alla fotografia. Nello stesso tempo, ha collaborato con molti fra i più noti poeti contemporanei, italiani e stranieri, per la realizzazione di letture pubbliche, manifestazioni ed eventi dedicati alla poesia. Ha all’attivo numerose pubblicazioni. Nel 2001 Iperpoesie per Save As Edicion e nel 2006 Utópos per Emboscall. Peccata Minuta sono stati tradotti in Spagna. Più volte finalista al Premio di Poesia Lorenzo Montano.
Website: www.albertomoripoeta.com
Matteo Vercesi, “Frammenti dal diario dell’erosione”, prosa inedita
LA MADRE DI MÜNCHAUSEN
Si narra che una signora di mezza età, madre di un bambino, sposata da decenni, portasse settimanalmente il proprio piccolo in ambulatori ed ospedali, e lo facesse sottoporre ad esami clinici continui, terrorizzata dal continuo malessere del figlio, inspiegabile; mai rassicurata dalle risposte dei dottori, che escludevano il male essersi impossessato di quel corpo.
Pure il bambino morì. E lei a gridare contro gli assassini in veste bianca, simili a sacerdoti in sacrificio.
Si scoprì che lei lo aveva avvelenato, lentamente, a piccole dosi; che lo strazio del bambino derivava dal quel quotidiano rito della madre, silenzioso e invisibile a tutti. Non negò, né si sentì colpevole. Lo sentiva liberato per sempre, leggero ora.
Avrebbe dovuto liberarsi da se stesso, tirandosi per i capelli, il piccolo Münchausen. Ma troppo piccole le braccia, e pesante il corpo da innalzare.
E poi la palude, che risucchiava dal basso, era l’unica cosa che conosceva e di cui in fondo si fidasse.
DICERIA DEL TOPO E DEL SECCHIO D’ACQUA
Da tempo i topi hanno invaso i piani superiori. Si sentono nella soffitta – non è una novità – e correre per le scale. Da tempo hanno preso le abitudini di noi inquilini: non si arrampicano più per i muri; se sentono rumori, spaventati si fermano; si sono disposti a più congrui nutrimenti, optando per i resti dei nostri pasti, lasciando integri fili elettrici e battiscopa.
Una vecchia consigliò di mettere un secchio d’acqua al sommo della scala: se riuscirete ad annegarne uno, disse, tutti gli altri lo seguiranno. Noi l’ascoltammo.
Prendemmo un secchio, lo riempimmo d’acqua, lo portammo alla fine della scala; oltre vi è il tetto. E ci mettemmo ad aspettare. Per ingannare l’attesa parlammo a lungo, seduti, mentre lentamente si faceva buio.
Non ci accorgemmo, conversando, che un topo era finito nell’acqua e annaspava; tentava di risalire le pareti di plastica ma non vi riusciva. Ci eravamo ripromessi di affondarlo con uno straccio ma poi, per inerzia o scarsa convinzione, lo prendemmo in mano e lo lasciammo andare. Fuggì lasciando una scia d’acqua dietro di sé.
Qualcuno tra noi si chiese per quale strano mistero quell'animale non nuotasse; altri perché avremmo dovuto ucciderlo: d’altronde i topi non disturbavano più e si erano pure sforzati per rassomigliarci.
Ma vi fu anche chi si allontanò portando rancore agli uni e agli altri.
TESTAMENTO IN RIVISTA
Mi è capitata in mano, per caso, una rivista: fatta da dei dopolavoristi, in una scuola che li ospita in sere illuminate a neon, ripulita dalle lordure del mattino, dal chiasso delle aule ai cambi di ore. Per anni si sono incontrati, dopo l’ufficio, la fabbrica o la casa: madri e padri di famiglia, per poche ore a settimana, per discutere, confrontarsi, approvare. Tante le materie: poesia, storia locale, onomastica anche.
Una di loro è morta di cancro, poco dopo i cinquanta. Ha scritto una lettera ripercorrendo con il pensiero i momenti trascorsi, ringraziando tutti nell’accomiatarsi.
Insegnava loro spagnolo. Per quanto tutti fossero già impegnati e nessuno avesse intenzione di cambiare impiego – si è troppo avanti infatti con l’età – ed una lingua in più in fondo non servisse, la ascoltavano sempre in assoluto silenzio. Facevano domande, anche. Così li ricordava, e così loro ricordano lei. Nella rivista stampava le sue ricerche.
Basta questo, ma forse molto meno, per fare un’esistenza.
Nota dell'autore: Autoesegesi minima
Le tre brevi prose aprono sentieri intorno ad alcuni nodi emblematici che si nascondono sotto il velo apparente della quiete e del transito ordinario di eventi quotidiani. Nodi che ci spingono alla decifrazione.
La madre di Münchausen attraversa il crinale del doppio legame Eros-Thanatos, rappresentandone il volto orrorifico e patologico.
Diceria del topo e del secchio d'acqua è una – tra le infinite possibili – rappresentazioni delle aberrazioni del potere; la messa in scena del programmatico tentativo di eliminazione dell'«altro». Testamento in rivista è un atto di conciliazione etica nell'intersoggettività. L'unica possibile. M.V.
Matteo Vercesi è dottorando di ricerca in Italianistica e Filologia classico-medievale. Ha al suo attivo pubblicazioni in volumi collettivi e in varie riviste, riferibili prevalentemente alla produzione in volgare del Duecento e Trecento e alla poesia del Novecento e dell'età contemporanea. Si è occupato di aspetti riguardanti la riscrittura letteraria di figure e tòpoi della mitologia classica e della tradizione biblica, collaborando alle opere, edite in più volumi e dirette da Pietro Gibellini, Il mito nella letteratura italiana e La Bibbia nella letteratura italiana (Brescia, Morcelliana); della ricezione e diffusione della figura di Alessandro Magno in epoca medievale e moderna; e di letteratura dialettale, con particolare riguardo alla produzione lirica di Biagio Marin (nel 2007 si è aggiudicato ex aequo il Premio Nazionale di Poesia “Biagio Marin” per la saggistica). È segretario di redazione della rivista internazionale «Letteratura e dialetti». Collabora alle attività di ricerca del Dipartimento di Italianistica e Filologia Romanza dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.
Marta Rodini, poesie da “Entrata in scena”
La presente raccolta, Entrata in scena, è da poco stata pubblicata da Anterem Edizioni, con nota critica di Flavio Ermini.
***
sguardo senz’occhi, cieco tremolìo
attendono il farsi del mio corpo
avrò braccia sottili e caviglie
e reni che ritmeranno i suoni
della strada e mosse ancora d’animale
scattanti di paura e desiderio
***
quali sussurri nell’ecclesia della vita,
dei sottoboschi i bisbiglii, l’alitare
nella sera della fresia, quali sospensori
l’anima a levare nell’ora verso Sirio
la notte e l’alba, dell’ala il sottosuolo,
quali silenzi a crepitare, quali sussurri...
***
anche questo fare che è il disegnare
versi e muovere la lingua in ritmi
soppesare sillabe baciare alternare
incatenare le carte con l’inchiostro
strutturare gradini di scrittura
posizionare il triangolo perfetto o le
metafisiche farfalle anche questo
andar per fogli e migrare da
cielo a terra e dal pane ai versi
dove porta, dov’è il mio rincasare?
***
cos’è questo mestiere di catturare
parole con le pinze attanagliarle
e batterle fino a farle ardenti
tra gli incessanti tramestìi del cuore
ubriacarle come i funamboli di vuoto
sorseggiarle a labbra strette sul bicchiere
frantumarle in sillabe troncate
assettarle nei suoni delle ottave
mascherare le assenze che stan sotto la logica
***
Incamminati a ritroso e duplice sia l’evocazione
nel tuo corpo specchiante, non me trasparenza di musico,
ma lei alle spalle, la sfuggente, la appena intravista,
la troppo amata, la semprepersa; flettine l’immagine
un po’ a lato, guizza e cattura al pizzico concorde
ed entrambi sopporta sulla soglia
Fuori, due passi nella veglia e il mio ovunque divenir banchetto
***
chiude il dito indicante sulla sabbia
una figura di giustizia e spada
ago non flesso a bilanciare
bussa alla porta chiede i rendiconti
dove la bocca della neve s’apre, bianca
una figura di vagiti e fame butta semi
volge i palmi lima la chiave
il suono è nell’aria in sospensione
Ermes si avvolge al polso le due
serpi: indistinti accadere e scomparire
cala il sipario si arrotola il lenzuolo
attorno al capo zittisce anche il silenzio
non ancora naturante il destinarsi
Marta Rodini è nata nella provincia di Cremona. Vive e lavora a Milano. Dal ’92 fa parte del gruppo di scrittura “Sinonimi & Contrari“ fondato da Marina Incerti. Sue poesie sono state pubblicate su diverse riviste, tra cui “Il Segnale”, “Le voci della Luna”, “Poiesis”, con nota critica di Giorgio Linguaglossa e Franco Romanò. I suoi testi sono presenti in varie raccolte antologiche e partecipa a letture poetiche e manifestazioni letterarie.
E’ segnalata per due volte, nel 2007 e nel 2010, alla biennale di Poesia di “Anterem” nell’ambito del premio “Lorenzo Montano”.
Fra i suoi lavori più recenti: “Parole in gioco” ( 2005); “Arabesco al nero” ( 2008 ) edito dagli Archivi del ‘900 come vincitore della VII edizione del Premio Nazionale di Poesia “Antonia Pozzi”; “Poesie dell’acqua” ( 2009 ) Edizioni “Le voci della Luna”; “Entrata in scena” ( 2011), Anterem Edizioni.
Luca Paci, poesie inedite da “Guardafili”
Filò
se fossimo noi
foglie soltanto
l’albore della foglia
l’impressione
della clorofilla
che pulsa
nelle vene del nostro
unico pneuma
Visione
Nome delle cose
Puro nome
traffico delle intenzioni
mezzi di locomozione
fragranza continentale
Impercettibilmente sottile
Jazz
Passato anche il riflesso d’oro degli ottoni
lucea il viso rifratto correa la nota del fa
umore d’acqua nell’assurdo brancolare
la tastiera la ghiaia della batteria
il fumo fumo l’assolo del ragazzo
l’amaro di birra devo continuare
fece il gregario al trombettista
tutto questo in un cenno di mano
devo...
Chet riattacca e se ne va in levare
e l’orchestra tutta lo segue
e l’orchestra cercando un appiglio
un bicchiere una coscia un flicorno
e le donne si stirano al pianto
passano i corpi degli avventori
figure di spettri cospira
il tintinnar di bicchieri cospira
la gira la trama del corpo del
verbo del corpo del verbo la trama.
Pae<s>saggio
I
Divise immagini sciamani tuva
cielo d’occhi sterminati pioppi
depressi slanciano falangi
come all’infinito grido
fanno cenni col capo
un saluto-murmure invano
puntano il selciato nell’atto
di proferire
mani e piedi e seni
croci di voci
presenti-assenti trascina
la risacca dello specchio
figure tagliate a neve
spicchi di frammenti raccolti
pensanti concessi o definiti
dall’iride malferma
IV
il tempo presente
sta fra il passato e il niente
e del rosso non esiste l’ardore
solo colori che sfondano nel grigio
e della grigia limatura hanno il sapore
Immoto
Lucide traiettorie psicogeografiche. Il senso e la dispersione. Il frammento fotogrammatico della narrativa, il pensiero panoramicamente antiaccademico. Disporre parole e frasi con cura. Praticare l’atarassia verbale. Ogni movimento deve essere controllato. La città è flusso. Musica istantaneamente dimenticabile, biforcazione della memoria venuta meno.
Luca Paci (Novara, 1970) ha studiato filosofia e letteratura all’Università di Pavia e a Swansea (Galles) dove ha conseguito un PhD sulla teoria della storia in Croce. Ha vinto il premio internazionale di poesia a Giulianova Terme nel 1994 e pubblicato una raccolta di poesie in inglese (The Fine Line, Chanticleer Press, 2005). Ha tradotto e curato l’edizione inglese de La Ragazza Carla di Elio Pagliarani (Troubador, 2006).
Ha scritto un saggio su Carmelo Bene ed uno sul travestitismo in Pagliarani. Ha collaborato a Cities, architecture and society con un corto su Londra per la Biennale architettura di Venezia nel 2006. È apparso con una serie di poesie sull’antologia Poesia del dissenso II (Joker, 2006). Ha realizzato il videopoema London Triptych con Luke Heeley e Rowan Porteous (Dubious Audio, 2007). Ha contribuito all’antologia Vicino alle nubi sulla montagna crollata (Campanotto, 2008). Ha curato l’edizione di Pro/testo, raccolta di poesie civili contemporanee (Fara, 2009). Ha completato la raccolta Guardafili di cui alcune poesie sono state presentate all’Istituto Italiano di cultura a Londra. Vive ed insegna letteratura italiana e filosofia a Londra.
Viviana Scarinci, “L’amore senza persona”, saggio su Giuseppe Piccoli
Nota dell'autrice
L’amore senza persona è uno scritto che appartiene a una fase iniziale di un percorso conoscitivo riguardante la figura di Giuseppe Piccoli. Percorso che in un secondo tempo, rispecchiando il mio personale approfondimento della sua poetica, mi auguro vedrà la luce in una pubblicazione più ampia. Tuttavia il mio amore per la figura di Piccoli non è recente. Risale al 1997. Quell’anno, in occasione del decennale della sua morte, la rivista Poesia, pubblicò sul numero 103, alcuni inediti a cura di Arnaldo Ederle. Lettera per una domanda di perdono, la poesia analizzata nel testo seguente, era appunto compresa in quella pubblicazione.
L’amore senza persona
“e sarò il tuo concetto
d’amore, debole, senza persona” G.P.
Come in una sinusoide la poesia di Giuseppe Piccoli, in un quadro che ne escluda la cronologia, somiglia a una fluttuazione che assume i caratteri del picco e del recesso, a seconda degli spostamenti di una coscienza poetica assai singolare. Sorvolando su quanto questo si leghi alla patologia che tragicamente gli governò la breve esistenza, qui si vuole solo sondare superficialmente gli effetti, che un dato moto, nel ripetersi, genera su una poetica originale, spesso sorprendente, come quella di questo straordinario poeta.
Il patrimonio poetico che la poesia di Piccoli costituisce è per la maggior parte inedito e frammentato in pubblicazioni di non facile reperimento. Inoltre, anche la cronologia della sua opera non è di semplice ricostruzione. E ciò ha stabilito, prima come un’esigenza, poi come una fascinazione cui è stato difficile sottrarsi, questo pormi all’ascolto, in un modo del tutto improprio ossia leggendo il poeta, come sperimentandone empiricamente il respiro. Una lettura cioè che, a prescindere dalla collocazione cronologica delle poesie analizzate, le raccolga in un tempo zero che ne metta in luce ciò che intuitivamente mi è parso il movimento costante di questa poetica. Compresi in quest’ottica i versi sembrano come pronunciati da un moderno Orfeo che si ascolti parlare, ora dalla superficie e ora dall’infero stesso. È da immaginarsi, questa poesia, per assurdo, come fosse una vera e propria fluttuazione, come il ritmo costante di una respirazione vista nel suo aspetto di coscienza del respiro in un punto di concentrazione recondito che è la radice umana dell’aria, e dello sperdimento, che procura l’esalazione di questa radice. Così la parola di Giuseppe Piccoli assuma il carattere innato del respiro e insieme il suo aspetto di estrema necessità. Qui è assai forte l’impressione di una parola poetica che si lega a una fluttuazione della coscienza, da un recesso interiore alle labbra, alla pelle, cui il poeta approda, proveniente dal suo abisso, con l’angoscia che questa non protegga. Pare con ciò che in questa poesia convivano due lingue di provenienza. C’è una lingua pulitissima, lapidaria. E assai consapevole. C’è ne un’altra aulica, quasi leziosa. É la prima, quella legata ai recessi, la più ariosa, la più illuminata da un sentimento di complessità che non tradisce spavento nella dizione del suo infero. E una seconda che diventa leziosa fin quasi al querulo, quando risale alla percezione epidermica, al mare magnum della superficie abitata dal mondo di sopra.
La scelta di analizzare la poesia “Lettera per una domanda di perdono” è data non solo dall’indiscutibile bellezza del testo ma perché nella sua struttura, rappresenta pienamente la sinusoide in cui Piccoli (malgrado la sua opera sia ancora tutta da studiare e ciò ne rappresenti solo un aspetto) non veste i panni di Orfeo, in un orfismo di genere, ma ne dimostra la sua incarnazione, tornando a essere il poeta che per primo fu chiamato a porsi tra fisica e metafisica senza la difesa di un ruolo che ne regoli la coscienza ma solo con il respiro come bussola.
“L’esperienza ci ha strappati
l’uno dall’altra, amore;
l’esperienza ci ha rattristati
l’uno nell’altra, amore;
e il mio “tu” e il tuo “tu”
si perdono nel vento:
quale furtiva foglia
asciugherà il pianto del rubinetto?
Quale cotone assorbirà
il mio canto?
Io nudo come il cielo;
tu troppo densa, troppo carica,
troppo, troppo.
Sbaglio le parole e suono
come un peccato, come una percossa,
come un tradimento, come una pazzia.
E tu, se mi disegni a lungo,
mi perdi. Ritrovami
nel giuramento della sera:
io sono
il dèmone del dramma e della catarsi.
Ma per raggiungerti in purezza
dovrò mangiarmi le mani?
La tua bocca mi guarda e io svanisco,
insano dentro una perla
umida di nebbia.
Le tue mani mi dividono
e io scivolo
in un tempo di zanzare.
Resta solo di me il bicchiere
di questo seme sparso sul cuscino;
le radici di questa barba
che abbrutisce il cuore;
il grido di questa gola
che nessuna pastiglia addolcisce
e questa rovina che assapora
tutto il pudore che mi resta,
tutta la malizia che ho consumato
e tutto il canto.
Vieni, e credi di nuovo
che il mio corpo, sposo del tuo;
che il mio silenzio, padre del tuo;
che il mio canto, fratello
della tua amarezza
raggiunga il dio nel tutto che supplichi
e s’allontana.
Non ci sono più ossa, ma rose;
non ci sono più muri ma strade;
non ci sono più inverni, non ci sono:
tra poco è marzo, vieni,
camminiamo.” (1)
L’esperienza separa, l’esperienza rattrista. Sembra da questi versi iniziali, come se da un punto noto e inamovibile il poeta osservasse il percorso che avrebbe potuto autenticare il suo presente adulto. Vista da qui, l’inamovibilità di questo poeta risiedere nell’adolescenza, forse nella frattura non ricomponibile di un osso fragile ma anche nella prepotenza inesausta che la poesia esercita con la sua complessità, sulla coscienza galvanica di un giovane poeta, prima ancora che la si nomini come tale. “L’adolescente (Piccoli) ha tratto dai libri aneddoti dalla valenza enigmatica che si concretizzano poi nella sua poesia in una fuga che pare fondamentalmente riconducibile all’archetipo di Orfeo che scende agli inferi per ottenere, in realtà per perdere definitivamente Euridice (…)”. (2)
Da allora, dall’adolescenza, dall’inizio glorioso del viaggio dell’eroe, al ritrovamento e perdita di Euridice, c’è tutto un separarsi e un rattristarsi che riguarda l’ambito adulto e pieno. È attraverso questi versi iniziali, che il poeta sembra guardare da un suo punto inamovibile, all’assenza totale di leggerezza dell’adulto. A ciò si riferisce da adolescente che al contrario è sopravvissuto all’adulto, poiché l’esperienza, nel suo caso, in qualche modo, sembra aver impedito alla maturità il suo compimento. È da questa inamovibilità che Piccoli guarda a un’interlocutrice, una Euridice che oltre a essere “orfica” qui è conchiusa nel mistero dell’alterità, attraente e estranea perché non più rarefatta nell’adolescenza delle passioni indistinte e voraci che brucano ma addensata in un troppo, reiterata in una densità femminea e adulta che la eccede e spaventa. Spaventa senza limitare. Uno spavento che schiude la prosecuzione necessariamente alterata e irrimediabile che fa capo a ogni alterità ravvisabile nell’altro, in superficie. Uno spavento che confonde parole e contenuti in modo da legare per serendipità dramma e catarsi, per analogia consunzione e germe, cosicché si commetta l’oltranza: la visione che nella grande poesia perpetra gli astanti senza riguardarli. Ma ora l’unico potere che due alterità abbiano in questo tu per tu, il poeta lo riconosce a Lei che separa, Lei che è percepita fino alla radice irsuta del volto e da quel bilico canta l’opposto, elargendosi ora in una chimera glabra, ora in una rovinosa caduta del pudore di fronte alla realtà innegabile della propria umanità di genere.
“Dalla finestra
sale un buon odore di fiori,
dalla cantina sale un buon odore
di vino: non è questa, la vita?
Questo grido che mi interromperà
mentre scrivo il mio canto?
Le ciabatte calpestano: “Vengo”;
gli sportelli si chiudono: “Vengo”;
le bottiglie si stappano: “Vengo”.
E le voci? Che fanno le voci?
Cadono e invecchiano
E tu le seppellisci, lontano.
Ed io le riesumo, vicino.
E presto non avrò che tempo
tra i libri; non avrò che spazio
tra i vestiti; e sarò il tuo concetto
d’amore, debole, senza persona.
E cadere nel folto dei padri
e della madri, assaggiando la torta
del sacro e del profano.
Attendo che una porta si svegli,
e che un bambino reciti per me
la morte ossigenata, la fuga espiata,
la pietà saziata, la percossa dimenticata:
tu inseguilo al limite, tu
la casa che sale dagli inferi,
a perdonare se ho rubato,
se ho fatto violenza, se ho maltrattato
sopra e sotto
gli elementi e i punti insaziabili” (3)
Ma non sempre il giorno consente un’oltranza sulle cose. E non sempre deve. Non quando si avvicina marzo: le calende primaverili smagano la visione dell’infero in superfici solari e pure, disdicono le sonorità del profondo, quando chiedono l’oscurità arcaica della vista. E ciò accade con un tale clamore da chiedersi, quale la vita: questa o quella? Quella del vino, del canto e del pane: e emergere a questa con una fatica immensa, di sotto a sopra, da quella a questa luce. Come discernere nelle profondità “nel folto dei padri e delle madri” il lecito dall’illecito? Come differenziare la movenza che conduce il corpo, dal solco che esso genera?
In che tempistica ciò avviene? Come non soggiacere all’impossibilità di sapere il quando, il dove del proprio corpo, mentre qui e ora, in questa superficie piana che è il visibile, non compare la prepotenza di esistere, in quanto compresa in un meandro che non libera il poeta, se non attraverso il verso che lo dice. Come perdonarsi allora la disperata ferocia che arma la liberazione da questo smarrimento?
E chi sarà in grado di perdonare se si ruba una chiave, per evadere dall’insanabilità di una casa chiamata appartenenza? Ma il profondo della casa, nel caso di Piccoli, conclama il mistero delle voci plurime che non gli appartengono ma avendolo scelto, lo straziano per differenza dal suo presente, con un legame tagliente e vorace che lo condanna a sentirsene mai differenziato.
“Ma basta un fiore che dubita,
per dare o ridare salute al disamore:
dubita forse che siamo? che parliamo?
La sua sapienza stagionale
è più forte dei nervi che leggi
nel gas della ragione, quando leggi
i tuoi discorsi disaccordi e mi telefoni
pallida e nervosa. E disfi
la maglia dell’abbraccio, la gabbia
che non suona, e stai zitta, stai
zitta. “Punìscilo” ti dice ancora …chi?
“Punìscilo”, “Puniscìlo”. E tu:
“No: sono stanca. Solo stanca
di vedere le mani, di ascoltare la voce,
e un poco stanca di essere me stessa”.
Io mi attuo. Tu vivi di stanze.
Io ti lascio. Tu ti lasci lasciare.
Io ti guardo. Tu ti lasci vedere.
Non guardi. Ma respiri. Respiri.
E osservo la tua statura,
allungarsi e calare; le tue braccia,
asciutte o insaponate; la tua testa
cerchiata. E sei profonda
come la disperazione.
Ma amo i fiori, per oggi;
e, per oggi sono un ragazzo tranquillo:
e posso renderti cenere, credo.
Ma vedi, ho digiunato, per te, per me,
per una pioggia e per molti baci.
Molti. Molti. Tuo” (4)
È ancora Lei con la sua presa sulla realtà a contenderlo per un po’ alle voci. Lei, l’eterno femminino che veglia sulle valenze plurime e tutte le sintomatologie dei generi nutre. Lei che quelle voci sa e che pure ascolta ma ne è libera, esse non la pretendono, come invece pretendono il poeta. Il poeta che già sa quale termine la contesa abbia: Lei è stanca, Lei può stancarsi e punirlo lasciandolo alle voci e all’interregno che queste gli vegliano nell’occhio, per farsi dire. E il poeta dice tutto, da questo sguardo che più che appartenergli lo appartiene, tutto, fino alla visione di Lei, vera, più vera della realtà e della sua assenza di verità. Ma è marzo. Un mese somigliantissimo alle correnti controverse che attraversano la poesia di Piccoli che è “come se si trattasse ogni volta di un miele sparso dentro cui c’è sempre qualcosa di estremamente tagliente, come delle lamette, delle tagliole, che sono pronte, mentre la dolcezza sembra ammaliarti, a ferirti a colpirti nel profondo, a darti dei fendenti dai quali è impossibile poi guarire” (5) . Tuttavia questo è uno strano giorno in cui le voci oltre che essere dette non vogliono altro e lasciano il poeta tranquillo, credere, senza davvero crederci che il suo digiuno, possa garantirlo incolume dalle virate rapaci che la poesia impone alle sue fattezze.
Note
(1) Giuseppe Piccoli, Lettera per una domanda di perdono, Poesia 103, Crocetti Editore, Febbraio 1997 pag.70
(2) Giulio Galetto, Orfeo nella poesia di Piccoli, “Bollettino della Società Letteraria di Verona ”, 1998-1999, pp. 83-86
(3) Giuseppe Piccoli, Lettera per una domanda di perdono, Poesia 103, Crocetti Editore, Febbraio 1997 pag.70-71
(4) Ivi, p.71
(5) Maurizio Cucchi, Per una sistemazione critica di Giuseppe Piccoli, “Bollettino della Società Letteraria di Verona”, 1998-1999, pp.83-86
Giuseppe Piccoli nacque il 5 aprile 1949 a Verona. Seguì studi classici senza però portarli a termini, dedicandosi giova-nissimo a scrivere poesia, prosa e articoli di critica letteraria per “L’Arena”. Nel settembre del 1981, in seguito a una ricaduta della sua malattia psichica, ferì il padre, che morì dopo pochi giorni, e la madre, che invece si salvò. Venne re-cluso nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia per un pe-riodo di detenzione di dieci anni. In seguito fu trasferito in altri reclusori. L’ultimo che lo ospitò fu quello di Napoli dove, nel febbraio del 1987, si tolse la vita.
Viviana Scarinci è nata nel 1973. Ha curato per Apeiron Editori, il libro di memorie collettive L’isola di Kesselring. Ha vinto diversi premi letterari tra cui la sezione Scrivere i Colori del Premio Grinzane Cavour. Le sue poesie sono state pubblicate tra l’altro su Nuovi Argomenti, Atelier, Gradiva, Capoverso, il Segnale, Tratti. Nel Gennaio 2009 è uscito il libro Le intenzioni del baro, poesie 1995-2007. Fa parte della redazione del blog letterario collettivo Viadellebelledonne. Nel giugno 2010 partecipa al numero 86 de Il segnale, percorsi di ricerca letteraria con l’articolo Regole e virtualità. Ha pubblicato con Paolo Fichera l’eBook Dormi come visibile. Suoi scritti sono presenti sui principali blog di letteratura. Gestisce i suoi inediti attraverso il blog http://vivianascarinci.wordpress.com/
Marianna Marino, poesie inedite da “Mangiaragni”
Nota dell'autrice
Queste parole sono strenuamente a caccia di una controparola. E far poesia del vissuto diviene la forma più assoluta di perifrasi: dire altrimenti, dare un nome, un altro nome.
Al contempo, far della poesia una parola-a-distanza, che permetta di vedere la voce che la dice o si strozza. Ecco dunque il ragno, esserino pacifico che Leontes, protagonista del Racconto d’inverno shakespeariano, trova in fondo al suo folle calice amaro. Una strana sensazione tra disgusto e solletico. Un dolore bizzarro, all’altezza delle corde vocali. Ma in Mangiaragni il ragno non è il visibile indizio di un veleno: il ragno è volontariamente mangiato. È un male da buttar giù a colazione, a pranzo, a cena. Il male quotidiano che ci nutre e sostiene. M.M.
Mangiaragni
da La controparola
Perifrasi sentimentale
Un istante di verità,
di libertà nella stretta:
del braccio,
del senso.
Nel morso dell’ora.
***
Paesaggio
è allontanare la parola – là,
dove si vede la voce.
***
Notti troppo cattive per darmi buio,
e silenzio.
Gli occhi sempre stanchi:
corrono dietro i colori,
ma vogliono bianco.
Vogliono una luce lieve,
un giorno di meno.
Un altro nome al dolore.
da Donne
Paris
Eccomi: paccottiglia dorata e adorata.
Il mio vuoto è dolce e luminoso,
non mi chiede nulla in cambio.
Mi basta sorridere,
senza neanche guardare.
Bocca cieca, le parole scivolano via
- significano lontano da me.
***
In nome di quell’uomo di meno
ci guardiamo,
cerchiamo la linea della ferita,
la reliquia del dolore.
Ci guardiamo,
e non sappiamo più
dove sia lo specchio.
da A mio fratello
Requiem
Di noi resterà
il nostro calco,
scavato pian piano
nell’aria.
Il silenzio che non abbiamo giocato.
Le trasparenze ribaltate degli specchi,
i ritratti increspati, imprecisi,
dei sorrisi nascosti.
Delle vene
che non ci hanno tenuto.
Marianna Marino, dottore di ricerca probabilmente senza futuro, cerca di adattarsi a un presente precario. La sua tesi di laurea è stata dedicata al poeta e filosofo Jacques Garelli.
Luisa Pianzola, “Coltivazione del deserto”, poesia inedita
Coltivazione del deserto
1
Non mi spaventi. Schiacciami, tempo. Pianifica
per tutti noi la totale assenza di futuro. Vedi
che restiamo immobili duraturi, finché la biologia
ce lo permette, anche per moltissimi anni. Possiamo
vedere molto bene, da questa postazione, la tundra
ghiacciata delle possibilità. Ci prepariamo a coprire,
dopo l’esondazione, migliaia di chilometri resi
vergini da un sistema solare spietato.
Ma abbiamo bisogno – non ci crederai – di questa
desertificazione. L’abbiamo voluta, ci appartiene
come questo suolo lunare da nausea.
2
Niente è ancora troppo poco. Tanto vale il mai
stato, il mai essere stati e con un colpo di frusta
completare il quadro: zero. Uno zero docile, attivo,
dove poggiare la sapienza molle. Io su questa rada
totale ci faccio un picnic, mi ci rotolo coi miei simili,
ci preparo una nuova specie, magari senza testa
né gambe.
3
Quali città, quali metropoli stranite o suburbia
allampanata: qui saranno tutti campi, prati di nuova
seminazione. Mi basta un cenno (sono un tipo
pratico) e mi faccio da parte per le nuove
generazioni.
Come prendere congedo da sé e da conduttori esausti dare
un ordine al vissuto. Senza mestizia collocare la parola fine.
Ma non mortale, da guarire e darne un segno, da vedere oltre.
Nota dell'autrice
Nel rileggere questo testo, segmento di un lavoro inedito, ritrovo una spinta verso il
basso e una tensione al grado zero (che appartengono alla mia poesia) bizzarramente
mescolate a uno sguardo quasi divertito, a un’idea di positività caparbia e un po’
cattiva. Ho sentito fin da subito che lo scenario desolato di questi versi non era fatto
solo di macerie esistenziali, personali, ma aveva a che fare con le derive del nostro
tempo. L.P.
Luisa Pianzola (Tortona 1960) è poetessa, giornalista e copywriter. Si è laureata in Storia dell’arte contemporanea (Lettere moderne) all’Università di Genova e ha studiato visual design a Milano. Ha pubblicato i libri di poesia Salva la notte (La Vita Felice, Milano 2010, note critiche di Gabriela Fantato e Mario Santagostini), La scena era questa (LietoColle 2006, prefazione di Gianni Turchetta), Corpo di G. (LietoColle, Faloppio 2003, prefazione di Maurizio Cucchi), Sul Caramba (Sapiens, Milano 1992). Coautrice del video poetico Bíos (2007) e cocuratrice dell’edizione 2006 de Il Segreto delle Fragole (LietoColle), suoi testi sono apparsi nelle riviste “Specchio”, “Poesia”, “Pagine”, “La Clessidra”, nei siti web Blanc de ta nuque, Liberinversi, La poesia e lo spirito, Terres de femmes e sono presenti nei volumi Senza Riparo. Poesia e Finitezza (Stefano Guglielmin, La Vita Felice, Milano 2009), Leggére variazioni di rotta (Le voci della luna, Sasso Marconi 2008), La nebbia non si mangia.
Dodici poeti alessandrini (in uscita per Manifattura Torino Poesia). Ha ricevuto riconoscimenti ai premi BazzanoPoesia (2010), Lorenzo Montano, D. M. Turoldo (2009, menzione speciale della Giuria), Città di Corciano (2008, Premio Presidente della Giuria). Ha partecipato a readings poetici in varie città italiane.
È redattore della rivista di poesia “La Mosca di Milano”.
Il suo sito internet è www.luisapianzola.it.
Alessandra Cava, poesie inedite da “RSVP”
***
in sorellanza sono gli anni gentili, sono gli anni, indicativi
presenti, muscolo lingua che sbava disegni sull’incanto dello stare
dove i muri si incontrano, nel tutto finito e oltre, e
oltre neppure un suono: il sottoscala non ha porte, non si slacciano
i polsi, non chiama nessuno, nessuno muore -
***
in memoria imprimo l’angolo dell’oggetto: registrarsi immobile
del frammento, inquadratura fissa della frammentazione, contorno
da strofinare con l’occhio, depositarsi antiquario dell’occhio in potenza
nascosta di cosa, di pezzetto di carta, di orecchino, di scarpa
di bambola, in sua piccolezza, in sua riduzione indicibile -
***
e cammino in queste strade incrinate, in queste
fuorviate strade del petto, nel battere clamoroso
del petto, nello spaccato battere di questo mio divenire
orizzonte, sala d’aspetto, corpo in filigrana, organo incerto -
***
fossi il limite inutile, l’inganno del confine, fossi l’apertura
generosa del valicare, fossi quella generosità del confine a
schiudersi, disponibilità infinita dell’accedere, del passare,
dell’oltre, del traversare - potessi sporgermi da tutti i balconi
e vedere passare, potessi vedere passare le cose, potessi, sapere
per caso che cosa, l’oggetto che ha trama speciale, che ha l’intreccio
introvabile, lo strappo, introvabile tessitura delle cose perdute -
***
amore durissimo, articolarsi delle ossa, scorrevole
rotolarsi delle ossa dalla pelle, solitarie per quel loro esitare
la diramazione, incantare, mettersi nel canto, mettersi
tutte nel canto, nell’aspro canto del sangue, nell’angolo
appuntito dei nervi, nello schiocco delle membrane, nelle aritmie,
nella violenza delle arterie, per quel lasciarsi ricoprire, isole
bianchissime nella carne, per la loro modestia di impalcatura,
di scheletro schivo, di lungo fiore sotterraneo, di radice -
***
oggi è un sole lungo, uno sguardo di notte bianca -
natura mi scosta, mi ignora: di sicuro la offende
il mio amore d’interni, di tubi, di tetti, di vetri all’incastro;
ma poco le basta, quel poco che afferra alle spalle
con passi d’altalena, quando sbaglia e prende aloni d’inferno,
quando pare artificio, un inganno, uno schermo
e m’attendo si spenga - processo d’infrazione del mondo, nulla
che raduna i suoi pezzi, così il mio seguire una parola
con altra in spazi di vuoto - ecco me allora, a chiedere di quale
tessuto è il ricordo, di quale s’intreccia, se è uguale, uguale
il colore - ecco allora l’immagine fatta di niente, ecco che arriva,
ecco, col suo bagaglio di niente - si sta a scrivere
allora, si sta in angolo stretto, si sta –
***
continuo stare, questo stare in vita per vie traverse,
secondarie strade dell’assenza che disegna nitida
la fessura del canale, questo stare in parole abitando
la dimensione orizzontale, leggera, del narrare -
ora è estate che sfinisce, liquefazione dei sensi,
dei cataloghi ragionati: si va a capo per sentito dire,
dentro un’istintiva nostalgia di mani fredde, di giri di maniglie,
di vento e strade vuote - neanche ora c’è equilibrio,
qui nell’aria ferma della scelta si sta a caso e per stortura
d’animo, qui si incrociano gli sguardi e si distolgono, ma le dita
sfuggono, tentano raccordi - tutto intorno è piegarsi alle linee
spezzate e chi ha un vago rimpianto dei tornanti non si volta -
mentre io vado a cercare sconforto negli specchi, le ginocchia
mi abbandonano davanti allo splendore, ormai luogo
comune, che ancora non abbiamo consegnato -
ALESSANDRA CAVA è nata a San Benedetto del Tronto nel gennaio 1984. Ha studiato Storia del teatro all’Università di Siena e vive ora tra Roma e Bologna, dove si sta laureando in Discipline dello spettacolo dal vivo. Lavora con Altre Velocità, gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche. La sua prima raccolta, rsvp, segnalata al Premio Montano, è di prossima pubblicazione per Polìmata, collana ex[t]ratione.
Sandra Morero, "E' così...un incontro", saggio su Clarice Lispector
SU “L’ORA DELLA STELLA” di Clarice Lispector
Tutto inizia in un attimo denso come un lungo sonno. Una bancarella; libri letti sporchi e consumati. Come a spiare i letti di divoratori ansiosi e insonni, e lampadine appannate dal fiato della notte. Osservo, scarto, compro un libretto. Non so perché. Giace nella mia mano, inconsapevole. Grigio-nero-raschiato con scritta gialla e rosa. Due mani secche stringono al cuore rami nervosi e fiori indistinguibili dal consumato dello sfondo. Volto ovale bianco sotto il titolo: L’ORA DELLA STELLA. Due occhi neri e stanchi, labbra fresche di bambina protese in un sussurro. Uno sguardo asimmetrico mi attraversa e cerca il mio sfondo. Il nome: Clarice Lispector, misticanza di erbe espettoranti e fiori bianchi, profumo di sambuco e di cannella. 90 foglietti giallognoli di carta scarsa.
Sulla quarta di copertina leggo: “questo romanzo, pubblicato nel 1977, lo stesso anno della morte di Clarice Lispector, è considerato il testamento spirituale della grande scrittrice brasiliana.”
Il demone assopito alle mie spalle ora mi sveglia.
Una scrittura che mi legge. Sarà questo il mistero da velare? Scrivo solo per necessità. Necessità di chi? Solo porosa alla materia verbale. Non chiedere altro. Che la materia entri! Ineffabile, sottile, avvolgente. Bozzolo di seta buia. Per sciogliere il tempo addensato nell’istante-già. Accadimenti futuri e passati inconclusi si avvolgono alle dita. Amore. Non capisco più. Sento soltanto?
Il sussurro ora è assordante.
Un punto di domanda. Non c’è ritorno. All’ingenuità sola si torna. Oppure no.
L’inizio è quasi un tuffo:
dedica dell’autore (alias Clarice Lispector)
seguito da vertigine:
E poiché dedico quanto segue al vecchio Schumann e alla dolce Clara che
oggi sono ossa, pietà di noi! Mi dedico al rosso intenso scarlatto come il
mio sangue di uomo adulto e mi dedico quindi al mio sangue… Mi dedico
alla tempesta di Beethoven. Alla vibrazione dei colori neutri di Bach. A
Chopin che mi ammolla le ossa. A Stravinskij che mi ha sbalordito e con il
quale sono volato in fuoco. Alla “Morte e Trasfigurazione” in cui Richard
Strauss mi rivela un destino? Mi dedico soprattutto alle vigilie di oggi e
all’oggi, al velo trasparente di Debussy… a Schönberg, ai dodecafonici, ai
gridi raschianti degli elettronici – a tutti coloro che in me hanno raggiunto
zone spaventosamente impreviste, a tutti i profeti del presente che tanto mi
hanno predetto, a ma stesso che in questo istante esplodo nell’io. Quell’io che
siete “voi” perché non tollero di essere solamente io, ho bisogno degli altri
per stare in piedi…
Questa storia ha luogo in stato di emergenza e di calamità pubblica. È un libro
incompiuto perché non ha risposta. … Amen per tutti noi.
Mi fermo, sono già stordita. Parla con me. Non parla a me… in forma di ...
Vuole risposte?
No.
Altre
domande?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
Comincia con un
SI
Poi seguo
Vado fino al fondo. Sfondo grigio squallido. Fango. Una storia di niente. Come di nebbie. Freddo ucraino, fango brasiliano. Punteggiata qua e là di stelle o buchi neri. Pesanti. Di quali pensieri? Stelle interroganti. O dementi?
Come cominciare dall’inizio, se le cose accadono prima di accadere?
Non si tratta di una semplice narrazione, è innanzitutto vita primaria che
respira, respira, respira. Materia porosa, un giorno io qui vivrò la vita di
una molecola con la sua possibile esplosione in atomi. Ciò che scrivo è più di
un’invenzione.
Io non sono un intellettuale, scrivo col corpo. E ciò che scrivo è una nebbia
umida. Le parole sono suoni diffusi di ombre che s’incrociano diseguali,
stalattiti, trina, musica trasfigurata di organo.
Giuro che questo libro è fatto senza parole. Questo libro è un silenzio. Questo
libro è una domanda.
Scrivo con tratti vivi e grossolani di colore.
… l’eternità è lo stato delle cose in questo momento.
Scrivo a orecchio...
Devo ricopiarmi con la delicatezza di una farfalla bianca.
…con la punteggiatura, faccio giochi di prestigio di intonazione, e costringo il
respiro altrui a scandire il mio testo.
Lo scritto che tra non molto dovrà avere inizio – non reggo ormai più
la pressione dei fatti – lo scritto, che tra non molto dovrà avere inizio, è
sponsorizzato dalla bevanda più popolare del mondo – ciò non toglie che io
non sia retribuito – bevanda diffusa ai quattro angoli del globo, e che è stata
lo sponsor dell’ultimo terremoto in Guatemala. Malgrado quel suo sapore di
smalto per unghie, di shampoo contro la forfora, di plastica pressata. Cose che
non impediscono che tutti in coro la amino, servili e compiaciuti. … perché
quella bibita, che contiene coca, è l’oggi. Un mezzo con cui le persone si
sentono aggiornate e nel presente.
I fatti sono sonori, eppure tra i fatti c’è un sussurro.
Sussurri dipinti come gridi in spazi vuoti.
Grigia, povera Macabéa,
Per lei anche la realtà non aveva nessun valore. Si trovava più a suo agio
con un quotidiano al di fuori della realtà, viveva al ralleeeeentatooooore,
leeeeepre a luuuuunghi baaaaalzi sooooopra le cooooolliiiiiine. Il vago era il
suo mondo terreno, il vago era l’essenza della natura.
- Ma so solo essere impossibile, non so altro.
Cosa devo fare per diventare possibile?
- Tu sai se si può comperare un buco?
E grigio sfinito fino alla stazione terminale. Un rivolo di sangue rosso. Una verde piantina d’erba, più felice di una foresta, che sbuca dal canaletto dello scolo, il giallo di un’auto e una luce rasa sull’asfalto bagnato. E un grido:
- QUANTO AL FUTURO.
Aveva nostalgia del futuro? Sento l’antica musica di parole e parole, si,
proprio così. In questo esatto momento Macabéa sente … Voleva vomitare
ciò che non è il corpo. Vomitare qualcosa di luminoso. Una stella dalle mille
punte.
…
Vivere è un lusso.
…
Adesso comprendo questa storia. È l’imminenza che c’è nelle campane lì lì per
oscillare.
La grandezza di ciascuno.
…
Vi domando:
- Qual è il peso della luce?
E ora – ora non mi resta che accendermi una sigaretta e andare a casa. Mio
Dio, solo adesso ricordo che le persone muoiono. Ma – ma, anch’io?!
Non dimentichiamo che questa è la stagione delle fragole.
Sì.
Sembra che parli della morte e dice altro. Neppure Dio è di casa in questo libro-straccio. E non c’è speranza. Non c’è salvezza. Miseria. Nulla. E ancora nulla. E non è una morte. Interroga, domanda. Mi domanda ed io non posso che interrogarmi senza rispondermi.
È la rivelazione dell’imminenza di. Di che cosa? Chissà se un giorno lo saprò.
E scrivo nel momento stesso in cui sono letto.
La morte è l’indicibile. Questo è l’ineffabile. O la grandezza? C’è grandezza tra le righe, negli spazi vuoti. Vuoto – pieno. Pieno di che? Pieno.
… vuoto è l’unica cosa che potrò mai avere. Oltre a quel vuoto, nulla. Eppure
il vuoto ha il valore e la parvenza del pieno. Per ottenere non c’è che da
cercare, per avere non c’è che da chiedere e da credere semplicemente che il
silenzio, che io credo in me stesso, è la risposta al mio – al mio mistero.
Silenzio pieno di esistenza
Mi esprimo con parole che sono limitate. Ho bisogno di parole silenziose.
Nota dell'autrice
Lo scritto è una rievocazione di una scoperta casuale ma significativa che ha dato
slancio ad un lavoro di scrittura che, altrimenti non avrebbe forse avuto un luogo in cui
manifestarsi. Si tratta di una scrittura che sgorga nella necessità di relazione con altri
sguardi; l’intenzione è di ricercare e di generare uno spazio di attesa e di reciprocità,
uno spazio anche teatrale, fatto di aria e respiro, che possa “forare” la pagina scritta.
Proprio questo breve scritto è, quindi, il tentativo di vivificare un’esperienza ineffabile, una
relazione ritmica. Come in un teatro interno leggente e scrivente sono vicini, possono
toccarsi, possono trovare il punto dove mettere al mondo una “cosa” sospesa, vibrante di
suono; è possibile, allora, nella deflagrazione del tempo e dello spazio, vedere una porta
aperta? S.M.
Sandra Morero. Nata a Torino, vivo, tra famiglia e lavoro, a Pinerolo. Da molti anni mi occupo di teatro con attenzione all’uso della voce. Leggo, recito e scrivo per necessità di uno spazio di ricerca autentica, vitale. Lavoro inoltre con i linguaggi non verbali delle arti e del corpo in progetti per migliorare la qualità di vita delle persone, in situazioni di handicap e disagio, nella scuola e in diverse strutture nella provincia di Torino.
Enzo Campi, poesie inedite da “Dei malnati fiori”
La raccolta è in fase di pubblicazione per le Edizioni Smasher. L’uscita è prevista per Marzo 2011.
La voce del singolo è defilata, ma evoca possibili scenari di compensazione: si dilegua e appare invece il tutto. È il senso di un trapasso, una migrazione dell’essere, eppure di una finitudine dolorosa. La soggettività si lascia appena svelare in un atto, “erratico” e dialettico ad un tempo, che allude proprio al trapassare e, in antitesi, al rafforzamento.
[…]
I fiori sono spesso metafore sessuate, ma nel nostro caso c’è un superamento del duale, il poeta infatti, sebbene riconosca incessantemente la cifra della dualità, anche in senso fisico e corporeo in particolare, procedendo per opposti e provocazioni, si studia di trascenderla, immergendosi in tali antinomie mirabili, lasciandosi coinvolgere e lacerare come in un pasto di felini si consuma la preda.
[…]
D’altronde: “Il libro della vita / è logoro e consunto / sopravvive al disastro / nutrendosi di polvere ”; ed è quest’ultima una constatazione inevitabile alla quale non sfugge nemmeno la fantasia più esuberante che si trova a osservare e valutare le criticità esistenziali per scegliere la strategia giusta, nei suoi vagabondaggi sublimi. Per tale motivo “le parole rinunciano al messaggio / e si fanno sensibili”: è il riconoscimento della vulnerabilità umana non rimosso, essere infatti precari al mondo vuol dire fraternizzare con ogni respiro, con qualsiasi delicata, o forte, esperienza, accettandola in un’ottica di rara dignità e bellezza. L’abbandono alla condizione “malnata” non è senza appello, resta la capacità di sostenere il proprio destino ‘errabondo’ avvalendosi anche della potenza della parola, farmaco (Derrida) non da sottovalutare.
(dalla prefazione di Marzia Alunni)
***
Le maglie scandiscono il tempo che fagocita i fiori per restituirli al coro solitario dell’essere che non si basta e che si rassegna a dirsi in molti modi; il punto è che però quel “ti estì” è in mano propria seppure apparentemente si chiami con altri nomi. È il “chi” infatti – e non il “cosa“. Il percorso lento procede in alterco con se stesso ed è in questo stretto passare che chi detiene la parola sem(in)a nelle forme dell’armonia. In questa sua nuova amalgama però (che è ogni volta monito di rara bellezza) sembra che la parola poetica di Campi acquisti una rinnovata compiutezza, quasi un sollievo dettato da quell’abisso innato che fa da sfondo e in cui ci si riconosce come soffio. Si accetta il tradimento dell’imprevedibile confessando la necessità dell’erranza : la cifra che mantiene vigili sulla sopraffazione dell’agguato. Sempre nella cartografia crudele del thumos desiderante.
(dalla nota critica di Alessandra Pigliaru)
Dei malnati fiori
da Pre-ludi
***
Del malnato fiore
che in me s’intrude
e al non più dirsi ancora
ch’in vano a me si tace
voglio cantar la saga
e zittire il coro
ch’ancor dilaga
nel voce a voce
del colpo contro corpo
***
Del malnato fiore
ch’a me s’affaccia
con lo sguardo indegno
di chi fomenta lo scontro
voglio amar lo sdegno
che vibra come incontro
nel loco ameno
del disconoscimento
***
nel bifido rizoma
scavo
e vado alla ricerca
del derma a derma
che mi protegga dalla norma
in cui defaticare lo sdegno
e svilire l’ingegno
del pressappoco in quanto
tale
e quale sia l’approdo
è sì deriva
del situarsi presso il poco
ch’ancora impera
dettando la legge
del sono io
in quanto cogito
perché
da che mondo è mondo
l’inessenza
è il male da abiurare
***
nell’infido feticcio scavo
e vado alla ricerca
della pellicola stantia
che ricopre il derma
decomposto
in cui ritatuare il segno
e mortificare il sogno
dell’oltretutto in quanto
vale
e sale il sentore
del situarsi oltre il tutto
ch’ancor digrada
all’assolversi della norma
dell’io mi manco in quanto
e in quando
perché
da che tempo è tempo
ciò che conta
non è l’attimo da cogliere
ma solo l’istante
di cui disfarsi
***
Non ho lucori
in vita
se non ariosi gesti
in cui rischiare
l’asfissia
e solo
vengo
zolla a zolla
le stasi
a delinquere
degli immoti spazi
Poco più che altero
vago
vacuo
per chiavi ignave
senza dare fiato
al vento
e il tempo schiuma
l’ombra violata
del limo
in cui condursi
al fondo
Cedo al fumo
la traccia che si dissolve
senza aspirare al fuoco
e vengo
al vano
che rigenera
l’ignoto
Enzo Campi. Nato a Caserta nel 1961. Vive e lavora a Reggio Emilia dal 1990.. È presente in alcune antologie poetiche. È autore del saggio filosofico Chaos Pesare-Pensare scaricabile sul sito della compagnia teatrale Lenz Rifrazioni di Parma. Ha pubblicato per i tipi di Liberodiscrivere Edizioni (Genova) il saggio filosofico-sociale Donne – (don)o e (ne)mesi nel 2007 e il saggio di critica letteraria Gesti d’aria e incombenze di luce nel 2008. Nel 2009 ha pubblicato per BCE-Samiszdat (Parma) il volume di poesie L’inestinguibile lucore dell’ombra. Sempre per lo stesso editore ha curato una postfazione in Collezione di piccoli rancori di Lara Arvasi e l’antologia di prosa e poesia Poetarum Silva. Nel 2010 ha curato una postfazione in Di sole voci di Silvia Rosa (LietoColle – Como) e pubblicato il poemetto ipotesi corpo (Smasher – Messina).
Sebastiano Aglieco, “Tre tempi della giornata”, saggio su Gabriela Fantato
TRE TEMPI DELLA GIORNATA
variazioni intorno a tre poesie di Gabriela Fantato
Primo tempo
La città sparita
Esistono due possibili modi per parlare di un libro: il primo è l’attacco frontale, corpo a corpo, nello scontro/incontro tra la propria biografia e la scrittura dell’altro; il secondo riguarda la storicizzazione: i legami fra le parole, gli accadimenti fissati sulle pagine, nel rimando ad altre parole, ad altre pagine. Nel primo modo si legge sulle crepe, sulle increspature insidiose dell’acqua, della pelle; nel secondo si sceglie come supporto la superficie della carta, il luogo in cui ogni civiltà ha fissato i paletti della propria letteratura. Tutto questo avviene nel tempo, nel mutamento dei giorni e delle stagioni. Nelle ore, nei giorni più vicini.
Leggo gli ultimi testi inediti di Gabriela Fantato indossando gli occhiali da vista: una recente necessità a cui però non mi sono ancora abituato. Il libro è appoggiato sul grande tavolo bianco, freddo, inamidato, dell’aula insegnanti. Le lettere sfarfallano un poco,
Una traduzione lenta di ombre
in corpi mi restituisce i bordi …
Sono i bordi di un mattino avvolto in una nebbia concentrata, cattiva. Attendo di entrare in classe, aprire il registro, fare l’appello.
Così il mio primo sguardo a queste poesie. Non leggo, infatti; semplicemente guardo le piccole ombre delle parole; distanti, come le sagome dei condomini alle mie spalle. Sguardo distante. Occhi rovesciati di una città che non ho mai amato.
Ecco, la città è sparita in un’ora indefinita del mattino. Mentre sognavo.
Forse è sparita nel cappotto
o in sandali d’estate…
Il libro ha reclamato il suo tempo dovuto. I primi versi mi hanno detto così:
Forse non ci sono più…
Siamo veramente in un altro tempo: l’inverno e la sua digestione lunga, il suo passaggio misterioso, nelle budella. Che cosa fiorirà? Quale speranza o malattia segnerà la nuova primavera? Devo proseguire nella lettura, ma rimango in questi centimetri quadrati della pagina, nell’obbligo di questa traduzione lenta di ombre.
Forse non ci sono più…
Si può scrivere di un testo partendo da un’esperienza personale? “Mattino. Aula insegnanti. Nebbia dalla finestra.” Non so. Intuisco però che leggere è come tradurre. Tradire: “tradere”, passare oltre.
Una traduzione lenta di ombre
in corpi…
Non esiste letteratura senza questo lento sguardo che si pone, senza l’enigma della cifra nera. Spaccata. Il testo mi obbliga a guardare la stanza nel suo colore più freddo, come un occhio a distanza; come un occhio che guarda dalla finestra, emergendo dalla nebbia. Quale parola giusta potrà improvvisamente mostrare la forma dei ciliegi, le grandi chiome degli abeti? La città sparita chiede l’attesa. Non risponde
… Un cielo senza
rughe, non fa la differenza
Secondo tempo
Una mattina di nebbia
Pausa del mattino. Ore dieci e trenta.
Torna ancora una mattina di nebbia …
Nel cortile riposa l’asfalto; non ci si vede, non ci si parla. Intuisco le sagome dei bambini che si rincorrono; improvvisamente il rosso della giacca, il nero corvino dei capelli
(ogni bocca, assomiglia a un paese
dove correvano i bambini).
Nei cortili qualcuno spera
guarigioni…
Sono io: un medico mancato. Sogno spesso di guarire, di redimere qualcuno o qualcosa. Guarisco dalla vita, per una vita redenta da tutto il dolore. Correranno in fretta i bambini.
(occhi sgranati nella durezza di Milano).
A chi appartengono versi come questi? Chi li ha veramente scritti? Quando una poesia appartiene a tutti, essa ci autorizza a pronunciare parole collettive. Una bocca parla, immersa nella bocca di tutti; uno sguardo ama con durezza. L’amore non è dolce; l’amore è duro e dato con affronto. Se le parole ci feriscono, allora esse sono state capaci di un dono, hanno travasato carne e senso.
Ancora la nebbia. Le parole dei bambini mi arrivano a tratti: monosillabi, monconi strappati nella corsa. Sono parole eccitate dalla nebbia perché uno sguardo che non vede, è costretto a fiutare.
e il bianco affoga tutto il male...
Paesaggi dello spaesamento, del silenzio dei contorni: navigli, via Larga, porta Venezia, Bovisa, treni di Milano: paesaggi che, a distanza, richiamano altri paesaggi.
Un tempo ci assomigliavamo…
Dove abita il bambino che ci ricorda? Quale sonno custodisce la cifra oscura della sua parola?
Le labbra sanno intatto il perdono…
Ecco: dovremmo parlare solo per perdonare.
Terzo tempo
Quasi febbre
Tienimi quel battere tre volte
per farsi riconoscere alla casa
chiusa a muro e l’inverno
si fa crepa nel cemento.
Un inverno battuto. Un battere sulla dura crosta del ghiaccio. Battere tre volte, come il pugno duro sulla porta: Danoia, Osterlicchi, Tanaï, cricchi, Tambernicchi.1
Tornare a casa, nella morsa del cappotto. Leggo questi ultimi versi per strada, camminando, come sempre; lo sguardo esclude il mondo e lo recupera nella letteratura.
Ti darò la mappa delle strade
con dentro questa fuga…
Attraverso canale Villoresi: una bocca in secca, putrida, che mostra i suoi residui masticati, il suo ventre
aperto, gli avanzi del tempo che attraversiamo e non rimane.
C’è una promessa d’acqua nei versi successivi:
dove il salto è un’acqua leggera,
senza nome…
Una fuga, un guizzo.
Tu respirami
pesce d’oceano: ricorda la bocca.
Sogno i capelli lunghi dell’acqua nel salto che attraversa la strada e schiumeggia, quando le giornate si allungano e la primavera è alle porte.
Regalami l’innocenza della pelle
e i sandali bianchi dell’infanzia…
Ma ora è una fredda bocca, il secco del ghiaccio, nel ventre.
Solo ora, aprendo la porta di casa, mi rendo conto di questa progressione, di questo cammino, al contrario.
Un ritorno alla casa, da dove siamo partiti. Solo ora riecheggiano i versi, nel loro suono e senso compiuto.
per farsi riconoscere alla casa
chiusa a muro e l’inverno
si fa crepa nel cemento.
Monza, sabato 17 dicembre 2005
Sebastiano Aglieco è nato a Sortino il 29/01/1961. Ha pubblicato diversi libri di poesia. Gli ultimi sono: Giornata, La vita felice 2003; Dolore della casa, Il ponte del sale 2006; Nella storia, Aìsara 2009; e il libro di saggi Radici delle isole, La vita felice 2009. Insegna nella scuola elementare.
Il suo blog : Compitu re vivi (miolive.wordpress.com)
1 Dante, Inferno, canto XXXII
Stefano Piva, due poesie inedite
***
Di cos’è fatta la siepe
se non di patti stretti fra l’eterno
e l’adorno, di una chiosa
tra la fuga e la voglia di casa
tra l’illusione e mille motivi
per la sua recinzione.
Di cos’è fatta la siepe
se non di compromessi fra la catalessi
e l’operosità dell’ape, di una postilla
tra il vento e il suo abbellimento
tra il batter di ciglia e il non andar
al di là della soglia.
Di cos’è fatta la siepe
se non di un accordo fra lo sterminato
e un suo lato, di un intervallo
fra lo stare e il distare
tra il divagare lontano il non muovere
mano.
Di cos’è fatta la siepe
se non di alleanze fra il poeta
e le mille scadenze, di una glossa
tra pace e radice
tra il foglio e un trifoglio.
Parole di un piede e mezzo
Immaginazione
o sterile coltura
del vuoto
di una possibile
zona di secca
e al contempo
pluviale
di un silenzio
strumentale al pensiero
ove nulla è reale
ove nulla è più vero.
Una pura variazione
del corpo
che da se stesso
giunge a tutt’altro
sul posto
e non si muove
di un passo
dallo stato mentale.
Un’invenzione lessicale
e infedele che rimane
da sola
che viaggia, tra l’enfasi
e il sogno, tra il finto
e l’incanto e i luoghi
dell’aria
parole di oraziana
memoria calpestando
quest’erba
sesquipedalia verba.
Stefano Piva è nato a Parma nel 1971. Nel 2008 e 2010 segnalato al Premio Lorenzo Montano.
Michele Porsia, poesie inedite da “Bianchi girari”
Verba volant
Non è un filo. La parola è pensiero in polvere, il residuo grigio di una materia cerebrale.
Celebra la cenere, la terra. Arretra, se temi la parola, ma poni prima un fermacarte sulla fossa, che indichi il pericolo di questo luogo.
O il vento, senza neppure chiedertelo, prenderà la scrittura e la porterà sulla tua bocca.
Mettici una pietra sopra. Tu temi la parola perché vola.
Tu temi la parola perché vuole
***
Un suono basso, la vibrazione
nera delle ossa, parole, passi minimi
percorsi a stento. Tendo il cordone ombelicale,
taglio, tento le vocali e le prime sillabe
le pronuncio nella lenta disciplina dell’infanzia. Sono un uomo
di parola, eppure qui
inizia un’altra fase della pietra,
un’altra faglia. Percuoto il poema con le dita, il primo suono.
Il testo si allenta, rallenta
nella frequenza d’onda a banda larga
***
In questo lago bianco
non tiro pietre, osservo i cigni neri
che camminano sull’acqua
con le punte, per non intorpidirla. Le parole immobili macigni.
Il dolore, un’altra razza
un verso aguzzo di avvoltoi.
Ti ho avvolto, ti ho portato sulla mia colonna,
la più alta,
perché questo è l’antico rito dei Persiani.
Reincarnarsi nella penna, per volare
***
Le stampe di Malevic.
Quadrato nero
e cerchio su fondo bianco,
vicini.
In composizione diagonale la parete.
Immagini bistabili
parole piene, pagine vuote. Eravamo diversi
dicroici prima del ritorno
prima dei dettagli, prima delle crepe
sul mordente. Così eravamo. Quasi niente
astratti
da restare appesi dentro la cornice.
Quadrato bianco su fondo bianco.
Prima del figurativo o dopo.
Intorno
una circonferenza traccia il tentativo del ritorno
***
e si infila orizzontale
sotto l’infisso, basta un respiro
e una foglia,
una particella di esterno entra dentro. Aria
che dilata gli interstizi
passa tra le pagine
nelle fessure, consuma
la cartilagine tra parola e parola
glena delle ossa. Fori, cedimenti,
micro moti che sollevano
staccano, slegano nei punti di sutura
Michele Porsia. Nato a Termoli il 6 maggio 1982, vive a Firenze. Fa parte di Hanife Ana, gruppo sperimentale, e della redazione Giovin-astri delle edizioni Kolibris.Pubblicazioni e festival: Nodo sottile 5 (Le Lettere, 2008) è un’antologia di dieci voci emergenti: raccoglie alcuni suoi testi inediti e altri tratti dalla raccolta Sintomi di Alofilia vincitrice della prima edizione del premio Cose a parole e in seguito, nel 2009, pubblicata integralmente dalla Giulio Perrone Lab. Nel 2009 ha partecipato al Parma Poesia Festival e, nel settembre 2009, alla Biennale di Skopje dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Dal 15 al 19 febbraio 2010 alcune poesie della prima raccolta sono state trasmesse durante il programma Fharenheit di Radio3. Nel 2010 è stato segnalato al Premio Lorenzo Montano (ed. Anterem, Verona) con la raccolta Bianchi girari e al Premio Miosotìs (ed. D’if, Napoli) con la raccolta In altre acque. Tra il 2010 e il 2011 alcuni testi tratti da Bianchi girari sono apparsi nell’antologia del premio Renato Giorgi (secondo premio) delle Edizioni della Luna e altri su Absolutepoetry.
Ottobre 2010, anno VII, numero 12
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
Questo numero di “Carte nel Vento” ospita i poeti finalisti dell’edizione 2009 del Premio Lorenzo Montano, corredati dalle note di Giorgio Bonacini, Marco Furia e Rosa Pierno della redazione di “Anterem”.
Oltre che testimoniare il continuo lavoro sulla poesia di questo Premio, il presente numero opera un approfondimento sulla poesia italiana contemporanea, colta nella varietà degli stili e nelle mutevoli luci del senso, nelle punte dell’esperienza.
La poesia che qui si offre, sia edita che inedita, viene proposta anche attraverso le riletture musicali di Francesco Bellomi, che da alcuni anni compone brani originali per i vincitori del “Montano”.
Spartito di Francesco Bellomi per Folin [pdf 2.2MB]
Lorenzo Carlucci, da “Sono qui solo a scriverti e non so chi tu sia”, con una nota di Giorgio Bonacini
Lorenzo Carlucci
Sono qui solo a scriverti e non so chi tu sia
Tante e indeterminate sono le modalità con cui la poesia misura la sua efficacia linguistica e concettuale, ma tutte tendono a spostare, decentrandolo, il centro conoscitivo che l’esperienza del pensiero (di chi scrive e di chi legge) si propone di attuare. Nei testi di Carlucci si assiste a una concentrazione di senso in cui la possibilità del dire non eccede mai la sua necessità e la sua appartenenza al fare poetico. Ma ciò non significa affatto che ci si trovi in presenza di una scrittura, per così dire, avara: quella che affiora è una precisa coscienza del limite in cui la parola viene a trovarsi. Chi ha troppa urgenza e non misura l’invadenza di quanto dice o scrive, spesso “ha detto una parola di troppo/.../e quella parola ha desolato il cuore, ha spento l’orizzonte”. Un’esattezza del linguaggio che lascia però alla voce la possibilità, se vuole, di suonare in affanno o regredire o impoverire lentamente o sfidare il silenzio: insomma essere comunque sempre viva, mai bloccata in rigidità formali istituzionali che ne svuoterebbero il pensiero.
E questi testi sembrano proprio avere origine da una capacità di presenza e proiezione tali da sfociare in una libertà esistenziale, tracciata sul corpo: “una carezza che graffia la pagina rossa dei nostri toraci nudi”. Ma non c’è nulla di ingenuamente contenutistico in questa appropriazione vitale, bensì una consapevolezza, data al poema, di percezione nei confronti del mondo: vedere l’esterno come pagina scritta e significarla in più, portarla sempre un po’ più in là. Carlucci cattura la visione della parola in sé, dove la parola è una cosa senza intermediazioni artificiali; pensa e concretizza una poesia in cui “tutte le forme sono rotte”, e nonostante questo, ma forse proprio per questa sua forza di distruzione, può dire: “canto”. Possiamo chiamare la sua poesia come vogliamo (prosa poetica? poesia in prosa?), ma ciò che conta è che egli riesce a catturare la vita (il dolore, la desolazione, l’amore, l’illusione, il sogno, ecc.) attraverso l’emissione di una “povera voce”: un’ essenzialità che è l’unica cosa di cui la poesia ha bisogno, per rompere e sovvertire il tradizionale stare nel mondo, spaccando i mattoni della lingua ordinaria, ma anche della lingua di una certa poesia bloccata in sé, nelle sue presunte verità.
Insomma, ci sembra che uno degli aspetti più significativi di quest’opera sia la capacità di operare con un linguaggio che scava al fondo di ciò che è sconosciuto, e che tenta, non tanto di conoscerlo unilateralmente (dandogli un nome preciso o definendolo in una o poche singolarità), ma di guardarlo dentro, riconoscere l’avvicinamento a se stesso “attraverso il bene degli altri”. In questo modo il punto di vista soggettivo si apre, senza ideologie o dogmi conoscitivi, nel tentativo di percorrere l’interiorità poetica cercando di interrogare, di rinnovare, di rimodulare l’esistenza per parlare di “tutto ciò che non so ma che so come spiegare”. Dunque provare a dire (per scoprire) ciò che non si sa, con forza ma anche con umiltà, nella consapevolezza che il mondo assume una forma reale quando viene scritto: non perché non esista indipendentemente, ma perché esserci dentro non è solo stare lì, ma meditarlo, ritagliarlo, frantumarlo nelle tante entità di una lingua a cui la poesia dà senso.
Testi poetici
***
Olimpia mi spiega, guidando su questa strada interstatale, i segreti della numerazione delle highways. Come “pari” significhi nord-sud, “dispari” est-ovest. Come “pari” significhi ancora intorno, “dispari” attraverso. Mi spiega anche, senza parlare, muovendo il sorriso come un radar della polizia lungo la circonferenza del paesaggio che scorre, come il sentimento del bello che proviamo anche in posti del tutto anonimi nel nostro paese sia in larga parte, e forse del tutto, determinato dalla famigliarità dei luoghi che vediamo, un tessuto di segnali che non riconosciamo apertamente, ma che ci battono come i tasti di una macchina da scrivere su un foglio già scritto. Mi viene in mente allora che esistono poeti che scrivono come se si battessero a macchina sugli occhi, sorrido, e sono felice come un bambino quando allunga la mano in un freezer per prendere un ghiacciolo, e ha il braccio troppo corto, tenendo tra le dita il lembo della gonna di Olimpia.
***
(encore)
|...| e forse mi prende per mano o forse aspetta qualcun altro. Meglio credere che mi prenda per mano, sì, mi prende per mano e mi porta un po’ a spasso, lungo le strade vuote di notte, mi porta in un posto, o soltanto in un tempo, nel quale non esistono orgoglio e paura, nel quale non esistono indugi, mi porta in un tempo, o in un ritmo ch’è il ritmo del suo passo, e tenendomi per mano, e senza espressione definita, e quasi senza esserci (questa è la levità della sua presenza), mi porta a camminare sull’asfalto nero bagnato dalla pioggia, come i suoi occhi. Come la sua mano, la mano di una madre tra le scapole di un figlio, a un funerale, come la sua mano la luna è bianca, di pelle bianca, in un viso di occhi blu cobalto.
Lorenzo Carlucci è nato nel 1976 a Roma. Filosofo, è specializzato in logica matematica alla Normale di Pisa. In poesia, ha pubblicato: Semeyazah – il mionome ha visto, ADR 2002; La Comunità assoluta, Lampi di Stampa 2008 (finalista al Premio Diego Valeri 2008); Ciclo di Giuda e altre poesie, L’Arcolaio 2008.
Marcella Corsi, ...) E ti dolzura, con una nota di Marco Furia
Marcella Corsi, "...) E ti dolzura"
Con "...) e ti dolzura", Marcella Corsi presenta quindici versi la cui forma, echeggiante antichi ritmi, rimanda nel contempo a sé medesima ed al suo contenuto: a sé medesima, poiché incuriosisce quel suo negarsi, almeno alla prima lettura, alla normale comprensibilità (non a caso viene tradotta), nonché al suo contenuto, la dolcezza, più volte esplicitamente richiamato.
Una contraddizione?
Per nulla, se è vero che qualunque aspetto, in quanto tale, può essere fatto proprio dalla poesia e che perfino il consueto rapporto scrittura - suo oggetto può avere risvolti non scontati.
Una banalità qui esclusa da lineamenti idiomatici inconsueti, difficili proprio in quanto già a prima vista sembrano promuovere un dettato impostato, per così dire, su canoni tradizionali eppure non immediatamente intelligibili.
Un gioco?
Anche, senza dubbio, ma di quelli non da poco, poiché capace d'indurci a riflettere su come la parola possieda una specifica natura, ossia su come qualunque traduzione, anche autentica, costituisca nuova opera, certo simile, ma, proprio per questo, differente rispetto all'originale.
E poi, come non provare commozione di fronte a quella "dolzura" (dolcezza) in grado di sopravvivere "noi nonostante"?
***
...) e ti dolzura che te vorressi
rinverdire e dolzemente avere loco
e permanere e rindolzire noi pure
e liberare de nostre durizie più dure
ti dolzura minuscola, ‘nnascosa
‘ndoleita de tanto nasconderse
in tra durizie nostre grandi, ti
picolizia impertinente de frescura
intima mente pura, de nullo indolente
- donde te prende forsa e duratura
come te ‘ntrighi ne la tera nostra dura
e nuda de le piante che sole te nudre
donde te prende forsa che te dure
noi nonostante e tutta intiera
la durizia nostra contra la vida vera
***
...) e tu dolcezza che vorresti
rinverdire e dolcemente avere luogo
e permanere ed indolcire noi pure
e liberarci delle durezze più dure
tu dolcezza minuscola, nascosta
indolenzita da tanto nascondersi
tra le durezze nostre grandi, tu
piccolezza impertinente di frescura
intimamente pura, di nulla indolente
- da dove prendi la tua forza dutatura
come t’impasti con la nostra terra dura
e nuda delle piante che sole ti nutrono
da dove prendi forza che ti duri
noi nonostante e tutta intera
la durezza nostra contro la vita vera
Marcella Corsi, milanese di nascita, vive a Roma. Tra le pubblicazioni di poesia: Cinque poeti del Premio “Laura Nobile”, All’insegna del pesce d’oro di Vanni Scheiwiller 1992; Hanno un difetto i fiori, Amadeus 1994; Distanze, Archivi del Novecento 2006, premio Antonia Pozzi.
Maria Grimaldi Gallinari, Per Emilio Villa, con una nota di Marco Furia
Maria Grimaldi Gallinari, "Per Emilio Villa"
Con "Per Emilio Villa", Maria Grimaldi Gallinari presenta un'articolata poesia in cui la riflessione sulla lingua, ossia sul farsi stesso della scrittura, appare predominante.
I versi
"creatività energia luce
nel segno di una parola che è corpo nel corpo che trasuda"
paiono davvero emblematici.
Se la lingua costituisce vero e proprio campo d'energia, àmbito nel quale operano forze espressive capaci di trovare sbocco in parole, nel caso del testo poetico, in particolare, opera una marcata autonomia tendente a produrre specifico senso, più che significato logico.
Nel caso in esame, ad uno spazio bianco molto presente, che pare richiamare quel "silenzio colmo d'espressione" cui si riferiva Aldo Giorgio Gargani, si aggiungono accostamenti linguistici del tutto inediti ("il buio si annoda in filo di luce"), pronunce ricche d'enigmatico fascino ("lucciola impazzita nel groviglio della sintonia"), altre, rare, di tipo descrittivo ("Camminavamo lenti sulla riva di un mare piatto"), espliciti richiami al lavoro stesso dell'artista ("Principio dell'arte è il suo principio"), il tutto secondo cadenze tese ad attirare il lettore non al fine di proporgli una teoria, ossia d'insegnargli qualcosa, ma a quello d'inserirlo, direi quasi a farlo precipitare, in un mondo vivido, suggestivo.
Un mondo in cui continue successioni di vocaboli, non prive di brillantezza retorica, implicano totale coinvolgimento in una persistenza linguistica diversa quanto assidua, perseverante.
E, in prospettiva, infinita, come suggerisce l'assenza di punto finale.
***
Ombra sia luce di memoria
tu credi che non sia
così necessario
è il dire
se lungo è il filo lenta trattenuta parola
abbandonata su di un foglio bianco
in nebulosa estiva
dicevi
corno di nebbia
la vera origine della parola
sublime anima
dicevi
stretta parola al corpo straziato
percorreva cieli infiniti di silenzi in spazi di luce intensa
quanta è dura la scorza che vita s’inchioda
nell’ingiustizia subita
terra fuoco acqua fare arte dimora
sfera di raggio infinita ossessione
dicevi
vedo che vedi sento che senti devi
che devi oltre il mondo
dicevi
Principio dell’arte è il suo principio
eva nera del linguaggio zero silenzio madre
evanescente ritrovata dimora
del tutto poesia
sommo essere al sommo di noi che
stringe si stringe fa male ti abbandona
ti prende ti annulla ti chiude ti apre sei
qui non ci sei e
il buio si annoda in filo di luce e
noi ascoltiamo in un più in là del mondo
la tua mente che stringe il linguaggio dell’ape d’oro
(...)
Trattenevi parola nel fondo della gola
quasi un morso quasi un nodo
nei tuoi occhi luce di luce come
lucciola impazzita nel groviglio della sintonia
Dio come l’alveo misterioso
dicevi
segreto
motore dell’infinito silenzio?
Krishnamurti Krishnamurti
sangue raggrumato ai bordi che stringe ai margini dei fogli
domande raccolte trattenute
nel misterioso segreto dell’infinito silenzio
sussurro del non detto da sempre
preghiera poesia nel tuo spazio vuoto
respiro respiro che riempie
sempre
Gabriela Fantato, Parking America – in tre passi, con una nota di Marco Furia
Gabriela Fantato, "Parking America - in tre passi"
Con "Parking America - in tre passi", Gabriela Fantato presenta una successione di versi in cui il dato biografico, già richiamato nel titolo, evoca immagini e riflessioni d'indubbia intensità.
Non si tratta, qui, si badi, d'una sorta di punto di partenza esterno, capace di provocare il divenire poetico, bensì d'una felice fusione di elementi tra loro non estranei.
Ogni avvio, a ben vedere, fa parte della storia e, in questo caso, non ne costituisce soltanto l'inizio: non ci sono principio e fine in un complesso che raggiunge la propria spiccata qualità di linguaggio originale e consapevole, aperto nella direzione d'un pensiero che è anche affetto, passione.
Così a
"La sosta - al motel, questo va bene.
Nel nero di questo Midwest assetato"
segue
"un letto a tenere la paura dentro
le tue ciglia"
secondo la cadenza imposta da tratti visionari persistenti, diffusi, non effetto di, ma naturalmente uniti a, esperienze comuni, quotidiane.
Molto significativo il quartultimo verso della seconda sezione:
"Una vastità".
La vastità dell'esistenza, enigmatica, mai comprensibile fino in fondo, eppure così ricca, così grande da non lasciare "mai scampo".
Tenace nella fedeltà ad un verso che non abbandona il lettore nemmeno nei momenti di massima apertura, sapiente nell'offrire immagini ben definite senza mai cadere nella descrizione fine a sé medesima, quasi premurosa nel proporre pregnanti riflessioni in maniera del tutto priva d'enfasi, Gabriela ci accarezza con tocchi per nulla superficiali, ma leggeri.
Anche se "Qui è tutto enorme".
***
II.
La stanza è quadrata, così nuda da fare
freddo alle ossa, così uguale
da implorare una casa
- nel temporale che sa di ferro.
Di nero.
Viene verso di noi e si scivola
piano come i sogni tagliati.
Il bianco sul fondo ha allagato le ombre,
il bordo nel tetto dove c’è l’ultima porta
non aperta, come tutte le altre.
Il cielo oltre le spalle trema,
spacca le finestre.
Una vastità.
Dove vanno queste luci così gialle,
più sole di come si possa mai
essere nati un giorno?
Gabriela Fantato è poetessa, critica, saggista. Raccolte poetiche: Fugando, Book 1996; Enigma, Dialogolibri 2000; Moltitudine, in Settimo Quaderno di Poesia Italiana, a cura di Franco Buffoni, Marcos y Marcos 2001; il tempo dovuto, poesie 1996-2005, editoria&spettacolo 2005; Codice terrestre, pref. di Milo De Angelis, La Vita Felice 2008. Dirige la rivista di poesia, arte e filosofia La mosca di Milano e la collana di poesia, saggi e traduzioni Sguardi per l’editrice La Vita Felice.
Giulio Galetto, “Il viaggio” di Lorenzo Montano
Il nome di Lorenzo Montano è ricordato nella sua città natale, Verona, dal premio di poesia che la rivista “Anterem” gli ha intitolato e che giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Ed è proprio per iniziativa del direttore di “Anterem” Flavio Ermini e grazie al sostegno della Biblioteca Civica di Verona che, giusto nel cinquantenario della morte, approda nelle librerie, con la sigla di Moretti e Vitali Editori, una nuova edizione dell’unico e ormai introvabile romanzo montaniano “Viaggio attraverso la gioventù secondo un itinerario recente” (pp. 192, € 16,00). Iniziativa meritoria perché Montano è certamente un autore che ha un suo posto per nulla secondario nella letteratura della prima metà del Novecento, riconosciuto da nomi prestigiosi della critica, ma purtroppo scarsamente conosciuto e scarsamente letto rispetto ad altri scrittori che, al pari di lui, furono protagonisti delle vicende letterarie italiane fra secondo e quarto decennio del Novecento, legati a nomi di riviste importanti come “Lacerba” o “La Ronda” e a definizioni inevitabilmente approssimative ma che funzionano da bussole di pronto orientamento come “futurismo” prima e “prosa d’arte” poi.
Nel 1953 Montano aveva raccolto in un corposo volume edito da Sansoni, sotto il titolo “Carte nel vento” che aveva un evidente intento di understatement, alcune delle poesie scritte ai temi di “Lacerba” o poco oltre e parecchie pagine di prose narrative e saggistiche; non vi era compreso però il “Viaggio”, che era apparso da Mondadori nel 1923 e che ebbe una seconda edizione, a cura e con prefazione di Aldo Camerino, solo un anno dopo la morte dell’autore, nel ’59, presso Rizzoli. Ora la nuova edizione del romanzo riprende la “Premessa” di Camerino e si arricchisce di una postfazione di Flavio Ermini oltre che di una ricerca bio-bibliografica di Claudio Gallo.
L’inquadramento critico del “Viaggio” era ben fissato nella nota di Camerino e nel completo ed equilibrato profilo montaniano di Gian Paolo Marchi (“Il viaggio di L. Montano e altri saggi novecenteschi”, Antenore, 1976): da un lato le suggestioni derivanti da quegli archetipi del romanzo moderno che sono gli inglesi del Settecento o il Goethe narratore e dall’altro quella prosa a metà fra racconto e saggio, stilisticamente molto sorvegliata, che caratterizza, sia pure con notevoli differenze individuali, i contemporanei “rondisti” di Montano. La postfazione di Ermini insiste ora sulla dimensione di “romanzo di formazione” che caratterizza il “Viaggio” e lo accosta, rilevando simmetrie e scarti, ai nomi di Kafka, di Rilke, di Musil, di Svevo.
Potremmo definire il “Viaggio” un romanzo destrutturato: sono due lunghi frammenti (due “quaderni”) che registrano, senza precisazione di tempi e di luoghi, due momenti della giovinezza di un personaggio che non ha nome, momenti legati a due esperienze d’amore vissute, sia la prima che la seconda, secondo una parabola che comprende innamoramento, intensità ma anche brevità della passione, stanchezza e abbandono della donna. I due quaderni che registrano, come in un diario, le due esperienze, molto più “ragionate” che raccontate nella concretezza degli eventi, sono incorniciate fra una “Introduzione” e una “Aggiunta” in cui si dà conto delle vie attraverso cui sono stati trasmessi i quaderni e – non senza ironia – viene lasciato irrisolto l’enigma dell’identità del protagonista e autore dei due quaderni.
Leggere oggi il “Viaggio” è un’esperienza interessante: significa immergersi in quel non ameno ma acuto e profondo e imprescindibile paesaggio (vogliamo chiamarlo “terra desolata”?) che caratterizzò i primi decenni del Novecento europeo: un paesaggio di sentimenti autentici ma dolorosamente inariditi o negati dal nero velo di una crisi che, pur restando spesso impronunciata nelle sue storiche motivazioni, fu tuttavia radicale e irreparabile. E, per esprimersi, poté assumere vesti o maschere diverse: dall’esplosione imposta alle forme della tradizione ad un loro recupero in chiave aristocraticamente, magari anche dandisticamente raffinata; dal rifiuto del sentimentalismo romanticamente esibito all’ironia e all’autoironia praticate con diversi gradi di corrosività. Nel “Viaggio” di Montano, che Montale vedeva come “un labirintico vagabondaggio nella memoria”, c’è un po’ di tutto questo. Accanto agli uomini senza qualità di Musil, ai distratti senza attitudine a vivere di Svevo, ai colevoli senza colpa di Kafka, ai personaggi senza autore di Pirandello, anche l’uomo che dice “io” nei due quaderni del “Viaggio” di Montano è un uomo “senza”: un uomo, come recitano le ultime due parole del libro, “senza figura”. Avvolto, quest’uomo, nella cifra assolutamente montaniana di una “malinconia” e di un “riserbo” (sono ancora indicazioni di Montale) che rendono il libro caro al lettore non frettoloso, attento alle ombre e penombre delle cose.
Biografia
Danilo Lebrecht (questo il vero nome dello scrittore che, fin dalle cose giovanili, si firmò con lo pseudonimo Lorenzo Montano) nasce a Verona il 19 aprile 1893 da una famiglia israelitadedita ad una fiorente attività industriale. Compie in città gli studi classici e mostra presto la propria attitudine per la letteratura, attirato dalle tendenze più innovatrici delle esperienze poetiche italiane (il futurismo) e d’Oltralpe. Quando nel 1913 nasce la rivista fiorentina “Lacerba” con un programma vistosamente di “avanguardia”, Montano vi aderisce e su quel foglio appaiono le sue prime prove poetiche. Nel ’15 pubblica la breve raccolta di versi “Discordanze”, nel ’17 “Ariette per piffero”. Alla svolta fra secondo e terzo decennio del secolo è tra i fondatori della “Ronda”, la rivista fiorentina che propone un ritorno ai modelli dei classici. Nel ‘23 pubblica con Mondadori (diventerà poi autorevole promotore di importanti iniziative della casa editrice) il romanzo “Viaggio attraverso la gioventù”; nel 1928 appare la raccolta di prose Il perdigiorno. Nel 1938, in seguito all’emanazione delle leggi razziali, emigra in Inghilterra. Terminata la guerra, collabora a vari giornali, ultimamente al “Corriere della sera”, risiedendo però non in Italia, ma dapprima ancora in Inghilterra, poi in Francia, infine in Svizzera. Nel ’56 esce presso Sansoni “Carte nel vento. Scritti dispersi”, un volume che si propone come sintesi della sua intera opera. Muore improvvisamente il 27 agosto 1958 a Montreux. Una raccolta di scritti rimasti inediti alla morte appare postuma, col titolo “Pagine inedite”, nel 1960 (Stamperia Valdonega, Verona).
Francesco Marotta, da “Impronte sull’acqua”, con una nota di Rosa Pierno
Francesco Marotta, “Impronte sull’acqua”, Le Voci della Luna 2008
Nel voler rappresentare il mondo, nel costruirne un’immagine personale – qual è, in sintesi, la specifica attività del poeta – Francesco Marotta si trova a fare i conti con una restituzione sforacchiata e bruciata sui bordi, resa lacunosa dal silenzio e forse insediata dall’impossibilità di dire. Ma di fatto leggendo ci ritroviamo già avvolti da essa. Intorno a noi vengono proiettate immagini sfocate e pallide, luminose e instabili ove insieme alle cose vediamo sfilare parole: “la chioma / scomposta di lampade / che si rincorrono / si urtano non / ti riconoscono, ma / sono state il rosa di ogni pelle..” Comprendiamo allora che tale visione è costruita con materiali impalpabili, mobili, dondolanti. Seguiamo una sintassi franta, dove preposizioni penzolano nel vuoto, ma nella quale gli aggettivi sono saldati ai sostantivi. Non scorgiamo nessuna dissolvenza o cesura, invece, nel passaggio continuo e forse non individuabile fra il reale e la scrittura, il percepito e la sua rappresentazione. Infatti, lacune sono presenti in ogni aspetto della realtà e della rappresentazione, ma al tempo stesso intere porzioni di materia trapassano da uno stato all’altro. Che il mondo divenga instabile perché messo in moto da segni senza freno, ora è certezza. Non solo il caso, dunque, nella costituzione di un mondo reso finalmente dicibile, immaginato come se fosse fisicamente costruito, ma anche responsabilità poiché ciò che si inventa può anche accecare. In questa rullante onda che travolge non si deve comunque perdere la consapevolezza del proprio intervento. Mutuando dalla scienza quantistica, potremmo dire che, intervenendo col processo creativo, il poeta determina lo stato del mondo: “sempre al termine / l’inganno dello sguardo / punito, trovare in se stessi / il rame che modella la festa”. E’, comunque, la parola stessa che, se pure registra la separazione di tali entità, si assume il compito di portare a termine l’impresa. Nessuna scissione tra corpo, realtà e parole: è questo il potere della poesia, dopo che, pure, ne ha registrato la separazione.
dalla sezione Una rosa, in pieno inverno, è un caso, una distrazione del nulla
***
disordine di sguardi, artefice
il fuoco che altrove
spinge l’occhio a una
vicenda di transiti, al
l’ombra che avvalla e
rovina nell’erba
umida di scintille, e tu
che crolli per l’aria
nel segreto coltivi vertigini
di perdute tenerezze, la
passione che ci perseguita di
anni dementi, e forse
solo la cenere ormai
continua ad albeggiare
in superficie, mentre
i figli, ignari
giocano un sogno
tra gesti raccolti qui
a terra, la tua bocca
in un angolo, la
veste nuda
che mi somiglia come un
grido, come un
addio
***
scrivere sull’acqua dei pozzi
ignorando la luna
che la dimora e la
consuma di febbre, come
se la luce in
comunione di distanze
si disponesse al tramonto
proprio sul limite che
coniuga le labbra al
la sete, o forse
sogna di chiudersi
in un punto in
attingibile, un dove
di riverberi e di cerchi
che alleva piogge
in equilibrio di crepe
e incide sui marmi
venature per la rosa, uno
scambio di riflessi
per il gioco paziente
della goccia, io
mi tendo sui bordi, da
sempre visito il lume
che al mio corpo accende
la stretta, abitua la pupilla
a riscoprirsi fossile, un
rudere a stella, una
memoria di creta sul
la mappa in
penombra dei fondali
Francesco Marotta è nato a Nocera Inferiore nel 1954. E’ laureato in Filosofia e in Lettere Moderne. Vive in provincia di Milano, dove insegna Filosofia e Storia nel Licei. Tra le sue pubblicazioni in versi: Le Guide del Tramonto, Firenze 1986; Memoria delle meridiane, Brindisi 1988; Alfabeti di esilio, Torino 1990; Il Verbo dei Silenzi, Venezia 1991; Postludium, vincitore del Premio “Lorenzo Montano” per raccolta inedita, Verona 2003; Per soglie d’increato, Bologna 2006; hairesis, E-book, Milano 2007. Gestisce lo spazio web www.rebstein.wordpress.com
Mauro Germani, da “Livorno”, con una nota di Rosa Pierno
Mauro Germani, “Livorno”, L’arcolaio 2008
Col ritmo di una nenia o di una filastrocca Mauro Germani accumula parole e versi, i quali compilano la lista delle immagini, dei ricordi, degli odori, dei suoni che compongono l’identità della città di Livorno. Nonostante l’utilizzo di una sintassi lineare, non è privo di oscuro portato l’elenco: “A quale fine / queste parole superstiti, / questo singhiozzo di terra e di nulla?”. Forse, solo leggermente chiarito dalla poesia successiva in cui il tono nostalgico maggiormente s’apparenta con quello drammatico. Bacio e addio, sogno e vita, morte e ombra costituiscono le ferree coppie con cui si susseguono i passi d’una travagliata esperienza esistenziale. Senza soluzione, si direbbe, visto che la partita finale sembra giocarsi tra i vivi e i morti, o meglio con quello che dei morti resta nei vivi: “Questi nomi di morti nell’aria e i numeri che tornano per le strade dentro fotografie ingiallite.”. Quasi restasse come unica possibilità, per sopravvivere, il dimenticare, la tabula rasa, eppure, impossibile da realizzare. E, così, quasi naturale andamento insito nelle cose, il movimento successivo non può che essere quello di rimembrare, di riportare in vita nel ricordo: “Parlava il tuo mondo nella stanza / e tutto era come un bacio / dato per sempre”. Senza più dolore, ma con la certezza che quello è l’unico modo per far restare in vita la persona amata. Ma fra lacerti di visioni e fantasmatiche apparizioni, fra ricordi e invocazioni non sorprende che cada il gelo nella stanza, quando esse d’improvviso crollino: “E’ questa la sconfitta di Dio, / la verità perduta del tempo..”. Bisogna in qualche modo sopravvivere anche nel gelo della coscienza, nella inevitabile constatazione dell’assenza, poiché non si può ingannare se stessi a lungo: “E ancora scontare gli addii, una mano dopo l’altra nell’ombra, fino ad una terra nuova, una sposa davvero per pochi minuti…”. Inevitabilmente, perdere gli altri è perdere il proprio io. Anche se finché si riesce a pronunciare ancora una parola, la possibilità di esistere degnamente continua. Germani ci consegna una sorta di diario vuoto: diario dell’afasia, ma insistentemente, coraggiosamente, perseguito.
Dalla sezione Un Dio di niente
***
Scriverò la storia dei morti, diceva,
l’eterna differenza della notte.
Saranno segni non più opposti,
doni forse nell’invisibile cielo...
***
Io come niente, come nessuno.
Un graffio bianco a ricordare,
a dire perché in una stanza vuota,
in un ronzio di voci,
come un allerta di nuvole e di capelli,
come una discendenza di mani...
***
Una casa per dire qualcuno oppure sempre.
Come a cercare un giorno,
una parola lontana, un tempo fermo.
Come trovare un’infanzia e una collina,
un attimo di terra, un destino vero,
nome e cognome in un punto solo,
una pausa infinita, un dio di niente...
Dalla sezione Come un destino
Ho aspettato, ho visto la strada, Natale tra i singhiozzi, il freddo, e questo male che non esce, che non parla di te. Una corsa senza nessuno, un abbraccio già perso dove tutto si incrina, mentre la città scivola in una meraviglia lontana, un battito dentro le vene, uno sguardo trattenuto dal gelo.
Mauro Germani è nato a Milano nel 1954. Ha fatto parte della redazione di “Schema” e nel 1988 ha fondato la rivista di scrittura, pensiero e poesia “Margo”, che ha diretto fino al 1992. In poesia ha pubblicato L’attesa dell’ombra, Schema 1988; L’ultimo sguardo, La Corte 1995; Luce del volto, Campanotto 2002.
Tonino Vaan, da “Cosmesi”, con una nota di Rosa Pierno
Tonino Vaan, “Cosmesi”, L’arcolaio 2008
La realtà, mercificata, ridotta a una corrente di onde, flussi informativi ridondanti, sembra trasmettere un unico concetto. Stranamente questo concetto riguarda il corpo, sia in quanto oggetto del messaggio, sia in quanto ricettore dello stesso. All’interno di queste forbici si aprono innumerevoli diramazioni, in cui il corpo è ora passivo, ora attivo, ora produttore, ora fruitore. Nel paesaggio virtuale disegnato da codeste correnti traverse, s’instaura, eppure, un dialogo con varie voci, provenienti dai quotidiani o dai libri di poesia, le quali, innestandosi in tale immateriale tessuto, fungono da depistatori, da antidoti al rumore prodotto dalla comunicazione massificata. Sarà proprio questo tessuto sfrangiato a distendersi sui dati esistenziali, sui non-eventi “una gomma masticata alla finestra. / nell’uso smodato della sera”. Proprio durante un non-evento può capitare di sentirsi soli e, dunque, forse vi è la possibilità che queste voci, tutte, finalmente, si spengano, che il corpo assurga a unico soggetto legiferante, che le sue reali necessità si impongano. Eppure, chi può sentirsi definitivamente al riparo dagli attacchi delle voci? In agguato forse resta sempre l’isterica volontà della mente di costruirsi una scenografia e dei personaggi con cui attuare, se non la narrazione della propria esistenza, la narrazione di qualcosa che pure accade: “un boccone, ha ucciso il boxer, avvelenato / gli tirava i carnicci era suo amico / per dovere padrino”. Una insufficienza di autonomia, la diremmo, dell’individuo, il quale fatica a distinguere la parte di sé costruita coi materiali spuri di tali massificanti onde. Vero è che il poeta stesso ci invita a non sopravvalutare tale distinzione: “.non ci ostiniamo però ad attribuire virtù in eccesso / ad una o all’altra parte che là in fondo un’oscura materia / già incurva i fonemi del tempo”. E, in fondo, pare non comprimibile l’impeto di attribuire a un medesimo suono un diverso significato. Forse questo può aiutare ad abitare un mondo variamente costruito. “Qui, dove si paga lo scotto di una lunga corsa / passeremo queste giornate a fare cerchi / sulle frasi più belle di un libro / .restando nel timido sole di un’avventura”. Sarà l’immaginazione a salvare tuttavia invivibile mondo, ove bisogna convivere con la noia quotidiana e i massacri trasmessi in un telegiornale? Immaginazione, nemmeno a dirlo, è, anch’essa, pericolosa.
***
questa stanza arredata per fuggire
mista di metalli fusi ed ossa di cammello
pesante di incensi e vuota
.nei bianchi ha ombre pallide
che delineano luci nascoste.
aperta a nord alle correnti
dalla lunga vertebra dorsale
offre scudo, con i suoi vetri riparo
condensa ai pensieri incerti
riflesso in espansione, freddo ed umile
come tutto il nostro mutare nelle attese
***
come se niente
consacrasse i nostri minuti
noi seduti sulle panchine, la pietra
in pausa pranzo, quattro chiacchere
e una luce senzatetto estranea ai fatti
.storia di mani congiunte sul viso e maschere
che lo sguardo
ha un segno profondo
una ruga scavata, dentro a un senso di impotenza
***
supponi l’ossigeno di una visione
accanto al punto morto
ne più ne meno nella zona dei cerchi sotto agli occhi
.sequenza dei confini visibili
oltre ogni pratica cieca
che in qualche modo
entra e rende diverso
il problema del luogo nel contesto
.oltre la vertigine il vetro
perde la sua funzione
e ci riappropria ad un senso l’osservare
che prevale e resiste
come una storia d’amore
Tonino Vaan (Antonio Vasselli) nasce a Tivoli nel 1960. Matura la sua poesia nella rete web. Nel 2004 vince il Premio “San Bernardino”. Cura il blog www.piccolifoglibianchi.splinder.com
Giovanni Turra Zan, da “Stanze del viaggiatore virale”, con una nota di Rosa Pierno
Giovanni Turra Zan, “Stanze del viaggiatore virale”, L’arcolaio 2008
Il viaggiatore è ingabbiato in una scenografia inscenata dal suo stesso corpo: “i pollici / hanno occhi di viaggiatore, hanno di un uomo / i movimenti prigionieri, le perdute stanze”. Nella carrozza dei pendolari ogni mattina si ripete il contatto delle membra senza riconoscimento. Corpi che non assumono un’identità. Che non possono rimettere niente all’altro perché privi di qualsiasi relazione, se non quella istituita dalla repulsione del sudore. Ma il viaggio è qui metaforico, perché investe l’intera vita: la scena viene infatti repentinamente rubata da interni domestici in cui due conviventi vengono fotografati mentre sono sotto osservazione “come due coleotteri nel loro documentario”. Corre subito l’obbligo, per chi redige la nota critica, di registrare che ogni frase nel testo poetico di Turra Zan subisce uno scarto, causa un soprassalto, denuncia il comune come paradossale. Insomma, una poesia quasi acida e corrodente, che reclama, perché attua, una critica al reale, lo infilza con gli spilli, lo stravolge perché lo vuole diverso. Potrebbe essere definita una poesia civile, tutta votata alla critica delle relazioni fra gli esseri umani: la base dell’esistenza: “ecco i vicini vengono al consiglio / degli intrusi, alle grida e alle indiscrezioni che stempiano, a mettere in piazza la pena che avanza, fino al dare volta.”, ma con quel senso di disperata consapevolezza data da una lucidità che mai arma depone: “quando bocca tace e stanzia fondi / per gli ingialliti ponti”. Non si può che restare invischiati da un uso così sapiente - chirurgico - di aggettivi che stravolgono usuali parole, di sostantivi che trascinano pur estranee qualificazioni. E, d’altronde, non ci sorprendiamo di fronte alla tenerezza o alla virulenza che efflora nel racconto dell’esperienza d’amore (“ degli affetti tollerato il carcere d’orti e viscere”), poiché una tale dirompente forza poetica, avevamo già compreso, non può essere che partorita da uno squisito, sensibilissimo percipiente, assoluto padrone dei propri mezzi espressivi. Raramente poesia denuncia complessità e contraddittorietà dell’esistere, insegnando contemporaneamente l’arte del vivere. E in questo libro accade.
dalla prima sezione
VI
un ciclo inizia calcando silenzi con la carta carbone,
con le impronte dei lemmi sul nastro della loro olivetti
trovato in una cassa dopo il trasloco del novantatré,
dove si leggono intere le ultime lettere di commiato,
il testamento del bene fatto.
XI
A Fabio F.
in quel corpo un fitto instaurarsi d’ossa
e le biglie da gioco rilucevano al calore
delle lampade d’estate. eccoti allora
evaporare, frizzando in alto per poi
precipitare, farti sempiterno muschio
tra i rovi.
Da Rimanenze
nella profondità del covo si vedeva uomo durare,
in equilibrio muoversi come in attesa di recitare
il dramma, scrivendo nello spazio la sua scena
necessaria.
sedeva cauto sotto il ciliegio, maneggiando
i fili e le ombre degli spiriti,
del non conoscere che lo rendeva intimo
al bosco delle rimanenze, alle vie nel buio.
Giovanni Turra Zan è nato a Vicenza nel 1964. E’ laureato in Psicologia dell’Educazione e diplomato al Conservatorio Musicale di Vicenza. Ha pubblicato Senza presso Agorà Factory nel 2005 e il volume Lavoro del luogo” con Fara nel 2007. Ha vinto il Premio “Poeti per posta” indetto dalla trasmissione radiofonica di Radio Due “Caterpillar” e da Poste Italiane nel 2005.
Giuliano Rinaldini, da “Sequenza del fico”, con una nota di Rosa Pierno
Giuliano Rinaldini, “Sequenza del fico”, Joker 2008
E’ solo a partire dalla perlustrazione della realtà, in questo caso un percorso in una pianura - ma già viene il sospetto che si tratti di puro pretesto – che, fra le maglie delle cose, e più che percepite solo elencate, si ravvisano squarci metafisici in cui un “invisibile aritmico” aleggia fra pali e covoni. Con il repentino, ma distinguibile intervento della memoria, la tessitura del visibile si arricchisce in maniera sostanziale: “(memoria) / guardo i rovesci marci della terra. / campagna aprente il mio orecchio”. A tal punto che più il poeta guarda e meno crede a ciò che di fatto vede, essendo quel che si vede un ibrido risultato, un conglomerato di diversi “materiali”. L’esistente siamo noi. Da un mero dato si passa a un complesso oggetto, dove ben presto le componenti si confondono, sono fittamente intrecciate. Indistinguibili. E’ un attimo e il risultato visivo/mentale diviene più forte fino al punto da sostituire totalmente il reale. Forte al punto da emozionare. Presenza epifanica, con tutto quel che comporta per la conoscenza. O per la rappresentazione. Non è forse solo attraverso essa che si può individuare un processo formativo? E, dunque, ecco che fa ingresso il “coro: / pezza di terra capovolti / visi di argilla. / le cose sono meno affilate / un ossario di cose”. Seguiamo Rinaldini nella continua spola tra percezione e processo conoscitivo (sapendo che la percezione è già parziale processo elaborativo nella costituzione del testo poetico): “e, com’è buona l’aria, / anche se squallida, buona come un’ancella: / altra cosa la poesia : solo un incontro / con una mia miseria”. Poiché passa per questa via qualsiasi definizione della propria individualità: inestricabile dal dato percettivo e culturale. Inesistente senza essi. E anche così suscettibile di essere da loro travolta: “chiusura (ermetismo di me), / torcimento (o tortura) di viscera.”. A dire che l’intervento massivo dell’emotività travolge il paesaggio, lo rende totalmente dipendente: “pianura, come un’arnia lunga e sorda, o una tonnara… / luce di una notte seminata di fanali / sofferenti nell’alba: / di pali elettrici”. Sappiamo con certezza, ora, che presto la pianura rioccuperà l’intera scena con la sua opprimente afa. Rinaldini non manca di avvertire: “di tutti i mali / che può una mente, qui non ne vedo alcuno” ponendo così un sigillo che connota tutta la sua poesia come un atto di altissima quanto paludata investigazione morale.
Secondo intermezzo
sulla strada di lentigione,
giovedì ventotto settembre. verso la foce dell’enza:
le macchie dei fiori alti gialli sugli argini. i pioppi
|allibiti, allisi, stampati sul fondo.
lontano, un rossore di case.
spari.
(un continuo rossore debole)
campane.
rumore di passi (i miei).
pezzi di terra sull’asfalto.
i fiori dei fossi.
sono in piedi con una smorfia e scuto
(nulla in particolare).
(premuto
tra il sole
e la linea del suolo)
la notizia del silenzio
è sui campi.
emerge dall’aridità, durante un giorno:
collega le cose.
(guarigione dei rumori)
essere solo in questo seno.
lontano, sulle ghiove, un cacciatore e attorno i suoi cani.
in mano gli luccica un fucile.
venerdì ventinove settembre, nessun luogo.
non ritrovo il posto del silenzio.
(tutto si mischia, imbrunisce)
le strade e i campi si uniscono in un nodo.
Giuliano Rinaldini è nato a Reggio Emilia nel 1981. Laureato in Lettere Classiche a Bologna, attualmente i suoi studi si orientano in ambito biblico e nella poesia italiana del Novecento. Ha pubblicato Cognizione di un’alba, Cierre 2007, nella collana “Opera prima” diretta da Flavio Ermini.
Alberto Casadei, da “Genetica”, con una nota di Rosa Pierno
Alberto Casadei, “Genetica”, Aìsara 2008
Nell’andirivieni fra quotidiano e metafisico, convenzionale e imprevisto, ordinato e caotico, la scrittura di Alberto Casadei, si sviluppa come un elastico tirato che rilasciato vibri: quasi una rincorsa alla compresenza, a una sorta di elencazione con impeto esaustivo. Ma anche sguardo dell’osservatore subisce un’alterazione: “Io vi guardavo da lontano, / non sembravi più mia moglie, / non sembravi più figlia”. Nella discontinuità prodotta dalla variazione è, però, possibile rintracciare una linea generale che colleghi il precedente col successivo, che consenta di chiudere il cerchio, ottenendo un ciclico ritorno. Ciò è possibile soltanto astraendo dalle azioni biologiche: “Ma se tutti finissero il generare, se / solo rimanesse l’accostarsi infinito a corpi / e corpi / cercando bellezza”. Sarebbe allora realizzata “l’indefinita ascendenza”. Continui cambi di scala, di parametri di riferimento, di contesti caratterizzano il metodo che Casadei utilizza per “vedere, trasfondere, reiniziare”. Ma quella di Casadei è contemporaneamente una ricerca sulla capacità artistica, indagata nelle sue prime manifestazioni, anche se già complesse: le statue dell’isola di Pasqua, i graffiti di Lascaux, la città di Ur nel tentativo di rintracciare le forme prime, diremmo, della costruzione culturale. Non esimendosi nemmeno sull’abisso che separa l’iniziale coacervo di enzimi che porterà alla formazione dell’essere umano. Per ampliare la propria investigazione includendo l’uomo-poeta: “reimmerso nel liquido, come nacqui, senza / ricordare niente del nascere, ma / nato e compiuto in questa lunghezza”. Rintracciando/creando in sé il tempo, la musica delle sfere, l’entropia. Immaginazione e gioco concorrono a farci vedere ciò che altrimenti nemmeno potremmo percepire: “nell’io / nel gioco_tutto / il tendere-tentare-tremare /dominò”. Non sarà solo la scienza per Casadei, ma l’unione di scienza e arte, di ragione e passione a spingere “alla forma universale, al principio, / mancante, al perfetto segno che della massa fa energia-bellezza”.
dalla sezione Un altro ritorno
***
E si profila finalmente la sagoma,
del riparo della casa abitata da ora o
da milioni di anni, baci, risa,
bossi a distanza regolare,
mattoncini di cotto rossastro, poi
sfere armillari esigono
altri geni, fini, tentativi
di rendere misura adeguata
il caotico susseguirsi che fonda
i corpi.
***
L’identità lunga dell’amore
non sostiene i minuscoli dissesti,
e solo cercando ancora più
a fondo nel bene trasmesso,
nell’eredità che collega il prossimo
e l’inizio, e io con io fino al
diventare tu,
solo sperando nel connettersi
e combinarsi e cercarsi
si chiude forse il circolo
che sigilla il ritorno.
Dalla sezione Ur
“Cosa si vede, adesso?” delle città che furono,
dei regni transeunti, degli innumerabili atti
inconsapevoli naturali travolti
in un ordine più vasto ma ignoto,
innecessario, di errori fatto e fu poi
sangue che nutre organi che si espandono
indefiniti che si legano in alte sinapsi che
creano l’utile e il buono, queste case
di fango e paglia e creta,
sopravvissute ai diluvi,
al dilavarsi dei tempi.
Alberto Casadei, nato a Forlì nel 1963, vive e lavora a Pisa, dove attualmente insegna all’Università. Ha scritto numerosi studi sulla letteratura italiana rinascimentale e contemporanea. Tra i suoi volumi di saggi: Letteratura italiana: il Novecento, Il Mulino 2005; Poesia e ispirazione, Luca Sossella 2009. Come poeta, prima di “Genetica”, ha pubblicato I flussi vitali, Editing 2005.
Lino Giarrusso, In febbrile peregrinare, con una nota di Marco Furia
Lino Giarrusso, "In febbrile peregrinare"
Con "In febbrile peregrinare", Lino Giarrusso presenta una sintetica riflessione su quanto, lungo ardui itinerari idiomatici, può emergere quale idea o parola.
Si tratta di un'immediata percezione del fatto che il linguaggio risulta fondato esclusivamente su regole date non una volta per tutte, ossia di come un costruttore di testi (il poeta) si trovi a doversi riferire ad una materia la cui forma, mai già disponibile, occorre porre in essere per via di nuovi accostamenti.
Ne possono nascere inquietudini, turbamenti, preoccupazioni, ma, se il processo creativo ha felice esito "l'incoerenza s'acqueta".
S'acquieta, forse, perché si è perfezionata "la complessa decifrazione / del nulla"?
Bene, credo la poesia consista in un'originale lingua - forma di vita e, perciò, non nel nulla, ma ritengo altresì che siffatta espressione possa in questo caso essere considerata presa d'atto dell'assenza di aprioristici fondamenti della lingua, alludendo, appunto, alla difficile attività del poeta.
La pronuncia "delicata armonia", ad esempio, mi pare renda convincente testimonianza dell'esistenza di valori scaturenti da esperienze costruttive, ossia d'impegnativo lavoro sulle parole, escludendo qualunque nichilismo poetico.
Il tutto in otto eleganti, intensi versi.
***
in febbrile peregrinare
le idee vagano in tortuose albe
le parole mutano di suono
l’incoerenza s’acqueta
esulta
in delicata armonia
la complessa decifrazione
del nulla
Lino Giarrusso vive ad Augusta, in provincia di Siracusa. Ha pubblicato i seguenti volumi di poesia: Cocktail, 1982; La tegola sul capo, 1990; Dove dormono le lumache, 2000; Nel tempo, 2006. Ha partecipato nel 2005 e 2006 a Umanitaria, indetta da Aldo Forbice a Valmontone. Finalista al Premio “La Zisa” nel 2008 e segnalato al “Domenico Rea” 2008.
Marina Corona, da “I raccoglitori di luce”, con una nota di Rosa Pierno
Marina Corona, “I raccoglitori di luce”, Jaca Book 2006
Fra foglie, sassi e uccelli, muoviamo i primi passi nel libro di Marina Corona, e sono passi lenti e meravigliati in un mondo silenzioso, poiché vi vengono convocati elementi naturali personificati, ove l’aria è un libro e il guanto ha dentro una mano. C’è dunque un capovolgimento che spiazza, che rende gli ambienti favolistici e i personaggi che lo abitano altrettanto irreali. Ciò che viene prelevato dalla realtà, un bambino, un cappello, la pioggia, nel momento in cui vengono immessi in questa scatola che è il libro, diviene magico, se con questa connotazione può indicarsi una nostalgica considerazione per il valore delle cose perdute, rimpiante, mai avute. E, pertanto, preziosissimo è il travaglio che si dispiega in queste pagine, è esso che incute cautela al lettore: egli deve muoversi con attenzione e rispetto in questa stanza impolverata, ove eventi senza legame figliano gli uni dagli altri e la logica con la quale si susseguono è esclusivamente quella del desiderio e della vita interiore: “catene scivolano nell’acqua dell’estate / la guardiamo coi capelli allungati / come alghe semprevive / “requiem” per il dolore che portammo”. Esistono scatole per ogni sentimento. E persino per i sentimenti sottoposti all’impegno quotidiano come l’amore, è l’ombra, l’apparenza, una diversa sostanza delle cose a prendere il posto delle persone: “Un uomo è la sua ombra / accanto alla tua ombra ho dormito”. La metamorfosi ha un ruolo non secondario in questo cambio di sostanza: “ fingo di non vederlo / di essere cieca / di essere muta / di essere la docile pianta beata alla luce”. Strategie di resistenza potremmo chiamarle, per una sensibilità resa vulnerabile dalla sua stessa singolarità. Quando scatole contengono pezzi di cielo o pura luce, la metamorfosi ha, invece, un ruolo d’investimento e la passività si tramuta in capacità progettuale: “mi faccio faro, / nella salsedine raccolgo i raggi / a mia luce / li volgo in un’intermittenza / per chiaro vastissimo alfabeto”. Le radici del nulla restando sempre in agguato, poiché è esso che ghermisce amori e oggetti e solo poesia trattiene.
dalla Parte prima
Il segreto
Questa sola veste
la nuca fissata dal fuoco
forgiata
la fronte chiusa
mio ripido cielo
andiamo per mano
gli alberi si levano foglie e uccelli
hanno gli occhi di sbieco
un segreto si fa sottile
mi lascia toccare le mani dell’aria.
L’illustrazione
La mano molle di gelatina
in artiglio decomposto
era una mano di bambina,
nel collegio le maestre
si chiamavano solitudine
e le compagne statue
in cera e fresco alito plasmate,
il giornalino mostrava
la mano sfatta e lo sfasciume
dal polso al braccio salire
per la carne arresa,
sbiadiva il prato, non reggeva
il peso del corpo leggero
e degli occhi schiantati tra le mani
ma il cielo in alto
ordiva trame spostava
stelle ordinava
per sé azzurro
un quesito di salvezza.
Marina Corona è nata a Milano nel 1949. Nel 1993 ha pubblicato il volume Le case della parola, presso “I Quaderni del Battello Ebbro”. Nel 1998 L’ora chiara con Jaca Book. Cura cicli di poesia e presentazioni di poeti contemporanei presso la Casa della Cultura di Milano.
Rinaldo Caddeo, da “Dialogo con l’ombra”, con una nota di Rosa Pierno
Rinaldo Caddeo, “Dialogo con l’ombra”, La Vita Felice 2008
L’ombra diviene concetto estensivo, si allarga simile a una macchia d’olio, inglobante tutto ciò che trova sul suo percorso, come se una tenda tirata, a ogni cosa, rapinasse non solo luce, ma anche sostanza. E, dunque, sotto questo effetto: “sagoma di lepre in fuga / tenuta alla catena / fantasma di un amore / gettato alle spalle / inchiostro rovesciato latte scuro / strana idea di me che t’allunghi” gli oggetti denunciano non soltanto un cambiamento nelle condizioni ambientali in cui essi sono esperiti, ma, di fatto, un’effimera apparenza. Un tale immediato darsi sulla scena comporta che si traggano conseguenze altrettanto repentine, se non altro per non essere sorpresi dagli eventi, per sintonizzarsi immediatamente con ciò che ci si troverà a fronteggiare nell’istante successivo: “sei solo una forma / un’orma, un vuoto?”. L’accerchiamento del poeta sferrato da tali oggetti viene però completamento capovolto. E’ Caddeo a inchiodarli, riconoscendo la reale materia di cui sono fatte tali ambigue apparenze: esse appartengono alla sua medesima sostanza, sono l’oscurità che risiede in lui. In un corpo a corpo serrato, poiché non è da credersi che tale riconoscimento possa essere neutrale o risolutivo, l’oscurità ponendo un problema almeno di chiarificazione, Caddeo intesse un dialogo con la parte oscura di sé, la quale, certo, per essere umbratile non è meno corposamente ossessiva. E se non è l’ombra a inseguire il poeta, è lui che la insegue per tentarla, per dare corpo al poetico testo. Quello che si svolge sulle pagine sarà il tentativo di fissarne limiti, di definirne i poteri, di rintracciarne la storia, di determinarne il raggio d’azione: l’ombra è concetto preesistente alla singola storia dell’individuo. In qualche modo, la propria oscurità viene condivisa, se ne rintraccia la geologia nell’oscurità dell’umanità. Perché l’individualità è sempre frutto di ciò che ci viene culturalmente tramandato. Al termine di questo viaggio nei meandri in cui la parola ombra dispiega tutta la sua enorme capacità simbolica, Caddeo potrà affermare di avere: “imparato a decifrare l’alfabeto delle tenebre / le spaccature del terreno / le crepe ai muri l’orlo”. Se anche la scrittura che ne risulta appare di cenere è questo il segno di una capacità raggiunta di accettare le ombre nella nostra esistenza in quanto mitigatrici ed equilibratrici di una altrimenti accecante sostanza.
Dal prologo
Mattino
chi sei? scivoli sulla terra
dietro me senza una briciola
un filamento o un’abrasione
sulla tua tunica nera
sfiori tutto
senza spostare niente
Dall’epilogo
Preghiera del mattino
dacci la nostra ombra quotidiana
non ridurci a destinazione
liberaci dalla tentazione
di un contatto troppo stretto con le cose
e con le persone metti la giusta
distanza tra noi e la lucetta frisa
non chiederci un assegno a vuoto
sul valore del mondo
al posto del cielo
al posto della terra
al posto della superficie
liscia ruvida umida secca
metti la tua impronta
la forma di una forma
alla nostra faccia alla nostra voce
perdona la materia
se è un cieco che ci conduce
diventa la nostra guida
illumina di buio
l’oscura nostra vita
Rinaldo Caddeo è nato a Milano nel 1952. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Le fionde del gioco e del vuoto, Narciso, Calendario di sabbia; una raccolta di racconti: La lingua del camaleonte; una di aforismi: Etimologie del caos. E’ redattore della rivista milanese di poesia, filosofia e arte “La Mosca di Milano”.
Massimo Sannelli, da “L’aria”, con una nota di Rosa Pierno
Massimo Sannelli, “L’aria. Poesie 1993-2006”, Puntoacapo 2009
Frangere la frase, frullarla, scardinando la sintassi, per ricomporla con pochissime regole: fra cui quella basilare che associa paradossali aggettivi a oggetti respingenti è l’atto con cui Sannelli dà luogo al proprio tessuto poetico. Se, infatti, “il bianco fino è, è, in una meraviglia / di spazio ovale, e il suo riposo: questa” allora sappiamo già con certezza che questa è una poesia in cui si chiede al lettore di focalizzare la propria attenzione su ciò che non è possibile dire, ma che si può indicare per via traversa, con un escamotage, con una formulazione insita nel linguaggio stesso. Ad esempio, con una reiterazione di aggettivi dimostrativi mancanti del referente: “quanto, questo, quanto” oppure con “né meraviglia, né onore, né elevazione, né umiliazione” eliminando, cioè di colpo qualsiasi rimando a concetti e definizioni. Se ci fosse un’isteria del linguaggio sarebbe questa, ma è un’isteria pilotata, strumentale, per giungere a ottenere faglie, fratture attraverso cui un nuovo senso possa zampillare copioso e fresco. Infatti, anche facendo vorticare, mettendolo alle strette, il linguaggio, si ottiene comunque una produzione di significati. Seguire le modalità con le quali è dato corso a questo nuovo processo di produzione del senso può consentirci di accostarci al mondo visionario da esso inaugurato, infatti la modalità è - in casi come questo - il mezzo che ci trasmette l’unica informazione fondante: “dove scompare è morbido: l’acqua e / la gonna, e la bocca parlata, e la bocca / solo, e la bocca verdissima, e la bocca: / tutto e quello. L’occhio conosce un segno, seminagione: prenderne fronda o fiore”. Se un oggetto assume un’aggettivazione non pertinente se non in ambito metaforico, diremmo che non c’è un referente oggettivo. Alla verità si può accedere soltanto attraverso l’artefatta assunzione di un senso che prescinde dal mondo reale, dove le cose sono segni che attestano altro e solo l’altro è ciò di cui si ha bisogno, ciò che sazia, ciò che redime, se pure è in forma franta. Verità non può che essere un brandello, quello tirato con i denti, strappato, amorevolmente sovrapposto. Lembi di broccato, d’oro fino, di vegetale filigrana con cui tessere la tenda che mondo ricopre anziché disvelare. Non se ne ottiene una realtà ricomposta, ma una pura azione, ove il ricevuto è tramutato in irricevibile. E in questo trova la sua libertà di ricreare, di stare al mondo.
Dalla sezione Lo schermo
***
per mille cose una sola concordia:
che snerva; una sola salute, che aiuta
tutti; il candore, che spaventa.
Ecco. In un primo maggio, in una
Pasqua di marzo, scompare
il caldo, nei rapporti la timidezza
per un parlare latino, sciolta-
mente. L’innocuo vuole ferire, come
alleguance va, rosa, il rosa; e da-
gli occhi le onde.
questo scuro e bianco, fratelli, duo
tratti sono poesia e critica, fortuna
e ventura: un crespo e un lucido,
o un altro zinco, amico della luce.
***
voi siete un desiderio sinuoso, striscia. Inizia
su una posizione, continua: né cuore lo sa
dire, e la lingua non può: due non sono
una cosa sola. Cede la notte e cala: con
ancora dispersione – ma gioco; e alterazione
giocosa, che dura poco; con fuori, e uscita, e
perdita, ed emozione, intanto. intanto?:
chi approfitta ne sogna, e soffre: per
il suo spazio violato, liberato dai vincoli.
Massimo Sannelli (1973) vive a Genova. Si è occupato di testi medievali e di teoria e critica della letteratura. Ha tradotto Eric Suchère, Emily Dickinson e Rati Saxena. Opera anche nel teatro e nel cinema di poesia, come attore e autore. In rete: www.massimosannelli.splinder.com
Massimo Scrignòli, Luce verticale, con una nota di Marco Furia
Massimo Scrignòli, "Luce verticale"
Con "Luce verticale", Massimo Scrignòli presenta una versificazione fluida ma complessa, tale da rendere partecipi d'una vicenda poetica in cui autore e materia trattata convergono, fino quasi a coincidere, nell'immagine del fiume.
Dico "fino quasi", perché coincidenza perfetta non v'è: s'avverte, in ogni modo, la presenza dell'io scrivente, sebbene molto partecipe.
Versi quali
"Per uscire dal mondo dobbiamo
intuire decifrare tradurre
tutti gli indugi del tempo.
Ma i miei fiumi hanno scelto
la clausura delle mareggiate, hanno
condiviso i misteri impazienti di Orfeo"
paiono indicare una sorta d'inclinazione verso una natura in grado di offrire, di per sé, scampo alla "paura", al "timore" presente nell'incipit.
Siffatto atteggiamento reclamerebbe una completa rinuncia all'individualità umana con tutte le sue spiccate attitudini riflessive e logiche, uno scioglimento quasi nirvanico nei misteriosi flussi dell'essere al mondo.
Ma non è questo l'atteggiamento del poeta, il quale, piuttosto, è propenso a constatare, a prendere atto: esiste una contrapposizione, non si vede, nell'immediato futuro, la possibilità d'una sintesi, di un'armonia e, di fronte a tutto ciò, l'arma della ragione non sembra abbastanza rapida, efficace.
L'inquietudine, insomma, emerge come tema d'una poesia che non indulge a toni scomposti, ma, con un dettato chiaro, preciso, in cui la forma ben aderisce all'esigenza di esprimere circostanze drammatiche, presenta una situazione certo poco allegra.
Un'inquietudine, tuttavia, che i "fiumi", e con essi l'autore, non hanno rifiutato (lo dimostra, al penultimo verso, la congiunzione "e" riferita al precedente "hanno scelto"), in un gesto di fiducia nell'esistere, testimoniato, almeno per il Nostro, dal fatto stesso di scrivere.
***
C’è timore e ancora si sente
quando soltanto un soffio convoca
tutte insieme le foglie
eppure
alla paura avvertita in aria i miei fiumi
preferiscono la clausura, scelgono
la grazia del gorgo, una grazia misera
da pioppo di golena, piccola
ma figlia di un’annunciazione
che mai si potrà compiere.
E quando a Praga sono le undici
e anche sopra l’ombra della mano
di Jan Hus sono esattamente le undici
allora la pioggia diviene fiume
e svuota il cielo, muove i tetti
li spinge adagio sulla riva della Moldava
e dell’Elba, e sul Tamigi e giù
sulle foglie della Senna. Poi
sul ponte più antico ritorna pioggia
e aspetta il Po di mezzogiorno.
Per uscire dal mondo dobbiamo
intuire decifrare tradurre
tutti gli indugi del tempo.
Ma i miei fiumi hanno scelto
la clausura delle mareggiate, hanno
condiviso i misteri impazienti di Orfeo
e tutta questa libertà inquieta dove
il pane è una luce verticale.
Massimo Scrignòli è nato nel 1953. Dalla fine degli anni ’70 svolge un’intensa attività in ambito editoriale. Ha collaborato con vari artisti per la realizzazione di cartelle e libri d’arte. Già finalista al “Viareggio” per la poesia, ha ricevuto diversi riconoscimenti e premi letterari. Ha pubblicato alcuni volumi di poesie con prefazioni, tra gli altri, di Raboni, Ramat, Pampaloni, Sanesi. Il suo libro più recente è Lesa maestà, Marsilio 2005.
Tiziana Gabrielli, Il respiro dell’Aperto, con una nota di Marco Furia
Tiziana Gabrielli, "Il respiro dell'Aperto"
"Il respiro dell'Aperto" di Tiziana Gabrielli, affronta con elegante precisione formale un'ardua materia.
Nulla più dell'aperto è privo di vincoli, schemi, paradigmi, per cui, si può ritenere nessun linguaggio sia in grado di farsi carico di tale argomento.
Tuttavia, con piglio dichiarativo, che talvolta sfiora il sospetto del manifesto poetico, Tiziana offre un'articolata sequenza d'accurati versi, mostrando di aver superato ogni timidezza.
In effetti, si parla dell'aperto per mezzo di tratti idiomatici che l'apertura non temono, anzi promuovono, tratti che, pur non rifiutando a priori le regole della logica, sanno porre in essere lineamenti dal senso specifico, allusivo.
Così, la suddetta accuratezza nella costruzione del verso, ben lungi dal costituire un ostacolo come potrebbe a prima vista apparire, si rivela originale cifra d'una poetessa consapevole di poter avvicinare l'ineffabile per via delle metafore, delle vivide suggestioni dei propri versi.
Se "La poesia ri - vela / la splendente / oscurità" ma non la dice, se "il mistero / dell'essere" resta tale e "l'Assente" rimane "innominato fiore", se, insomma, nemmeno il poeta può superare certi confini, è tuttavia possibile una partecipe testimonianza di tale stato di cose.
Solo chi conosce bene i propri limiti è in condizione di parlarne: la nitida scansione in esame ne costituisce chiaro esempio.
***
I. Ouverture
La poesia sta
prima della cosa, ver(ti)gine
irriflessa,
impresentato Prius,
fonte battesimale
della parola-lingua
immemoriale madre
aurorale
II. Il thauma dell’Origine
La poesia ri-vela
la splendente
oscurità
germoglio e grembo
stupore muto
dell’Origine
- una e duplice –
soglia e varco,
sussurro
e respiro dell’Aperto,
dove risuona
inespresso
il mistero
dell’essere
III. L’ora senza nome
La poesia ri-crea
l’Assente,
innominato fiore
che dice la vita,
l’indicibile
pronuncia dell’Altro
che non cessa di affiorare,
annunciare
l’evento
della parola-mondo
Negli interstizi dell’ombra
“riluce il silenzio”,
il Senso
Tiziana Gabrielli è laureata in filosofia. Attualmente è impegnata sia nell’ambito della filosofia classica tedesca, sul rapporto tra ontologia ed ermeneutica nel pensiero contemporaneo, che sul versante dell’etica applicata e delle nuove declinazioni dell’estetica tra filosofia, arte e letteratura.. Come poeta è presente in numerose antologie e ha vinto premi nazionali e internazionali.
Allucinazioni Urbane: un saggio degli studenti del Liceo Classico “Maffei” sui vincitori per l’edito
Studenti del Liceo classico “Scipione Maffei”
Premio “Lorenzo Montano” 2009
Allucinazioni Urbane
La città, attraversata da canali di bitume che raccolgono i rifiuti di un’umanità senza più aspettative, troppo presa dalla fretta di esistere.
Con in mano il biglietto salivano senza parlare.
L’autobus si riempì lentamente.
La città sfiorata, e il cielo, il fiume, quello che c’era all’interno, tutto era grigio scuro, come di pietra. I loro volti e quelli degli altri passeggeri, la stazione davanti alla quale passavano in quel momento, tutto era tinto di un unico colore. Uno spesso vetro opaco li aveva imprigionati. Quelle strade che conoscevano così bene e che correvano loro accanto appartenevano allo strano mondo di pietra nel quale la loro vita abitava.
“Buongiorno..”
“Buondì!”
“Salve”
- Prendo questo stesso autobus dai sedili vecchi e tarlati tutte le mattine. Spesso l’imbottitura esce, una frolla gommapiuma gialla, quasi occhieggiante, mi preme sulla schiena.
Tutte le mattine, lo stesso guardarmi intorno e poi volgersi fuori. Ma dico, nessuno ha mai notato quanto sono ingombranti le persone, compresse in uno spazio così? Eppure esse sembrano prediligere questo sicuro senso di soffocamento. Escono tutti dalle auto, quasi esitando a immergersi nell’atmosfera tagliente e invernale delle sette di mattina, senza guardarsi intorno, senza emettere suono. L’aria aperta li ferisce, è chiaro, i colori delle cose li irritano, i profumi li confondono: ogni sera vedono i loro sogni passare sugli schermi, ma la realtà è sempre più grande di come se la possono aspettare. Compiono il tragitto correndo, presi nei loro freddi meccanismi: tornano al chiuso quanto più velocemente è possibile, con gli occhi iniettati di sangue. Se solo si avesse il coraggio di guardare dritto in quelle loro agghiaccianti pupille... Alcuni ormai non hanno più problemi, soffrono e basta, come fosse il loro unico hobby, il solo lavoro, il mestiere più degno.
I loro passi segnano il ritmo che spinge avanti la città, in un movimento perenne: c’è spazio nelle sottili fatiche dell’attraversare per un attimo di sospesa calma?
Già: bisognerebbe fare una storia, andarla ad estrarre come una scheggia, per ogni ombra passante che vedo dall’autobus, in fondo al viale, tra questi palazzi. Dare qualcosa dal centro, inventare che ci sia centro, dissonante distrazione, che colma il vuoto nel vortice delle azioni. Di quale storia si parli non è chiaro, ma renderla mia è rallentare, andare in un sogno qualsiasi, trovare una via di scampo. No, anche oggi non moriremo, nonostante i miei passi siano così lenti e pesanti, nonostante continuiamo ad andare verso il solito posto, anche se gli edifici sono terribilmente grigi. Camminando, non posso che guardare asfalti, misteriosi e levigati, che hanno in sé le immagini di una folla che si ferma, di vecchi che rallentano il flusso, di giovani che pensando sono costretti a fermarsi.
Sono fissate lì, addormentate in ciò che ancora tiene tutto fermo e fissato, in ciò che conosce l’eco dei nostri passi, il suono dei nostri pensieri: questi gusci di cemento, appena più longevi di noi.
- Piove. Perché non sono rimasto a casa oggi? Il chiasso è soffocante. Guardare la pioggia che riga i vetri...no, questa città è troppo grande. Voglio tornare a casa...voglio tornare da te. La tua bocca mi impone il silenzio. Ti immagino. Il fiato, il colore dei capelli, l'opera dolce delle labbra, le ciglia, il bianco aspetto. Vedo la stanza dietro la finestra, il lume acceso come un segno. Le pietre, il muro, i letti umidi sfatti, i visi pianti. Mi giunge l’impronta della tua voce anche se non posso sentirla, è un tenue tintinnio di chiavi in tasca - sto entrando. La camera, piccola, nuda affonda nel sonno. Un lume al centro colora gli oggetti, cade l'ombra addosso al muro. Io lo sapevo dal muro caldo di luce che questa casa vuota ci aspetta; hai fiato a dire in bocca che il domani qui va oltre il tempo. Tutta questa smemoratezza, qui, in questa città! Intorbida i colori, stacca i segni ai muri, imprime l'apparenza. Solo l'aria ferma mi dà pace, quanto basta alla figura che ritorna a farsi viva, nell'immagine intravista. Veglia la radice sotterranea. Uno tace, l'altro parla, ci guardiamo le mani. Lascia che a dire siano le cose...
- Dietro il vetro dell’autobus perlato sotto ipnosi al ritmo di metronomo scandito dal tocco di rasoio del tergicristallo, il parabrezza schermo e davanzale alla mia immagine. Un cielo tutto sgorbi sbaffi immobile. Ma quest’alba sarà la stessa per chi di loro non avrà dormito? Vorrei facesse di nuovo buio per continuare la mia corsa, fuga dal mondo, e poter di nuovo ritrovare quel mondo a rovescio, quando davvero l’asfalto fa più luce di quel cielo sottosopra, cieco sotto l’ingombro degli alti cumuli di nera ramaglia e nuvole, quelle che non pensano e passano. Tutte queste persone, stipate una sull’altra che corrono, tutte, verso l’immortalità dell’estinzione attraversando la città, quartieri interi senza soluzione aggirando acquitrini e parcheggi selvaggi zone morte. Morti, precipitati ridotti ultimi nella decrepitudine dell’arte, sono io il vero residuo? O solo il più colpevole per non aver visto questo gioco al massacro, il massacro della storia. È chiaro il mondo oggi e il panorama di rifiuti irrefutabili contrassegno di civiltà sacrificato cammina, fondale delle nostre azioni ferme. Dalla città recondita ad ogni bocca di fogna o caditoia in nerofumo un drappo, uno straccio di prova estorto fa barraggio e assorbe la risacca di liquami. Tutto scorre attraverso e ti senti spettro, riflesso dell’infanzia di un’infanzia.
Oh lady la realtà è apparenza e l’apparenza…
(liberamente ispirato a:
“La distrazione” di Andrea Inglese,
“L’opera racchiusa” di Federico Federici,
“Le omissioni” di Ottavio Fatica)
Giulia Cecchinato (3 I), Chiara Gagliardi (3 I), Maddalena Giglia (2 I), Benedetta Nonis (2 I)
Giovanni Campana, da “Pensieri sulla soglia”, con una nota di Giorgio Bonacini
Giovanni Campana
PENSIERI SULLA SOGLIA
La poesia, che è una prova di ascolto, e dunque un atto di sfida nei confronti nostri, del linguaggio e del mondo, è sempre sostanziata da un pensierosu cui nasce e che genera conoscenza. Ma è un tipo di conoscenza particolare (non lineare o assodato o consolidato) che si autocommenta in modo implicito, in profondità, per la natura stessa (segnata da una metamorfosi costante)del movimento meditativo che la parola poetica mette in atto. Nelle poesie di Giovanni Campana questa unicità, intima e discorsiva, si sdoppia in modo esplicito: le poesie, per così dire vere e proprie, sono accompagnate da altri testi che aprono e diffondono ulteriormente la gamma delle riflessioni e dei sensi.
Dunque non parole in più che vorrebbero, ingenuamente, precisare il significato (cosa di cui l’autore è perfettamente e poeticamente consapevole, perché significherebbe svuotare il dire poetico dalla sua capacità di trasportare un sapere e sovvertirlo), ma scritture che incentivano un senso infinito, che attendiamo e a cui attendiamo. Ed è proprio in questa doppia precisazione del termine “attendere” che si manifesta un aspetto forte, altamente significativo della scrittura pensante e poetica di Campana: dedicarsi, offrendo il proprio impegno, a un’attesa (sulla soglia) non passivamente, ma attivando una propria contemplazione del mondo. E lì percepire di essere dentro, di appartenere a un pensiero che sente di sperimentare l’inquietudine di una mancanza, individuale o collettiva, non di presenza, ma, più dolorosamente, di ogni mancanza: “Anche l’assenza se ne andò/ciò che non è non lasciò più alcun vuoto”.
E’ su questa mancanza di un vuoto, nel niente che ribolle nel mondo, ricco di sensi potenziali che scava la parola, che si fa voce e ricompone le tracce alla ricerca di un buio (quello che oggi c’è è “diminuito ormai irreversibilmente” ), di una tenebra nuova: non da superare, ma da attraversare per arrivare, forse, a qualche forma di luce. Un’illuminazione fioca, debole, ancora non lasciata dall’oscurità, ma certamente luce concreta, mentale o corporea, da abitare e interrogare. Questa è la tensione poetica che anima il pensiero scritto in questi versi: mai disgiunti dalla certezza che “sarebbe cieco il mondo/se non lo circondassero parole”. Ma non le parole ordinariamente circoscritte nel dire le idee sulle cose, bensì quelle tese verso un significato in crescita: che non sta in una verità, non sta in una certezza o in un sistema di certezze, ma in ciò che ci attendiamo quando ci parlano, quando ci dicono le cose vere al fondo di una continua ricerca di confini.
Il limite è ciò che permette al poeta di pensare oltre, di immaginare ciò che senza confini non potrebbe essere. Perché è in questa coscienza - il paradosso di un limite che obbliga allo sforzo e, dunque, non è limitante - che si attiva e si attraversare il poema. Una voce che respira all’interno di una scrittura che non smette mai di offrirsi alla lettura; uno sguardo che tenta un superamento e rende questi testi così capaci di generare pensieri da un pensiero mai chiuso, mai univoco o concluso; l’interiorità di una mente che non esita a soffermarsi sull’impossibilità di sapere, sui dubbi, sulla difficoltà di abitare se stessi continuando a porsi domande.
Dalla sezione Confini
***
Era più fermo il passo sul terreno
quando l’abisso era dietro casa
e da ogni lato
ci chiudeva il cerchio delle tenebre
lungamente piangevamo
coloro che restavano inghiottiti
ora il buio è confinato in sgabuzzini e intercapedini
e gli abissi sono costantemente colmati
e per tutto c’è qualcosa
anche la morte si è indebolita
per questo vanno in tanti alla ricerca del nulla
presto le guerre avranno un periodo felice.
***
Qui è il punto di molte soglie
infinite soglie
o nessuna
solo varcata, ogni soglia è tale
quanti valichi non erano valichi
questa soglia è tra soglia e non soglia.
Dalla sezione Parole
***
Da più riposti silenzi
a volte a noi risalgono parole
da lungo destituite
in più tombali notti dissepolte
scorgiamo in esse antiche permanenze
-ritorni da epocali spoliazioni
dalla mortale prova del deserto-
appena vive un resto
(sepolcri smossi, in noi, le nostre anime).
Giovanni Campana è nato a Modena nel 1949. Laureato in filosofia. La sua esperienza intellettuale è dominata dalla durezza del confronto tra il riferimento religioso, sia pure incessantemente problematizzato, e la piena immersione nel pensiero filosofico ed epistemologico contemporaneo.
Andrea Gigli, da “Cronache di variazioni aeree”, con una nota di Giorgio Bonacini
Andrea Gigli
CRONACHE DI VARIAZIONI AEREE
Tante le direzioni di lettura per queste poesie, dove il termine “cronache”, con il suo senso denotato di “registrazione corrente” non deve ingannare, perché è più sulla parola “variazioni”, che ne moltiplica la significazione, che si deve indagare. Infatti si tratta di un poema, suddiviso in alcune parti, che ha il suo centro e il suo motore nel motivo delle “percezioni”. Da questo concetto, che diventa esperienza di scrittura, scaturiscono i versi che si concentrano in sensibilità visive, sonore, tattili.
La tripartizione del testo è esemplare: si parte dalla visione dell’orizzonte (al suolo), passando per pause di concentrazione (stati di attenzione), per arrivare alla descrizione di un movimento vertiginoso (in verticale). Il poema ha inizio quando “si apre la porta della/stanza...” con un preciso gesto in cui lo sguardo si volge sulle cose del mondo - i dintorni della stanza, della casa, dell’esterno artificiale e naturale - osservate con una lente mentale che l’andamento poetico rileva nei suoi aspetti dinamici. La parola è attentissima e non cede mai a forme, anche minime, di realismo ingenuo, perché Gigli dosa la scrittura con una precisione che gli permette di raggiungere il massimo grado significativo. La voce poetica è lo strato profondo della lingua da cui emerge un’immagine sfigurata, ma tanto più densa e persistente, che si lascia trasportare in modo lieve e si fa prendere da una necessità incisiva in cui basta poco: è sufficiente “solo un dito” a tracciare “righe sulla/polvere...”, e a far innalzare e sospendere questo polline significante che oltrepassa e compenetra sottilmente ogni codifica del senso, come in un “moto/del pulviscolo sospeso”.
Ed è proprio intorno a questi sciami, a queste nuvole impalpabili, nella parte centrale del testo, che il linguaggio prova a catturare, con l’uso del suo sguardo che determina da sé le prospettive, e dunque il suo proprio vedere, una conoscenza mobile che possa essere detta in un suono vibrato e sensibile, con la sua “voce, liquida dal/capo nella bocca”. Sono i segni di una fisicità che si prepara, si attiva per raggiungere una mobilità che non escluda nulla: il gesto, l’attrito, l’occhio ed ogni capacità sensoriale per incontrare e accogliere “la cosa” che sta fuori dalla concretezza pensante, ma che vorrebbe raggiungerla: “se chiara o liscia/o ruvida, averla/detta è tutto...”. C’è dunque una consapevolezza estremamente lucida, nella poesia di Gigli, di come il dire sia a fondamento della formazione del poema, e ciò che viene detto (nel caso specifico il tentativo di percepire, dare senso e ricostruire una visione nell’interiorità del canto) attraversa l’esistenza nella con l’attivazione di una forma di conoscenza del mondo che affiora e affonda “cadenzando con/cura l’impatto...” di ciò che si riesce o non si riesce ad afferrare.
Ma questo non è ancora abbastanza, perché all’esterno lo spazio è abitato nel volo. Appaiono uccelli: e il loro moto, troppo umano per essere fissato, procura vertigine. La scrittura, allora, prova a distendersi, cercando di seguire quelle evoluzioni, “la rincorsa sulla/corrente calda, la discesa/la lunga curva e la ripida/picchiata...” . Poi come in un fiume d’aria ciò che si vede va e viene, si ferma, ruota, si sposta in un movimento di passaggio che ha fine solo “nel tocco/quieto della luce.”
Da Stati di attenzione I
I, 6
la voce finalmente
sollevata dal carico
di un’ora nel semplice
ascoltarsi in crescita
o caduta, pochi residui
lasciati accantonare per
poi deporsi non lontano
un incavo la zona di
raccolta, in rapida
sequenza la sosta poi
la ripresa, ma non
avanza e cede, come
per sorreggersi sul filo
del riposo: è tutto
Da Stati di attenzione II
II, 6
dev’essere così, essere
stato un mai rappreso
ma dopo, dopo come
tornare, come da
qui ad allora lo
stesso tratto dice
calce del viso dove
dove pensata, come
dice: “guarda” è solo
questo, guarda ma è
proprio allora che si
spegne
II, 7
sarà breve il passaggio
appena oltre un tipo
d’indagine mai nota
un’allegria, il consenso
la corsa che non
cessa e ancora suoni
il moto che li volge
il nesso che ancora
lega il punto a cui
tornare
qui una
presenza ingannevole
così limpida l’assenza
Andrea Gigli è nato a Firenze nel 1956. Ha pubblicato Tavole fenotipiche, Cierre 2005. Suoi testi sono presenti nel Portfolio “i miosotis”, Edizioni d’if 2007, nel volume Poeticamente abita l’uomo, Moretti&Vitali 2008, in Registro di poesia n.1 e n. 2, Edizioni d’if 2008 e 2009.
Alfonso Lentini, da “Il morso delle cose”, con una nota di Giorgio Bonacini
Alfonso Lentini
Il morso delle cose
Muovere la parola: è questo il tentativo (e dobbiamo dire, riuscito) che Alfonso Lentini mette in opera in queste poesie. E lo fa collegando, in una struttura mobile, la scrittura di tutte e quattro le sezioni di cui il testo si compone. Ma è nella prima parte che troviamo una felicissima immagine che configura e riassume il senso di questa idea in un moto poetico: “e i sandali/scritti/di ghiaia”. La metafora è semplice, ma il processo di significazione che vi è condensato dà la misura giusta di un linguaggio che si prefigge di non rinunciare a ogni sua possibilità: per creare un mondo che si articoli e si misuri, attraverso i testi, con proprie specificità.
Ed è proprio la scrittura (come attività materiale e come sostanza conoscitiva del fare poesia) che, fin da subito, prende vita e dà vita con due parole fondamentali: “ti scrivo”. Questo semplice atto, che viene ripetuto più volte, non è solamente un richiamo a un destinatario femminile: da lì parte un vero e proprio concentrato lirico (sviluppato in profonde sonorità, ritmiche e significanti) che, con una grande felicità di trasfigurazione delle cose e ricchezza di forma nell’incontro con la parola, rende tutto il percorso essenziale e coerente con il movimentato fulcro che lo regge, lo anima e dalla cui sensibilità si sprigiona. Fulcro che emerge con l’immaginazione e la forza di chi è deciso ad aprirsi una via che parli, che indichi una direzione, o anche solo una traccia, “in questa massa/ di luce graffiata” che lentamente, ma vibratamente, “a voce bassa” l’autore esplora. Ma anche dove una certa staticità è resa esplicita nella visione fotografica, c’è sempre un movimento che origina, che sta dietro e affiora: nelle foto che Lentini dice, ma non descrive, attivando solo la nudità della scrittura, il viso e lo sguardo sono mossi, perché nulla è fermo ma tutto è “oscillante nel moto/perpetuo delle cose”.
Ma è nella seconda sezione, quella che dà il titolo alla raccolta, che la voce, andando verso un tu solo raffigurato in trasparenza, prende corpo e accentua la sua fisicità. Qui, con grande coerenza, la parola concretizza (con musicalità di assonanze interne e rime) la sua intenzionalità fonica: quasi un vocalizzo visivo che innerva e morde la lingua: la graffia, la soffia, la scioglie e ne allenta il morso sibilando in “fili/ e sillabe...”. C’è una necessità, di forme e sentimenti, in questo vibrare (e forse anche tremare) totalmente corporeo di pelle, bocca, caviglie, scapole, denti; c’è un bisogno di smuovere il senso della parola dalla sua natura fonica, alla sua materia ossea e carnale: in definitiva unificare voce e vita. Si scrive col corpo, e il poeta lo sa. Per questo Lentini ci porta, nella terza parte, in un viaggio reale in Marocco: non per raccontare, ma per scrivere il tragitto e il passaggio. E questo lo porterà alla fine, con un ritmo settenario battente, a sprofondare vorticosamente e visivamente, in un’esistenza segnata dal ritmo pronunciato dal senso del nome. Un nome che è nascosto, è universo, è ferito, è uccisione, ma è tutto ciò che unifica e rende indistinguibile la proliferazione dei sensi. E lì, nella molteplicità del soggetto che scrive (una cadenza di determinazioni che si autoproclamano: io sono... sono...sono...), ritroviamo la ragione, o se vogliamo la causa, di ogni poesia: “sono solo domanda”.
Da Laus creaturarum
1
il mio nome è nascosto
nelle ceste del pane
sono nero e impaziente
non ho braccia né lingua
ma lunghissime ciglia
la mia maglia è strappata
sono assente e respiro
miro al cuore e ai polmoni
ho calzoni d’acciaio
sono in cerca di un occhio
specchio spento e graffiato
sto chiedendo uno strappo
spacco vetri e sorrido
grido e lecco ferite
sono zebra che cerca
di parlare ai gabbiani
sono donna e montagna
vendo schiuma di mare
2
sono azzurro e inchiodato
il mio nome è valigia
sono il tasto sbagliato
che cancella la riga
vedo un lupo di ferro
mangio nuvole rosse
sono un carro di fuoco
gioco i numeri e aspetto
sono un gatto stregato
sono polvere d’ambra
sono zolfo ed allume
tocco un fiume e mi accosto
il mio nome è nascosto
nella cesta del pane
5
il mio nome è immigrato
il mio nome è ferita
è gheriglio di noce
permanenza, il mio nome
è cancello chiodato
tengo un capo del filo
l’altro è in mano a un soldato
sono senza ragioni
mi concedo al futuro
come un campo incendiato
sono azoto disperso
sono sabbia e paura
il mio nome è figura
il mio nome è universo
Alfonso Lentini è nato in Sicilia nel 1951 e dalla fine degli anni settanta vive a Belluno. Opera nel campo della scrittura, delle arti visive e della ricerca verbo-visuale. Fra i suoi libri: L’arrivo dello spirito, Perap 1991; La chiave dell’incanto, prefazione di Alessandro Fo, Pungitopo 1997; Mio minimo oceano di croci, Anterem 2000, finalista al IX Premio Lorenzo Montano; Piccolo inventario degli specchi, Stampa Alternativa 2003.
Andrea Rompianesi, da “Arcaismo a fronte”, con una nota di Giorgio Bonacini
Andrea Rompianesi
Arcaismo a fronte
La materia linguistica è la sostanza concreta di cui è fatta e su cui, nei più svariati modi, lavora la poesia, ed è da lì che scaturiscono i sensi che fanno della scrittura poetica una speciale “forma di conoscenza” che si dirama, con legami spesso inestricabili, in tantissime direzioni. Nei testi di Andrea Rompianesi, qui presentati, la direzione è eminentemente lessicale: ma ciò non significa esercizio di pura grammatica o semplice tecnicismo, ma un originale lavoro significante che porta in superficie, attraverso una specularità temporale, la contemporaneità poetica di passato e presente.
In “Arcaismo a fronte” le poesie si mostrano come davanti a una specchio deformante, che destruttura e ristruttura non solo la forma-scrittura, ma anche la significazione che la parola e il suo doppio (in un richiamo reciproco tra l’arcaico e il moderno) producono. Il passato linguistico affiora e si riversa nel presente in un costante andirivieni che sembra annullare ciò che è e ciò che era nella costruzione di ciò che la lingua fa. E “il fare”, che è costitutivo essenziale del poetico, arricchisce la sperimentazione di questo lavoro grazie alla scelta traduttiva all’interno del campo semantico dei termini. Prendiamo ad esempio la poesia VII, dove il testo arcaico dice: “Zinzinnando dimoiaticcio attarantolato/computrescere airolderando vacanteria”,viene reso (quindi tradotto) a fronte in lingua odierna così: “Centellinando terreno morsicato/imputridire negando vanità”. Ma se andiamo a vedere i significati delle parole arcaiche, leggiamo che “zinzinnare” deriva da “zinzino” che significa anche “pezzetto, piccola porzione”; che “dimoiaticcio” è “il terreno reso molle da neve o ghiaccio sciolto” e che “attarantolato” è più precisamente “morso dalla tarantola”. Ecco allora che Rompianesi, nella sua versione, ha operato come un traduttore (di se stesso) nel rendere le parole dalla lingua di ieri a quella di oggi e viceversa. Ma lo ha fatto da poeta: con la consapevolezza, cioè, che le potenzialità di significazione messe in atto dentro la lingua poetica non sono riconducibili né riducibili a una semplice trasposizione. Il pensiero di chi scrive si intreccia con la mente di chi legge (che può essere anche lo stesso poeta) creando una polifonia che rimanda costantemente il senso a se stesso e ad altro.
In questi testi verifichiamo veramente come, in poesia, il significante veicoli nel suono non solo dei significati, ma una vera e propria nascita contemporanea e indistinguibile di senso vocale e scritto. Ciò vuol dire che l’audacia sperimentale del nostro autore fa sì che la scrittura sia intimamente sonorizzata dalla doppia valenza delle parole, che manifestano con forza questa musicalità (“Inlucere d’ancude condicevole lasso” - “Risplendere d’incudine s’addice stanco”), dove la vocalità e la consonanza trasmigrano da una parte all’altra creando stupore. E dove c’è stupore c’è un continuo riavvolgimento di sensi che provano a districarsi, ma di nuovo si riagganciano, anche in operazioni apparentemente tecniche che diventano, invece, tentativi di avvicinare le energie di un pensiero con le innumerevoli sfaccettature della poesia.
Testi poetici
|
VIII |
VIII |
|
Rarificativa scherna fontale |
Divenuto rado l’inganno d’origine |
|
impedica allotta invenia |
distoglie allora il perdono |
|
sonevole e allenia cumpater |
risonante e lenisce complice |
|
rusponi elucidati vadati |
ricchezze dichiarate passate |
|
lenendo esterminevole costinci |
placando da luogo distruggitore |
|
XI |
XI |
|
Abigeato bolso insembre convoia |
Furto fiacco insieme trascina |
|
tegumento d’acedia sine rinceffata |
tessuto di malinconia sì rinfacciata |
|
addire l’inguala o crazia dannevole |
dedicare la voce o moneta nociva |
|
s’intuasse aguale midolluto inzillo |
entrasse adesso recondito sguardo |
|
festinato flussile finanche flavente |
affrettato fluido perfino dorato |
|
eulogia nodrice costì amamelide |
pane santo alimenta qui con i meli |
|
XXI |
XXI |
|
Luberna in essiglio agunando |
Pelle in esilio adunando |
|
linci cum ontanza ontosa |
di lì con vergogna ingiuriosa |
|
allenendo obrizza ombrosia |
mitigando pura dubbiezza |
|
acrigna discioltura insemitarsi |
acre sveltezza avviarsi |
Andrea Rompianesi è nato nel 1963 a Modena. Formatosi all’Università di Bologna, nel 1998 ha fondato Scrittura Creativa Edizioni. La sua produzione poetica, iniziata nel 1979, ha ottenuto numerosi riscontri dalla critica. Ha pubblicato, in poesia: Orione, 1986; Vascello da Occidente, 1992; Punti cardinali, 1993; Scendevi lungo la strada, 1994; Momenti minimi, 1994, 1999; Apparenze in siti di trame, 1996; La quercia alta del buon consiglio, 1999; Ratio, 2001; Versi civili, 2003; Metrò: Madeleine, 2004; Rimbaud Larme, 2007.
Ciro Vitiello, da “Finitezza delle cose o rose”, con una nota di Giorgio Bonacini
Ciro Vitiello
FINITEZZA DELLE COSE O ROSE
Possiamo subito osservare, iniziando dal titolo di questo poema, che se sono veri il senso e la percezione di “finitezza delle cose” a questi corrisponde però l’esplosione di un linguaggio che, frantumandosi, genera una parola poetica dalle diramazioni indefinite, inafferrabili nella loro totalità. Vitiello concentra la sua attenzione e la sua scrittura nell’urgenza di una voce che è lingua e suono dei sensi e dell’eros. Ma non si confonda questa poesia con ciò che comunemente si definisce “poesia d’amore o erotica”: nel nostro caso, dal centro discorsivo e propulsivo della relazione a due, dove le figure io e tu costruiscono la loro storia di passioni fisiche e mentali, si irradiano diversi percorsi significativi, con la lucidità, la passione e la coscienza di uno scavo interiore, al fondo delle tante implicazioni di chi sa cosa vuol dire stare nella poesia.
Infatti, nei testi che compongono il poema (che vedono al loro interno anche una storia e un sentimento del dire), si individuano alcune linee che concentrano la poetica in percorsi di pensiero tesi a raccogliere richiami di ogni genere - storici, sociali, politici, filosofici, quotidiani -, ma con una particolare attenzioni a quelli fondamentali e fondanti in poesia: Leopardi, innanzi tutto, richiamato implicitamente nel senso di dolore che attraversa l’adolescenza, dove “gli anni/sono/assemblati in voragini”; oppure nel più esplicito, anche se diversamente formulato, verso iniziale di una poesia in cui il malessere di vivere esplode e le illusioni fiaccano la ragione fino a svuotarla, mentre “chiaro e calmo è il mattino...”. Un’immagine che avvia però a un’oscurità, dove il corpo e la mente barcollano nella consapevolezza che qualcosa di indicibile c’è. Ma nonostante l’impossibilità di dire tutto e la percezione di aver perso l’inizio delle cose avviate dal tempo, il poema continua: si gonfia e scoppia in frantumi vitali.
Dalla pura e carnale “pinguedine folle, laida e sensuale”, la spinta della meditazione poetica raggiunge le vette di una scrittura che imprime una torsione alle forme istitutive dell’amore, legandosi, ad esempio, a sogni di ricordi politici: ad assalti e barricate, a vora- gini borghesi e inferni operai. Ma anche a riflessioni che affondano nell’oscurità e nella conoscenza che si dà in poesia: dal buio che “è il nulla delle forme” fino alla vetta del “pen- siero che crea paesaggi” e “recide l’esistente”. E questo percorso si attua con una naturalezza ta- le da far ricadere una trasfigurazione intellettuale (o ciò che appare come tale) nella sua realtà d’amore (possederti,/suggerti l’anima...), legandola, nello stesso tempo, ai primordi di una nascita nel mondo (cerco la tua prima/impronta, Natura...).
Si comprende, allora, che non manca niente di vitale ed esistenziale in questa poesia: la materia linguistica e la voce danno sostanza a una parola che ha origine, andamento e fine nell’interiorità del poema. Ma il percorso si snoda e va a cogliere altri aspetti che si parlano e si compenetrano. Facendo crescere la multiformità dei versi o deviando i toni verso una leggerezza più lirica, il corpo da amare, toccare, radicare e sradicare sembra svelare la sua natura “nello scintillio della pioggia”, dove anche l’ignoto è vita. Perché alla fi- ne, con la forza e la sapienza dell’immagine, il battito rallenta e lì dove “galleggiano i paesag- gi” lo sguardo punta a una visione più leggera.
I, fr. 8
...dell’adolescenza gli anni/ sono
assemblati in voragini...aumenta la sete/
di stagione in stagione è mondano godimento/
la radice dei sensi/ domina l’irta libido – sopra i tetti grigi
è assenza di passeri...un trastullo terminato appena ieri/
è già evo lontano. Nella pianura/ all’ombra della città/
carcasse d’auto sono totem di feroce sentenza/ metastasi...
|le idee non fluiscono più, non vale parlare dell’anima...
giacere è gaudente transito per chi
ha perso la moneta...non giova la
menzogna...tu sei acqua di fonte...
II, fr. 7
...io ho mangiato dell’albero e sono nudo del tempo
e delle malevole bufere/ per immagini scomposte il freddo
è l’alito della morte ancipite (non ho avvistato il fine)...
(adesso tutto è misurabile/ e inesorabilmente sospinto-
le vie si dissociano e fangose aggravano lo spirito- le vite
nostre di viandanti si giocano/ tra luce e ombra/ sulla fessura
(io a) una tavola seduto consumo l’ultimo pasto
prima di riprendere il cammino...
tutto è un momento
Ciro Vitiello, poeta e critico, vive a S. Sebastiano al Vesuvio. E’ stato redattore di Altri termini e ha diretto la rivista di letteratura Oltranza. Dirige presso l’editore Tullio Pironti la Biblioteca della poesia italiana contemporanea. Ha pubblicato, in poesia: Corpor.azioni, 1975; Ciclica, 1979; Apocalipse quattro, 1980; Cantico d’Erugo, 1980; Le resistenze, 1983; Suite, 1984; Accensioni, 1991; Rapimenti, 1992; Il gioco degli errori, 1994; Quisquis o delle solitudini, 1996; Origini d’amore, 2001; Il male sorgivo, 2001; La tenue armonia, 2003; Lunedì perduto, 2008. Per la critica: Teoria e analisi del linguaggio poetico, 1984; Teoria e tecnica dell’avanguardia, 1984; Idetica, 2002; Pensare la poesia, 2005.
Federico Condello, da “Altro e corone”, con una nota di Giorgio Bonacini
Federico Condello
Altro e corone
Due soggetti (o fantasma di soggetti), maschio e femmina, alternano in modo apparentemente disarmonico, ma in realtà ricco di sfumature e attentamente misurato nei ritmi, un dialogo che ingloba in sé una vasta gamma di registri linguistici e di forme in cui la poesia si incarna e si manifesta. Nei testi di Federico Condello la scrittura che dà spazio alle voci è sviluppata sia in forme, personalizzate, già fissate dalla tradizione (sonetti, madrigali), sia in forma teatrale, dove la drammaturgia è, però, scarnificata all’osso dei parlanti: presenti ma trasparenti. Ma anche la forma tradizionale è resa con precise articolazioni mobili: ogni poesia, infatti, termina con un enjambement che la lega direttamente alla poesia seguente. E non è una semplice rielaborazione di un espediente tecnico-retorico, ma una fondamentale modalità di produzione del senso, e necessaria per il suo andamento in profondità.
Il movimento poetico impresso in questo testo, che è un poemetto spezzato, è serpentiforme, a cerchi concentrici, passa da una precisazione iniziale a uno sviluppo polidirezionale dove la parola è “una lettera/perfetta come pietra: ora ch’è aperta//sfuma: traspare...”. Ma nonostante questa evanescenza di significazione, l’autore nel dare continuità e dialogo (benché solo indicato, quasi nebbioso, mai personificato con precisione) al percorso dall’Io al Tu, sa che “ogni segno che dici è il segno esatto”: dove l’esattezza e la precisione non si
situano solo nelle parole in superficie che qui leggiamo, ma, con una risonanza e una tensione ben più importanti, nel groviglio vitale delle voci che scendono e salgono.
La ricchezza linguistica di quest’opera segna con grande effetto - emotivo per il poeta ed emozionale per il lettore - lo spezzettarsi, la frantumazione di un discorso interiore, anche visivamente concepito, in una profonda solitudine. C’è quasi una sospensione fisica (come di un corpo mentale sognante) nelle figure che partecipano a questa scrittura, che, pur avvolta in una realtà materiale ben conosciuta, sembra frutto di ricordi in ombra, di allucinazioni che trascendono il luogo e il tempo in cui vivono. E qui, in questo mondo a parte, ma ben reale e vivo, si alternano immagini, gesti, passioni, tristezze.
Così, l’evocazione teatrale che interrompe il fluire dei sonetti, non è solo una pausa di respiro, ma un aggancio percettivo: la scrittura si scioglie e ciò che era “pietra piena, e certa: e creta//nera...” diventa “seriamente, silenzio”. Ma c’è in questo “seriamente” un’apertura inaspettata verso un percorso che si chiude all’ascolto, scivolando in un vuoto senza drammaticità, quasi disinteressato, dove chi parla non ha più parola e chi dovrebbe ascoltare è in distrazione: “dico a te...mi senti?...ehi... dico a te...ma mi senti?...ehi...ehi...”. Ecco, nel chiudere il testo Condello misura veramente la forza e l’efficacia di un isolamento linguistico che, mentre incontra il respiro della poesia, si accorge della sua distanza dal mondo ordinario. Per questo ciò che crea è una reale esperienza immaginativa (forse illusoria, fatta di voci incorporee, indecise, nata da memorie senza contorni, ma senza falsità) legata a un mondo interiore di illimitata accoglienza e con una coscienza proiettata al di fuori, dove nessuno con certezza può sapere “se durerà così perfetto il/miraggio”.
Da Prima corona
1
gioca rose, conviene, se di questa
cenere rovistata a dita nude (e
di questa brace ruvida che resta a
dire: a finire: incerta: viva: a elude-
re ogni altra luce viva): se di questa
cenere, adesso, o brace (o bocca: o pudet
dicere: o dire brucia): (o segno: o testa-
mento), una spira almeno si conclude
qui, adesso, e ti dà nodo (tu: finita
così: cenere e brace e bocca: a rete
conclusa): (adesso, qui: dire, ripetere
tre volte): (e ancora sporgere le dita al
fuoco): (ma non ti ho detto della cera-
lacca spaccata: della busta nera):
5
gelare come vetro: come creta): a
dire: a finire: ancora (adesso tenta
la traccia: il nodo vero): e tutto aspetta
pioggia: vento che batte, ombra più densa,
cielo che mette grumi, che s’invetria,
aria che sa di cera appena spenta: (e
pausa: pausa che dura): (era una lettera
perfetta come pietra: ora ch’è aperta
sfuma: traspare): e tu, distratta a un altro
segno di sole opaco (nono: o decimo:
“rubare”): importa poco: se qui intrecci
voce: se fermi il nodo): (oro, cobalto e
ruggine): se qui il fuoco ti trattiene
cenere sulla soglia della cenere:
Da Quarta corona
5
di tutto il filo, un capo fra le dita: (e
un nome sillabato a labbra nude,
chiaro come un richiamo): “ecco, si chiude
l’acqua: la terra è certa: ecco, è finita
l’acqua: ora l’acqua è terra”: (acqua o palude
livida): (“visto, il segno: e l’ombra: vista
tutta: fino alla luce: e viste grida e
carte: carte a castello: e viste tutte
le linee, sulla mano: e visti gli occhi:
visti, e bruciati: dimmi, non hai altro?
dimmi, non hai altri simboli, altri giochi
che io possa frantumare?”): (sì, ricordo:
parlava: di profilo: mormorando:
morta per luce: morta: mi ricordo):
Federico Condello è nato a Verona nel 1973 e risiede a Bologna. Ricercatore universitario in filologia classica, è docente di grammatica greca. Fra le sue pubblicazioni di ambito poetico, due brevi sillogi in antologia: Sibili e nodi in “Quinto quaderno italiano di poesia contemporanea”, Crocetti 1996; Nodi, in “Sette poeti del Premio Montale”, Scheiwiller 1999. Inoltre, singole pubblicazioni in rivista, fra cui Anterem, Semicerchio, L’immaginazione, Atelier.
Gennaio 2010, anno VII, numero 11
Carte nel Vento
on-line della Biennale Anterem di Poesia
e del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
“Carte nel Vento 11” accoglie e documenta alcune recenti esperienze del Premio Lorenzo Montano e della Biennale Anterem di poesia.
Questo numero propone momenti teorici legati alla letteratura in rete, saggi, commenti, recensioni, immagini, esempi di ricerca poetica contemporanea.
La scelta dei poeti presenti deriva da testi pervenuti al “Montano”, effettuata con la volontà di offrire varie prospettive, differenti esiti espressivi: in alcune delle opere qui presentate è prevalente il pensiero che le sottende, in altre è prioritaria la forma, colta soprattutto nel passaggio in cui diventa essa stessa sostanza.
Il lavoro del Premio prosegue, come sempre, oltre la designazione dei vincitori. Quello che vive intorno al “Montano” è una continua riflessione sulle potenzialità e sui destini della poesia.
Da quest’anno, cercheremo ancora più lontano: infatti, la grande novità legata alla 24^ edizione, di cui è possibile scaricare il bando, è l’apertura anche alla prosa e alla saggistica.
Scarica il bando [pdf 225KB]
Scarica il bando [rtf 560KB]
Immagine di Giancarla Frare, Todesfuge-Celan 3

Poesia e internet 5 / Sebastiano Aglieco incontra Francesco Marotta
Estromessa dalla carta stampata quotidiana e periodica, la poesia èentrata significativamente nel mondo di internet, con un fiorire di iniziative che fanno capo a siti, blog, riviste on -line, aggregatori. Tutto questo, se da un lato testimonia la sua vitalità, al passo con le nuove tecnologie e con i tempi, dall’altro pone esigenze di comprensione e studio del fenomeno.
Per capirne potenzialità e limiti, per offrire nello stesso tempo una chiave di lettura e una mappa, un’istantanea della situazione, dal numero 6 “Carte nel Vento” opera una sorta di ricognizione in rete, attraverso i principali operatori della poesia nel web.
Nei numeri precedenti:
Vincenzo Della Mea, Un colpo d’occhio sulla rete della poesia
Christian Sinicco, Qual è il centro? Internet, tra passato e futuro
Luigi Nacci, La grande proletaria dei poetinternauti s’è mossa, o no?
Marco Giovenale, “I vicini (quasi non) ci guardano”
Massimo Orgiazzi, “Poesia e web: esperienza diretta, riflessione e punti chiave per un’evoluzione futura”
Nabanassar, Della Rete o del Dilettante
Antonella Pizzo (Viadellebelledonne), Fino a qualche anno fa
Sebastiano Aglieco interroga Francesco Marotta: L’assoluta gratuità dell’atto
1. Nel lavoro di diffusione della poesia che stai facendo in Rete, mi sembra ci sia una specificità – o un’anomalia, dipende dai punti di vista. E cioè l’essere al di sopra del gusto, delle preferenze e delle somiglianze con la propria scrittura. Puoi confermare questa mia impressione?
Credo che la tua impressione sia giusta e che (specificità o anomalia, poco importa) dia la misura esatta di quello che è il mio intendimento di fondo: testimoniare (nei limiti delle mie possibilità, anche di gestione temporale dello spazio virtuale) la diversità di percorsi di scrittura oggi esistenti, siano essi allo stato nascente oppure il frutto di un lavoro già ampiamente consolidato e riconosciuto. Sono da sempre convinto, almeno da quando ho iniziato a scrivere testi in modo consapevole, che la poesia sia un corpo plurale la cui esistenza è definibile unicamente entro un orizzonte di sensi possibili, mai dati, sempre in fieri, praticamente inafferrabili, di intrinseca, sostanziale natura metamorfica; e che la formalizzazione, nei limiti e nelle strutture dell’opera compiuta, della materia poematica che si cerca di padroneggiare in quel corpo a corpo carnale, feroce, che è l’incontro con la pagina bianca, rappresenti non l’approdo, come avviene in tante scritture anche di buon livello, ma statiche, quanto l’inizio di un ulteriore segmento di percorso: un cammino che, per quel che mi riguarda, vedo refrattario a ogni quiete, ad ogni contemplazione più o meno autocompiaciuta del prodotto finito. La maniera – in definitiva: la morte della poesia – è l’istanza narcisizzante che stempera e ipostatizza (con la conseguente resa al calligrafismo – malattia senile anche di tanti giovani poeti) non solo il proprio profilo in uno sguardo pietrificato che abbaglia e illude unicamente se stessi, ma anche la stessa acqua nella quale ci si specchia: spogliata della sua tensione all’oltranza, svuotata della sua natura erratica, e ridotta a una confortevole dimora senza finestre, a simulacro vuoto dei paesaggi che non traverseremo.
Andare in cerca di ciò che ci somiglia, per farlo nostro e riconoscervi, con compiacimento, l’eco dei nostri passi o la misura delle nostre orme, sarebbe un esercizio ancora più inutile e vuoto del precedente, significherebbe nient’altro che aver sottratto all’acqua la forma dell’andare, cioè la sua ragione primaria di esistenza. Guidare la propria corrente (o lasciarsene guidare) ad osservare, magari, lo stesso paesaggio da altre rive, o fermarsi ad ascoltare, da sponde mai toccate, il suono increato della nostra stessa fonte: ecco, è questo che mi interessa, è in questo ascolto risonante che mi piace vagare, misurandomi con quanto in me cambia, nel silenzio che una parola altra mi porge liberamente, come un dono, come un’eredità, come un lascito che si fa legame.
A una ricerca dell’alterità così orientata, mi piace affiancare la (ri)proposizione di testi a loro modo esemplari, per dire (ma credo non siano in tanti ad ascoltare) che noi non inventiamo niente, che solo il confronto con una tradizione (passata o più recente) che ci vive, e che ci chiede, dimorandoci, unicamente di essere attraversata, può permetterci di fare qualcosa di diverso dal semplice imbrattare fogli e andare a capo, mentre scriviamo, prima della fine del rigo.
2. Questo atteggiamento di vasta portata e visione, in che modo può venire incontro al dibattito di questi anni sul senso del fare poesia oggi?
Credo che un vero dibattito sul senso del fare poesia oggi non sia mai veramente partito, dopo la cesura segnata dal rifluire e dissolversi di alcune esperienze, teoriche e di scrittura, alla fine degli anni Ottanta. Ma, sia chiaro: dicendo ciò, nulla voglio togliere a quelle poche esperienze significative (le conto sulle dita di una sola mano, e, allentando un po’ la presa e allargando il ventaglio, al massimo di due), individuali, in buona parte, o legate alle poche riviste di valore che resistono, che nel silenzio e nell’ombra portano avanti ancora adesso precise istanze di ricerca e di studio. E forse è proprio da lì che bisognerebbe ripartire, per rifondare, insieme al dibattito, gli statuti e gli strumenti di una critica a misura della costellazione di organismi plurali di cui dicevo. Su questa mappa possibile, io cerco di lasciare un piccolo segno, un indizio minimo: che non esprime giudizi, criteri di valore, né azzarda canonizzazioni, rotte, incroci, appartenenze: soltanto, attesta esistenze. Resta inteso che, per me, nessuna ricognizione sarà mai in grado di dare conto di qualcosa di veramente utile e duraturo, fino a quando non sarà ridefinito, a trecentosessanta gradi, l’orizzonte della poesia italiana degli ultimi trenta/quaranta anni; fino a quando non sarà data piena visibilità a tutte quelle scritture e quelle esperienze che hanno segnato un solco profondissimo nella prassi di due generazioni, a dispetto del riconoscimento ufficiale, delle antologizzazioni, delle consacrazioni accademiche. E’ un lavoro enorme, forse impossibile in questo momento storico caratterizzato dal profluvio di frammentati esibizionismi, in rete e su carta, ma è un lavoro da fare. Assolutamente.
3. Esiste, a tuo avviso, una relazione tra un’intensificazione del fare poesia e la facilità di fruizione dei mezzi di comunicazione (internet, soprattutto)?
Sì, esiste sicuramente, ed anche abbastanza forte, ma non credo che la relazione sia indice di un accresciuto valore delle produzioni, non solo poetiche. Internet, in modo particolare, sta sicuramente avendo un ruolo fondamentale nella diffusione della poesia, nella scoperta di importanti esperienze, di percorsi che altrimenti sarebbero rimasti pressoché sconosciuti e inaccessibili; sta dando visibilità a tanti autori di valore, permettendo, nel contempo, le prime ricognizioni critiche ad ampio raggio all’interno di un panorama che diventa di giorno in giorno sempre più esteso e articolato e, per ciò stesso, più confuso; ma c’è anche il rovescio della medaglia, ed è un risvolto che, lasciato alle logiche di una indiscriminata proliferazione dell’offerta, senza nessun argine critico, finisce per inficiare, fino a sterilizzarli, i tanti aspetti positivi di cui si può dar conto, non ultimo quello della possibilità di reperire facilmente testi altrimenti inavvicinabili. Il rischio è quello di un dilettantismo diffuso che tende a farsi sistema, la mancanza di rigore, la convinzione, che vedo ingenerarsi in tanti, purtroppo, che basta aver pubblicato qualcosa in rete o una plaquette di dieci testi per essere poeta, l’abbandono ogni ipotesi di studio, di ogni necessità e urgenza di conoscenza, di confronto, di apertura alla pluralità dei percorsi, l’ignoranza di ciò che si muove, da anni, nel panorama internazionale, il plagio più o meno diffuso, vista la quantità di materiali di cui chiunque può entrare in possesso. E questo è deprimente; così come risulta oltremodo sconfortante, in alcuni contesti o occasioni di dialogo, vedere con quanta facilità passino, quasi come un vanto e un segno distintivo, la presunzione della propria unicità, che non esiste, da una parte, e il disconoscimento del valore di alcuni autori e di alcune opere.
Sebastiano Aglieco cura il blog “Compitu re vivi” http://miolive.wordpress.com/
Francesco Marotta cura il blog “La dimora del tempo sospeso” http://rebstein.wordpress.com/
Ultima pagina, sulle immagini di Giancarla Frare che illustrano il numero: una nota dell’autrice
Giancarla Frare, Sulle immagini di questo numero
Todesfuge è un'opera realizzata per MURO CONTRO MURO, evento monstre a cura dell'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma.
Spazi museali e gallerie private hanno celebrato la caduta del muro di Berlino. In molte maniere, anche parlando dei "Muri" della Storia e del presente.
Lo Studio S, storica galleria di Roma, ne ha fatto una mostra sulla Shoah. Gli artisti invitati hanno scelto una foto d'archivio. Il gallerista ha stampato la foto su una tela, al centro della stessa. La tela e' stata messa su un supporto con chiodi agli angoli. Ogni opera aveva dunque un'identica dimensione.
Ho scelto d'inserire i poveri resti fotografati in una livida stanza, come visti dall'alto, scoperti in una fossa, aprendo una botola. La tela e' fissata con grandi viti al supporto ligneo che e' stato dipinto mimando una cornice di legno.
Non e' un caso che io abbia preferito le viti a dei chiodi. Ho evitato ogni elemento che dicesse di una violenza in atto. Allo stesso modo ho volutamente raffreddato la tavolozza cromatica (parchi colori, realizzati con pigmenti naturali e inchiostri) a dire di una consunzione ancora precedente alla morte.
Realizzata l'immagine, io stessa ho avuto bisogno di coprirla. Ho usato un vecchio lino militare degli anni '30, che porta ancora i timbri dell'epoca, e vi ho stampato in serigrafia e col carattere courier delle macchine da scrivere, i celebri versi di Todesfuge di Paul Celan, nella traduzione di Giuseppe Bevilacqua.
L'osservatore arriva all'immagine solo sollevando il lino e la scritta. Paul Celan è il testimone. La testimonianza diventa la mediazione fondamentale perchè la memoria stessa rimanga intatta. E molti testimoni sono ormai scomparsi.
Sollevare il lino è retrocedere nel tempo e riattualizzarlo.
Ho volutamente rimosso l'iconografia consueta della Shoah, Fili spinati, sangue, pigiami a righe...la parola "indicibile"...
TODESFUGE, Cm 100 X 80, anno 2009
tecnica mista:
Pigmenti naturali su tela
Serigrafia su lino (tela militare)
Biobibliografia di Giancarla Frare
Di origine veneziana, Giancarla Frare si e' formata alle Accademie di Napoli (diploma 1972), Urbino e Venezia. Ha vinto, nel 1981, la Borsa di Studio del Museo d'Arte Moderna di Ca' Pesaro a Venezia. Ha esposto in oltre 200 mostre individuali e di gruppo in Italia, Europa, America, Medio Oriente.Tra le mostre personali più significative: 1975 Museo Arengario di Monza,1983 Museo di Ca' Pesaro Venezia,1987 Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia,1990 Musei Civici di Como, S.Francesco (mostra antologica a cura di Enrico Crispolti),1997 Galleria Civica di Palazzo Crepadona Belluno (mostra antologica a cura di Flaminio Gualdoni), 2002 Galleria Giulia Roma, 2005 Palazzo dei Capitani Ascoli Piceno, 2005 Istituto Austriaco di Cultura Roma, 2005 Sala d'Aspetto Reale Monza, 2006 Galerie im Traklhaus Salzburg, Istituto Italiano di Cultura Vienna, Leopold Franzens Universität Innsbruck, 2007 Kro Art Gallery Vienna, 2008 Palazzo Crepadona, Cubo di Mario Botta, Belluno, 2009 Palazzo dell'Abbondanza Massa Marittima...
Tra le mostre collettive più significative: dal 1979 al 1987 Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia,1983 Museo M.I.S. S.Paolo del Brasile, 1983 Museo di Ca' Pesaro Venezia, 1984 Moderna Galerjia Lubiana, 1987 Fondazione della Biennale di S.Paolo del Brasile, 1989 Galleria Civica di Idrija,1989 West Room Gallery New York,1994 Biennale Internazionale di S.Paolo del Brasile,1995 Istituto Italiano di Cultura del Cairo, 1995 e 1997 Biennali Internazionali di Lubiana, 1996 Museo Barracco Roma,1997 Galleria d'Arte Moderna Roma, 1997 Modern Art Museum Portland USA, 1997 Museo Nazionale di Haifa, 1997 Istituto Nazionale per la Grafica Roma, 1999 Palazzo delle Esposizioni Roma, 2000 Triennale d'Arte Celano, 2000 e 2003 Triennali Internazionali del Cairo, 2000 Museo di Arte Contemporanea Luigi Pecci Prato, 2001/2002 Musei di Arte Contemporanea di Tunisi, Rabat, il Cairo, 2002 Museo da Agua Lisbona, 2003 Istituto Nazionale per la Grafica Roma, 2004 The Niavaran Foundation Teheran, 2007 Museo di Arte Contemporanea Erice, 2007 Kro Art Gallery Vienna, Miart Milano, KunstArt Bozen, International Art Fair Zurich, Arte Moderna e Contemporanea Roma, 2008 Biennale Internazionale Musei Civici di Bassano del Grappa (1° Premio), 2009 Fondazione Umberto Mastroianni Arpino, 2009 Istituto Italiano di Cultura New Delhi..
La sua attivita' letteraria inizia con "Rasoterra" opera segnalata , nel 1994, al II° Premio Letterario Nazionale "Nuove Scrittrici" , con la motivazione:
" Sintesi dell'espressione e forza icastica sono il segreto della poesia di Giancarla Frare, che si manifesta con una sintassi scarna, quasi assente, per evidenziare la ricerca linguistica..." " Rasoterra" è segnalata, nel 1995, al Premio Internazionale "Eugenio Montale".
" Rasoterra" è pubblicata dalle Edizioni Tracce nel 1996.
Vince nel 2006 la XIII Edizione del Premio Letterario Nazionale " Scrivere Donna" con il libro " Come Confine Certo". Il testo e' pubblicato nel 2007 dalle Edizioni Tracce e segnalato nella XXII Edizione del Premio Lorenzo Montano.
Le opere di Giancarla Frare sono presenti nelle collezioni permanenti di Musei e Fondazioni in Europa e America. Tra le più significative: Graphische Sammlung Albertina Vienna, Museo del Castello Sforzesco Milano, Museo per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci Prato, Istituto Nazionale per La Grafica Roma, Museo d'Arte Moderna di Ca' Pesaro Venezia, Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia, Portland Art Museum USA, Museo di Arte Contemporanea Erice, Musei Civici Bassano del Grappa...
Dalla III Biennale Anterem, filosofia del web e poesia in rete: Lorenzo Barani, Stefano Guglielmin
Riportiamo due relazioni legate alla letteratura in rete, argomento che ha caratterizzato una delle giornate della recente Biennale Anterem.
Lorenzo Barani, Filosofia del web
«CHE COSA CI DICE, CHE COSA DICE “NOI”, E CHE COSA SI DICE DI NOI…»
(una nota di Lorenzo Barani sulle tracce di Jean-Luc Nancy e Jacques Derrida)
Mi è consentito, e ringrazio Flavio Ermini, un fulmineo tempo di pensiero ad alta voce.
Taccio, dunque, ora del rapporto tra Web e Voce, titolo esigente che avrei desiderato suggerire e che tengo nel cassetto. L’Web, sotto l’apparente illimitato vociare, è l’implacabile oltrepassamento della Voce. La voce, come il suono, è corpo e si porta dietro le tenebre e il pesante e perciò, in virtù della sua ricchezza e delle sue segretezze, è più lenta della luce; da sempre, infatti, la voce anela alla luce e alla verità che sta nella luce. L’Web, sotto l’apparente illimitato vociare, è l’implacabile vittoria del veloce sulla stessa luce, dunque sulla verità che la luce parametra.
Taccio pure del titolo L’Web e la nuda vita che tengo accanto all’altro per la loro reciproca compagnia, temi che proverò a trattare nel Seminario di Filosofia per il Comune di Modena nel gennaio-marzo 2010.
Ho preferito tentare di comprendere una frase di Jean-Luc Nancy, «che cosa ci dice, che cosa dice “noi”, e che cosa si dice di noi…»; solo un incipit, beninteso, che tenta un approccio dall’interno dell’interrogazione a cui la filosofia è nuovamente costretta a questionare se stessa, disarcionata, così come si ritrova, dal Web. Certo, anche un semplice incipit si ritroverebbe nel garbuglio di impossibili scelte non volendosi ridurre a una mera elencazione delle molteplici quaestiones.
Vado dunque in leggerezza e pennello a guisa di semplice acquarello mentale, qualche rapida velatura, che, spero, lasci trasparire i solchi e gli arativi mentali che l’Web sta scavando nei logoi, nella voce, nella nuda vita, nella lingua e nella poiesis in generale. Della lingua voglio toccare il destino cui va incontro nel Web il pronome personale «noi».
I pronomi personali nella mondialità automediatizzata
Da tempo Jean-Luc-Nancy s’interroga sul destino del nostro mondo che si va globalizzando, sulle prospettive della nostra società e sulla relazione dell’essere singolare-plurale. L’attenzione filosofica all’uso sempre più problematico dei pronomi personali è da considerare un sintomo del tutto inquietante. Nella mondialità automediatizzata, è il caso di domandarsi se il soggetto io di «io sono divenuto questione a me stesso» (quaestio mihi factus sum, Agostino), abbia o no ancora qualcosa in comune con l’io che entra nel Web; se la relazione io-tu del linguaggio tradizionale ha ancora qualche riferimento con l’io-tu che viaggia in Rete. In-Rete tutti sono io per tutti e, all’unisono, tutti sono tu per tutti.
Questo unisono non va sottovalutato, perché è proprio la cosa da pensare. Nella virtualità elettronica dell’unisono, la contemporaneità del contemporaneo è in sé un’atemporalità del tutto indifferente al tempo, ed è in sé una aspazialità del tutto indifferente alla locazione. Nell’unisono della mondialità automediatizzata del Web, l’onnicompresenza di tutto e del suo opposto è tale da non rimarcare più nessun rilievo, da non salvare in sé, qua talis, nessuna differenza, neppure la differenza io-tu. In questo punto virtuale tutti gli io e tutti i tu sono compresenti con i loro logoi e i loro contra-logoi.
L’’unisono pensato nella potenza illimite della tecnologia precede e sovrasta senza confine la problematica stessa dell’unificazione delle lingue, processo che, peraltro, di per sé, ha già corso avanzato in direzione di una perdita stordente delle differenze. Nella babele dell’unificazione delle lingue, il problema della tra-duzione/tra-dizione delle lingue è dei più urgenti e complessi della Filosofia, e non lo si potrà più pensare a prescindere dal problema della lingua-Web, che non costituisce né una semplice metafora né una pura metonimia del linguaggio.
Prendiamo i pronomi personali come parte sintomatica per il tutto e chiediamoci: che ne è del destino dei pronomi personali, innanzitutto, dunque dell’identità e delle differenze, del sé e dell’altro, a partire dall’interno stesso del Web, ammesso che supporre una interiorità-Web non sia proprio quell’ingenuo e sviante antropomorfismo che va del tutto messo in lente. Eppure Agostino – ormai evocato ce lo ritroviamo innanzi – dopo aver scandagliato invano la propria interiorità alla ricerca di una verità incontrovertibile e stabile, non trova che impermanenza e transitorietà, e nonostante abbia passato in rassegna tutte le maggiori scuole di pensiero dell’antichità, dunque tutto lo scibile disponibile (già, che noi oggi diremmo in Rete). Solo a partire dall’altro, a questo punto con la A maiuscola, può rinominare propriamente, cioè secondo i giusti limiti, l’io, il tu, il noi. Questa avventura che va dall’io al noi passando per il tu (agostinianamente con la T maiuscola), ci porta nel cuore della questione dei pronomi personali. Ebbene, questa logica va radicalmente abbandonata se si vuole prendere sul serio il problema, il cui nocciolo è che la Rete ci precede, ci parla, ci dice, ci narra, ci interroga ben più radicalmente e ci interpella aprioristicamente ben più di quanto noi per lo più non si sia disposti ad ammettere. Il noi, se di noi si tratta, è il problema che ci si pone e da cui partire. Il fatto è che rispetto al Web siamo nella condizione inestetica del ciclista in salita, il quale via via che s’avvede che tutte le strade sono in salita e, paradossalmente, nessuna porta alla cima, checché si creda, suda, alita e puzza,.
In questa pre-cedenza e rinominazione dell’io-tu nel «noi» del Web, la tékne con cui si pone il «noi» e che si sottrae non va considerata tanto come un trascendentale veritativo, ma orbene come un’attuosità performativa, radicalmente metamorfosante. Non solo, ma la performatività non si limita al piano sociale, a una possibilità esteriore di commercio, di comunicazione, di informazione; diviene, piuttosto, anamorfosi pubblica e politica del mondo a venire, che attraversando l’interiorità di ciascuno, modifica l’intimità più sacra che ciascuno ritiene di essere, e questo ben prima dell’auto-certificazione pronominale e auto-possessiva. Ecco, tentiamo uno sguardo perspicuo su questo punto e riappelliamoci a Iean-Luc Nancy.
Essere singolare plurale nella lingua del Web
In Essere singolare plurale, J.-L. Nancy, scrive:
«Senza dubbio, noi ancora balbettiamo: la filosofia giunge sempre troppo tardi, e di conseguenza troppo presto. Ma il balbettamento stesso restituisce la forma del problema: noi, «noi», come dirci noi? Oppure, che cosa ci dice, che cosa dice “noi”, e che cosa si dice di noi, nella proliferazione tecnica dello spettacolo sociale, del sociale spettacolare, della mondialità automediatizzata e della mediatizzazione mondializzata? Noi non siamo più capaci di appropriarci di questa proliferazione, perché non sappiamo pensare la natura spettacolare…»1.
Nancy vede un salto rispetto alle società precedenti, proprio nella mediatizzazione mondializzata che costituisce la nostra società. La spettacolarizzazione prima di essere una devianza patologica di politici scalmanati e arroganti anziché no, è posta in essere ben più radicalmente dal semplice differenziale di potenziale tecnologico. Da lì derivano il fatto che è a portata tecnologica che tutti dicano contemporaneamente tutto, che il noi preceda illimitatamente l’io, che i contatti si moltiplichino all’inverosimile velocizzandosi magicamente, che il tempo di “collegamento” mediatizzato sia destinato a farsi sempre più assorbente e interlocutorio, e così via.
In questo «e così via» c’è la performatività del mondo a venire, rispetto al quale gli atteggiamenti di risentimento inveggente, le accuse di non senso degli eventi mediali, il rifiuto apocalittico2 che impedisce che la perspicuità della reale posta in gioco possono comportare la perdita del punto di gravità del presente. È necessario, piuttosto, per comprendere il mondo nel suo farsi, non alimentare un atteggiamento di sprezzo occludente la vista circa il fatto che, se nel frastuono universale certo ha luogo la megafonia, il sovratono, tuttavia il carattere specifico che dobbiamo pensare della nostra società è la spettacolarizzazione delle relazioni, dei sentimenti, delle comunicazioni, delle informazioni.
Qual è, dunque, la caratteristica della sovversione degli eventi nel mondo della spettacolarizzazione? Qual è il punto di immanenza da cui osservare i fenomeni nel loro divenire, tale da fare vedere i veri pericoli e tra essi, primo, la perdita di senso? Qual è il punto di gravità del presente che permette di individuare le forme opportune per combatterli?
Per Nancy c’è una strana visibilità intrinseca all’uso che la gente fa dei media multimediali, e proprio questa esposizione dell’atto di comunicare, di informare, di collegarsi e stare collegati, è proprio questa istanza di visibilità che costituisce la nuova sociazione, il nuovo collante del sociale e il particolare stravolgimento del politico. Tutto il reale esistente deve apparire in questo spettacolo; il reale deve farsi atto ostensivo di sé; l’agire deve agire nell’esposizione di ogni singolo atto. La tékne più raffinata si concretizza nel rendere concreta questa istanza di visibilità, questa sottolineatura di presenza. La tékne consente la presentificazione della presenza – direbbe Heidegger.
Il fiore all’occhiello della potenza dell’universale presentificazione e attualizzazione nell’esposizione-mondo è la Rete. L’orizzonte dell’accadere è sempre più circoscritto dalla forma-Rete. Il fatto che la forma-Rete si faccia un baffo dell’aura del senso, non significa che non sia comunque in se stessa che si rendano per lo più possibili gli accadimenti. Al senso subentra l’ob-stenso, alla significatività la spettacolarità. Il possibile sarà possibile solo secondo la forma ostensiva dell’accadere. Solo nel piano di immanenza della spettacolarità cadono i fatti, o non accadono affatto. Le filosofie che professano a vari titoli nostalgie del senso si devono interrogare e devono innanzitutto chiedersi se non svolgano il compito di distrazione dal punto di immanenza radicale della tecno-scienza e di inibizione della comprensione dell’orizzonte dell’accadere. Eppure, la filosofia deve pensare ciò che è realmente in gioco, la chance possibile-impossibile che è nelle cose.
L’essenza della spettacolarità sta nel gioco di moltiplicazione dell’alcunché imposto dalla logica dell’inter-ferenza della tékne. La tékne funge comunque da moltiplicatore, da valore aggiunto, da capitalizzazione in atto, da inarrestabile, insopprimibile attuosità. Ha visto bene Nietzsche quando colloca l’essenza di questa macchina performativa al di là del bene e del male, cioè nell’essenziale indifferenza ai valori, alle tradizioni, al consenso stesso. La tékne è la morte della politeia intesa come partecipazione alla costruzione di un senso comune, nel senso che la avoca a sé e solo al suo interno la rende possibile. Ridescrive a priori la scena che permette all’essere di mostrarsi e agli enti di divenire. Ma allora non si tratta più della politeia che crediamo di avere conosciuto, e invero è già da lunga pezza che ci bendiamo gli occhi innanzi alla sua tecnologica metamorfosi, perché già da tempo la tecno-scienza procede allo smontaggio del senso come scena del mondo e al suo rimontaggio nei termini della pura spettacolarità.
Ecco allora un primo punto su che cosa sarebbe la nudità di senso quando ci si interrogghi sul
«che cosa ci dice, che cosa dice “noi”, e che cosa si dice di noi, nella proliferazione tecnica dello spettacolo sociale, del sociale spettacolare, della mondialità automediatizzata e della mediatizzazione mondializzata?»3
Questo nuovo senso è il senso spoglio di rinvii teologico-metafisici, ed è, dice Nancy.:
«“il senso”(…) trasformato nel nudo nome del nostro essere-gli-uni-con-gli-altri: noi non “abbiamo”più senso perché siamo noi stessi il senso, interamente, senza riserve, infinitamente, senza altro senso al di fuori di “noi”»4.
Questo «noi» s-nudato di tutto l’apparato mimetico, proiettivo e di ogni transfert nel Padre, snudato di ogni genealogia e appartenenza, di ogni memoria e idealità, è il «noi» più impensato, è il peso più grande del mondo che nella nostra fragilità di infanti dobbiamo portare. Un vero salto rispetto alla metafisica.
In questa nudità assoluta di senso del “noi” nel mondo automediatizzato, l’apparenza elettronica ha già schiacciato in sé passato e futuro, ha già cancellato in sé lo spazio, l’animalità, il corpo, e ha già ritradotto la possibilità di essere nella possibilità della sua tecnologica spettacolarizzazione. Mai la filosofia ha ricevuto una sfida di questa portata, mai le categorie su cui nei millenni precedenti s’è strutturata subiscono uno spiazzamento così radicale e inaudito. Ci rimane solo una prassi impossibile, non una consistenza ontologica, psico-sociologica. Dobbiamo continuamente ri-leggerci, ri-pensarci nel bagliore del nostro apparire e riapparire estenuatamente velocizzato. Noi siamo balugini di noi stessi. Dice Nancy:
«Noi non dobbiamo identificarci in quanto «noi», come un «noi». Dobbiamo semmai dis-identificarci da ogni specie di «noi» che sia il soggetto della propria rappresentazione, e dobbiamo farlo in quanto noi compariamo: il pensiero di noi anteriore ad ogni pensiero – e la sua stessa condizione a ben vedere –, non è un pensiero rappresentativo (non è un’idea, una nozione, un concetto) ma una praxis e un ethos: la messa in scena della comparizione, quella messa in scena che la comparizione è. Noi già ci siamo, ci siamo già sempre, ad ogni istante. Non è una novità – ma occorre, a noi occorre, reinventarla ogni volta, entrare ogni volta di nuovo in scena»5.
Ora, elettronicamente, ogni punto dello spazio e del tempo è un “possibile” crocevia infinito di messaggi, informazioni, immagini, logoi e contra-logoi; di questa potenza inaudita è capace la tékne, oggettivamente. Che io abbia scritto “possibile” e non attuale non dipende dalla logica della tecno-scienza, ma, ad esempio, dalla contingente convenienza economica. Pensare filosoficamente, tuttavia, è portarsi al livello di maggior potenza della sfida. Per dirla in breve, citando Nancy:
«Noi non siamo più capaci di appropriarci di questa proliferazione, perché non sappiamo pensare la natura “spettacolare” (che releghiamo, tutt’al più, sotto le insegne inconsistenti dello “schermo” o della “cultura” […]. Noi non siamo all’altezza di «noi»…non abbiamo nemmeno cominciato a pensarci, a pensare «noi stessi» in quanto «noi»»6.
L’impensabilità dell’evento
In questo luogo estremo, la sfida della tecno-scienza alla filosofia è che «gli eventi nel loro accadere nella scena dello spettacolo contemporaneo non sono pensabili»7. Siamo incapaci di pensare la spettacolarità perché scioglie come neve al sole le categorie deontologiche tradizionali in cui saremmo tentati di inscriverla. Che il reale sia pura fenomenalità senza residuo, senza rinvio, senza noumeno, senza mistero, questo è il mistero, il segreto dell’oggi impensabile.
L’Web è il «qui e ora» dello spazio tempo simultaneo. Nel Web il «noi» non è mai la semplice autocoscienza di noi scrittori, di noi intellettuali, di noi occidentali, di noi gruppo di appassionati d’arte, ecc.; non è neppure un’indeterminatezza o una generalità diffusa. È una pluralità che si dice nella spartizione e nell’accavallamento contemporaneamente. Si è noi in una simultaneità multipla. Questa simultaneità multipla precede il mio stesso io che entra ed è in rete, come un’autoreferenzialità in generale, come un’appartenenza alla spettacolarità di ogni possibile referenzialità. Io entro come io particolare nella referenzialità generale e «ogni volta» come un unico, ma «ogni volta» mi precede la simultaneità dei «ciascuno» in cui vado a collocarmi e che mi consente di riconoscermi e di essere riconosciuto. Perché io possa essere debbo entrare in questa dimensione di spettacolarità tecnologicamente fondata. Dice Jean-Luc Nancy:
«L’«ogni volta» implica in un sol tempo la discrezione dell’«uno a uno» e la simultaneità dei «ciascuno». Poiché un «ciascuno» che non sia nella simultaneità non sarebbe nello-stesso-tempo-accanto ad altri «ciascuno», si troverebbe in un isolamento che non sarebbe neppure un isolamento, ma la pura e semplice impossibilità di designare se stesso, e dunque di essere «sé»»8.
Con l’Web non si tratta più di identità, ma di identificazioni. Dice Nancy: «mai identità, sempre identificazioni»9
L’Web ci costringe su una linea di estrema impensabilità della scena dello spettacolo. Innanzitutto, l’impensabilità è nell’ordine di una nozione univoca? Possiamo ancora dire, oggi, cosa significa impensabilità? L’impensabilità è nell’ordine del significato, o l’impensabilità che l’Web instaura se ne fa un baffo e si va ad attestare fuori di ogni significato? Come pensare semanticamente il bit e l’elettrone? Tutta la speculazione filosofica è nata per guantare l’impensabile e ogni volta da capo ripartire a ordinare il mondo in funzione dell’impensabile ritradotto così in impensato. L’impensato come punto massimo di esercizio di ordine e di potere. Ma, allora, che cosa di eccezionale si va prospettando se la filosofia avverte una difficoltà invalicabile di fronte alla messa-in-Rete del logos, alla riduzione dell’essere a pura immagine fenomenalizzata, spettacolarizzata?
Di che razza di sottrazione è portatore l’Web? La filosofia ha da sempre coltivato un’inimicizia rispetto all’attualità del proprio tempo e ha pensato l’impensabile per respingerla, per metterla alle strette, così concependo la verità come scarto, come s-velamento-ri-velamento, come a-lethzeia. Oggi sembra che si siano capovolte le parti e che la chance dell’impensabile non appartenga più alla filosofia, alla religione, ma alla tecno-scienza. Questa, nata per l’evidenza e la manifestatività dimostrative nell’esattezza calcolatoria, è proprio lei che oggi respinge la filosofia dall’impensabile che sempre l’ha attratta e di cui da sempre è stata vestale.
L’evidenza come impensabilità
L’Web, fiore all’occhiello della tecno-scienza, si pone come attualità in atto in ogni direzione e questo al di là di ogni pretesa consistenza sostanziale, di fondamento o di principio. Sbalza da cavallo, dal sancta sanctorum della metafisica i suoi dispositivi più possenti e fa dell’attualità in atto tutto il gioco possibile. Come farsi carico dell’evento in un’attualità ricondotta alla pura spettacolarità? Si potrebbe pensare che si va aprendo una nuova chance al di là di ogni senso?
Siamo a ripensare i parametri metafisici nella filosofia moderna. Per Cartesio l’idea chiara e distinta è il sintagma per eccellenza della verità dell’io che si dà solo nella scena stessa della sua evidenza. La ragione moderna è l’evidenza evidente per l’io come per chiunque. Osserva Nancy:
«La scena è lo spazio della comparizione, in mancanza del quale resterebbe solo l’essere puro e semplice, ossia tutto e nulla, tutto come nulla.
L’essere si dà singolare plurale e si dispone in tal modo come la propria stessa scena. […] In tal senso, non c’è società senza spettacolo o, meglio, non c’è società senza spettacolo della società. […] Non c’è società senza spettacolo, poiché la società è lo spettacolo di se stessa.»10.
Si appare a sé e agli altri distintamente e simultaneamente, essendo la comparizione l’essere-insieme sociale stesso. In questo senso «si appare a sé solo nella misura in cui si è già un altro per sé»11
Bene! Il fatto è che l’attualità ricondotta alla sua visibilità virtuale è insieme l’evidente per eccellenza e l’impensabile stesso. Abbiamo pensato in antico la verità incontrovertibile del Modello ideale a partire dal quale, nella logica mimetica, nella logica della corrispondenza, abbiamo pensato il mondo. Poi, nella modernità, l’abbiamo pensata nella logica secondo evidenza della soggettività e della rappresentazione. Ma, oggi, l’evidenza puramente evidente nell’infinitesimo, e basta, è impensabile. Superiore alla velocità della luce e del pensiero. Il miliardesimo di secondo la tékne saprà calcolarlo, ma noi non riusciamo a pensarlo, a significarlo, a memorarlo, a narrarlo. Un’evidenza invisibile, una visibilità invisibile – ma è la pura visibilità senza fondo, senza veli, infondata e infondabile; uno spettacolo in-svelabile. Il messaggio digitale, l’immagine elettronica, una notizia informatizzata partono già senza fondo, non patiscono la mancanza di fondo, non viene loro a mancare nulla. Partono da un non-inizio e compiono una vicenda virtuale. Tutto è già sempre mancato e tutto è già sempre passibile di comparizione, dunque tutto è ridotto alla mera apparizione nel non tempo e nel non luogo propri della mediatizzazione iperelettronica. Si sgancia la relazione tra tempo e verità, relazione che precede e fonda la filosofia stessa. È di Talete, il primo dei sette sapienti, la sentenza che ci riporta Diogene Laerzio: «Il tempo di tutti è il più sapiente perché scopre ogni cosa».
Il senza fondo della pura spettacolarità
La dematerializzazione della dimensione “al di là della luce” fa saltare l’apparato categoriale di riferimento (materia-forma, sostanza-accidenti, potenza-atto e tutte le liturgie linguistiche, sintattiche, di consecutio temporum e tutte le inflessioni espressive conseguenti) evocando l’impensabile demone della pura apparenza della totalità, demone che s’aggira irremovibile per il mondo impermanente delle pure apparenze. L’arte delle avanguardie aveva anticipato qualcosa di simile, nel suo smembrare ogni durata della tradizione, ogni tenuta durevole delle forme. Tutto diveniva possibile e ogni azzardo ne richiedeva un altro fino al funambolismo della mera gestualità dell’artista, fino alla confezione ed esposizione della defecazione d’artista, ovvero alla coincidenza della performance con la performatività pura. Non faccia velo all’intelligenza la scabrosità ambigua dell’immagine Merda d’Artista del Manzoni, che invece inscatola nel massimo di artificiosità e di artefattualità la più nuda e la più povera naturalità che sia concessa alla nostra natura di animalità, com’è degli umori, del muco, dello sperma, del latte, e che so io.
L’Web si spinge ben oltre, fino alla declarazione dell’evidenza che nell’atto virtuale infinitesimo non c’è più nulla da pensare. Non reggono la delocazione spaziale a tentare uno smontaggio-rimontaggio di senso, un cambio d’uso dell’oggetto, uno spiazzamento simbolico; tutte operazioni disperate del senso e nel senso tentate dall’arte delle avanguardie. Il paradosso dell’arte d’avanguardia sta nella bellezza della disperazione assoluta del senso a cui fa da apripista e che vanamente potrebbe illudersi di seguire. Capolinea abissale, vertigine della vertigine: tutta la storia dell’opera d’arte precedente aveva ritenuto di lasciar più spazio allo spirito dematerializzando il gesto dell’artista, puntando sempre di più sull’atto del creare, dell’inventare, del porre, dell’installare, ma è ora, nel Web, che l’infinita potenza dell’attuosità si ritrova esibita in sé senza spazio e senza tempo, nella virtualità stessa del suo differenziale di potenza.
Certo l’opera d’arte, più della filosofia e della teologia ha rincorso, preceduto, guantato la folle velocizzazione della tecno-scienza. Perciò, a suo modo, l’Web, come forma del linguaggio e della vita, è forma d’arte, la forma che l’arte delle avanguardie ha concepito e che ora viene conseguita, infine, non solo al di là delle forme, ma oltre, addirittura fino alla distruzione tecnologica dello spazio e del tempo – involucri necessari, si è sempre ritenuto, dell’arte. L’arte dà forma di visibilità spettacolare alla cosa nella magia tecnica della mancanza-presenza dello spazio e del tempo. Così, si pone come la visibilità da vedere e come l’informazione da ascoltare al di là del vero, come l’annuncio che si dà, semplicemente, al di là del vero.
Il fenomeno-in-generale divenendo automaticamente spettacolarità, prende forma d’arte, di fenomenalità, un’apparenza nella sua forma propria, cioè di pura apparenza. L’opera d’arte nel ventesimo secolo compie la vertiginosa metamorfosi di scomparire nella sua proprietà specifica di carattere estetico e acquista il compito infinito non di costruire modelli, ma di donare “apparenza di forma” all’istante che, velocizzato all’inverosimile, scomparirebbe nel suo stesso apparire, anzi, sarebbe già scomparso nel suo stesso apparire. Appare solo in quanto già scomparso. Infatti, la spettacolarità dà consistenza di presente all’esistente come all’inesistente indifferentemente, proprio per la natura fuggente più della luce del bit e dell’elettrone. Così l’evento acquista valore estetico e la forma d’arte si spalma su tutta la vita, nel nostro caso rende spettacolare tutto ciò che transita per l’Web, cioè tutto.
È in atto una tangenza tutta speciale tra la spettacolarità del mondo attuale e lo spettacolo che ha a che fare con l’opera d’arte. Spettacolarità nella assolutezza della lingua del Web ed evento dell’arte convergono in un oggi asintotico. Ciò che risulta impensabile alla filosofia è la convergenza asintotica di pura spettacolarità ed evento dell’arte, di pura spettacolarità e storia, di pura spettacolarità ed economia, di pura spettacolarità ed amore. A proposito di spettacolarità ed eros, abbiamo sott’occhio esempi illustri che andrebbero letti, dunque, non tanto nella forma del disgusto etico-politico, quanto nel loro porsi come esempi limite di volontà di consistenza della pura apparenza. La pura spettacolarità ci ha sempre preceduti e ci può sempre seguire, indifferentemente; infatti, non perché spudoratamente apparente e basta, non perciò ci obbliga meno ad assistere ai suoi giochi di effetto a catena, giochi non certo senza causa, ma indifferenti a ogni causa, dunque davvero sconcertanti.
L’evidenza impressionantemente smarcata del puro darsi da vedere dell’evento
L’evidenza impressionante del puro darsi da vedere dell’evento che si impone è già un’evidenza smarcata rispetto alle domande etico-deontologiche della filosofia. È assai difficile pensare un evento il cui accadere venga perduto ogni volta che lo si solleciti a rispondere del suo messaggio, del suo referente, del suo senso, del suo essere. Il singolo evento non è tale da finire per non essere decisivo e interlocutorio, nel Web, a causa del flusso illimitato di informazioni, di messaggi, di linguaggi, di relazioni. Nell’orizzonte del Web nessun significato è decisivo per il suo evento. Il singolo evento, se di evento si debba parlare, non è mai decisivo per il suo senso, accadendo in un mondo fuori dell’ordine di senso e anche fuori dell’ordine del non senso. La filosofia, anche nella più vertiginosa fenomenologia, è in difficoltà a parametrare una fenomenalità che si offre in riduzione zero di senso, e dunque totalmente in rotta con l’attitudine onto-metafisica.
L’opera d’arte è stata più duttile e sottile nel seguire come ombra la velocizzazione dei mutamenti imposti dall’evoluzione della tecno-scienza. La storia del Novecento mostra la potenza della tékne di spostare i limiti dell’esperienza del mondo. L’Web, in questo senso, è un fiore all’occhiello di questa rivoluzione in atto. L’Web è un dominio in cui si generano le differenze di potenziale inaudite, tali da accelerare il corso della vita fino a farlo uscire dai suoi cardini, dai cardini del tempo e dello spazio. Non solo quindi le categorie dell’intelletto sono messe sotto una pressione improponibile, e con esse tutta la logica trascendentale del Soggetto kantiano, ma la stessa estetica trascendentale, le forme pure spazio-tempo, il basamento stesso della fenomenicità del Soggetto. La potenza attuale della tecno-scienza mette sotto pressione tutta l’esperienza per strapparla da ogni limite. Così la tecnica funge da piano inclinato dell’illimite su cui la vita ha preso a scivolare, a lasciare tutto alle sue spalle, persino se stessa.
Dall’Illuminismo e dalla rivoluzione industriale, la tecno-scienza è il luogo di tutte le accelerazioni e di propagazione di mutamenti inesausti; nella propagazione della velocizzazione infinita solo una certa formalità, che chiamo spettacolarità, riesce talora a rattenerla per un attimo. Ecco perché tutto tende a farsi spettacolare, religione compresa. La filosofia non è in grado di stare al passo e di formalizzare l’esperienza nel merito dell’universo mediale. Non c’è frammento virtuale o frame della vita che oggi possa sottrarsi di principio alla sua possibile esposizione mediatica, e nel contempo, non c’è frammento mediatico che non aspiri alla spettacolarizzazione, cioè alla sua elaborazione tecnologica.
La mobile frontiera tra la spettacolarità degli eventi e l’opera d’arte
La formalità estetica è funzionale alla vertigine della accelerazione tecnologica, anzi, la ri-configura come esperienza possibile. Per il resto pare che non ci sia resistenza al rovello rivoluzionario tecno-scientifico. Che la temporalità del tempo della tékne rivendichi a sé tutta la possibile rivoluzionarietà della produzione-mondo è ormai evidente e segna il declino delle ideologie rivoluzionarie, che nel corso del XX secolo si sono trovate nella condizione della rincorsa perdente, invece che della anticipazione seduttiva. Oggi, l’unica forma capace di cavalcare la produzione tecno-scientifica dell’evento è la forma-spettacolarità. Per ciò che concerne il punto d’incontro umano delle nuove generazioni, l’Web è come il nuovo esperanto cosmopolita in virtù dell’universalità della sua estetizzazione spettacolare. Lì sta la nuova formula della politica. Tutti, giovani e non più giovani, preceduti nel loro essere da questo necessario dover apparire, desiderano approdare, a questo universo della multimedialità, nell’aspettativa della permanente traduzione multimediale del loro essere sociale. Sono persuaso che il problema della traduzione sia il vero problema del linguaggio negli anni a venire. La macchina della traduzione del mondo nella multimedialità è la spettacolarizzazione, la possibilità della totale fenomenalizzazione, e questo è il cuore battente dell’Web. D’altronde, Web sta a significare la svolta epocale in cui tramontano tutti i grandi dispositivi di traduzione del moderno. Il fatto è che l’Web, che pure appare come la più smagliante circolazione di idee, interessi, proposte, contatti, informazioni, nella sua accelerazione tecno-scientifica senza centro e senza perimetro, brucia in volata ogni dispositivo traduttivo, ogni processo di formazione di cultura e di Bildung. Questi processi esigono e assorbono spezzoni di temporalità che subito risulta inattuale e anacronistica rispetto al continuum della dimensione ininterrotta della circolazione e del collegamento. La realtà virtuale del Divenire-Web è la sua pura fenomenalità, estranea al resto, perché senza resto di sorta. Tutti i frammenti spazio-temporali della possibile esperienza sono traducibili nell’immagine spettacolare; tutto il reale deve venire riscritto in immagine mediatizzata.12
Ma l’apparato categoriale mentale e disciplinare per comprendere la chance di questo processo resta ancora in ombra; da qui il disagio a trattare dell’ Web, lo spirito di risentimento nei confronti della pura fenomenalità che è in atto nella multimedialità. La filosofia, in merito, sta segnando il passo, mentre l’Web incalza indomito. La filosofia, che sempre ha avuto la passione per lo scarto e la differenza rispetto al reale esistente e sempre ha inseguito l’impensato, si trova, oggi, a solidarizzare con gli arroccamenti del reale e dell’umano che non vuole lasciarsi tradurre in immagine spettacolare. Stenta in tutti i modi ad aderire alla nuova misura dell’alethzeia come pura nudità del virtuale. Il fatto è che la derealizzazione dell’esistente, la riduzione dell’esperienza a flusso immaginale impone una nudità assoluta.
È cambiato, con Web il criterio di verità: si tratta di un’alethzeia senza lethe. Un’immagine senza contro-realtà, una vertenza senza contro-versia, una partita senza contro-partita, un dictus senza contra-dictus, o meglio, un’infinita dizione all’unisono dell’infinita contra-dictione, una relazione senza cripte e segreti dell’io e del tu nel noi, un rapporto immerso in un noi indeterminato e indeterminabile. Passaggio dal futuro al passato senza presente testimoniale e testimoniabile, senza l’«Egli » della parabola di Kafka, così come la riprende e la argomenta Hannah Arendt in Tra passato e futuro.13
La spettacolarizzazione è l’unico istante di permanenza nell’attuale della visibilità trasfigurata dell’evento elettronico, digitale, ipermediatizzato, sempre troppo veloce per non essere già passato. Hai un bel da contare in millesimi di secondo, in milionesimi di secondo; ogni cifra che proferisci è già illimitatamente inesistente. Il tuo contare è già s-contato e non sta contando nulla. Sì!, non solo conti il nulla, ma il tuo contare non conta nulla e tu con lui. Allora non ti rimane che credere nella verità elettronica del contare, e così, paradosso, il massimo di tecno-scienza e la credenza, sempre ritenuta pre-scientifica, si incontrano in una linea di confine indecidibile. L’indecidibilità, dacché Web va irretendo il mondo, è una linea di confine che taglia all’interno sia la credenza sia la tecno-scienza, ed è comunque una nuova misura per iniziare a pensare l’Web. Non rimane, certo, intatta la credenza (leggi religione, ideologia, fede politica, tifoseria sportiva, ecc.) agganciata al transito dell’apparente nella momentanea permanenza, nel trattenimento del transito nel bordo sempre già inattuale dell’attualità. Proprio perché l’evento, la notizia, l’invenzione stessa non sfiorano che i margini dell’attualità, ecco che non bastano più neppure alcuni canali televisivi e alcune testate di giornali per essere attuali. È un bel peccato possedere canali televisivi, testate di giornali, case editrici e, non poter controllare, di principio, l’Web.
La fascinazione est-eatica (estetico-etico-mediatica) e il male assoluto
Oggi, la politica e l’etica subiscono senza quartiere il fascino del differenziale di potenza della macchina tecno-scientifica e ne rincorrono sconsideratamente la mera spettacolarità. In questo modo invece che amministrarne, nell’ambito del possibile, le chances e le contraddizioni, desumono tutta la loro logica dalle forme del sistema di ricatto della spettacolarità. Ma questo piano inclinato si affaccia già sull’orlo della vertigine. Che cosa si intravede già? Si intravede il male senza senso, il male senza ragione. È il male assoluto che, appunto, compare quando la ragione non è più in grado di elaborare un senso, ma intanto l’agire continua a procede indifferentemente performativo.
Scrive Meazza: «Dobbiamo convincerci che la nostra epoca è capace di un male gratuito con una confidenza impossibile in altre epoche (nelle epoche in cui dominano le figure del senso il male è sempre fatale, ma non gratuito. Esso è l’eterogenesi di un bene particolare. Le religioni infatti ne costituiscono, quando perdono il rapporto con la fede, il paradigma esemplare)»14. Già per gli scolastici, il male doveva vestirsi del bene per motivare l’azione, e quindi il bene rimaneva come causa formale anche del male. Oggi questo non vale più, e in radice non vale più. Oggi la tecnica avanza senza fini, senza bene finale di sorta. In un mondo in cui l’agire e il produrre possono essere senza fini, il male può mostrarsi in tutta la sua gratuità. La fascinazione per la spettralità estetica degli eventi può comportare la nuova gratuità del male. Il nodo sta nella reciproca conversione di spettacolarità del presente ed evento estetico. In che senso qui si cela il male assoluto? Nel senso che la pura spettralità, la riduzione ontologica alla pura apparenza, ritraduce il fenomeno in fenomenalità, cioè in fenomeno senza traccia, senza lascito, senza testimonianza, senza responsabilità. Tutto e l’opposto di tutto è possibile, e qui sta la radice del male assoluto, sciolto da giudizio e da giustizia. C’è un’incredibile inaccessibilità da parte del pensiero pensato a entrare nel meccanismo della conversione reciproca di eventualità e spettacolarità.
Per Jean-Luc Nancy, l’essere-gli-uni-per-gli-altri è l’unica misura mentale e il solo argine sociale al dilagare tecnologico del male radicale. Ma è già dentro un «noi» intessuto dai nodi della Rete, tecnologicamente preceduto e oltrepassato dal differenziale di potenza della tecnica. E in effetti, la prospettiva che si è aperta con l’Web è per degli io-tu che sapranno destreggiarsi in Rete nella misura del loro essersi alleggeriti di ogni bagaglio metafisico, ma capaci di inventare un «noi» non indifferente al male assoluto. Fare i conti con la Rete e vivere il mondo del Web comporta una estenuante apnea ma esige insieme una grande creatività, uno stato di disillusione-seduttiva, per ricorrere a un ossimoro, se non ci si vuole abbarbicare in modo letale a un’altra istanza onto-teologica già fagocitata in partenza dalla realtà di fatto tecno-economica.
La mancanza che non manca e la figura della différance di Derrida
Dunque la inaccessibilità della filosofia alla produzione-mondo secondo la tecno-scienza starebbe nel confine osmotico di eventualità e spettacolarità. Bene, la spericolata riflessione di Derrida sulla différance e sulla sua doppia distinzione sia dall’identità sia dalla differenza ha proprio di mira questa inaccessibilità. L’intera pratica della decostruzione è un entrare nel merito.
Innanzitutto, la decostruzione segna il venir meno di ogni altezza e di ogni profondità. Derrida prende sul serio il fatto che gli eventi sembrano accadere senza sfondo, come che l’orizzonte dell’accadimento coincidesse con l’accadere stesso dell’evento e, quindi, con l’evento stesso dell’accadere. Ebbene, quale vuoto segreto regge questa conversione dell’accadere dell’evento nell’evento dell’accadere? La différance vuole leggere questo vuoto segreto, vuole decodificarlo, sa che è lì che bisogna lavorare a ricreare, per non essere sempre in ritardo, sempre fuori sesto, per non «cercare mezzodì alla quattordici». Ebbene, la produzione della spettacolarità e la coincidenza dello sfondo dell’evento con il mostrarsi dell’evento stesso sono la nuova relazione extra-ontologica, la nuova scena del virtuale che importa pensare. Non pensare il virtuale nel suo continuo vertiginoso prodursi e riprodursi sarebbe riaffidare la decostruzione e la différance a una nuova modulazione della differenza ontologica, che altro non sarebbe che l’altra faccia del Medesimo e dell’Identità. Un inutile, nuovo capitolo di una ratio che ha già perso di vista il reale come virtuale.
La filosofia della différance vuole entrare nell’orizzonte impensabile dello spettacolo senza sfondo degli eventi e prova in vari modi a smarcare la filosofia dalla scenografia metafisica da cui pure prende le mosse. Giunge a mettere in evidenza la diversa natura dell’evidenza virtuale rispetto all’evidenza della verità onto-metafisica. La mancanza abissale che intesse la virtualità è di altra natura rispetto allo scoperto-velato del paesaggio filosofico tradizionale. La virtualità si accompagna a una mancanza che non si presenta come mancante e si sottrae così alla critica. La logica stessa della identità e della contra-dizione rimane fuori soglia rispetto alla pura presenzialità del presente nell’attualità della sua attualizzazione.
La filosofia in generale sembra dover segnare il passo di fronte a un insieme che, come l’Web, nell’opulenza dell’attualità della sua ex-posizione, non mette affatto in opera il proprio mancare radicale, tanto che la sua mancanza non fa segno, non alberga pentimenti, non dà estro a confessioni, non lascia traccia del suo stesso mancare, condizioni necessarie perché la filosofia metafisica proceda appunto a liberare un senso inveduto, inattuato, impensato. La spugnosità assoluta del virtuale sbaraglia in anticipo le accuse di superficialità e si fa un baffo del non senso.
L’Web mi appare come un insieme sterminato, illimitato dell’illimite, come un àpeiron anassimandreo inverso, dove tutto è destinato a confluire, ad archiviarsi, a mettersi in folle circuitazione, nell’indifferenza indifferente di un ipotetico mondo esterno, di una physis, di una qualsivoglia naturalità. L’Web, a ben vedere, non fa neanche questione dell’impensato, ma dell’impensabile, o meglio, dell’indifferentemente pensabile. Un insieme la cui messa in scena non è effetto di una causa, non è il fine di uno scopo, manca di ogni sfondo di riferimento, ma soprattutto un insieme assolutamente inverificabile, invalutabile, un insieme mancante della sua stessa condizione di possibilità, un insieme che di tutte queste mancanze non lascia traccia alcuna, una mancanza senza traccia del suo mancare, un mancare inassegnabile in una presenza. Ebbene, del Web non c’è critica che tenga, che non vi sia già caduta dentro, che non si perda nell’infinita circuitazione del tutto. La critica coglie la contraddizione, morde la approssimazione di senso, ma l’Web senza fondo si fa un baffo del senso e del contro-senso.
La posta in gioco estrema, nelle cui prossimità ci conduce la filosofia della différance di Derrida, compiuto il cammino della decostruzione dell’identico e del differente, sta nello spingere se stessa al di là di se stessa, ma un al di là non concepito come un altrove in rapporto a sé, come un proprio altrove, ma un altrove differente dalla stessa differenza, la disseminazione infinita del testo e della scrittura. Qui il pensare deve divenire puro ritmo performativo, evento performativo a sua volta, e deve accettare il passo della forma estetica così come si pone nella sua inessenzialità. Si tratta di tentare l’impossibile decostruzione della voce disperata – vibrazione di spettacolarità che si dona e si disperde come i cerchi concentrici sul pelo d’acqua dello stagno del linguaggio del mondo. Si tratta di carpire la voce insperata del mondo e di esprimerne l’energia, il ritmo, l’andamento, la musicalità.
Qui si apre lo sterminato orizzonte del Web, una differenza che si fa un baffo dell’identità e della differenza, un mancare che non si vela più mentre si svela, che non si rinvia mentre si presentifica, una performatività che ogni volta batte su se stessa come colpo riuscito e compiuto al di là di ogni dire, oltre i logoi possibili e gli illogici possibili. L’Web fagocita il giorno e la notte, le vie delle cavalle condotte dalle dee di Parmenide verso la Verità come Giustizia. L’Web onnivoro fagocita la coerenza e l’incoerenza, ingurgita ogni nocenza e ogni innocenza, deglutisce ogni senso e contro-senso, pura attualità performativa dell’accadere degli eventi tutti indistintamente.
La filosofia di Derrida è leggibile, infine, come la messa in scena opulenta dell’impotenza metafisica nei confronti della spettacolarità degli eventi e del loro orizzonte virtuale, ma è pure un passo avanti verso il recupero della divina unità di filosofia e poesia, la creazione della filosofia come poiesis, opera d’arte e letteratura insieme, come contro-spettacolo e spettacolo a sua volta.
Lorenzo Barani (Castelnuovo Rangone, Modena, 1948) insegna filosofia al Liceo Classico S. Carlo di Modena.
Ha pubblicato: Vita Spinoza (1986) Edizioni Tam Tam, con un saggio di Adriano Spatola; Lilla, viola, talvolta però fucsia (1987), per l’Almanacco Tam Tam; San Peregrino (1989); Nietzsche e le cure dell’io. L’innocenza del tempo e la logica del risentimento (1998); Derrida e il dono del lutto (2009), Anterem Edizioni.
Fa parte della redazione della rivista filosofica éupolis.
Stefano Guglielmin, La natura della rete: tra pesciolini di plastica e ossi di seppia.
Da alcuni anni seguo e segno quotidianamente alcuni quartieri della rete, ne marco gli angoli, come un cane di strada. Ho anche una mia cuccia, bianca, dove deposito gli ossi. Talvolta sono di seppia, talaltra di gallina, ma l'intenzione è sempre la stessa: offrire un catalogo di bontà ad un pubblico presente e futuro.
Girando per la cittàvirtuale, incontro di tutto, essendo questa un luogo liberamente accessibile, costruito da chiunque per ognicosa. Anche la poesia, lasciata libera di brucare bellezza e verità dalla blogsfera, rischia di crescere stereotipata. Non dobbiamo gridare allo scandalo, come leggo qui e là, navigando; trovo invece in tutto ciò un ennesimo emblema della povertà dei tempi in cui viviamo. Se la poesia che si sente in giro è quella recitata sulla sedia dal bambino ben educato la domenica di Pasqua, quella banalmente intelligente di "Zelig", quella imparata al liceo da un professore pigro, se tutto ciò che vogliamo dalla poesia è che sia un contenitore del nostro magnifico ego, allora è normale che anche la rete pulluli di pesciolini di plastica. Obiettare che in quest'ultima manca una docimologia condivisa sulla qualità dei testi, non ci porta da nessuna parte. Tale evidenza, infatti, è un dato epocale, conseguente alla crisi delle ideologie e al moltiplicarsi dei centri di potere sul territorio; questa condizione semmai, appunto per le due ragioni storiche appena espresse, andrebbe riconosciuta nella sua novità, in quanto finalmente capace di accogliere nella discussione – prima accademica, elitaria o di corporazione – interlocutori altrimenti esclusi o emarginati. Non ultimi i bloggers, il cui background plurale allarga senz'altro, anche se inevitabilmente in chiave pop, la materia del contendere. Fra l'altro, la mancanza di un vertice, di un'oligarchia di comando, sostanzia la natura stessa del web: esso infatti altro non è che un labirintico pullulare di arcipelaghi, spesso indifferenti l'uno l'altro o, alla peggio, in reciproca tensione. La rete è infatti una selva, piuttosto che una società organizzata democraticamente, uno spazio babelico agguerrito, dove la libertà estrema diventa spesso arroganza.
Talvolta capita, tuttavia, che l'arcipelago sia fondato su altro: rispetto reciproco, curiosità di conoscere, amore per la professione, dedizione. Posti così ce ne sono a bizzeffe in rete, in tutti i settori. Chi, malgrado questo, si ostina a buttare il bambino con l'acqua sporca, è un sabotatore o un malizioso. E comunque il bambino, dentro e fuori, continua il suo serio lavoro lo stesso, giocando con il suo lego. Nel mio caso, costruisco via Blanc de ta nuque, dando spazio alle poetiche più diverse, sostenendo non soltanto il merito e i piccoli editori, ma anche i lettori che vogliono capire che cosa accade nella poesia, specialmente italiana. Lo faccio tessendo relazioni, non erigendo steccati; portando il mondo reale nel web, non edificando un mondo virtuale, chiuso al confronto con chicchessia.
Al di là di quanto si legge in giro, dove giornali e accademia si rubano il pane di bocca per sputacchiarlo con maggior livore sulla testa del web, e dunque scavando e mirando di làda questa assiepata masnada, in rete si trova un onesto e talvolta lodevole lavoro. Penso in particolare ai siti poetici cui Poecast ogni giorno attesta l'operato, ai poeti e ai lettori che frequentano Blanc, alle riviste in rete, ai siti dedicati ad un poeta d'antologia. Certo, dopo anni di onorato servizio, credo sia ormai finita la fase di mappatura generalizzata, di ostentata esibizione di creatività; tuttavia, l'autorevolezza per cominciare una selezione ulteriore, che metta in luce alcune linee forti della poesia contemporanea, la si guadagna sul campo, scrivendo critiche autorevoli, anzitutto, e postando poeti su cui ci si gioca la reputazione. Tale scrematura non può essere infatti decisa a priori, né da un cenacolo di mandarini né dall'agenzia bloggers riuniti. Occorre, invece, contemporaneamente al lavoro in rete, tenere vivo il dialogo fra ogni parte del sistema (studiosi, autori e riviste interessante alla discussione), organizzando incontri pubblici in cui si parli non tanto di come vincere la battaglia del virtuale o su chi debba decidere le regole per tutti, bensì di poetica, di politica culturale, del rapporto fra tradizione e avanguardia, fra poesia e scuola, della tecnologia applicata alla divulgazione della poesia. Si producano insomma idee e si materializzino progetti, anziché i soliti lamenti, che dalla rete, occorre dirlo, faticano a dissolversi.
Stefano Gugliemin (1961) vive a Schio (VI), dove lavora come insegnante di lettere. Laureato in filosofia, ha pubblicato le sillogi Fascinose estroversioni (Quaderni del Gruppo Fara, Bergamo 1985, premio “poesia giovane”), Logoshima (Firenze Libri 1988), Come a beato confine (Book editore, Castelmaggiore 2003, premio Lorenzo Montano per l’edito), La distanza immedicata (Le Voci della Luna 2006) e i saggi Scritti nomadi. Spaesamento ed erranza nella letteratura del Novecento (Anterem, Verona 2001), e Senza riparo. Poesia e finitezza (La vita felice 2009). Un suo racconto breve è pubblicato su AA.VV., La lente chiara, la lente scura (Empiria, Roma 2002, premio A.M.Ortese). Fitta e interessante è la sua partecipazione a riviste, tra le quali si ricordano: “Atelier”, “YIP. Yale Italian Poetry”, “Il Segnale”, “L’Ulisse”. Cura il blog di poesia “Blanc de ta nuque” http://golfedombre.blogspot.
Immagine di Giancarla Frare, Todesfuge-Celan 1

Domenico Cipriano, una premessa e poesie inedite da "Novembre"
Nota dell’autore
Sono poesie ispirate dal tragico terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia, un pezzo della mia vita e di quella delle persone di questi luoghi dove ho vissuto l’infanzia e la crescita, con uno sguardo anche al dopo, avendo come riferimento il luogo.
Per ricordare diventano ossessivi i numeri, ecco allora 23 poesie come la data del sisma, tutte composte da “stanze” di 7 versi, (poesie eptastiche) come l’ora del terremoto 7,34, completata da un prologo di 34 versi. Inoltre l’introduzione di 11 versi (come il numero corrispondente al mese di novembre). Le misure metriche sono differenti con prevalenza di versi liberi.
Non si può definire un poemetto, mancando dei personaggi ben visibili su cui costruire una storia, ma l’intento è mantenere l’io lirico e parlare della gente, la vera protagonista delle vicende.
I testi, come di consueto nella mia ricerca poetica, sono affiancati dall’indicazione di un brano guida, un invito “stilistico” ad ascoltare una musica che emotivamente si lega ai versi. Per questa sezione ho scelto: “Blood” di Annette Peacock, nella versione tratta dall’album M. Crispell, G. Peacock, P. Motian, Nothing ever was, anyway (ECM, 1626/27).
Intro
ti guardo con occhi
diversi parola risorta
ogni notte udendo
la voce degli uomini
senza piùvoce, lontani
sfuggiti dai luoghi.
torni di notte, distante
un respiro e lìgermini
frasi distorte che
modifico in vita.
poi credo e non vedo.
1.
trema la terra, le vene hanno sangue che geme e ti riempie.
è un fiotto la terra che lotta, sussulta, avviluppa, confonde
la terra che affonda ti rende sua onda, presente a ogni lato
soffoca il fiato, ti afferra, collutta, si sbatte, si spacca, ti vuole
e combatti, chiede il contatto, ti attacca, ti abbatte. èfuoco
la terra del dopo risucchia di poco le crepe: la terra che trema
riempie memoria. ti stana, si affrange, ti strema, èpadrona.
16.
le pietre saranno risalite per ripetere
monumenti e campanili. si baratta
il dolore per le cose perdute, si riparte
per chi non ha avvistato il miraggio
americano, i parenti lontani. i progetti
sono nelle fabbriche che salderanno
la terra. ma le crepe non sono nella terra.
20.
gli addii sono lunghi da superare, tra le foto
nelle ricorrenze si prova sempre a cercare
un viso, il disegno delle case abbandonate.
tra i viali intrecciati che non hanno segni
vive il calpestio sulla terra sgretolata quando
tutto si strinse sulle case e nuove case
si mescolarono in grigioscuri di cemento.
23.
la morte ha soggiornato per anni
ora le nostre case hanno bisogno
di respiri, abbandonate come sono
al silenzio. abbiamo traslocato
i nostri corpi e lasciato solo
le crepe nude delle rughe
a vegliare sulla piazza.
ITALIAN POETRY REWIEV, USA, anno 3, 2008, pp. 97-104
Domenico Cipriano è nato nel 1970 a Guardia Lombardi (Av) e vive in Irpinia. Già vincitore del premio Lerici-Pea 1999 per l’inedito, nel 2000 ha pubblicato la prima raccolta organica dal titolo “Il continente perso” (premio Camaiore “Proposta” 2000). Interessato al connubio Jazz e Poesia ha dato vita al progetto “JP band” da cui il CD “Le note richiamano versi” (2004), con i musicisti Enzo Orefice, Piero Leveratto ed Ettore Fioravanti, e l’attore Enzo Marangelo.
Ama da sempre legare la poesia all’arte, collaborando con artisti di vario genere nella realizzazione di libricini da collezione. Suoi versi e contributi critici sono apparsi su antologie e varie riviste, si ricordano: «Poesia», «La Mosca di Milano», «Specchio della Stampa», «Gradiva», «Italian Poetry Review», «Capoverso», ecc. È redattore della rivista «Sinestesie». (www.domenicocipriano.it)
Gianluca Giachery, un saggio e poesie inedite da "Geometrica passione"
Gianluca Giachery : Il segno perduto della poesia
Il testo come feticcio
Barthes propone un accostamento: il testo è corpo che si dispiega attraverso l’evento che ne determina l’incontro. Accanto al corpo dell’amante è possibile percepire l’emozione che distrae dalla coscienza, rendendo il corpo dell’altro nella sua dimensione erotica: esso è il dischiudente, ciò che lascia apparire negando da subito l’immediatezza della conoscenza. È una incessante sottrazione, che richiede una mediazione (Se e l’Altro, non Se o l’altro). Dalla semplice congiunzione (che riscatta l’oppositività dello scrittore volta al continuo allontanamento) si svolge un’intermediarietà che solo apparentemente ristabilisce l’ordine delle parti (scrittoreÞ testoÞ lettore). Il testo scompensa qualsiasi ordine del discorso, prospettando sempre un’alterità che genera nuovi piani di immanenza (mobili), sui quali si innestano diversi discorsi, diverse narrazioni. È questa polisemicità a rendere il testo nell’attraverso della scrittura. È la scrittura a separare le forme e unire i tratti che si combinano tra di loro per rivelare la profonda asimmetricità dei piani. (Qui risiede il problema dell’inizio e della fine del testo).
Come il corpo, il testo si sottrae alla concessione gratuita: o dà di sé l’essenziale, oppure si mercifica rendendosi oggetto che reifica un tributo. Diviene cioè simulacro di una ripetizione.
L’avvicinamento sottende sempre un’attesa, un’aspettativa che non si risolve mai nell’impeto della cupiditas, del voler ad ogni costo appropriarsi dell’oggetto. L’avvicinamento è fatto di attese, di piccole rinunce, di tentativi che costituiscono il movimento stesso del testo: in esso, infatti, si trova l’amante capace di custodire un segreto liminare, ciò che annuncia un inaspettato incontro.
Cosa custodisce il testo? La storia, narrazione che si dipana dinanzi ai nostri occhi donandoci il piacere segreto dell’irrinunciabilità di quel particolare momento; le figure, i personaggi che si costruiscono l’uno accanto all’altro quasi a voler suggellare il richiamo ad un mondo altro; il nostro sguardo ansioso o genuinamente rilassato dal piacere, la nostra voce pronta a scandire parola per parola, lettera per lettera il procedere di una simulazione. Il testo custodisce questo e altro ancora.
È profondità. Custodisce poiché nasconde. È una sua funzione precipua. Il testo nasconde ampliando le possibilità di lettura (semplice atto che mette in relazione con esso), trasportando con sé (e fuori di sé) il senso delle allegorie, dei fantasmi metonimici che incarnano un passaggio. Il nascondimento presuppone la fatica della scoperta, l’impegno a cimentarsi e legarsi in modo continuativo alle movenze della parola, ai suoi traumi, alle cesure che (pronunciata con veemenza o silenziosamente) crea. Tuttavia, il nascondere, il custodire generano l’eccedenza che circonda la storia testuale: il testo non si sottrae al destino degli oggetti che popolano la contemporaneità. Esso diviene merce. Per questo si utilizza il testo per procurare un piacere, il sottile fondo della parodia.
È contraddittorio, si può comprendere. Proprio in questa contraddizione (che è il paradosso delle merci nel momento in cui si trasformano in feticci, perdendo il proprio valore d’uso/scambio) risiede il suo valore d’eccedenza. Lo scambio “s’impadronisce del testo, lo immette nel circuito delle spese inutili ma legali: eccolo di nuovo collocato in un’economia collettiva (anche se puramente psicologica): è proprio l’inutilità del testo che è utile, a titolo di potlach” (R. Barthes, Il piacere del testo, pp. 91-92). È questo scambio estenuante, ripetitivo a rendere il testo feticcio.
Nessuno meglio di Freud ha descritto il carattere di feticcio di alcuni oggetti cui rivolgiamo il nostro desiderio: essi sono permeati di un’aura particolare che ne trascende il senso, perdendo qualsiasi legame con la realtà. Il feticcio si sostituisce all’oggetto, essendo un’elaborazione del pensiero, svuotandolo di significato per renderlo una sorta di oggetto-oggettivato. Solo in questo modo l’oggetto-feticcio può soddisfare indiscriminatamente la ricerca di piacere. “Il testo – scrive Barthes – è un oggetto feticcio e questo feticcio mi desidera. Il testo mi sceglie, attraverso tutta una serie di disposizioni invisibili, di cavilli selettivi (…); e, perduto in mezzo al testo (non dietro, quasi un dio da macchinario), c’è sempre l’altro, l’autore” (ivi, p. 94). Eppure il testo-feticcio nasconde (tra le tante) anche l’angoscia della profondità. Mescolata ad essa, quasi fosse tutt’uno, sta la perdita dell’oggetto, lacerazione che costringe a trasformarlo nel senza-più-vita, completamente a disposizione del nostro godimento.
Parole di poeti
Vi sono testi poetici (penso a quelli di Giorgio Caproni) che si intersecano al segno su piani diversi, custodendosi in una metamorfosi di simboli che avvertono della lacerazione imminente. È come attraversare un ponte e, affacciandosi ai lati, vedere svolgersi le immagini dell’esistenza. Non un’esistenza qualsiasi, ma quella esistenza poetica che assegna per sé un ruolo nomade. Ciò può dirimere rispetto alla lacerazione, cercando una molteplicità di vie che riportino alla mancanza iniziale intorno a cui l’essere si arrovella sin dalla nascita.
Platone aveva già visto questa lacerazione, che si pone come alteritàtra semen e soma, riportando nel Cratylo il detto di “altri” (qui: l’alterità?): “E dicono alcuni che esso [cioè il corpo] sia il sema [segno, tomba] dell’anima, quasi che essa vi sia sepolta nella vita presente; ed anche per questa ragione, che con esso l’anima significa ciò che significhi e perciò è giustamente chiamato sema” (Platone, Cratylo, 400 b-c).
Caproni riprende questa lacerazione. Proponendo la simulazione di un non-luogo. “M’ero sperso. Annaspavo./ Cercavo uno sfogo./ Chiesi a uno. ‘Non sono,’/ mi rispose, ‘del luogo’” (G. Caproni, L’opera in versi, p. 322).
Il disperso è colui che tra le maglie della scrittura fruga di continuo il senso dell’esistenza, lasciandosi alle spalle l’esistente, non con il guizzo dell’aristocratico che rifugge dalla quotidianità, ma come chi conosce gli orrori e le paure della dispersione che fa vacillare l’anima, che ritiene e poi con un fragoroso smottamento sconvolge gli equilibri d’un sempre precario assestamento. Allora, solo allora, il poeta può domandarsi, come in una postilla: “(Non ho saputo resistere/ al suo non esistere?)” (ivi, p. 332), ponendo tutto tra parentesi, in un’epoché che lasci sospesa ogni continuazione. Egli sta lì ad osservare e, così facendo, ritaglia ancora una spazio di mondo nella propria vita, in attesa dello scompiglio che rimescolerà tutto in un dissidio. “Imbrogliare le carte,/ far perdere la partita./ È il compito del poeta?/ Lo scopo della sua vita?” (ivi, p. 363). È questo “gioco” a farci apparire spesso un testo poetico (così come quello filosofico) insensato, incomprensibile? Allora esso è sicuramente accostabile all’“insensato gioco di scrivere” di cui parla Blanchot.
Vorrei dire ancora della poesia, soffermandomi sull’esperienza del suo testo, così poco conforme ad essere considerata una scrittura della condivisione. Essa viene piuttosto percepita come un limite, l’incapacità a rendersi conto dello spostamento (il sisma di cui si è parlato poc’anzi) che ci obbliga ad essere nomadi. Piuttosto essa è “una parola di soglia” (das Schwellenwort), come afferma Celan.
I testi dei filosofi
Ho accennato all’inizio e alla fine del testo, dovrei dire, forse, della scrittura. In questo modo si diviene consci che, in realtà, ci si adagia sul libro, involuzione dell’elementare processo della vita.
“… i testi che leggo e rileggo – afferma Derrida – sono sempre nuovi per me. (…) È anche una certa amnesia a darmi questo gusto, che si può considerare una forza o una debolezza. Non dirò che so dimenticare, ma so che dimentico, e che non è solo né sempre un male, anche se ne soffro” (J. Derrida, M. Ferraris, Il gusto del segreto, p. 43). Nella costruzione delle nostre ipotesi, dei nostri testi, spesso bisogna dimenticare chi ci ha preceduti, per tornare poi a ricordare (ma è solo un vezzo della memoria?) quei filosofi la cui parola ha rappresentato il turbinio di una vita, la solerte (e a volte disprezzata) pazienza necessaria a costruire concetti. Proprio di questo si tratta. L’ermeneutica (divenuta ormai una tecnica di mestiere) ha insegnato a ben chiosare (decostruire e, vorrei dire, a lasciar decantare) scritture che non si degnano più d’una lettura serrata, perché si preferisce ascoltare chi ha già scritto su di esse. Ogni scrittura (a maggior ragione quella filosofica) è un arbitrio, il risultato di un tentativo di dis-alienazione che appare e scompare dando l’illusione d’aver trovato un nesso causale (o casuale?) nella decifrazione dello spettro del mondo.
È per questo che si denigra la filosofia, perché si crede d’aver scoperto il meccanismo della sua inutilità. Così ancora una volta ci si ferma all’apparenza, poiché anche se si crede nell’infallibilità della tecnica non si fa altro che riproporre un testo che si adagia sull’illusoria capacità d’essere molteplice, “vestito buono per ogni stagione”.
Cedendo lo spazio filosofico si ostruisce una passione che è passione per la lingua, per ciò che necessita un atto di rinuncia ad una parte di sé. Attraverso tale rinuncia il filosofo proclama la frammentarietà del reale, l’impossibilità a percepire in modo unitario il mondo e le sue relazioni, unico tramite di contiguità.
È una maledizione possedere la necessità di chiosare i testi filosofici, di posarsi accanto ad essi e riempire interi quaderni con citazioni, brani, interi paragrafi che giustifichino il proprio pensiero. Quasi come tracciare un albero genealogico, una mappa genetica che ci riconosca figli di quel tale o talaltro pensatore. È nota l’ossessività con cui Benjamin riempiva foglietti e piccole schede con la sua minuta scrittura costruendo quel libro impossibile che è il Passagenwerke. È altrettanto nota la sua idea di voler creare un libro di sole citazioni, il libro di tutti i libri, un enorme mosaico senza alcun autore e al tempo stesso con una collettività d’autori mimetizzati nella palude della non-appartenenza.
Da Nietzsche in poi il testo filosofico ha proclamato la propria rottura con la precedente tradizione, permeandosi della necessitàdi porre innanzi a sé non la programmatica discussione di ciòche èil fondamento (della metafisica, dell’estetica, della scienza ecc.), bensì liberandosi da qualsiasi riferimento ad esso, pur cadendo nell’ambigua trappola (fascinosa e seduttiva) di un pensiero che naufraga silenziosamente nelle proprie incertezze. Così l’aforisma (genere di per sé letterario e, in passato, privo di qualsiasi qualità speculativa) diviene il riferimento costante della speculazione nietzscheiana, il percorso che conduce a un non-dove che è, appunto, perdita. La penna del filosofo “raspa”, ma si trova ad arare un campo inaridito da secoli di incoltura.
“La penna raspa: è un inferno!/ Son io dannato a dover raspare?–/ Arditamente afferro il calamaio/ E giù densi fiumi d’inchiostro./ Come affluiscon pieni, come larghi!/ Come ogni cosa che faccio, mi riesce!/ Manca invero allo scritto la chiarezza–/ Non fa nulla! Quel che scrivo, chi lo legge?” (F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, p. 47)
Ciòche permea il testo filosofico è, dunque, l’estrema passione che congiunge il pensiero alla scrittura, la ricerca della e attraverso la conoscenza non (e mai) disgiunta da quella peregrinazione interiore che si pone in costante confronto con l’alterità. È quanto ottiene Nietzsche, ammonendo i “realisti”. “Voi uomini sobri che vi sentite corazzati contro la passione e i capricci della fantasia, voi vorreste gloriarvi del vostro vuoto e pavoneggiarvi con esso, vi chiamate realisti e date a intendere che il mondo sia realmente costituito nel modo che appare a voi: davanti a voi soli la realtà starebbe senza veli e voi stessi ne sareste forse la parte migliore” (F. Nietzsche, ibidem, p. 102). Questo brano, che s’anima dinanzi ai nostri occhi, pretende quasi un ossequio, un’attesa ironica che desti finalmente chi ancora osi pensare che tutto ciò che appare è realtà, che il mondo s’apre all’uomo nella sua verginità.
La questione, dice Nietzsche, si gioca tutta sull’ebbrezza che s’avverte nel rapporto con il mondo: chi non riesca a vivere tale ebbrezza (il caos della stella danzante!) è come tagliato fuori dal flusso dirompente della vita, condannato invece ad arrovellarsi nelle proprie elucubrazioni. “…forse – scrive Nietzsche – la nostra buona volontà di tirarci fuori dall’ebbrezza è altrettanto rispettabile quanto la vostra convinzione d’essere del tutto incapaci d’ebbrezza” (ivi, p. 103).
In questa ebbrezza (lungi, sembra, dallo slancio dionisiaco dello Zarathustra eppur così paradossalmente vicino) è tutta la capacità del filosofo a creare concetti, a farsi promotore attraverso il proprio testo dello scandalo generato, ad esempio, dalla parola verità: chiunque abbia coscienza d’essa ne rifugge come dinanzi a un fantasma. Eppure, avvalorando i continui emendamenti ai testi filosofici che vengono da chi ama che la parola sia inevitabilmente interpretata, sostiamo increduli, quasi trasognati dinanzi al leggero battito di “stupidità” che ci riporta alle cose ovvie, alla capacità di nutrire il dubbio degli incapaci o, per dirla con Voltaire, del “filosofo ignorante” che socraticamente ammette la propria limitatezza. Un monito, allora, ancora da Nietzsche, che ci costringe a leggere il testo filosofico con l’ingenuo dissapore di chi vive nel proprio tempo: “Occorrono dunque intelletti virtuosi – ah! Voglio usare la parola più inequivocabile – occorre la virtuosa stupidità, occorrono coloro che battono imperturbabili il ritmo dello spirito lento, affinché i credenti della grande fede collettiva restino insieme e proseguano la loro danza: è una necessità di prim’ordine che a questo punto impera e pretende” (ivi, p. 113).
Su questa urgenza il testo, che raspa la propria infernale perversione, svanisce come per ritrovare un originario perdono.
Gianluca Giachery : da "Geometrica passione"
Sottrazioni
“Segreto è il calore
delle cose obliate”
Canetti
Spezza
con tacito silenzio
la vergogna che ti chiude
al reclinare sordido
dell’armonioso evento:
conosce il tuo approssimarsi
il dio della lingua sottratta?
Ti hanno scritto, allora,
della calda fuliggine
che muove gli angoli
remoti della distrazione:
se nel manto del ciliegio canuto
troverai il pianto che dissoda,
quello sarà la mia voce,
l’ebbro canto dell’appartenenza.
Distrazione
a Franco Fortini
I poeti si fanno
dai poeti, nel diàspero
di un notturno tacitamente
reclamato.
Le brune del vermiglio
non colgono più
le croci della parola
dissipata: lasciano
intatta (con inattesa vergogna)
la chiusa del riverbero.
Nessun compromesso
scioglie le mani del poeta:
egli non ha
merce di scambio, solo
parole irsute e metafore ostinate,
che stringono il cerchio
dell’apparenza.
Preludio della forma
Le foglie del manto autunnale
non mitigano la brina
né la parola dei ritorni:
nella bocca
la fronda dell’astio
rintana come
smorzata serpe: chiudono
il loro tempo
le fatiche consacrate
al silenzio.
Strettoie
Alla volpe
L’orgia da cui l’incavo
produce l’assidua metafora
delle affezioni
è il corale strepitio
che calpesta le dolorose
attese:
non detta alcun decalogo
il reciproco delle appartenenze –
bensì sposta
con animo inquieto
la curva dell’occhio
(acuta come l’ombra
del passaggio meridiano).
Il segreto sta
nella rivolta – come dicevi:
ad essa appartengono
le banalità della storia
e le verità distratte
dell’inconsueto.
Haiku desolato 2
Terribile e vuoto
è il nome,
pienezza d’assoluto:
ma nei ritagli inquieti
del mondo,
il destino è paura.
Gianluca Giachery è dottorando di ricerca in Scienze dell’Educazione presso la Scuola di Dottorato in Scienze Umane dell’Università di Torino e collabora agli insegnamenti di area pedagogica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere della medesima Università. Sue pubblicazioni sono comparse su «Encyclopaideia», «Paideutika. Quaderni di formazione e cultura», «Pedagogika.it», «Hortus musicus», «Adultità» e «Anterem». Collabora a «L'Indice dei libri del mese». Tra le sue pubblicazioni: Il volto dell'Angelo. Walter Benjamin e l'esperienza novecentesca del tragico (Torino, 2004); Esperienze vissute ed esistenze incarnate. Per una critica sociale dell'educazione (Torino, 2006). Redattore di «Paideutika», è recentemente uscito il suo volume Etica della padronanza. Le pratiche educative come pratiche di riflessività (Roma, Anicia, 2009). È autore, inoltre, di una raccolta di cartigli poetici dal titolo Transiti.
Elena Corsino, una premessa e poesie inedite da "Nature terrestri"
Nota dell'autrice
La parola dice il cielo e la terra, dal momento che la parola li riempie. Ma la parola non contiene nétutto il cielo néla terra intera; cielo e terra sovrabbondano. Dove dunque si riversano cielo e terra quando di essi è colma la parola?
Fino a qui mi sono mossa parafrasando. Ora mi chiedo: puòl’essere che eccede la parola riversarsi in una parola nuova, i cui confini impercettibili di senso siano estesi nella misura in cui si estenderà, al contempo, l’essere sovrabbondante? È ciò che eccede la parola il caos, da cui la parola rifugge. La parola sentinella al cospetto del caos, quell’indicibile che noi percepiamo oltre, in un terreno non umano ma sia pure naturale e intimamente famigliare.
Tendo la mano verso ciò che alla parola sovrabbonda; ecco che la parola muta e io sono altro. Si manifestano le metamorfosi dell’essere, pure del mio essere. Potrei anche finire col credere che la parola sia me, ed io la parola. Nulla di panteistico, bensì movimento dell’uomo, forse solo del corpo, a tastoni dentro la sovrabbondanza dell’essere, di natura.
In luogo di premessa
Nessuna parola direbbe il caos. Lo fuggirebbe. Il caos la contraddice. Il caos ride.
E contraddicendo la contempla come sua tenera parte: lo spazio dove dimora l’uomo.
L’indicibile è nei nostri occhi infiniti e muti.
***
Solo il bianco agli occhi rimane
come la neve, dove affonda –
il passo che l’occhio attende lieve.
Non sappiamo piùdire: l’occhio
che vede guardato – dal confine,
rinnega, richiama, abiura, – ama
mentre scende nel marmo a spirale
nel frammento vuoto di luce.
***
È lastricata e sdrucciola la mia
non retta via di fragili orizzonti
sui fianchi di rovine umide e muri
– e scarti ricoperti di muschi
verdescuri, lungo questo risucchio
dell’aria – mantra d’assenza e d’oblio.
Io vengo all’accorrere del cielo
all’azzurro in grembo alle colline.
***
Gesti ed esili che cedono alle mani
come lungo vettori di gole
negli aneliti fra le dita oltre l’andare
scivolare su questa ghiaia di cose
oltre lo schianto.
***
1.
Il nero dove scavo in evento
limite, all’estremo perimetro
ritagliato intorno alle cose,
dove l’ombra dal sud si muove.
L’ho veduta nel sogno ululare
ma forse era uomo sul ciglio,
le labbra colme di cose chiamate.
2.
Le cose che vedo – sono
le cose cedere al nero.
Cadere all’azzurro degli occhi
alle nebbie del grembo, in volo
ritorno a respiro a ritroso.
Elena Corsino (1969) traduttrice e docente di Italiano come lingua straniera presso l’Università degli Studi di Udine. Ha tradotto L. Carroll, M. Cvetaeva, O. Mandel’štam, F. Dostoevskij.
È autrice della raccolta di poesie Le pietre nude (2005), oltre che di saggi brevi e liriche per musica.
Mario Fresa, una premessa e poesie inedite da "Separazione dalla luce"
Nota dell'autore
Il poeta incide sopra se stesso una ferita che annuncia l’alto riverbero di una rottura decisiva: cioè l’esplodere di una visione dilatata, nobilmente oggettiva,che d’improvviso lo fa precipitare in un agone sconosciuto, dalle sembianze gelide e divine.
L’amoroso azzeramento che consegue a tale verticale epifanìa sa poi donare, a chi è tutto scivolato nell’attesa, un nuovo, inaspettato silenzio che produce l’aprirsi di una lingua tutta priva di modi e di desiderio e di intenzioni (ché la poesia deve, finalmente, solo interdire la comunicazione, strappandola ai suoi limiti finalistici). La poesia indica, appunto, quell’acuta coincidenza entro la quale agisce un insperato e involontario distacco dall’esserci: ed è allora che si è precipitati in uno sperdimento che, simile a un teatro impossibile,miracoloso e osceno, continuamente ci perde e ci rinnova. «Io fisso un punto dinanzi a me e mi immagino questo punto come il luogo geometrico di ogni esistenza e di ogni unità, di ogni separazionee di ogni angoscia. […] Aderisco a questo punto e un profondo amore di ciò che è in questo punto mi brucia fino a rifiutare di essere in vita per qualsiasi altra ragione che non sia ciò che è lì, per questo punto che, essendo insieme vita e morte dell’essere amato, ha lo splendore di una cateratta. E nello stesso tempo, è necessario denudare ciò che è lì da tutte le sue rappresentazioni esteriori, fino a quando non sia altro che una pura violenza, una interiorità, una pura caduta interiore in un abisso illimitato» (G. Bataille, La congiura sacra, tr. it. Torino 1997, p.123). La poesia richiama e stabilisce, in un istante, le coordinate della consumazione e della distruzione e, contemporaneamente, l’accecante manifestarsi di una festa grandiosa: non è lontana, dunque, dalla soglia perigliosa di una piccola morte. Essa è un’interiore plenitudine che ci trascina in una bellezza irrappresentabile, senza volto e senza direzione; e che amplifica e distrugge l’identità del singolo poeta e del lettore; e che a entrambi toglie tutto il respiro.
da Preghiera del Minotauro
5
Ti lascerò quel sangue e quel destino. Ti lascerò il coltello dell’attesa. Gli averi ansiosi della partenza. Oppure l’annegamento vano di quelle dita che cercheranno di sfiorare quelle maligne stelle. Adesso, ascolta: la scatola perfetta degli errori cade nel piatto e poi rimescola i registri, la dolce seduzione delle cene.
6
Domandi se sei viva. La pelle è dunque il nome, è dunque il nuovo riflesso che richiama e che sconcerta. Il corpo vede e suona. Il corpo è la pietanza. Ma il respiro definisce tutto quello che risplende: amami ed esci. E le unioni sono scarlatte e bianche. Le unioni sono vere: sono scarlatte e sono indivisibili, per sempre.
da Sculture
***
Ero un esile e curvo respiro e riparavo
ansioso nella tua mano e poi mi rifugiavo,
calmo, sotto un albero di verbi, dopo l’ultima
festa delle luci; era un nuovo stratagemma
per l’attesa ch’io ricevevo come una danza:
sopra le labbra tu accoglievi, in un istante, il vero.
***
L’anima cade nella vetrata quando muoiono, d’incanto, le
parvenze. Una semplice arena che cresceva notti lunghe:
era il poema violento della vista,
ma ti accorgevi allora di non essere che un inesatto
gesto, un sonno tutto lieve che scuoteva le dimore.
da Risposta di Arianna
1
Il mondo si riposava con la sua grande presunzione. Io vendevo tutte le stelle al primo passante che mi pregava ansioso. Non potevo distinguere i pensieri dagli eleganti impulsi. La vista mescolata ai futili motivi: e allora la tua mano,così pericolosa e amara, si trasformò in un albero leggero, in un sorriso buono che taceva. Per le tue forze perdute era un incanto avvicinarsi ai segni sconosciuti e gareggiare coi celesti risultati. Dietro l’amore della mattina si rivelava: l’arte di non sapere.
2
Adesso l’ora è piena di demoni e di frutti. Usciamo, allora, da questa vista povera e impaziente: c’è un doloroso impasto che invoca il nostro nome. E la camera profuma di rendiconti, di asciugamani intatti, di veri giuramenti: ecco il segreto, dici: ecco la dolce sorte.
3
L’arca dei sentimenti non è capace: le penitenze, le rose, le domande. La festa non aveva nessun ospite: perciò la notte io discendevo a seminare rozze spine in mezzo agli aranceti. C’erano sempre, disposti bene in fila, i giocattoli amici e nemici. Per un ineluttabile favore del destino.
Mario Fresa è nato nel 1973. Le sue più recenti raccolte poetiche sono Costellazione urbana (tre poemetti, in« Almanacco dello Specchio» n. 4, Mondadori, 2008) e Luci provvisorie, apparsa integralmente su «Nuovi Argomenti» (Mondadori, n. 45, 2009). Ha curato insieme con Tiziano Salari un volume di indagine critica, La poesia e la carne (La Vita Felice, 2009).
Cristina Annino: due racconti inediti, una poesia, un'immagine
Cristina Annino
Due racconti inediti, una poesia e un’immagine
Fatto sta
Fatto sta, la
speranza è una casa, ed è
larga più del luogo in cui dormo. La devo
sollevare sveglio ogni
alba, per infilarla in bocca; poi
con acqua la ingoio fissando sul guanciale
l’orma di lei che mi spacca
i polmoni per respirare. Se resisto son
degno.
da Casa d’aquila, Levante Editori, Bari 2008

Kid (Racconto inedito)
Fin da bambino ho sempre dovuto insegnare qualcosa a mia madre. Con la sensazione, ogni volta che la portavo ad essere differente da quel che era, di allontanarla dalla morte. Ingoiavo io qualche pezzettino di quella dandole in cambio una parte viva del mio corpo. Siamo pertanto giunti a un rapporto quasi eroico che però non ha niente a che vedere con l’amore spontaneo o con la riconoscenza. E’ qualcosa di più: il mio IO spropositato ha bisogno di una sua spropositata fragilità perché di questa campa, anche consumandosi.
-Sai quel’è il vero senso della letteratura?- le faccio domande di questo tipo; in tal modo mi addestro. Lei continua a mangiare ma pensa. Pensa anche di avere un figlio strano, le cui ampiezze mentali vanno e vengono all’improvviso. Come nell’imbecillità, che è lo stato originale prima dell’organizzazione. Insisto:
-Finché, per esempio, stimerai un grande architetto, ecc, qualunque fenomeno che ti sembri sul serio un fenomeno, non farai grande letteratura. Devi spellarlo vivo per guardargli bene le bucce e quando gli avrai trovato il punto debole sarai sulla buona strada. Ogni grande talento è un bravo scassinatore. Il più abile scassinatore delle proprietà altrui è il più grande artista.
-Vuoi dire che “questo” è il tuo metodo?-
Chiede o riflette, ma va bene: la mezza misura addestra. Devo solo stare attento che non arrivi alle conclusioni da sola. Quelle, deve impararle da me.
-No, intendo dire che questo è il metodo migliore…
Poi insisto, calcolatamente noioso:
-Il Metodo è ogni metodo degli altri. Qualsiasi attività altrui è la tua professione. La letteratura è ciò che sanno fare gli altri, ma tu devi farlo meglio di loro perché sorvegli anche tutto il resto e contemporaneamente.
-Mah, a me pare un modo d’essere invidiosi!
Spesso fraintende, però così posso andare avanti.
-Non potrei mica essere invidioso di un’ape, che c’entra. Eppure mi interessa anche il metodo delle api. L’invidia non è solo cattiva, cavolo!
Non c’è da meravigliarsi se non regge il mio ritmo. Smette d’ascoltare, nel suo solito stile, stile solo suo perché lei non ruba niente. Sposta il discorso su qualcosa di personale, mettiamo la collana che ha al collo. Dice, parlando di sé:
-Povero tesorino, tutti i gioielli me li son dovuti comprare io, coi miei risparmi. Mai un regalo, neppure quand’ero bambina. Il primo anellino me lo feci con una campanella da tende. Mi faccio tanta tenerezza...
Come no! Lei è l’unico fenomeno che faccia saltare i muri di casa, con la sua irrazionalità: E io che amo la logica, ammetto che i muri saltino, pur di renderle omaggio. Non perché sono suo figlio, non basta. E’ qualcosa che ha a che fare con la letteratura. Devo inseguirla perché possiede quel che non ho. Ha vitalità mentre io ho solo frenesia. Devo imparare. Lei parla persino coi tappeti, dal grande ottimismo che possiede; io dovrei vivere nel Tibet almeno un anno prima di riuscirci. Non so cosa la faccia agire e pensare in questo modo. Devo allora tenere alta la guardia, non perderla di vista e allo stesso tempo guardarmi le spalle, perché lei è il mio compare.
-Finirò con l’essere mediocre quanto te, se non la smetti coi tuoi anellini!
Le grido mentre termino la frutta; un po’ di vino mi va di traverso. Cerco di mantenermi calmo ma ancora non ho lo stile giusto. Quello di Hendry Jones, per intenderci. Dovrò impossessarmi di quel tono medio indifferente a cui non tremano mai le mani o la voce, anche quando pensa “la mia vita è andata”. E poi si gira, Hendry nel film, e questo potrebbe già finire su quelle sue dita ferme. Tipi così hanno il dono dell’ovvio. Come mia madre. L’Ovvio alla grande. Ogni mistero fonda qui la propria vitalità: nel piccolo sta il grande, mentre non è sempre vero il contrario. Quanto dico, Hendry detto il Kid, doveva saperlo fin da bambino. E solo per questo poté rispondere “e con ciò?”, alla fine della sua storia su questa terra. Tre parole così, dette a un certo punto, valgono un treno di neologismi. C’è bisogno di modi, soprattutto questi, fanno letteratura.
-Sta tranquillo, ho capito!- mia madre sorride. Poi respira profondamente perché ha il cuore debole. Potrei sentire il suo respiro da tre metri di distanza, come una sveglia dentro un cassetto “ce ne stiamo andando, Kid” allora penso.
Oggi comunque il ragno è stato affar suo. Nero, grosso, con una schiena ad attico. Quando l’ho colpito col piede, gli ho solo spolverato le spalle; è corso via ridotto a metà. Mia madre invece l’ha preso in pieno:
-Era una femmina- ha spiegato- sopra portava le uova.
-Che schifo!
-A te fa schifo tutto, anche la natura. E’ per questo che mi chiami col nome di battesimo.
-Mi viene naturale, che c’entra- le ho risposto quasi con meraviglia.
Che c’entrava, metter di mezzo sempre la biografia. Ma lei fa così, è il suo stile; siamo due compari. Ho pensato meglio non approfondire, queste cose non servono a niente, né a vivere né a scrivere.
Ma mi aveva colpito, Come un ebete nel mio studio continuavo a ripetere “mi viene naturale, ecco tutto, che c’entra”. Anche chiamare i miei libri preferiti col nome dell’autore, il titolo me lo scordo, ma non Dylan o Henry; il titolo non conta. Anche in loro cerco le persone perché cerco un segreto, come in mia madre. Anche quando guardo le nuvole tacchino. Non contano un accidenti le nuvole, ma sì il fatto di vederci dei tacchini. E’ il mio modo di guardare le cose, che conta. E questo ce l’avrò sempre, anche se le nuvole, in tutta la mia vita, non torneranno più ad essere come sono in questo momento. (1984)
Il tritacarne (Racconto inedito)
Io mi addormento con difficoltà. Devo prima fumare molte sigarette, poi camminare un bel po’ all’aperto, quindi tornato al chiuso, discutere con il sonno e fargli qualche buona promessa. Solo allora, se la posta è abbastanza alta, lui decide di stendersi accanto a me. E inizia così il nostro dialogo come iniziassero dei racconti. Gli unici racconti solo miei, cioè offerti dalla ditta; e garantisco che sono i migliori racconti che uno potrebbe mai scrivere.
Ogni notte io sono un grande autore, perché appunto tale tecnica mi costa sempre molta fatica e disciplina. Se sono arrivato a immagini essenziali e pulite; se i sogni barocchi di quando ricordo d’aver iniziato a sognare sono partiti da bravi verso notti altri, è perché con il tempo, i miei patti si facevano più risoluti. Allo stesso modo che sempre più stentavo ad addormentarmi. Ma così sono passato –come dire- dalla poesia alla prosa e poi sono giunto a quella autentica poesia ch’è solo un certo tipo di prosa.
Ora, la validità maggiore del mio sonno sta nel fatto che mi corregge la vita. Non la consola, la corregge. Tutti sappiamo che la vita è abbastanza retorica. Vi si consumano molti macelli soprattutto in nome della speranza. L’origine dei nostri mali, per me, è la speranza che è cieca, mentre definiamo cieca la fortuna che invece è, al massimo, originale o sciocca.
Non sostengo che la vita sia apparenza. La vita concede delle verità, come i miei sogni, solo che questi tolgono il refuso clamorosamente più umano e in buona fede. Cancellano insomma la speranza, cioè quel tipo di bellezza solo retorica che è il condizionale. Quello per cui tanti corrono felicemente al macello con l’illusione che il meccanismo potrebbe all’improvviso incepparsi. Prima della fine. Chiamano questa tecnica senso dell’esistenza; e beati se s’accontentano.
Io sono ormai giunto a tale grado di bravura per cui sono felice solo in base all’esattezza delle mie bozze.
-Beh, ora vado a dormire- dico uscendo di casa, prendendo un nuovo pacchetto di sigarette.
-Hai bisogno di qualche consiglio?- fa mia moglie.
-No, perché?
-Si dice che la notte lo porti. Si dice dormirci sopra, non è cosi?
-Si dicono tante cose.
Lei ha i piedi nel tritacarne; un giorno glielo dirò. Perché lei ama i proverbi, ci tiene ancora alla bellezza e annega nel condizionale.
-Si dice anche che sei stufo di me?
-Anche.
-Il tuo sogno allora ti consiglierà di “cancellarmi”.
-Anche.
-Insomma, non sai dire altro che anche?
-Sì, e prometti di chiamarmi Signor Anche. C’è qualcosa di sensuale. Io ti chiamerò Signora Potrei. Allora. La signora Potrei in Anche teme i sogni di suo marito perché non ama la buona letteratura.
-Qualcosa in te non funziona mica!- dice sconvolta.
-Lo so. Troppo assonnato.
-Guarda che un giorno invece sarò io a lasciarti.
-Può anche darsi.
-Ma si può fare almeno un discorso serio con te?
-Anche due. Domani però, ora vado a dormire.
-MA SE STAI USCENDO.
-Mia cara Potrei, io non ho bisogno di consigli, come dici tu. Non ho bisogno di lasciarti né di dormirci sopra. Né di essere amato o di amarti. Io non ho necessità a breve scadenza perché tutto, dico tutto, mi è efficacemente superfluo. E ora, se preferisci, dirò che vado in biblioteca.
Io sono il più bastardo, freddo tranquillo organismo vivente. Il signor Anche sa cos’è una pagina ben scritta. Di quelle che non si leggono da nessuna parte tanto sono ben scritte, perché non ce ne sono di così vere. Non ne esistono di così, tanto sono sincere. Non hanno niente a che fare con l’amore, non si noterebbero neppure, né farebbero bella figura perché hanno perduto la speranza. Ma sono le uniche che andrebbero scritte, uno di questi giorni, ad avere coraggio e coscienza e tranquilla fedeltà a se stessi. Solamente un signor Anche può farcela, con una simile sincerità. Essere il peso straordinario d’un uomo e compiere l’azione esterna di trasportare se stesso nel buco nero della verità col la massima leggerezza. M’è costato riuscire a crederci; m’è costato il prezzo di capire che la verità non è mai mortale quanto invece lo è la bellezza o la felicità. M’è costato come spengermi. Perché questo è il rigore dei miei sogni: mi tolgono il senso della morte e il senso della speranza, e ogni volta mi risveglio più freddo. Ma non credo ci sia altra tecnica. (1984)
Cristina Annino, nata ad Arezzo, vive e lavora a Roma. Nel 1968 pubblica il libro Non me lo dire, non posso crederci, edito da Techne a Firenze, città nella quale si laurea in Lettere moderne. Nel 1977, Ritratto di un amico paziente, Roma, Gabrieli. Nel 1979, Boiter, con Forum, Forlì, (romanzo). Nel 1980, Il cane dei miracoli, Foggia, Bastogi. Nel 1984, L’Udito Cronico, in “Nuovi poeti italiani n. 3, Torino, Einaudi. Nel 1987, Madrid, Corpo 10, Milano, libro vincitore del Premio “Russo Pozzale” nel 1988. Nel 2001, Gemello Carnivoro, Faenza, e nel 2002, a Prato, in collaborazione col pittore Ronaldo Fiesoli, Macrolotto. Nel 2008, Casa d’aquila, bari, Levante Editori. Ancora inedito il libro di racconti Una Magnifica Giovinezza. Numerose le plaquettes, recensioni e pubblicazioni in prosa, poesia, saggistica, in molte riviste e antologie sia italiane che straniere. Da alcuni anni si occupa anche di pittura.
Lucetta Frisa, poesie inedite da "Private city"
La musica èun’operazione per sottrarsi alle leggi di questo mondo (...) alla sua salda disumana materialità.
Henri Michaux
Danza dei dervisci ruotanti
la superficie del divano
non è pelle marina
l’onda non scopre tesori
quando a caso si sposta.
Restiamo qui seduti. Beviamo vino ed èbuio.
Danzano solo i pianeti.
Stesso colore della spiaggia a quest’ora e del suono
che batte sulla sabbia poco lontana e vorremmo
non essere piùnoi non essere
da nessuna parte
non piùfantasmi con le loro catene di parole
per legarci ad un senso.
Perché la pelle che avevamo un giorno
è ora larva strappata
in nessun luogo e modo traducibile?
Le nostre maschere tragiche ruotano nell’aria del salotto:
se solo potessimo sragionare,
nessun confine è perduto e il mare non sta qui e noi
sulla riva del divano
– mai partiti.
Quando saremo infine bambini e come?
Perchéla pelle scorticata solo lei
sa dirci dell’ustione in fondo all’estasi?
Questa èla nostra casa che danza
accogliente trappola e tempio
intorno a noi gira e misura
muro e soffitto
fa apparire sparire
il futuro
ci chiude gli occhi
la bocca
i libri
i balconi.
Toccata settima
(Girolamo Frescobaldi)
una scala sale e poi si ferma.
Resta lì a creare
altre scale
senza condurci
da nessuna parte.
L’aria chiama slanci
verso un aperto sempre più aperto
un alto sempre più alto.
Una stanza d’aria ferma
ha il peso specifico
dell’arabesco vaporoso
che non snida nulla.
La mia carezza resta a metà –
si crea a cerchio la sua aria
foglia che non va
né su né giù.
Dove siete anime dei cieli promessi?
Qui non ci sono voci
néparole, nulla progredisce
o torna, si danza o si fa finta
su passi sottili
distanti dal pensiero.
E io ti chiedo: dove sei?
E tu rispondi: dove sei?
Non c’è nessuno, qui. Neppure noi.
Concerto per la mano sinistra
(Maurice Ravel)
se il disordine segna i mutamenti
riaffiorano
i versi sbigottiti
galleggiano
verso nuovi mormorii.
Ciò che manca è la forza
di confonderci e rifare una gioia di sorprese
dalle menomazioni.
Le assenze
hanno germogli al buio
da coltivare attentamente
perché le ombre
raccolgono l’energia dei millenni
i profili potenti di terre morte
le trame
di chi in loro ha creduto
nelle ore diurne.
Chi si ripara nell’ombra per godere la luce
sceglie la parte sinistra di sé, gli oscuri
lobi temporali che dirigono
occulte partiture.
Ora tu suoni
per me per noi
per questa casa saturnina che a ogni nota
si frantuma un po’ di più.
Moduli assenze come
vuoti virtuosi
pause musicali.
Impari e dimentichi
Impari e dimentichi
e non smetti mai di suonare.
Naima
(John Coltrane)
dolcemente strappa la pelle
del viso
scivola
giù
indolore
fino ai piedi
I nervi
viaggiano
tra cartilagini e giunture
elettrica rete
s’infiamma
pietra miliare
snodo
sinapsi
da fiato a fiato
da sponda a sponda
L’arte
di ingannare la morte
è tutta nella gola.
Exodus
(Fausto Ferraiuolo)
dove andare
dove andare fuori da questo luogo
senza bagaglio e scarpe
di notte
col nostro scheletro
e un pensiero martellante
dove andare
fuori da questa stanza che ci spia
dai suoi oblò
con musica narcotica
acqua materna di fiaba
narrata
da mille e mille anni
verso altra diga o scafo
o sfondato mare?
come un popolo
sempre in cerca della sua aria
sempre in cerca
finisce
contro un muro
Queste poesie sono nate dalle suggestioni di brani musicali ascoltati nel corso di lunghe serate estive.
Lucetta Frisa, poeta, scrittrice e traduttrice, è nata e risiede a Genova. Tra i suoi libri di poesia: La follia dei morti (Campanotto,1993), Notte alta (Book,1997), L’altra (Manni,2001), la silloge Disarmare la tristezza (Dialogolibri,2003), Siamo appena figure (GED, 2003), Se fossimo immortali (Joker, 2006) e Ritorno alla spiaggia (La Vita felice, 2009). Tra i libri tradotti, ama ricordare i due di Bernard Noël: Artaud e Paule, 2005, e L’ombra del doppio, 2007 (entrambi per le edzioni Joker). Presente in diverse antologie come Il pensiero dominante (a cura di F.Loi e D.Rondoni, Garzanti, 2001), ha scritto in prosa, con Marco Ercolani, l’epistolario fantastico Nodi del cuore, 2000, e Anime strane, 2006 (entrambi per Greco & Greco) e Sento le voci (La Vita felice,2009) e insieme curano la collana I libri dell’Arca per Joker dove è appena apparso il suo Sulle tracce dei cardellini. Collabora alle riviste cartacee: La Clessidra, La Mosca di Milano e L’Immaginazione oltre a diversi siti-web tra cui http://rebstein.wordpress.com. Sempre in prosa, scrive racconti per ragazzi in Popotus, inserto del quotidiano Avvenire.
Varie volte finalista al Premio E. Montale e L. Montano, ha vinto il Lerici Pea per l’inedito 2005.
Alessandro Morino, poemetto inedito "Nella sospensione"
1.
nella sospensione
derivo il mio stato d’essere
la mia costanza
all’incostante
nella sospensione
2.
e se tutto finisse qui – ora
cosa ne resterebbe – cosa
di noi – o d’altro
di desiderio relitto del giorno passato
ma già qui – domani – tra noi
3.
derivo il mio stato d’essere
la mia ombra di costanza
nella sospensione
gioco le carte che non so tenere
e derivo il mio stato d’essere
4.
cosa ne resterebbe – cosa
di noi – o d’altro
se tutto finisse qui – ora
nel giorno andato di un relitto
cosa ne resterebbe – cosa
5.
la mia costanza
nelle mie mani
nella sospensione della carne
nell’istante di domani
ma già qui – ieri – tra noi
6.
di ieri – o d’altro
cosa ne resteràancora
se tutto finisse qui – ora
di desiderio relitto del giorno a venire
ma già qui – ieri – tra noi
7.
nelle marce mani
nella sospensione delle mie dita
scompongo ciò ch’è stato
la mia costanza
la vacuità nelle mie mani
8.
cosa ne resterà ancora
se tutto finisse qui – ora
di domani – o d’altro
del desiderio già stato a venire
ma già qui – domani – tra noi
9.
nella sospensione
raccolgo gli avanzi di un uomo
putrefacendo il mio stato d’essere
pietrificando la costanza
nella mostra senza forza
10.
e se tutto se tutto finisse qui – ora
cosa s’arresta ancora – nella cenere
cosa ne resterebbe – cosa
di noi – o d’altro
o della cenere finora in avanzo
11.
relitto di un segno marcente
nell’arresto passato
la mia costanza
giàqui – domani – tra di noi
come se tutto finisse
12.
qui – ora
di noi – o d’altro l’istante
giàstato nel giorno a venire
nella cenere delle mie dita
conservo le carte che non so giocare
Alessandro Morino nasce nel 1980 a Roma, dove attualmente vive e lavora.
Nel 2008 consegue la laurea specialistica in Filosofia e Studi teorico-critici presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza con una tesi in ‘Ermeneutica artistica’ dal titolo “Antonin Artaud o l’esperienza artistica di una rivolta”.
Nel 2009 viene premiato con menzione d’onore per una poesia inedita al Premio di poesia “Lorenzo Montano” XXIII edizione, sezione “Poesia inedita”, presso Anterem. Rivista di ricerca letteraria.
Nel Giugno 2008 pubblica il suo primo testo poetico dal titolo “Propriocezione di un feto riflesso dal libo si se stesso” edito presso le Edizioni Polìmata, Roma.
Nel 2008 pubblica l’articolo “Artaud: il gesto della parola” nel numero 39, anno 13, 2008, della Rivista di letteratura contemporanea Avanguardia.
Nel 2007 viene premiato con menzione per una raccolta poetica inedita al Premio di poesia “Lorenzo Montano” XXI edizione, sezione “Raccolta Inedita”, presso Anterem. Rivista di ricerca letteraria con la raccolta “Visioni della carne nuda”.
Nel 2005 pubblica alcune poesie nella Collana “Orizzonti” della Aletti Editore. La poesia Ricordi edita ne “Poetici Orizzonti” vol. 5, maggio2005; la poesia Ho provato edita ne “Gli Internauti”, giugno2005; la poesia Cos’è edita ne “Poesie del Nuovo Millennio” vol. 3, giugno2005; la poesia Tacito edita ne “Antologia dei Poeti Italiani Contemporanei” vol. II, dicembre 2005. Le poesie In quegli occhi di terra di fuoco… e C’è una maschera appesa alla ruota… edite da edizioni Pagine nella raccolta “L’Eco del vento” 2006.
Nel giugno 2005 partecipa al Premio Letterario Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni” XXII edizione sezione Poesia in lingua italiana presso L’Iride Associazione Culturale .
Ha tenuto reading di poesia e istallazioni verbo-sonore nel 2005 (Ci – Gît Viola, Roma) e nel 2008 (Costruzione n.1: Nigredo, Roma).
Nel Febbraio 2010 uscirà il testo poetico “Nuda Stabat Mater” pubblicato nella collana di poesia ex[t]ratione, edita presso le Edizioni Polìmata, Roma.
Dal 2005 si dedica più assiduamente anche alla pittura. Autodidatta, tiene la sua prima mostra collettiva “meta.stasi” presso la Sala comunale “Marie-Renè de La Blanchère”, nella Città di Terracina. Nel Settembre 2009 espone in una collettiva presso il Museo “Antiquarium Comunale”, nella Città di Sezze. Nell’Ottobre 2009 espone per la prima volta a Roma, nella collettiva “Esperienza Estetica” presso la Galleria Montoro.
Contatti: www.alessandromorino.net per vedere i lavori pittorici e poetici.
info@alessandromorino.net
Dalla III Biennale Anterem, interventi teorici e creativi di Giorgio Bonacini, Flavio Ermini, Carlo Penati
Dalle giornate della III Biennale Anterem di poesia, filosofia e musica, riportiamo i contributi teorici di Giorgio Bonacini (Oscurità 1) e Flavio Ermini (su “Viaggio attraverso la gioventù” di Lorenzo Montano), seguiti dalla cronaca in versi dell’ultimo evento (“Controcanto di giornata”) composta da Carlo Penati.
Carlo Penati, Controcanto di giornata
“Controcanto di giornata”
Cronaca in versi del settimo appuntamento della Biennale Anterem di poesia
Sabato 5 dicembre 2009
di Carlo Penati
la parola abbonda
abbandonata nell’aria
Stefano Baratta, La parola nella psicoanalisi
i nomi di Jung ho chiamato a raccolta
conclamanti forme dell’anima
per pronunciare la parola indicibile
che la psiche crea a ricrea
adattando e riorganizzando il mondo
anima-madre eccede,
soffocanti abbracci
invadono il conscio
anima-donna rivela il simbolo
e nell’archetipo profondo
traccia impronte che svelano
il sentiero dell’ombra
dove le parole affiorano
gravide di ogni senso cercato
Trio musicale: Stefano Baratta, Stefano Benini, Andrea Tarozzi
scivolano suoni a risvegliare
gli animali quieti dell’anima
turgidi risvolti dei ritmi spezzati
nel jazz regolatore d’influssi
l’emozione ondeggia negli specchi
dei flauti che tessono e ritessono
sul moto estenuante del piano
lasciami scendere senza freni:
l’arrivo è solo un abbraccio
e riparte il cuore palpitante
dal silenzio
che cosa sale dal fondo dell’anima?
o il suono confonde i piani
e non mi avvedo di quanto scende
palpitando nell’inconscio?
scende e sale in appassionata danza
gioioso battere di tasti in sequenza
che parlano voci lontane
evocando dai fiati risposte di memoria
ingenui scambi di ruolo
all’apice il rigo s’arrotonda
e solleva e risolleva la passione
insisti sulle corde già tese,
continua il sentiero dell’accordo
scomposto e ricomposto ad libitum
come accarezza il flauto la soglia
di stanze profumate ed assenti
Rosa Pierno e la poesia di Rinaldo Caddeo
l’ombra avvolge a poco a poco
che strano gioco il suo impalpabile movimento!
più mi ricopre e più nasce conoscenza
più è oscuro il giorno
e più la parte chiara di me affiora
stende una patina di luce
proiezione di leggera sostanza
Rinaldo Caddeo
sostanza oscura è l’ombra
sorella muta che accompagna
nella sua pretesa insistente
ogni passaggio di vita
un corpo che non proietta ombra
è la figura nitida del passato glorioso
laddove implode ogni conclusione
e l’epilogo consegna
mani piedi e sangue
all’alfabeto della nostra vocazione
Rosa Pierno e la poesia di Mauro Germani
superstiti parole s’affrettano
nelle strade e negli odori
tra ricordi e sogno
dove morti e vivi si susseguono
nel prendere e strapparsi la parola
solo negli altri mi ritrovo
Mauro Germani, Livorno
Livorno èl’altra
quella che non appare
e invoca il mare e la sua terra
che s’immerge in un cielo scoperto
domande in bilico all’altare
di divinità prive d’ascendenza
lì la voce brucia ferita dagli anni
e si perde in un vento straniero
Francesco Bellomi al pianoforte uno
John Cage Dream 1948
sogni sonori le note di Stravinskij
FA-RE-FA-RE lattiginose, testicolari
nel cerchio dei suoni prescelti
che escludono per sempre i diversi
attorno a sette note sogna John
e solo a quelle assegna un compito impossibile:
colmare d’immagini la sera
che avvolge Verona e i suoi poeti
nel rito dei segreti ormai svelati
Flavio Ermini introduce Franco Rella
Hölderlin sull’esergo dice la vita:
solo genera parola
chi interroga il proprio cuore
e sprofonda lo sguardo
nell’anima del vasto mondo
le strade in cui ci avventuriamo
nell’abbandono di ogni apatia del pensiero
Franco Rella, La parola postuma
fuori dalla città i poeti,
menzogneri che traviano dal vero!
l’essenza delle forme persa
nella paralisi dell’anima
ecco la ragione s’impone
sull’antico dissidio tra poesia e filosofia
la poesia irresponsabile della verità
inganno di versi affascinanti
distoglie la mente dall’oggetto
diaforà di strade antagoniste
innamorato che si stacca
nel sacrificio della poesia bruciata
dalla tragedia dell’amore
vinto l’agone col Simposio
ma resta il vuoto della rappresentazione
che Benjamin richiama con Cartesio
nel gioco del rimando
tra ciò che vedo e la sua specie
m’inoltrerò con coraggio nella culla delle parole
a catturare lo stupore del sogno
e immergerlo nel logico rigore
dell’ermeneutica più pura
custode dell’inesprimibile
attizzi il fuoco degli spiriti
che frantuma nell’orrore ogni forma
prima che la parola sapiente ricomponga
nell’unità di senso
l’incomposto sgranarsi di sostanza
nell’onirico volgere dell’estasi
la singolaritàconfina ai margini della città
ma la tragedia accomuna
chi pensa e chi poeta
in un identico coro della vita
il poeta è vincolato all’ombra
nel gorgo di bene-male indistinti
nell’indecisione che gli spetta
è la metafisica il campo dell’incontro?
la contraddizione sfuma nella coesistenza del diverso?
l’apparenza è il volto noto dell’ombra
dove l’indicibile alligna
e viene a volte in superficie
nella stentata trama dei ritmi di parole
attrito surreale del senso sulla carne
della realtà sullo spazio estetico
pensiero-sentimento
la polis riaccolga con gioia
chiunque ci doni conoscenza
Francesco Bellomi al pianoforte due
composizione su cinque tasti scelti a caso usando il timbro-ritmo e non la melodia
insiste il tasto in un ritmo d’industria
ma il timbro della natura riaffiora
nello strappo di un FA alto
che acutamente rimanda
al volgere del sogno
Rosa Pierno e la poesia di Giuliano Rinaldini
uno sguardo che non vede
pone la memoria sugli oggetti
che il tempo rende ossario
e la natura sviscera l’immondo
dell’artefatto di ogni morale
Giuliano Rinaldini, Sequenza del fico
sussulto nei rovesci della terra
allo sguardo che animali di pianura
disegnano nella messe di campi sfioriti
e il coro dei canneti scompone
il rettifilo senza spessore della strada
Rosa Pierno e la poesia di Giovanni Turra Zan
gli insetti della convivenza
nell’acido sussulto di versi civili
intrusi aggettivi dirompono
dall’accogliente placidità del giorno
Giovanni Turra Zan
distoglie da ogni oggetto
il rimando a sensi altri
di parole composte in segni alterni
che culminano in immagini
risolte dall’incavo di un prisma
Filippo Ravizza, Il turista
senza scampo m’affaccio
sul cerchio dell’essere/nulla
e mi sdraio al sole dei ricordi
nei luoghi che ri-conosco miei
il vero destino è un muro bianco
e oltre andare è il verso
Alberto Mori, Fashion
la vita viene detta dalla moda
strascicata la parola f-a-s-h-i-o-n
è suono di cromi di tessuto
che vestono il futuro
l’olfatto trattiene il rigonfio dei corpi
in abissi lastricati di lustrini
Francesco Bellomi al pianoforte tre
Tasti scelti dal pianista ed altri scelti a caso
ascolta l’anima e il conto del tempo
nel riverbero di note
che l’abitano ab origine
il cerchio ostinato del ritorno
come un temporale in fuga
rilascia lente gocce
di luce compulsiva
Flavio Ermini presenta Silvia Ferrari
piacere nell’ascolto di parole
che danno consistenza all’inconcluso
con l’aggiunta di un provvido segno
Silvia Ferrari, La parola nell’arte
la parola erompe nell’arte
decostruendo il campo dello sguardo
fino al contratto spasmo degli esse-emme-esse
ogni espressione ha senso
se solo rimanda ad altro
così l’elettronica diventa gregoriano
e la sinestesia racconta il nuovo incontro
dei linguaggi controversi
Francesco Bellomi al pianoforte quattro
basso ostinato accende ricami
di foglia, alloro, rincorse
velluti e tragici ossimori
Emanuele Modigliani
la prosa distende il racconto
in periodi di tempo e di senso
nel breve identico corso
di scene stirate sui muri
Carlo Penati, Vorrei imprimere un vuoto nell’aria
l’aereo s’innalza pesante
gravido delle spoglie di vite
sempre in agonia
nel duro lavoro del senso quotidiano
alla ricerca, ahimè, dell’infinito
Francesco Bellomi al pianoforte cinque
giro di do nascosto
maschera, confondi la ragione
di un cerchio ripetuto di note
se trovi la cifra che apre
verità di musica interna
contorno di rassegna
gran finale
Carlo Penati (Legnano 1954) è stato redattore del periodico di ricerche e analisi linguistiche "Pianura". Nel giugno 2008 ha vinto il 29° premio letterario "Città di Moncalieri". Sempre nel 2008 ha pubblicato Vorrei imprimere un vuoto nell'aria, Fara Editore, prefazione di Luigi Metropoli, segnalato al XXIII "Montano".
Giorgio Bonacini, Oscurità 1
Le parole, quando pensano il vero, si muovono all’interno di un sistema che ha a che fare, in qualche modo, con una zona franca della materia in cui ogni trasformazione sembra, se non attuabile, possibile.
Tutto è, concettualmente, materia; e ogni contrapposizione genericamente intesa sotto dualismi del tipo palpabile/impalpabile, sensibile/insensibile, visibile/invisibile, ecc., è priva di senso in termini concreti.
La poesia non ha preferenze operative: èessa stessa a determinare una selezione, svolta in astratto, per una considerazione fisica che permette di scrivere e di misurare la significatività dei propri testi.
Se guardo il mio linguaggio (che è anche una riflessione implicita sull’an- damento e sulla forma del vivere) penso al modo in cui i suoi tratti “irridici- bili” implodono all’interno della sua stessa assenza di potere.
Credo che ciòpossa rientrare in un’idea patafisica; una sorta di felicità mentale in cui però, alla scienza delle soluzioni immaginarie, devo aggiun- gere una metodologia dell’indecisione materiale.
Cosìil procedimento slitta su zone deformate, in modo tale che l’unica contrapposizione valida è forse quella fra realtà e reale, dove la poesia non si occupa, né potrebbe in alcun modo farlo, della realtà.
Si preoccupa invece della sua insistenza, della sua presenza che deborda in luoghi e tempi non giustificati dalla fatica o dallo sforzo di un io che non è mai, per fortuna, né curativo né rispondente a sé.
Bisogna allora organizzare un nucleo di tensioni che siano, nello stesso tempo, impermeabili e traspiranti, per far sìche la scrittura fuoriesca e di- venga un’indicazione esatta di ciò che chiamiamo reale.
E ciòche èreale èl’incarnato di una parola, la sudorazione fonica, l’esilio indefinito dell’esperienza individuale, inconciliabile anche con il carattere volontaristico di questa dichiarazione di poetica.
Sono cosciente che tutto ciòpotrebbe fallire, ma se ciò che creo è davvero reale allora posso far leva sui dintorni di una felicità quasi sofferta, parziale, pacata e senza tregua ma attentissima e precisa.
Perciòqualcuno ha scritto che “gli oggetti hanno evidenza nel vivente, tra le cose”; e in poesia queste resuscitano e si distinguono con una tale ric- chezza di particolarità che ancora mi stupisce.
Reale: la parola unisce in sé tutte le manifestazioni dell’immaginario, le intermediazioni naturali, i ritmi logici, le condensazioni, gli addensamenti e i pregi di una disquisizione imperfetta.
E’ lo sgretolarsi di un pensiero languido e scaltro, l’incedere elusivo attra- verso cui ci si ricorda che alle volte anche gli amori più invidiati (o più atmo- sferici) confondono gli oggetti con le cose.
Le cose del pensiero e gli oggetti della mente non sono intercambiabili: sembrano fondersi apparentemente nell’assolutezza del cuore, ma il loro di- stacco, ciò che li rende dissimili, è sempre visibile.
Ma è questa la condizione mitica in cui riconoscersi: “un’addolorante fini- mondo di euforia”, una contraddizione esorbitante a cui si crede ingenua- mente, e da cui si è certi di poter sempre sfuggire.
L’ultima possibilità è dunque borbottare; inventarsi un linguaggio ventri- loquo che finga d’essere falso e rovesci la lingua nelle meraviglie di un pos- sibile giardino interminabile: qualcuno dovrà pur farci caso.
Giorgio Bonacini è redattore di "Anterem". Per la sua biobibliografia vedi "Chi siamo" nel sito.
Flavio Ermini, Viaggio attraverso la gioventù di Lorenzo Montano
Trascrizione dell'intervento di Flavio Ermini per il Convegno su Lorenzo Montano e il Novecento europeo (6 dicembre 2008) nell'ambito della terza Biennale Anterem di Poesia.
Parliamo di Viaggio attraverso la gioventù di Lorenzo Montano.
Questo libro è stato edito per la prima volta da Mondadori nel 1923.
Successivamente (nel 1959) l'opera sarà pubblicata da Rizzoli nella collezione B.U.R., con un saggio di Aldo Camerino. Tale saggio viene riproposto ora in occasione della terza edizione, che si presenta arricchita da una biografia e una bibliografia aggiornate, a cura di Claudio Gallo, oltre che da una mia riflessione interpretativa.
L'edizione, a cura di Moretti&Vitali, è resa possibile dal sostegno della Biblioteca Civica di Verona.
Seguirò in questo mio intervento un itinerario, una sorta di "viaggio", tra le parola-chiave che caratterizzano l'opera.
La prima parola che propongo è: "desiderio".
Cominciamo con una citazione.
Ascoltate come il protagonista di questo grande romanzo definisce l'adolescenza: un «breve tumulto d'ombre cose passioni, incoerenti», fatte di «notti laboriose, alcune pazze, l'uno e l'altro compagno, qualche viso e corpo di donna, qualche paese scorso di sghembo, e quell'attesa, quell'impazienza incessanti …».
L'eroe montaniano si avventura sull'itinerario della gioventù senza calcolo; senza padronanza. Ma con la consapevolezza di un vivere che può aprire le porte all'immaginario, al desiderio.
E proprio a proposito di questo "vivere" Aldo Camerino nella presentazione scrive: «Il romanzo montaniano è il ritratto di un vivere straordinariamente distratto e pieno di voglie».
In questo inoltrarsi nella vita - un inoltrarsi «distratto e pieno di voglie» - tenebra e aurora stanno l'una davanti all'altra, e ognuna ripone nell'altra sempre nuove aspettative.
La gioventù. Sarà lo stesso eroe montaniano a sancire l'impossibilità di coglierla pienamente - e lo farà con una bellissima definizione: «Esita a lasciarci, s'indugia a lungo con noi, infine si stacca a tradimento».
Lorenzo Montano ci fa entrare in una vicenda che nasce come speranza e gioia per incupirsi nella perdita e nella pena, fino a chiudersi con l'ingresso nell'età adulta.
Qui ogni sorriso non potrà che mutarsi in malinconia.
E non può essere che così - se è vera quella definizione di "gioventù" che prima citavo:
«Esita a lasciarci, s'indugia a lungo con noi, infine si stacca a tradimento».
E "gioventù" è proprio la seconda parola-chiave che voglio segnalare alla vostra attenzione.
Il romanzo di Lorenzo Montano è un'opera che fa parte di un preciso genere letterario: il "romanzo di formazione"; un genere letterario che ha le sue radici nel Wilhelm Meister di Goethe (1796).
Ma appartiene a questo genere in modo del tutto particolare. Vediamone il perché.
Nell'Ottocento, intorno al romanzo di formazione si raccoglie una piccola moltitudine di giovani che incarna, con evidente foga, la smania di desiderare. E il desiderio è quello di entrare a far parte - in un modo o nell'altro - del mondo degli adulti.
Questo genere conoscerà poi i suoi ultimi capolavori - che ne decreteranno in pari tempo il culmine e il tramonto - con gli inizi del secolo scorso.
Alcuni di questi capolavori sono: i Turbamenti del giovane Törless di Musil (1906), i Quaderni di Malte Laurids Brigge di Rilke (1910), America di Kafka (1915), Dedalus di Joyce (1916).
In queste opere - anticipate da Gioventù di Conrad (1898) e da Tonio Kröger di Thomas Mann (1903) - c'è un dato comune evidente: la saggezza degli adulti non è più un contrappunto costante alle avventure dall'eroe.
Da qui in poi, pare che gli adulti non abbiano più nulla da insegnare.
Da qui in poi la gioventù comincia - se non a disprezzare la maturità - quanto meno ad autodefinirsi in opposizione a essa.
La separatezza rispetto all'età adulta diventa la vera compagna di viaggio di questi eroi.
A differenza di quanto accadeva nel romanzo di formazione dell'Ottocento, questo vivere gravita sempre più lontano dagli adulti e dalla loro società.
Quel disprezzo, quella separatezza emergono da un'osservazione dell'eroe montaniano, quando, seduto a un caffè, osserva i passanti e annota: «le loro facce così sicure di dissimulare la bestia interna, la quale a loro insaputa fa capolino da tutta la fisionomia».
Insomma, il mondo degli adulti non si configura più come una dimora ospitale.
E dunque il rifiuto di entrare con decisione nell'età adulta sancirà il fallimento, l'impossibilità della "formazione".
Arriviamo allora alla terza parola-chiave: "smarrimento".
Abbiamo visto che Montano, così come Musil, Kafka, Rilke, Joyce, ereditano la convenzione ottocentesca del romanzo di formazione ma vi apportano significativi cambiamenti.
Non è più la crescita a dare corpo all'inoltramento nella gioventù, prima, e nell'età adulta, poi.
Al contrario: è la ribellione, più o meno esibita.
Che l'adolescenza stia diventando sempre più narcisistica e regressiva ce lo dirà in modo più radicale nel 1923 (lo stesso anno del Viaggio montaniano) un altro "tardo" romanzo di formazione: Il diavolo in corpo di Radiguet.
Emerge l'"altro lato" della coscienza adolescenziale: quello "smarrito", e invade le nostre abitudini mentali; rende visibile la precarietà delle nostre regole, la sconnessione del mondo.
Sulla soglia dell'età adulta, lì dove le cose fluttuano e si mescolano, l'eroe montaniano, indugia, così come iniziano a fare tutti suoi compagni dal Novecento in poi, fino ai nostri giorni.
E si trattiene tra le sicure parentesi della giovinezza.
In questo romanzo ci troviamo di fronte a due precipizi che delimitano l'inizio e la fine dell'adolescenza. I due quaderni li rappresentano.
In questo senso è estremamente importante il corollario formato da "Introduzione" e "Aggiunta". Questo corollario ha il compito di farci gettare almeno uno sguardo in quella discesa nel Maelstrom che è l'età adulta…
Da quel gorgo, in una delle sue ultime poesie - poco prima di morire - Montano scriverà: «Adesso invece assidera il mio tocco / la vita, sotto alla mia mano il fiore / di gioventù impietrisce, e si trasmuta / il più dolce dei seni in duro sasso» (1956).
Quel gorgo racconta la notte, ovvero ciò che rappresenta il mondo adulto per gli esseri umani.
Davanti a quel gorgo, nella penultima pagina di Dedalus, Stephen insorgerà con una dichiarazione di guerra quasi programmatica contro l'età adulta e la sua febbre possessiva: « … cercherò di esprimermi attraverso qualche maniera di vivere o di fare dell'arte il più liberamente e integralmente possibile, difendendomi con le sole armi cui consento a me stesso di ricorrere: il silenzio, l'esilio, l'astuzia … Benvenuta, oh vita».
Come non rilevare un parallelismo con l'eroe di Montano? Il quale scrive: «Tutt'a un tratto conobbi che la mia giovinezza era finita … Rimasi attonito allora, ricordo, di trovarmi privato così di colpo di tutta un'età della vita … Mi fermai in una piazza, non sapendo che fare di me … M'era rimasto soltanto un grande smarrimento …»
Un'altra parola chiave per intendere il romanzo è "l'amore".
L'amore è rappresentato nel romanzo da due figure di donna: Biancanera e Delfina.
La loro presenza consente di leggere l'opera anche come una sorta di educazione sentimentale.
Si sa: chi si muove nel giardino di Eros è sempre in bilico tra l'indigenza della mancanza e la ricchezza dell'acquisizione. Ce lo ha detto Platone: penuria e risorsa accompagnano costantemente ogni gesto dell'innamorato.
Questo dipende ovviamente dal fatto che ogni passione amorosa si colloca in uno stato d'insicurezza. Ma Montano ne fa un riflesso dell'adolescenza, dove urge a ogni passo il richiamo alla brevità del tempo di cui possiamo disporre.
A tale proposito, a me pare addirittura didascalico il Viaggio attraverso la gioventù.
Questo romanzo infatti ci segnala che c'è un grande lavoro da fare nell'educazione all'amore, un sentimento che può dare senso e forma al nostro esserci:
--- contro il troppo caos dell'adolescenza,
--- o il troppo ordine dell'età adulta,
--- o semplicemente contro le tante illusioni che ci accompagnano per tutta la vita.
Il viaggio attraverso la gioventù nasce per ricordarci la polvere dell'effimero.
Parla a quella parte di noi che cede alla seduzione - una seduzione rappresentata nel romanzo montaniano da «un braccio nudo ... il pallore abbagliante del viso, la bocca pura, le grandi iridi cangianti».
A questo proposito, l'eroe montaniano davanti a tanta meraviglia, davanti a tanto amore, annota: «... mi pareva di stare affacciato sopra un paese favoloso e strano».
L'Io è un'altra parola-chiave per intendere il "Viaggio" .
Diciamolo con chiarezza: la "formazione" è destinata a fare i conti, all'inizio del Novecento, con la disgregazione dell'individuo come soggetto e con una nuova, incandescente realtà: l'inconscio.
Questa chiamata verso l'Io frantumato - e di conseguenza verso l'introspezione e l'autoanalisi - è imperiosa in tutto il tardo romanzo di formazione.
E risulta così evidente nel Viaggio attraverso la gioventù che può indurre ad accostare questa opera a un altro grande romanzo del 1923: Coscienza di Zeno di Italo Svevo.
Ne abbiamo dimostrazione soprattutto nel primo quaderno, per la forma frammentaria che lo caratterizza, tra schegge di personaggi, atomi di scene, briciole di realtà. "Frammenti" che sono specchio di un continuo soliloquio interiore e di un vibrante processo d'interrogazione. Schegge che provengono direttamente da quel baratro oscuro che il vivere "autorizzato", il vivere adulto, malamente cela.
Sarà proprio l'avventurarsi del protagonista nelle profondità interiori che renderà evidente la definitiva lacerazione tra l'Io e il mondo.
Cosa che porterà Montano alla decisiva scelta di non dare all'eroe un nome e nemmeno «figura».
A tale proposito nelle ultime righe del romanzo leggeremo: «Questo personaggio ha tralasciato nel suo scritto qualunque indicazione che giovi a dare un'idea del come egli apparisse agli altri …».
Lo sguardo e l'ignoto: le ultime due parole-chiave.
Come per il Malte di Rilke anche per l'eroe montaniano è necessario «imparare a vedere».
«Imparare a vedere.»
Vi è un modo di configurare il reale che non si appaga dell'intuizione, ma che preferisce porla tra l'emozione e la riflessione.
La sintesi che ne scaturisce è carica di una sua specifica mobilità.
Viaggio attraverso la gioventù è il romanzo di un saggista. E lo si avverte per come ogni sensazione viene con minuziosità indagata e faticosamente sottratta alle zone interiori, notoriamente poco decifrabili, ma sempre autorevoli.
Accostarsi a queste zone misteriose comporta un movimento che è propriamente il gesto del venire per la seconda volta alla vita. Un gesto che ogni volta mette a soqquadro il mondo.
Ed ecco allora uno dei grandi risultati di questo romanzo: consentire al nostro sguardo di accedere attraverso più prospettive a questi paesaggi dell'anima e di prendere con essi confidenza.
Dopo aver letto Viaggio attraverso la gioventù, sappiamo che proprio per questo motivo va custodita la memoria delle terre incognite dalle quali si parte, delle terre della gioventù:
--- siano esse caratterizzate dalla "formazione" (come accade nell'Ottocento);
--- o dall'"obiezione" (come si rileva dal Novecento in poi);
--- o siano esse un fenomeno della realtà o dell'illusione...
Ci si inoltra in queste terre - nelle terre della gioventù, ci dice Lorenzo Montano - per tornare a smarrirsi nell'ignoto.
Flavio Ermini è direttore di "Anterem". Per la sua biobibliografia vedi "Chi siamo" nel sito.
Gaia Gubbini, poesie inedite da "ritratto fiammingo"
***
serbatoio acerbo
[veleno da svuotare,
taglio che scola]
nel pomeriggio cupo
davanti ad uno specchio
- sfondo scuro:
ritratto fiammingo
***
purple brown
a Mark Rothko
aloni pulsanti
pacati
respiro di sangue rappreso
lividure accarezzate
furore pesto e vivo
***
quiete
rurale
umido silenzio
affreschi stinti
la frescura
riposta
d'umile chiesa
allevia
il carcere
di carne
***
pagine e notti di pallida viola
e parole taglienti come lune;
questo giorno trascorso senza luce
lugubre si dilunga sino all'alba:
l'anima palpita in oscurità,
luce ignea su sfondo perlato.
triste tempo di dolore imperlato,
liquefatta l'amarezza viola
la tiepida quiete d'oscurità.
aspetterò questa notte illune
lamentando il ritorno dell'alba
dai lunghi veli di rorida luce.
occhi pieni di cristallina luce,
cangianti pietre, bagliore perlato:
languida luce di liquida alba,
il vostro bigio riflesso di viola
avvelena crudele lunghe lune,
l'umido mattino e l'oscurità.
distempera lenta l'oscurità;
passa un sogno, arriva la luce.
non vivrò sino alle prossime lune
senza quel volto di astro perlato.
melencolia suona ancora la viola:
senza di lei non v'è notte né alba.
sol una nocte, et mai non fosse l'alba:
così ti volevo in oscurità,
nel fondo buio, color della viola.
bianca, vaporosa venne la luce:
versammo al gelido arrivo perlato
lagrime candide, acqua di lune.
ora nel postumo giorno illune
non ho buio sublime né orrida alba.
ritroso, silente in scrigno perlato
il ricordo nutre d'oscurità.
arriva avvolgente, privo di luce
e lascia nebbia soffice e viola.
saranno lune dai petali viola,
mai più la mia alba di grigio perlato,
non più un'oscurità densa di luce.
***
chantilly bagnata
ardesia translucida
curva gonfia,
livida:
lacrima
Gaia Gubbini si è occupata di lirica trobadorica e del laudario di Iacopone da Todi. Ha pubblicato Tactus, osculum, factum. Il senso del tatto e il desiderio nella lirica dei trovatori (Nuova Cultura, 2009); la raccolta oropallido in Nodo sottile 5 (Le Lettere, 2008) e objects in the mirror are closer than they appear (in «ore piccole» 11 - 2008, con una nota di A. Cortellessa e nel Registro di poesia n#2 a c. di G. Frasca, Edizioni d'if, 2009).
Lucianna Argentino, poesie inedite da "L’ospite inatteso"
- Se non c'è chi veglia mentre tutti dormono, è come se non ci fosse chi ama, chi spera veramente. Maria Zambrano
***
Dice che non c’è addio nelle asole
e asola allora sia:
poca materia intorno e vuoto.
Sia passaggio e allaccio
sia lo spazio dell’abbraccio e del ritorno
sia pertugio e rifugio
sia il chiuso esposto alla parola.
***
Non è che l’ombra del silenzio
questa parola che irrompe
e sgorga necessaria come tutto il bene
che in questo momento è compiuto
nel basso della terra
e si misura ad altezza d’uomo.
***
L’inchiostro scorre
e si rapprende come lava
fa fertile il foglio
fa anse all’ansia
spicca il vuoto alle cornici
ai cornicioni chiede la vertigine
per il salto nel pieno della vita.
***
E’ d’altra specie
e sente in fiamme lente
ardere lo squarcio
sente il costato aperto
e sano l’osso
a pestare la vita
nel mortaio dei sensi.
***
Qui stanno gli anni, le storie inconcluse,
gli sguardi senza più coraggio,
le assenze
dentro i sogni
o le troppe presenze ancora
ancora senza degna sepoltura, per questo
sarebbe meglio cambiare il pensiero
ora che ècambiato il millennio
e il silenzio si èfatto piùfitto
e le parole avvizziscono
cosìche si diradi questa luce bruna
e la paura sorrida di sé
e sollevi il capo dal risentimento.
Lucianna Argentino è nata a Roma nel 1962. Dai primi anni novanta il suo amore per la poesia l’ha portata a occuparsene attivamente come organizzatrice di rassegne, di letture pubbliche, di presentazioni di libri e con collaborazioni a diverse riviste del settore. Fa parte della redazione del blog letterario collettivo "viadellebelledonne". E’ coautrice con Vincenzo Morra del libro “Alessio Niceforo, il poeta della bontà” (Viemme, 1990). Ha pubblicato i seguenti libri di poesia: “Gli argini del tempo” (ed. Totem, 1991), “Biografia a margine” (Fermenti Editrice, 1994) con la prefazione di Dario Bellezza e disegni di Francesco Paolo Delle Noci, segnalato al premio Montale nel 1995. “Mutamento” (Fermenti Editrice, collana “Il tempo ansante” diretta da Plinio Perilli, 1999), con la prefazione di Mariella Bettarini, “Verso Penuel “ (Edizioni dell’Oleandro, 2003), con la prefazione di Dante Maffia (Premio Donna Poesia 2006). “Diario inverso” (Manni editori, 2006), con la prefazione di Marco Guzzi. Nell'ottobre del 2009 con la Lietocolle ha pubblicato una plaquette, “Favola”, con disegni di Marco Sebastiani. Con Pagina-Zero ha realizzato un e-book tratto dalla raccolta inedita "Le stanze inquiete".
Francesco Onìrige, una nota e testi da "Macerie"
da Macerie
Dozzinali
II
Questa che si scrive è un ponteggio,
un empio torreggiare delle lingue,
un’impresa edile.
Che getta fondamenta
soltanto quando è prossima al finire.
V
Questa sta per un’altra che non viene
perchè scrivere è passarsi il testimone
tra il detto e il dicibile non detto
che rimane, cancellato, da una pece;
è il divario tra opera e intenzione,
le altalene,
le supplenze di parole
dette “in vece”.
L’arte del tratteggio I
Ma alla fine vorranno veramente
qualche forma rivelare queste tracce
questo cumulo di linee e di presenze.
Oscilla ovunque la lotta degli opposti:
la stasi s’interpone al moto
come l’ombra si rivela nel volume
per la luce che la limita e contorna,
il pieno con il vuoto,
il suono col silenzio si avvicenda.
Restiamo fissi nell’intermittenza
col sentore che ad essa apparteniamo
fin nel nostro profilo segmentato
tagliato a colpi alterni da una lama
intanto che in disparte
qualcosa già s’intreccia, già si trama.
L’arte del tratteggio II
Ma alla fine vorranno veramente
qualche forma tacere queste tracce
questo cumulo di pause e dissolvenze.
Oscilla ovunque la lotta degli opposti:
il pieno s’interpone al vuoto
come la luce si rivela nel volume
per l’ombra che la limita e contorna,
la stasi con il moto,
il silenzio con il suono si avvicenda.
Restiamo incerti nell’intermittenza
col sentore che ad essa apparteniamo
fin nel nostro profilo dove, continua,
una linea superstite si attarda
intanto che in disparte
qualcosa già s’infrange, già si sfalda.
***
E proprio quando alla fine
dall’opera appena compiuta
ti allontanavi orgoglioso
per ammirarla da lungi,
s’insinua nel tutto compatto
un epicentro che freme:
vacillano travi e frontoni,
la chiave di volta non tiene.
L’abusiva
Tutto è in pezzi, tutto è frammentato:
adesso che ne parlo, si compone.
La tessitura traccia furtiva un nesso
dopo la frana, dopo l’esplosione.
Posano briciole nella grafia minuta
si addensa un cumulo, s’innalza già dal fondo.
Come lo zero, per eccesso d’essere nulla
si capovolge nelle orbite di un mondo.
Francesco Onìrige, Macerie, Selezione Quaderni di Línfera
Edizioni Progetto Cultura, Roma, 2009, prefazione di Maria Luisa Spaziani
Classificatasi al primo posto nella prima edizione del premio indetto dalla rivista Línfera, la raccolta Macerie di Francesco Onìrige, si presenta immediatamente articolata nella duplice e contraddittoria alternanza di immagini di demolizione, di frana, di frammentazione, da un lato, dall’altro, di un parallelo recupero -o almeno, di un tentativo di recupero- di compattezza, di integrità, di ordine. Denunciando all’apparenza la propria autodestituzione con tono sovente rassegnato o sgomento, talvolta invece ironico e beffardo (come nella serie delle dodici brevi, metapoetiche Dozzinali), la scrittura si definisce invece come strumento di comprensione e oggettivazione dell’avvicendamento continuo tra pars destruens e pars costruens, come evocazionne di un perduto “filo di Arianna”, come testimonianza di una residualità destinata a ricomporsi, secondo un progetto che anche l’espediente tipografico che corre tra le pagine del libro tenta di esplicitare al lettore. Così, dai testi, scritti solo sul recto del foglio, alcune parole “cadono” nella pagina successiva, come “macerie” appunto, per assemblarsi nella poesia conclusiva, in cui l’azzeramento estremo si rovescia in un superstite inizio, l’assenza diviene presenza, il caos ritorna cosmos. Scissi tra “un movimento sismico e antisismico”, secondo un’efficace definizione di Maria Luisa Spaziani, i versi suggeriscono pertanto come la cifra più autentica della condizione umana si riassuma in un “abusivismo” esistenziale, che - volente o nolente- addensa i propri materiali in attesa di nuovi crolli, di imminenti ricostruzioni.
Pseudonimo di Francesco Nigro, Francesco Onìrige è nato a Taranto nel 1973, ma vive da tempo principalmente a Roma, dove si è laureato in Lettere con indirizzo storico-artistico. Macerie costituisce la sua prima pubblicazione di rilievo. Una sua precedente raccolta di poesie, dal titolo Messinscena, è ancora inedita.
Immagine di Giancarla Frare, Todesfuge-Celan 2

Matilde Tobia, un’immagine e poesie inedite da "in luogo, in vece"
Prologo (A ben vedere)
I
E lentamente entro,
e batto il tempo.
Come si batte il filo
contro il muro.
S’intersecano piani
e sorgono gli spazi.
Avanzo, adagio,
nel tessuto dato
e creo profondità.
E lentamente batto.
II
Torno con te, in fine,
in dialogo serrato,
e nuovo;
cucio i tuoi punti
a trattenere insieme
diverse ruvidezze
in trame di fiato
lavorate; campi
contigui, distinti
da confini e visitati da
lacerti brevi.
Sembianza
Sembra
profondità poter strappare,
passando appena nuvole leggere,
(e nascondendo forza accumulata altrove)
la trama protettiva di rete famigliare. Dirompe
come vento immobile, al momento. Poi, nega al mio
sguardo una dimora: non vedo, riflessa nello
specchio, neppure un’ombra che mi dica
di fermare (in una forma almeno)
sintomi di rivelate verità
lontane.
Scrittura incerta
Vuoi la profondità negata. Non sai se
un rinato viola, da rosso e blu notturni,
sia sufficiente per mutare il nome al tratto
sottile, che disegni come se fosse di prospettiva fuga.
Epilogo
Sono entrata nell’unica stanza, e in quel bianco
ho racchiuso lo sguardo nel vetro di una lente.
Ho ruotato nel bianco e la materia si è sottratta ai miei piedi,
e si è fatta icona mostrandosi, morbida.
Dispiegato per me ora vedo ciò che devo sapere
così, attraverso la lente, un passo alla volta,
un pensiero alla volta, mi muovo accanto, lentamente.
Un tempo, quel lucido nero è accaduto.
Un tempo, quel lucido nero un passo alla volta si è mosso.
Un tempo, è successo che un passo alla volta ha mostrato l’opaco.
Ora succede che, un passo alla volta, guardo la forma
di quello che accade una volta e poi sempre: una traccia profonda
secondo la lente che ferma nel vetro un istante del tempo,
secondo il disegno del moto seguito a se stesso.
Così mi ha sospinto lontano, il lucido nero.
E adesso, alla mobile luce dei giorni dei mesi degli anni,
rivedo il cammino compiuto, attraverso la lente,
nel fatto accaduto e fissato, nel bianco.
testo scritto per il “Grande cretto nero” di Burri e pubblicato in Quaderni di Capodimonte, n.23, Electa, Napoli 2005
Inoltre (E’ piega nella terra il silenzioso ascolto)

Avete mai voluto immaginare
la tela di penelope lontano
dai narratori, dal loro divagare?
Avete posto mente e amore
al tempo generato, e saturo
d'immagine, da ritmo di colore?
Avete oltrepassato terre e ere
colle articolazioni delle mani
adoperate, della disinvoltura piene?
Avete visto l'accaduto, intanto?
Matilde Tobia vive e lavora a Roma.
Scrive i suoi testi in stretto dialogo con l'arte figurativa, oggetto dei suoi studi.
Ha ricevuto riconoscimenti per il lavoro Come in un libro aperto, e come in una stanza (Quaderni di Capodimonte,n.23, Electa Napoli,2005),poesie per una performance di attori e danzatori, prodotta per il museo napoletano;e per la raccolta Lemmi per uno sguardo, pubblicata nella collana Opera prima (cierre grafica, 2009) diretta da Flavio Ermini e ideata da Ida Travi.
La suapoesia Dall'ombra e da lontano è stata musicata per voce, pianoforte e flauto dal maestro E. Marocchini, nell'ambito della 30° edizione delFestival "Nuovi spazi musicali" (Roma, ottobre 2009), ospitato dall' Accademia di Ungheria, in collaborazione con il Goethe Institut di Roma.
I testi di Matilde Tobia e le immagini ad essi correlate danno sostanza al suo sito http://www.lemmaelabel.splinder.com/, on line dal 2007.
Renata Morresi, poesie inedite da “Vendesi”
da Vendesi
***
Da finestra in cucina una rivendita
d'automobili con un prefabbricato
di lamiera che sorveglia sulla vista
rinculando fino in bagno cieco stanze
ripetute a caso ripostigli d'altre
case gli agenti dicono “non badare
ai letti” letti ovunque sotto le reti
il pudore degli infradito appaiati.
***
In distinto condominio anni 60
finiture in buono stato per le scale
in camera sui muri ombre di mobili
smontati da tempo come una sindone
ma la signora che non aveva figli
ha lasciato l'immobile a un Istituto
di Torino che le regalava sempre
il calendario cioè una volta all'anno.
***
All'ultimo piano 3 vani 2 bagni
soggiorno ampio con angolo cottura
panorama sulla valle momentanea
sospensione degli allacci possibile
ricavare altra stanza-studio poco
rumore dagli appartamenti – ma no
non m'oriento troppo vuoto troppo nord
un vento che il muro non sa confinare.
***
Facciata bianca la palazzina in stile
ha interni di prestigio il cotto in terra
riscaldamento autonomo il cortile
di venti metri e portone blindato
affinché tutto rimanga chiuso dentro
o fuori a seconda del caso o del cuore
e il congegno finissimo non richieda
nuovi trasloco scialbare sentenze
***
La signora Perugini col sorriso
nella porta apre mescolando il gesto
al corridoio come quando allunga
il tavolo da pranzo ai quattro figli
ritratti in cornici blu e gialle e mattone
congiungendo il braccio e la stanza in fondo
come una costellazione o un lenzuolo
ricucito come un palazzo disteso.
Renata Morresi è dottore di ricerca in letterature comparate. Attualmente insegna Lingua e traduzione Anglo-Americana all'Università di Macerata, dove è anche borsista post-dottorato con un progetto di ricerca su transnazionalismo, intercultura e scrittura delle donne. Ha curato con Marina Camboni la raccolta di saggi e traduzioni poetiche Incontri transnazionali: modernità, poesia, sperimentazione, polilinguismo, Le Monnier, Firenze, 2005. Nel 2007 è apparsa la sua prima monografia critica: Nancy Cunard: America, modernismo, negritudine (Quattroventi, Urbino). Sue poesie sono raccolte in Locandine d'artista, Camera verde, Roma, 2009, Registro di poesia #2 (a cura di Gabriele Frasca, d'if, Napoli, 2009), in varie riviste cartacee e on-line tra cui Or, Trivio, Il nostro Lunedì, Absolute Poetry, La poesia e lo spirito, Nazione Indiana; nelle antologie Nodo sottile, a cura di V. Biagini e A. Sirotti, Crocetti, Milano, 2004, Lo stormo bianco, Premio Tina Accardi, Edizioni d'if, Napoli, 2004 e L'opera continua, a cura di G. Vincenzi, Perrone, Roma, 2005.
Immagine di Giancarla Frare, Todesfuge-Celan 4

Recensioni di Marco Furia su Galletti, Marotta, Misako, Plath, Ramsperger, Salvaneschi/Endrighi
Marco Furia è redattore di "Anterem". Per la sua biobibliografia vedi "Chi siamo" nel sito.
Yarita Misako
Un'elegante vita
Con "live", Yarita Misako presenta uno sfondo grigio, sfumato e non uniforme, percorso da linee biancastre, sul quale risaltano, elegantissimi, esili segmenti curvi, distinti nella gradazione di colore e nella forma, tali da porre in essere una figura elicoidale, quasi un inedito DNA.
Si tratta d'una vera e propria danza sempre piùevidente via via che lo sguardo, dopo essersi posato sull'immagine, se ne fa prendere, lasciandosi incantare da un movimento rotatorio non prevedibile, da una leggiadra instabilità che può ricordare certe installazioni mobili di Calder.
Dico "può ricordare", perché qui non si è in presenza d'alcun vivace cromatismo, né di concrete oscillazioni, bensì di accenni intensi e leggeri, statici e dinamici nel contempo, ossia di figure assieme reali e immaginarie.
Nemmeno qualche (pur presente) minuscola scalfittura interrompe la tendenza di questi sottili frammenti a muoversi, ad ignorare il pallido spazio rettangolare su cui si stagliano e, chissà, a disperdersi dopo una circostanza di felice incontro.
L'enigma dell'esprimersi è proposto, con toni né inquietanti né gioiosi, nella sua ineffabile persistenza, annullando il concetto stesso di significato (ma non di senso) in un gesto estetico di rara grazia.
Il titolo, poi, appare molto appropriato: c'è davvero vita in un'immagine capace di attirarci e, con assidua delicatezza, di rapirci, mostrando segreti palpiti, intime cadenze dell'esistere.
Un haiku - visual poem? Forse.
Yarita Misako, "live", in "d", n° 26, 7-20-82-504, kohokudai, abiko-shi, chiba 270-1132, Japan
Sylvia Plath
Affettuosi confronti
Il breve, lucido scritto “Un confronto”, di Sylvia Plath, inizia con
Strana davvero questa invidia, poiché la compianta autrice si è rivelata eccellente talento sia come poetessa, sia come prosatrice e, dunque, ha praticato tanto una prosa, in grado di muoversi con libertà nel “Tempo”, per la quale “niente è poco importante”, quanto una poesia “concentrata”, intensa, breve, “inizio e fine in un fiato solo” (unica eccezione dichiarata, i poemi epici).
Se, nel corso della versificazione, verrà inserito un elemento tratto dalla quotidiana esperienza, questo, salvo qualche felice, raro, caso, forzerà la mano al poeta, tendendo ad assumere il ruolo di protagonista, come accadde alla stessa Sylvia che, avendo introdotto “un albero, un tasso”, non riuscì a “sottometterlo” e finì per scrivere “una poesia su un albero di tasso”.
A differenza di quanto accade nel romanzo, le cose (“uno spazzolino da denti”) non stanno al loro posto o, almeno, presentano spiccate attitudini “a considerarsi degli eletti, dei tipi speciali”.
Il tono, come emerge già dalle citazioni, non è astioso: attraversa il testo una leggerezza quasi umoristica, retta da un’intelligenza sensibilissima, sobria, penetrante.
E non d’invidia, sia chiaro, qui si tratta, bensì dell’urgenza di un “confronto” nel cui àmbito differenze e somiglianze vengono poste all’attenzione del lettore sotto il profilo del fare: non s’indugia su presunti aspetti teorici o fondamenti delle due forme espressive, ponendo, invece, con decisione, l’accento su diversità (e difficoltà) concrete del porle in essere nel rispetto delle caratteristiche di ciascuna, senza dimenticarne i tratti comuni, anzi a partire da essi.
Emergono sentimenti di riguardo, premura, simpatia.
Il titolo del brano, perciò, appare quanto mai adeguato e l’incipit sembra assumere il ruolo della tenera, amorosa, provocazione rivolta da una grande artista della parola non soltanto ai suoi simili, ma anche a sé medesima nella duplice veste di poetessa e prosatrice: leggiadre frasi, precise e pregnanti, con una vena d’ironia terribilmente seria, così, riescono a rendere oggetto di analisi e paragone taluni non secondari tratti di due importanti registri di scrittura.
Proprio dalla suddetta duplice veste, proprio dal tono responsabile e appena beffardo, cioè proprio dall’ambiguità schietta, franca, dell’elegante scritto in parola, si è indotti a riflettere su temi più ampi, ossia, ad esempio, sull’esistenza a priori dei generi letterari e sull’opportunità d’intenderli in maniera rigorosa, rigida.
Certo, diverse forme si mostrano, ma considerarle non imprigionate entro
invalicabili confini risulta doveroso, se è vero che un consapevole, semplice, gesto di affetto, come quello di Sylvia Plath, può superarli.
Marco Furia
Sylvia Plath, “Un confronto”, in “I capolavori di Sylvia Plath”, Mondadori Editore, Milano, 2008, pag. 658
Gaby Ramsperger
Il cavaliere e la sua bella
Con “Pulzella di un giorno distante”, Gaby Ramsperger, immaginando una diversa conclusione dell’ opera “La partenza del crociato”, scritta nel 1856 da Giovanni Visconti Venosta, propone una “ballata” i cui toni eroicomici si alternano a tratti lirico – passionali.
Il “cavaliere dai piedi consumati e stinti” ritorna da prolungate imprese belliche e incontra la sua trepidante pulzella, non più giovanissima, certo, ma ancora innamorata, secondo un tessuto narrativo in cui la poetessa avvicenda versi scherzosi, quasi parodistici, a pronunce che tradiscono una sua partecipazione emotiva (“tu sei stata … / la sola pace”).
Non soltanto, quando suggerisce per via di derisione, va anche oltre: mostra con intento burlesco, ma, intanto, mostra.
E’ come se la canzonatura si ribellasse e fornisse vie di fuga da sé medesima, provocando non ambiguità, bensì compresenza: diversi lineamenti stanno assieme, convivono.
Non si opta né a favore dell’ uno né dell’ altro: ambedue godono di pieni diritti.
A ben vedere, ci si trova dinanzi a una riflessione su caratteristiche del tutto umane: talvolta ci capita di essere coinvolti in vicende amorose e, nel contempo, osservandoci come dal di fuori, di sorridere di certi nostri, pur genuini, atteggiamenti, talvolta, cioè, aspetti buffi vengono a trovarsi accanto ad altri di natura passionale su di un piano, per così dire, di rispetto reciproco.
Non a caso, l’ autrice dedica “All’ amore di tutte le età”, con tono serio, il proprio lavoro.
Davvero questi versi liberi aderenti al narrato, eppure capaci di offrire, repentinamente, suggestive immagini pressoché prive di perimetro logico (“come fosse ormai dall’ altra lente del suo tempo”) – dai tratti descrittivi, quasi in prosa, alternati a spunti d’ intensa valenza poetica con rapido variare dei registri – davvero questi versi, dicevo, ci inducono a considerare quanto la
complessità dell’ esistere possa celarsi dietro un’ espressione linguistica, uno stile, quanto, perciò, occorra soffermarsi su ogni passo idiomatico cercando di portarne alla luce, il più possibile, le molteplici fisionomie.
Come fa Gaby Ramsperger, con la sua ballata.
Marco Furia
Gaby Ramsperger, “Pulzella di un giorno distante”, ODISSEA, Milano, 2008
Marinella Galletti
Esperienza d’ amore
Preceduto dalla riproduzione fotografica di quelli che definirei dipinti plastici sospesi tra pop art ed espressionismo, nonchéda un articolato saggio di Alfonso Lentini, giungono all’attenzione del lettore i versi della silloge “Eva e Adamo – Percezione dell’esperienza d’amore”, di Marinella Galletti, artista e autrice del testo, unito, sotto lo stesso titolo, alle suggestive immagini.
Si tratta di ventisette sezioni, tre per ogni pagina, in cui l’“esperienza d’amore” viene come scomposta in molteplici sfaccettature dagli spiccati caratteri.
L’amore, lo sappiamo, implica mille pensieri, episodi, ricordi, si alimenta dei suoi vividi componenti e sa attraversare e congiungere in un solo attimo vicende anche lontane, dissimili, ponendo in essere un’emotiva condizione di disponibilità, un fecondo aspetto del vivere.
Aspetto che, rivolto verso l’ esterno, verso un’altra persona, può porre l’innamorato in uno stato d’incertezza, di dubbio (l’amore, intendo dire, per essere felice deve essere ricambiato).
Néi suoi risvolti fisici paiono in grado di sciogliere il dilemma: la diciottesima sezione, così, inizia con “Sia la natura nell’atto dell’amare” e si conclude con “Farà male. Male. Male?”.
Siamo dunque di fronte ad un non risolvibile enigma?
Ora se, dopo aver seguito la poetessa, rifletteremo sul suo appassionato proporre singoli lineamenti, ci potremo rendere conto di essere rimasti pressoché fermi sulla via di un’illusoria spiegazione, ma di essere giunti ben più avanti seguendo altri percorsi: l’esserci soffermati, brano dopo brano, su tratti di vario tipo è risultato utile in quanto ci ha aiutato a comprendere come sia possibile avvicinarsi al sentimento d’amore costruendone una (nostra) storia, non immodificabile, non stabilita una volta per tutte, bensì tale da illuminarsi, acquistando valore, ogniqualvolta la si narri con parola attenta, sensibile.
Quale parola èpiùsensibile di quella della poesia?
Con sequenze precise, esatte, capace di accostare immagini proprie del pensiero ad altre riferite a cose e azioni specifiche, sorvegliata nel richiamarsi all’esperienza amorosa, ossia abile nel renderne testimonianza per via di un linguaggio evocativo ma sobrio, incline a variazioni tipografiche di gusto futurista, Marinella Galletti affronta un tema non facile, infinite volte trattato dai poeti, riuscendo a trasmettere qualcosa di originale, di peculiarmente suo.
“Improvvisamente io e lui ci amiamo”, questa frase ricorre spesso: certo, l’amore è sempre improvviso, sorprende, stupisce, perfino quando dura da lungo tempo.
Marco Furia
Marinella Galletti, “Eva e Adamo – Percezione dell’esperienza d’amore”, Edizioni Nuovecarte, Ferrara, 2008
Enrica Salvaneschi e Silvio Endrighi
Etimologici incanti
Davvero molto articolato ed enigmatico si presenta "Libro Linteo - Titolo I. Il resto" di Enrica Salvaneschi e Silvio Endrighi.
Enigmatico, ma non indecifrabile, poiché il vero arcano è comprensibile nel non avere soluzione: tutti, intendo dire, lo comprendono, anche se nessuno può scioglierlo.
Di questo si tratta.
D'un itinerario, ricco di folgoranti citazioni, percorso in maniera risoluta, eppure non priva di affetto, lungo quell'indefinibile territorio che si trova tra vita e parola, idioma e silenzio, divenire e restare.
Anzi, nemmeno, perchéappare evidente che i suddetti poli soltanto in apparenza risultano dissimili o opposti, sviluppandosi, in realtà, secondo dinamici lineamenti linguistici comuni.
Lineamenti, si badi, non vere e proprie strutturate lingue.
Un'ampia e profonda opera di dissodamento del linguaggio conduce a riconoscere un'unità di fondo che, a partire dalla forma, in particolare dall'etimologia, riconosce nell'impulso del dire un ineffabile quid da cui tutto parte e cui tutto ritorna.
Autori quali Rilke, Leopardi, Kafka, Parmenide, Pindaro, Nietzsche, Dante, contribuiscono, per via di acute citazioni, ad illustrare la ragion d'essere di un atteggiamento giàreso evidente da un verso del componimento poetico "Tantalo": "Si diventa quando si é già nati".
Prima di nascere non si esiste come individui in senso fisico e neanche linguistico: gli altri, ancora, non possono parlare delle nostre peculiari fattezze, ossia non sono in grado di riferirsi ad un vero e proprio oggetto, bensì soltanto ad un'immagine, ad un'aspettativa (e nemmeno noi possiamo esprimerci almeno con il pianto o con un grido neonatale).
La comunicazione tra umani, insomma, avviene a condizione d'essere "già nati".
Una constatazione ovvia che presenta una precisa fisionomia d'annuncio: tutto quello che viene detto sta al di qua della morte e perciò, anche quando sembra richiamarla (ad esempio a causa della disperazione provocata dall'insolubilità dell'enigma, o della difficoltà dell'intrapreso viaggio, o di altro accidente) ne mostra, nello stesso gesto evocativo, l'attuale inesistenza.
"Poiché non crediamo nell'antitesi tra vivere e scrivere" "ma pensiamo semplicemente - o semplicisticamente - che scrivere sia un aspetto del vivere": apprezzata l'elegante umiltà retorica di quel "semplicisticamente", ci troviamo al cospetto di una rilevante affermazione.
Nel soffermarsi su quanto sfugge perchésempre sotto gli occhi, gli autori non distinguono tra vivere e scrivere, non credono che la vita possa costituire oggetto dell'idioma, ma dichiarano, senza mezzi termini, che lo scrivere è un aspetto del vivere, è fuso con esso, non se ne distingue mentre si svolge, diviene, ossia che la lingua è una forma del vivere medesimo.
Ed è proprio il vivere medesimo ciò che resta, che permane.
Ora l'enigma non è stato sciolto, ma le idee in proposito risultano meno confuse: le incantevoli etimologie, articolatissime ed incalzanti, di Enrica Salvaneschi e Silvio Endrighi ci hanno aiutato a capire che non dell'arcano dobbiamo avere timore, ma del non riuscire ad averne consapevolezza, ci hanno mostrato come riflettere con passione sulla lingua possa costituire feconda meditazione sulla vita.
Marco Furia
Enrica Salvaneschi, Silvio Endrighi, "Libro Linteo - Titolo I. Il resto", Book Editore, 2009
Francesco Marotta
Poetiche tracce
Con "Impronte sull'acqua", silloge vincitrice della quattordicesima edizione del Premio Internazionale di Poesia "Renato Giorgi", Francesco Marotta presenta sequenze accuratamente scandite, limpide nel loro assiduo alludere.
Alludere a cosa?
Un indizio si può trovare già nei primi versi:
"se arrivi appena a
pronunciare un nome".
Affermazione chiara, esplicita, di scontento: la lingua dice, ma non abbastanza.
Tanto è vero che
"la pagina èpronta
per l'inchiostro che
vaga tra silenzio
e silenzio"
ossia per un segno affiorante da mute regioni, nell'attesa d'un altro simile.
Mute regioni, dunque, non considerate quale vuoto, indistinto nulla, bensì ineffabili campi d'energia da cui la parola sgorga.
Ma, allora, se la lingua non spiega se stessa e soltanto si mostra, perché ritenersi insoddisfatti?
Non è sufficiente una presa d'atto?
No, davvero.
Il linguaggio non è qualcosa di statico, da analizzare una volta per sempre, ma di vivido e dinamico: possiamo aggiungere espressioni, proporre nuove forme.
Lo possono fare soprattutto i poeti, sensibili al senso più che a poco elastici significati, al farsi del dire più che a ripetitivi protocolli: costoro percorrono itinerari inediti, invitano gli uomini ad avere fiducia nei propri passi così da sconfiggere il timore del dissimile, del non usuale, chiamano a riflettere su usi idiomatici non semplicemente denotativi, ma fusi in maniera inscindibile con l'esistere.
La loro insoddisfazione, ben lungi dall'indurli a seguire sterili sentieri, è origine di gesti costruttivi che si aprono ad inconsueti scenari, che obbediscono ad impulsi in cui etico ed estetico sono congiunti, mostrando come restare schiavi di rigidi concetti non costituisca inesorabile destino.
Con pronunce nitide, non alieno da (vigile) attitudine a spezzare vocaboli in fine di verso, sicuro nel proporre tratti, talvolta vere e proprie traiettorie, che entrano ed escono ritmicamente dal campo visivo del lettore ("ci sono versi scritti / con gli occhi"), accostando elementi di natura esistenziale ad illuminanti riflessioni sul linguaggio, insomma, offrendo una versificazione varia e dinamica, Francesco Marotta mostra come la poesia non costituisca una via di fuga, un sottrarsi al mutevole divenire, ma sia un importante strumento, un aiuto nello scorrere della vita.
Originali e feconde impronte, senza dubbio.
Francesco Marotta, "Impronte sull'acqua", Le Voci della Luna Poesia, 2008, pp.55, euro 10
Maria Alessandra Tognato, una premessa e poesie inedite da "In tatto"
Un discorso in frantumi che raccoglie, tuttavia, impressionisticamente
o ironicamente, quanto piùcolpisce o svanisce o richiama l'attenzione.
E non c'è mai ripetizione, in questo sperimentalismo secco e pungente,
mai un abbassamento di tono. E' decisivo il legamento nascosto e
magnetico in cui sembra talvolta di riascoltare, intelligentemente
rivissuti, quei versi che negli anni '60 fecero conoscere fondamentali
pilastri della poesia quali O.Mandel'stam o A.Vosnesenskij.
Maria Alessandra Tognato ce li ricorda ricreando i loro umori sismici
in una modernità autentica e italiana. [N. Bonifazi]
1 50 days
perpendicolare
alla ragione
la Variazione
spacca spudora
e se addolora è
per rare-fare
per farci rari
5 Tre inverni
vene di neve e
schegge–sangue
arancio
si declina al presente
il primo maggio
11
perchè l’eleganza
delle cose non
sussulta
all’inciso defilato
di un profilo
ma piange a
fiume l’impiglio
d’alga
il lascito di
parole
12
Sfilarsi via
via andare
a vegliare
a filare una fine
come brina
come sale sul
bicchiere di
tequila
22
Grigio che piomba
i giunti già
dall’alba –
La tua scomposta
latitanza
che mi sfrangia
il gelo
del nascondimento
32 Tutto
Vinta non c’è più
urgenza
gonfia abbastanza
Ma amaro sale
maschile
da controseme d’assaggio
persa resina
al tatto
La parte per il
tutto
37
Lo svelamento affiora
Necesse est
A filo d’acqua
A non incerta ora
Per numero propizio
Maria Alessandra Tognato vive a Padova, dopo aver vissuto a Boston, a San Carlos e infine a San Francisco. Sue poesie sono state pubblicate nelle antologie "Great poems of the western world", "The best poems of the 90s" e "American Poetry Anthology". In Italia ha pubblicato le raccolte "Andrei", "Non c'è verso", "Rubina", "I Venti & l'Uno" e "D'Ali".
Oltre il Premio, Daniela Cabrini su poeti del “Montano” attivi in altri versanti: Berardini, Casadei, Infelìse
Oltre il Premio, Daniela Cabrini su poeti del “Montano” attivi in altri versanti: Sergio Fabio Berardini, filosofia, Nichilismo e rivolta, Il Poligrafo 2008; Alberto Casadei, critica, La critica letteraria del Novecento, Il Mulino 2008; Giovanni Infelìse, arte, Amedeo Modigliani, Book Editore 2008.
Daniela Cabrini è nata a Cremona nel 1961. Compie studi scientifici e si laurea in Matematica. Ha pubblicato Tempo Presente (Lieto Colle, 2002) e Attraverso interni (Lieto Colle, 2007). È presente con un suo intervento di Matematica in I nomi propri dell’Ombra (Moretti&Vitali, 2004). Sue poesie compaiono in: Rane, un dito nell’acqua (I Quaderni di Correnti, 2004) e I mondi creativi femminili (Lieto Colle, 2006). Vive a Verona.
Alberto Casadei, critica, La critica letteraria del Novecento, Il Mulino 2008
Per scherzo, potrei tentare una critica su “La critica letteraria del novecento” così che Alberto Casadei sia invitato a codificare un nuovo genere – studi sui saggi di critica letteraria e così via. Ma già avrei il problema di non saper collocare il suo stesso operare: saggio? studio? storia critica della critica?
Nell’introduzione l’Autore indica i criteri che ha scelto come condizioni iniziali, segnalando i margini fra il dovuto e la sua interpretazione per poi cogliere, con accurate selezione e sintesi, i tratti salienti delle origini sia filosofiche, sia estetiche, sia letterarie della critica per come è nata ed evoluta nel corso dei secoli.
Dopo l’introduzione, il libro si concentra sulla critica del novecento, analizzata per categorie – I) autore e mondo: critica sociologica, psicoanalitica, marxista, storicista... II) il testo e l’opera: formalismo, semiotica, retorica... III) il lettore e le culture: decostruzionismo, ermeneutica..., con chiara attenzione alle continue intersezioni fra queste tendenze e singole esperienze critiche. Si tiene conto, in particolare, delle triadi: autore-testo-lettore, studio-saggio-opera letteraria e studio-saggio- testo letterario. La prima triade dispiega le varie correnti interpretative presentate, la seconda e la terza convergono in una sola, ovvero le parole: opera e testo letterario vengono ad essere equivalenti negli ultimi due capitoli.
Attento a sottolineare le caratteristiche delle correnti teoriche nelle varie nazioni, riserva un adeguato spazio alla critica letteraria italiana e propone dieci schede biografiche e critiche stesse di altrettanti teorici stranieri (figure di grande statura: Frye, Lukacs, Benjamin, Adorno, Bloom, per citarne alcuni) proposte come piccoli esempi di un canone personale.
In chiusura un’analisi appassionata sulle tendenze attuali, in cui l’equilibrio intellettuale dello studioso riesce a tenere a debita distanza l’amara constatazione della crisi attuale della critica letteraria e, con sguardo fermo eppure vivace, prosegue alla ricerca di nuove prospettive. Le domande sono due alla luce dei cambiamenti socio-culturali (soprattutto portati dalle società multietniche) e mediatici - informatici (fra cui l’esigenza della spettacolarizzazione del prodotto, la velocità e la ricchezza delle banche dati che avvicinano opere lontane nel tempo e nello spazio): cosa è un’opera letteraria oggi e se è possibile stabilire un canone per poter dire quali opere siano decisive e perché. Si tenga conto che l’antica affermazione – un classico è tale dopo 50 anni dalla pubblicazione, non ha più senso: prima di tutto perché non sappiamo più quale testo potrebbe ambire a diventare un classico e perché, in secondo luogo, la caducità di lettura dei testi informatizzati ha spostato definitivamente nel non fondamentale la questione tempo e durata.
Casadei sottolinea che tutti questi cambiamenti non mutano la fondamentale questione sulla stabilità (qualità? bello?) di un testo letterario, di un contenuto che mantenga una sua forma conoscitiva propria. “Occorrerà allora ripensare ad alcune categorie fondamentali del fare letterario, per mantenere una distinzione tra un giudizio latamente culturale e quello specificatamente estetico sulle opere classificabili come letteratura”. Daniela Cabrini
Giovanni Infelìse, arte, Amedeo Modigliani, Book Editore 2008
Livorno è una città strana di mare e terra avvolta da una la luce irreale: viva e insieme spenta, nostalgica. Se la geografia è geografia d’anima, immagino la Livorno di fine ottocento, accogliere e dare origine di terra ad Amedeo Modigliani. Di questa figura si sa della sua breve vita, della sua povertà e solitudine, della sua relazione con Anna Achmatova, del suo grande, intenso e religioso amore con Jeanne Hébuterne, consumato e mantenuto eterno con la morte di lui e il suicidio immediato di lei. Di Modigliani si sa della sua grande arte, del suo lento lavoro su disegni che diventavano velocemente dipinti, della sua imperfezione come qualità intrinseca alla sua anima, punto di partenza e non di arrivo che rende l’arte e la vita così vicine nel sentimento e nell’autenticità.
Giovanni Infelìse ci regala in questo breve testo, commisurato alla breve vita dell’artista, uno sguardo poetico, appassionato, senza cedimenti a una qualunque forma di omaggio e tantomeno a un pretesto per parlare d’altro. Attraversano l’intero studio le parole poetiche e lo sguardo da poeta dell’Autore, e quell’indagine sottile e inquieta dello spirito romantico senza cedere terreno ai comparativi storici. Ciò che colpisce è il timbro di questo libro le cui armoniche sono: la tragedia come essenza tragica di un’esistenza votata all’arte; la felicità e l’amore come ossessioni consumate tra ragione e immaginazione; la sofferenza e la solitudine necessarie per poter essere artisti fino in fondo; la cifra poetica di Modigliani nei suoi nudi e nei suoi volti, dove un singolo segno può cambiarne la natura e la sua diversità senza un nonostante. Ma la combinazione di queste armoniche rendono un timbro fermo, sereno quasi disincantato. Al lettore non resta che il desiderio di conoscere Giovanni Infelise poeta, o abbandonarsi alle figure e allo sguardo nostalgico e romantico delle “Lettere di Modigliani”, di “Le Rose di Modigliani”, o scegliere uno dei testi citati nel libro e riportati nella bibliografia accurata e preziosa. Daniela Cabrini
Sergio Fabio Berardini, filosofia, Nichilismo e rivolta, Il Poligrafo 2008
Il sacro nome del demone russo
“ Adesso finalmente mi sono messo sul mio nuovo libro: su Dostoevskij. Conterrà molto di più (… ): grosse parti della mia etica metafisica, della filosofia della storia etc...” .
Siamo nel marzo 1915, chi parla è Gyorgy Lukacs a proposito del suo “Dostoevskij” (traduzione e cura, con postfazione, di Michele Cometa, edito da SE). Già il suo famoso “Theorie des Romans” conteneva dei precisi riferimenti all’autore russo, “ D. non ha scritto nessun romanzo (…) egli appartiene al nuovo mondo”. Il nome del demone russo e l’utopia del “regno dei cieli sulla terra” o al contrario la speranza in una nichilistica palingenesi agitavano speranze di rivolta e di superamento del nichilismo, del mondo abbandonato da Dio, con la coscienza precisa che l’ideale greco dell’unione fra filosofia, cioè pensiero, e vita era ormai irriproponibile. I personaggi di D. sono eroi di romanzi criminali perchè sprofondati nell’orrore dell’andare fino in fondo al delitto. Di più: un rinnovamento poteva venire solo dalla Russia dove i dettami dell’anima del singolo possono essere immediatamente trasferiti a tutto il popolo.
Si riparta da qui. Si riparte da un pensiero che non vuole riparare a disagi, né decostruire, né creare immagini necessarie come paradigmi anche se seducenti come la stessa solitudine che vorrebbero esorcizzare (deserto, vuoto, silenzio, segreto, solo). Qui errare vuol dire – sbagliare. Si riparte dal sottosuolo, preso anche nella sua superficialità (quella cara a Valéry) .
Si riparte dalla filosofia come uso sereno della mente, impresa dell’intendimento conoscitivo, dire e portare nel linguaggio un modo umano di stare al mondo.
Si riparte dopo cent’anni con il pensiero vicino di Zambrano, Natoli, Galimberti, Guardini, Givone, De Martino, Kojeve, altri sacri demoni attraverso cui rintracciare lo sviluppo del pensiero dell’Autore.
La meraviglia di questo libro è la sua forma estetica-etica: il libro è quello che si vuole e si va dicendo. Dunque è intimamente russo, connesso alla topologia delle proprie asserzioni, è un’epica del pensiero, un romanzo-racconto di idee, nel quale l’autore svela il proprio percorso di pensiero raccontandone le radici. I romanzi di D. e i suoi personaggi sono specchio oltre che motivo di analisi.
Con rara capacità Berardini cita anche ampie parti dei romanzi di D. che si fondono (strumenti, causa, mezzo) col proprio dire, sapendo mantenere la stessa nostalgia, la stessa musica. I temi sono fra i più urgenti: il male che vive nel mondo, la morte sia come caducità sia come mistero, il senso del vivere chiuso nella finitezza, l’anima e la coscienza, l’etica soprattutto nel suo rapporto col sacro (di cui B. propone il significato di “impedire l’accesso, sbarrare” individuato da Giovanni Semerano), la lotta fra gli opposti e la possibilità di superarli senza cadere in agganci metafisici né tantomeno morali. Temi urgenti in un tempo – questo – di altrettanta violenza, in cui l’uomo è così debole al richiamo del sottosuolo, inteso adesso come l’arte di “fare quello che si può” (il nuovo “da- farsi”). Tempo di rimozioni continue e parole che riparano alla mancanza di senso, tempo in cui tutto sembra possibile tranne seguire fino in fondo la propria unicità e il suo abisso.
E dunque: quale rivolta? A quale deserto? L’inquietudine non è sottile. E’ solo una confusione puntata, desiderio non gravido, sorriso spento. L’inquieto parla di sé, prima o poi dice perchè l’inquietudine trabocca l’anima, portandola ad ebollizione. Qualche voce comincia a pronunciare la parola “accudire”, avere cura di sé e degli altri – la madre che culla e alleva e che sorride alla propria gratuità. Ma è sacrificio, ne può valere la pena? La risposta di Fabio Berardini è una scelta cristiana, dove Cristo non è il Figlio del Dio cattolico, così come l’amore non è la religione a più buon mercato. Serve un’anima.
“ Il secolo della scoperta dell’anima è arrivato. (…). Dobbiamo riscoprire l’anima. E il potere dell’anima. Abbiamo bisogno di una nuova religione dell’anima, senza dogma, senza leggi – solo sentimento. Cristo divenne chiesa. E per questo fallì. Noi dobbiamo istituire un dominio dell’anima.” Da Lukacs si è ripartiti e con lui si chiude, in un’epoca ferocemente diversa, altrettanto violenta, in cui sembra che il nichilismo non sia giunto alla sua fine, in cui quella ragione che ha ucciso l’anima è stata studiata, sezionata, spesso condannata ma sempre più offesa e atrofizzata, un’epoca insomma senza anima, senza ragione, senza epica, senza limite, epoca in cui un libro come questo getta una luce sul pensiero libero. Daniela Cabrini
Marzo 2009, anno VI, numero 10
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
I testi poetici, le note critiche
In questo numero diamo visibilità a una parte del lavoro teorico che costituisce le fondamenta di un Premio come il “Lorenzo Montano”, occupandoci dell’ultima edizione che si è conclusa durante le giornate della III Biennale Anterem di poesia.
I testi poetici delle autrici e degli autori finalisti e vincitori, vera sostanza del premio, sono commentati dai redattori della rivista “Anterem”, esattamente come si è svolto dal vivo durante la “Biennale”.
L’intreccio di poesia di qualità e il suo approfondimento critico rappresenta un avvenimento di rarità nel panorama letterario contemporaneo. Su questa strada intendiamo proseguire, già con la nuova edizione del Premio che scade fine marzo.
Ranieri Teti cartenelvento@anteremedizioni.it
Una poesia inedita: poesie dei finalisti e del vincitore, commenti di Marco Furia
L’inserimento dei testi non ha seguito i risultati del premio ma un percorso che si delinea attraverso le tendenze della poesia contemporanea: tra possibili contiguità, in un itinerario che scorre non solo all’interno di questa sezione ma si connette, nel suo ideale svolgersi, alle altre due.
Chiara Poltronieri, Clio
Chiara Poltonieri, “Clio” [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Nota critica di Marco Furia
Clio
“Clio”, musa della storia, è titolo all’ articolata composizione di Chiara Poltronieri.
Si tratta di un complesso connettersi di riflessioni e immagini, nell’ àmbito delle quali il mondo della mitologia viene recuperato a una vivida contemporaneità.
Lungi dal considerare il divenire mera concatenazione di fatti regolati dal principio di causa/effetto, la poetessa dà voce a dimensioni in cui “non solo il futuro / è denso di enigmi”, ma “anche il passato / è un enigma”, in cui, cioè, il misterioso fenomeno dell’ esistere accomuna passato e futuro in un’ attualità imprescindibile.
Tanto è vero che soltanto “gli inspiegabilmente vivi / loro che avevano veramente provato / come ultimo desiderio / il desiderio della vita dell' altro" “loro che avevano veramente provato / un dolore vero / per la scomparsa / non di quello che avevano conosciuto”, unicamente loro “avrebbero saputo ascoltare/ quel che la musa della storia” “aveva conservato”: non una storia per tutti, dunque, bensì per chi possiede certe non comuni caratteristiche, certi purtroppo rari tratti affettivi, di generosità, di comprensione estrema.
Solo a costoro Clio si rivolge.
Elegante, capace di dominare con fermezza una materia enigmatica considerata non ostacolo, ma occasione, attenta anche ai minimi particolari del lessico, senza indulgere a toni scomposti, Chiara Poltronieri offre una Clio che avvertiamo vicina, contemporanea.
Una presenza in più, davvero.
Miro Gabriele, Le rose di Porto
Miro Gabriele, “Le rose di Porto” [1] [2]
Nota critica di Marco Furia
Una limpida offerta
“Limpida” davvero l’ “offerta” di Miro Gabriele che, con “Le rose di Porto”, presenta un articolato componimento in cui allusive scansioni mirano a porre in essere un’ “astratta geografia”, affascinante per la capacità di suggerire immagini interne ed esterne nel contempo, esiti evidenti di profondi rapporti di empatia con il mondo.
Gabriele, sapiente e tenace costruttore di versi, ossia di autonomi linguaggi, si mostra ben conscio delle peculiari potenzialità di un’ opzione artistica, quale la sua, particolarmente ricca di attitudine espressiva.
Siamo in presenza di una salda fiducia nel farsi poetico, di una conferma della tipicità d’ una lingua in grado di offrire non soltanto eleganti tratti descrittivi, ma anche di promuovere un leggere inedito, dalle molteplici possibilità e aperture, secondo orchestrazioni che non costringono entro rigide sbarre, invitando, al contrario, a servirsi dei paradigmi verbali con rinnovata sensibilità.
Con toni armonici, evocativi, contraddistinti da una vena espressionista poco esibita, quasi implicita, eppure intensa, trattenuta da parole che, proprio in virtù di tale scelta , riescono ad assorbire maggiore energia, senza mai cedere alla maniera dello scrivere semplice e comprensibile a tutti i costi, il poeta ci fa dono di una “luminosa pietà”, di un’ affettiva partecipazione all’ umana vicenda secondo accenti il cui “disegno”, “aperto” ma composto, testimonia di una equilibrata cifra stilistica.
Uno “sguardo” “netto”, senza dubbio.
Alberto Casadei, Ricognizioni dell’isola
Alberto Casadei, “Ricognizioni dell’ isola” [1] [2]
Nota critica di Marco Furia
L’isola
Come dal mare emergono le rocce e le terre di un’ isola, così dal silenzio affiorano i versi di Alberto Casadei che, con “Ricognizioni dell’ isola”, presenta costrutti poetici esili e robusti nel contempo.
Esili quanto a immagini, certo intense e vivide, ma come ancora prive di schemi utili alla comunicazione, robusti nell’ accorta composizione, frutto d’ impegno coerente e assiduo.
Quello che più colpisce nei versi in parola è proprio la fusione tra i due àmbiti, anzi, nemmeno, poiché per Casadei pare trattarsi di diversi aspetti di un’ unica, poetica, dimensione: egli, cioè, rende davvero conto, nel concreto della sua lingua, di uno stato di fatto in cui non c’è posto per apriorismi di alcun tipo, bensì soltanto per il fluire di energie.
Il suo idioma è già vita, nel senso che, altrimenti, null’ altro potrebbe sottrarre spazio al silenzio: tutto esclude nel momento in cui ogni cosa include, secondo un atteggiamento la cui natura intransitiva testimonia di un’ originale prassi poetica.
Gli ultimi versi “Un giorno arrivò, / un ritorno previsto, / acqua e acqua, / senza risposte / sino alla sabbia / appoggiata sul / vano” sono emblematici di propensioni che, non avvertendo la necessità di scomporre per poter analizzare, nulla escludono per meglio capire.
Un di più quantificabile non in oggetti o fatti, bensì in una scrupolosa attenzione nei confronti di quanto ci capita e ci circonda.
Il tutto senza abbandono, né enfasi.
Silvia Comoglio, Farfalla
Silvia Comoglio, “Farfalla” [1][2]
Nota critica di Marco Furia
Un’ aria che parla
Davvero l’ “aria” “parla” nei versi di Silvia Comoglio, forse come accade tra un battito e l’ altro delle ali d’ una farfalla, leggiadro insetto da cui il componimento in parola prende nome: un’ aria a tratti rarefatta, a tratti densa, talvolta tersa, secca, talaltra ricca di vapori, di umide fragranze.
Se il “filo della voce” suscita l’ interesse della poetessa (“della voce”, si badi, non soltanto della lingua), la sua scrittura, sempre rivolta ad accettare le sfide che ogni verso propone, riesce ad offrire non ambigua testimonianza di come si possa fuggire da certi vieti schemi senza negarne a priori le forme, di come, insomma, si possa ben continuare a parlare (e scrivere) senza rivolgersi a quell’ inarticolato nulla che assieme alla malattia annienta l’ infermo.
Occorre un altro dire, quello del poeta.
Egli parla, dunque usa uno strumento, ma non allo scopo di costringere in prigionia: al contrario, per offrire a chi ascolta possibili vie di scampo.
I canoni grammaticali, così, vengono modificati dall’ emergere di un’espressione ordinata ma diversa, in cui colori, suoni, simboli, risultano, più che effetti di un divenire linguistico, elementi inseparabili dalle parole assieme alle quali giungono ad esistenza, come ben dimostra la pronuncia “è il pianto della luce / è l’ ùltima memoria”.
Con cadenze efficaci, incisive, esito d’ incessante lavoro su materiali linguistici rivolti a porre in essere possibili condizioni d’esistenza diverse dall’ usuale, Silvia Comoglio riesce nell’ intento di creare una inconsueta consuetudine in cui il lettore vive, verso dopo verso, con naturalezza.
D’ inedita familiarità, insomma, ci viene fatto prezioso dono.
Mauro Dal Fior, Del bianco
Mauro dal Fior, “Del bianco”
Nota critica di Marco Furia
A parlare del bianco
Certo parla “del bianco” il testo, così intitolato, di Mauro Dal Fior: un bianco esteso e ridotto, un tutto e nulla o, meglio, un tutto che contiene anche il concetto di nulla.
Resosi ben conto delle ampie possibilità di un linguaggio, quale quello poetico, aperto nei confronti di ogni possibile propensione, ossia del tutto autonomo quanto a direttrici, Dal Fior, memore degli insegnamenti della migliore avanguardia, s’ interroga sul mezzo adoperato e, più nello specifico, sullo strumento adatto alla bisogna dell’ oggi.
La risposta è una scrittura fortemente allusiva capace di legare l’ uso di tratti non troppo lontani dai canoni quotidiani a un’ acuta riflessione su tale stesso impiego: non si è in presenza di forme d’ avanguardia spinta, ma di espressioni poetiche capaci di far rivivere, senza cadere in stanche ripetizioni, lo spirito di certe importanti esperienze del secolo scorso.
Con ritmo battente, ribadendo, per ben otto volte, agile, il verso “Parliamo del bianco”, il Nostro riesce a far balenare immagini vivide, dagli originali lineamenti, nel cui ambito inedite modalità linguistiche, gusto per la provocazione, nonché riferimenti agli oggetti, si fondono in felice connubio.
Così, disponibile a praticare un dire non fine a sé medesimo (“Parliamo del bianco / che gli inganni cancella”), la poesia mostra lo svolgersi di un itinerario che svela nelle sue pieghe linguistiche tratti profondamente umani.
Del resto, nell’ affettuosa “Dichiarazione di poetica” aggiunta, Dal Fior non nasconde, rendendo omaggio, qui anche nelle forme, a una mai dimenticata avanguardia, in quale “mare” gli sia “dolce” “naufragar”.
Citazione leopardiana che la dice lunga.
Massimiliano Finazzer Flory, Trittico sulla parola
Massimiliano Finazzer Flory, “Trittico sulla parola” [1] [2] [3]
Nota critica di Marco Furia
La parola
Con “Trittico sulla parola”, Massimiliano Finazzer Flory presenta in forma poetica una riflessione che, fin dalle prime battute, sfugge ai canoni dell’ ordine logico per proporre non tanto un’ idea, quanto un’ ineffabile biologia del linguaggio.
Ineffabile nella sua immensa totalità, ossia non possibile oggetto d’ analisi esaustiva, nondimeno concreta valenza: “il linguaggio è un veliero”, ma i mari attraversati non sono misurabili una volta per tutte, poiché uno scafo siffatto, in perenne navigazione, non risulta nettamente separato dall’ acqua che lo sostiene e le coordinate tracciate possono subire modifiche, scomparire del tutto, ricostituirsi all’ improvviso.
A ben vedere la lingua, qualunque lingua, se viene adoperata è sempre “madre”, nel senso che, comunque, anche là ove tentenniamo usando strumenti poco noti, non possiamo tradire noi stessi, in quanto non coincidiamo con l’ espressione, ma lo siamo.
Tanto, con scrupolosa eleganza, suggerisce Flory il quale, sapiente, si serve di forme piane, di costrutti non troppo inusuali almeno nell’ aspetto, capaci d’ indurre a riflettere sugli “argomenti” proposti, come sulle stesse modalità di proposizione.
Non occorre rivolgersi a ricercatezze di maniera, se è vero che “Domandare la parola è / interrogare una virgola in partenza”, ossia che un utile esame della dimensione espressiva può partire da materiale anche minimo, disponibile, presente, per nulla occulto.
Insomma, il Nostro non ci guida lungo un itinerario, bensì ci mostra una direzione lungo la quale innumerevoli percorsi sono praticabili, invitandoci ad assumere la responsabilità di una scelta.
Evidente, in lui, la radice etica.
Roberto Fassina, Nel biancore mattino
Roberto Fassina, Nel biancore mattino
Roberto Fassina
Nel biancore mattino
Nel biancore mattino
morde le rètine un livido sole,
in quest’alba monca attendo
l’artiglio del dio radente
(immanente destino l’attesa
di verità diviete)
mia afasica nuvola mia
res incognita,
empio quesito
recito, pie bestemmie
(redimo ai margini
silenziosa equazione d’acqua)
cenere di stelle
fummo senza colpa,
luce difettiva
genetica adattiva
(incognite lievi
perdute nel tempo)
Nota critica di Marco Furia
Roberto Fassina, “Nel biancore mattino”
Nota critica di Marco Furia
Verso liquide equazioni
Con “Nel biancore mattino”, Roberto Fassina presenta una concisa composizione in cui a immagini d’ “alba”, accompagnate da riflessioni repentine, ricche di enigmatica pregnanza, seguono vere e proprie asserzioni a proposito dell’ umano esistere: “cenere di stelle / fummo senza colpa”, “(incognite lievi / perdute nel tempo)”.
Questa sorta di cosmogonia, proposta in maniera asciutta e perentoria, mi pare riferirsi, gettandovi luce, alla “mia afasica nuvola mia”: l’ origine, polvere astrale illuminata da chissà quale sole, è “afasica”, non parla, al contrario
dell’ uomo in genere, nonché dello stesso poeta in particolare.
Come conciliare questi due aspetti?
Sembra che a Fassina tale questione non interessi poi tanto: egli insiste su uno stato di fatto e non va oltre.
Si sofferma soltanto su quanto ritiene evidente: lo stupore di siffatta presa d’ atto assorbe ogni altra esigenza espressiva.
Ma, credo, non ci troviamo di fronte a un punto di arrivo.
Non si tratta, ovviamente, qui, di discutere sulla liceità scientifica (o storica) dell’ assunto, interessa, invece, la presenza di tensioni interne alla scrittura dalle quali traspare una partecipazione affettiva ancora tutta disponibile a mostrarsi nel corso d’ itinerari poetici in grado di aggiungere ulteriori fisionomie a certe precise, lucide, scansioni, a certe originali immagini.
Occorrerà ritornare, insomma, a quell’ ineffabile “silenziosa equazione
Opera edita: poesie dei finalisti e dei vincitori, commenti di Flavio Ermini e Rosa Pierno
L’inserimento dei testi non ha seguito i risultati del premio ma un percorso che si delinea attraverso le tendenze della poesia contemporanea: tra possibili contiguità, in un itinerario che scorre non solo all’interno di questa sezione ma prosegue, nel suo ideale svolgersi, anche alle altre due.
Pierangela Rossi, Kairòs, Aragno 2007
Pierangela Rossi, “Kairòs”, Nino Aragno Editore 2007
Testi poetici
*
e la casa la casa era tutta di presenze immaginarie
a te quasi sottratto il cinto del reale in cui abitare
sempre più piccole zone circonflesse ad accento
e più fine più fine si faceva l’interno ascolto
*
- tu capace di durezze imprecisate
e sottili volte
affrescate a buon fine
- essi pure avranno incorrisposti pensieri
al sé dedicati
destinati in ordine
in un disordine lapsus
da ricomporre a te
Nota critica di Rosa Pierno
La similitudine instaurata da Pierangela Rossi, tra la voce dell’amato divenuta voce interiore per una lunga consuetudine, per completata osmosi, e le parole di una vecchia poesia, dichiara che l’amore sentito è l’amore scritto e l’osmosi avvenuta è allora quella fra la realtà e il linguaggio. Il libro è una variegata collezione di espressioni con cui la poetessa investiga le forme di questa miracolosa unificazione: “- giusta è la notte agli amanti \ l’una all’altro sono \ ciò che non sono escluso \ di carezza in carezza \ il buio esaudito”. La Rossi utilizza termini presi in prestito dal linguaggio matematico per dar luogo a un’operazione in cui si possa esprimere la forma dell’amore anche attraverso diagrammi. Le logiche operazionali di inclusione \ esclusione, le valutazioni di aurea proporzionalità, le sottrazioni di presenza e la ricomposizione dell’unità franta, le fasi alterne fanno di questa sintassi frammentaria, soggetta a scarti, a cesure, a inserti inusuali, ad accostamenti spiazzanti il racconto di un amore che ha una distanza siderale da quanto siamo normalmente abituati a leggere su questo argomento spesso trattato in maniera leziosa e banale. L’amore diviene, dunque, lo spazio in cui si fa esperienza: “siamo come un U un P greco \ un segno ostrogoto caro o discaro \ che per amore non riusciamo a districare”. Ma l’amore non è facilmente traducibile, la sua traduzione in linguaggio matematico non è così immediata, anzi appare azione resa complessa, al limite della fattibilità, proprio a causa del fatto che si cerca la via più difficile: la formula univoca per ciò che all’univoco si contrappone per antonomasia. Il tentativo della Rossi è assolutamente equivalente al tentativo operato nei centri universitari e di ricerca di rendere conto con modelli matematici della varietà e della complessità del reale. Ma, a differenza dei risultati non risolutivi e spesso fallimentari della matematica, il testo poetico della Rossi raggiunge il massimo dell’efficacia: quella di mostrare la capacità del linguaggio di esprimere una delle esperienze più basilari e fondanti dell’essere umano. Il lettore ha a disposizione con questo libro un esempio di come l’amore acquisti senso proprio dall’essere espresso. Di come possano essere tradotte in linguaggio quella miriade di sensazioni, percezioni, malumori e felicità legate all’esperienza dell’unione con un altro essere e che solo per una incomprensibile pavida rinuncia accade che si eviti di cercarne una possibile forma espressiva addossando le colpe proprio al linguaggio. Come sia tale espressione, invece, a valorizzarne l’esperienza, a renderla comunicabile ce lo mostra la Rossi, poiché è solo un’espressione povera a rendere povero l’amore. “- cosa diceva la stella e l’interno \ dell’interno in profonda voluptate \ l’ho appreso solo in tarda età \ del giorno: ciechi a volte e giustamente \ ai segni che seganti traduciamo in sorte magna et claritate a evento”. Siamo nei pressi di una poesia che ha altissime e blasonate origini. L’amore è una vetta di cui, dalle pagine di questo libro, vediamo tralucere la cima.
Pierangela Rossi (1956) ha pubblicato le raccolte Coclea e Kata, Campanotto Editore e Zabargad, Book Editore. E’ autrice di saggi di critica d’arte. Vive a Milano dove lavora alle pagine culturali del quotidiano Avvenire.
Vincenzo Di Oronzo, Mimi e sonnambuli, Empirìa 2007
Vincenzo Di Oronzo, “Mimi e sonnambuli”, Empiria 2007
Testi poetici
*
Al bagliore di lampada, uno soffiò un lume
per leggere la cometa di chi muore tra i passanti.
L’altro suonò un’armonica a bocca,
che sfiata il pianto dei comici.
Incantava in costumi serali l’abbagliante
indifferenza del passeggio,
l’impossibile gioco dell’io.
9 nasse
Oscillano lune come abiti dell’anima.
9 tracce,
cavalieri inesistenti di un viaggio
9 ellissi,
cembali d’acqua. Ruote di un sogno
*
Tu sei la vela di pietra che aspetta se stessa, il gesso che imbianca
il compito dell’ombra. Rotola il vaso cantore sulla porta
senza amore, il cembalo afono
tra i gesti neri.
Non è altrove la città opposta alla mente,
le mani prossime al nulla.
Nota critica di Rosa Pierno
Sulla pagina, vero e proprio teatrino di carta, sfilano personaggi e oggetti provenienti da epoche diverse, da ambiti inconciliabili, alcuni hanno volti in ombra o maschere, mentre alcuni hanno solo labili apparenze, sembrano larve dai contorni indefiniti. L’adunata sulla pagina è caotica, non offre loro un ruolo, una gerarchia. Le facoltà del poeta livellano la loro valenza e li legano attraverso fili trasparenti, velature, atmosfere, affioramenti. E’ una poesia, quella di Vincenzo Di Oronzo, diafana, avente la trasparenza del cristallo e magmatica al tempo stesso per la sua capacità di ammassare sulla pagine i rigurgiti del suo mondo interiore. Il verso stesso si sventaglia, assumendo lunghezza diverse, adeguandosi alla materia da trattare, alle occorrenze da depositare sulla pagina, ma anche al vuoto, alle inevitabili cesure che il flusso di materiale eterogeneo racchiude in sé: “Statue distanti un’eco, l’oppio di un volto. \ è Venezia? \ In una gondola cantano. In una gondola la morte indossa le scarpe di un bambino. \ Qual è la distanza tra le galassie e i cristalli dell’io? \ Nessun segmento. I naviganti dimenticano i loro ritorni nei porti d’Olanda”. Materiali così disaggregati, aventi verbi che corrispondono dal punto di vista grammaticale, ma non semantico, richiedono che il lettore deponga le sue aspettative per aprirsi a una inusitata maniera di pensare. Le associazioni possono avere una logica dissenziente e percorrere sentieri più ripidi e sorprendenti, possono tracciare una visione diversamente valida. Occorre disimparare per imparare, occorre avere il coraggio di giocare come funamboli con le parole. Si vedrà allora che il senso è sempre in agguato, che produce nuove costellazioni in cui ciò che è presente è un assemblaggio di memorie e di percezioni, di assenze e di presenze, di segni e di oggetti: tutte cose restituite attraverso un amalgama di suono \ senso: “Cloni d’uomini e uccelli, aspersi di luce, nella sala del Demiurgo, \ si abituano ai bagliori delle forme, alla cangiante grammatica della vita”. Il regno di Vincenzo Di Oronzo è dunque il mondo dei segni, ma mondo ambivalente dove le immagini, pur trasformate in parole, conservano intatta la loro capacità di materializzarsi davanti agli occhi del lettore. E’ una poesia visiva non solo perché c’è una costante attenzione alla disposizione delle righe in relazione alla dimensione della pagina, ma soprattutto perché sulla pagina si compone e si scompone continuamente un collage visivo con brani di immagini che si sovrappongono o si allontanano: “Figure erranti nei vetri; \ un vassoio di fichi e menta varcò l’uscio lunare. E donne sparite in una brocca d’acqua, \ tra porte d’occhi brillanti. Astri sereni”. Poesia di trasformazioni virulente, di imitazioni effettuate attraverso traslazioni, di risonanze prodotte da letture altrui, di versi franti e ricomposti. Si può considerare “Mimi e sonnambuli” una medioevale vetrata di inesauribili forme e colori, non solo un libro. Ma, appunto, un libro non è forse anche mobile duna?
Vincenzo Di Oronzo, docente di semiotica letteraria e linguistica generale, critico letterario e saggista, ha pubblicato numerose opere tra cui le raccolte poetiche La coscienza dell’acqua e Hanphora hermaphrodita.
Luigi Nacci, Inter nos/ss, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 2007
Luigi Nacci, “INTER NOS \ SS”, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 2007
Testo Poetico
*
Dirottiamo aeroplani di carta nei giorni di vento
Tramontana ci porta lontano e maestrale ci impenna
Nella stiva fa freddo si ghiaccia si gelano gli occhi
Non si vedono piste e non sono previsti atterraggi
Ci copriamo con pacchi – lenzuola e con coltri – bagagli
Incrociamo gli sguardi ma senza azzardarci a parlare
Che l’ossigeno è poco e il pensiero si ossida presto
Ci conforta il reattore che sparge potente il suo canto
Ed è come l’apnea delle prime nuotate in piscina
O la faccia contratta nel vetro del treno che parte
Ci mettiamo a soffiare a soffiare pensando alla luna
Si potesse saltare aggrapparsi coll’unghie a dei cirri
Poter dire una volta di avercela avuta la testa fra le nuvole
A giorni alterni qui crollano le case in tutte le stagioni
Nelle macerie si gioca a nascondino prima dei soccorsi
Liberatutti canticchiano le ruspe e arrivano i becchini
Scrivono i corvi con tremuli becchi la lista dei dispersi
Con le bombe facciamo palleggi di testa di piede di mano
Piroette sgambetti e passaggi fin quando non cade per terra
E’ un saltare di dita che pare la festa del primo dell’anno
A ciascuno il suo scoppio a ciascuno il tripudio di fuochi che spetta
Come stelle filanti le dita ricadono ognuna al suo posto
Ci si stringe le mani e stringendo si aspetta che faccia mattino
Zoppicando torniamo alle nostre baracche con meno coraggio
E c’è sempre qualcuno che arriva e controlla e ci conta e ci dice
Che nel campo si tace si dorme si muore anche il sogno è proibito
Siamo scorie eccedenze rovine del tempo robaccia che brucia
Riciclarci per cosa e per chi riciclarci per fare che cosa
Mentre grida ha negli occhi decine di metri di filo spinato
Col suo filo faremo una fune che sale alla volta celeste
Poter dire una volta di avercela avuta la testa fra le nuvole
A giorni alterni qui crollano le case in tutte le stagioni
Nelle macerie si gioca a nascondino prima dei soccorsi
Liberatutti canticchiano le ruspe e arrivano i becchini
Scrivono i corvi con tremuli becchi la lista dei dispersi
Nota critica di Rosa Pierno
La morte è presente nella vita attraverso lo squallore della vita stessa. Oppure nel reiterato tentativo di scrivere un testamento. Morte è come uno sfondo, ma non neutro, bensì opprimente e angusto, cappa che incombe e che non travolge solo per martellante crudeltà. Persino il foglio sul quale Luigi Necci scrive diremmo che è grigio, color fumo denso e untuoso persino, eppure nei primi componimenti della raccolta un insistito amore per la rima, per il rincorrersi delle sillabe attesta di un attaccamento alla vita, di una percezione affettuosa delle cose. Non sembra importare né al poeta né ai lettori a chi sia destinato il lascito. Il titolo d’altronde avverte subito che “avrai poche cose ma quelle le avrai”. Appare presto che si tratta di un elenco che individua la persona, visto che non si tratta di denaro, di immobili, di oggetti di valore, anche se la persona viene definita attraverso un ben più misero lascito: “la forfora nei vasetti, i ciuffetti \ di sebo, il pelo perso a primavera”, ma è appena un attimo, un tributo da pagare al fatto che in morte si lascia comunque un corpo. L’autore chiede che la sua urna venga riempita di fiori e di vento e che vengano stappati vini da versare nel corridoio per la festa da dare alla sua dipartita. Chiede che si apra un palcoscenico e si sollevino tendoni, che si rappresenti una commedia multicolore a cui debbano presenziare anche gli acrobati del circo. Un fantastico mondo si schiude dunque al solo paventare la morte, a testimonianza del fatto che nessuna vita è povera e priva lì dove le facoltà umane sono in azione. E se non c’è da lasciare un epitaffio, una considerazione morale, non importa. Non importa se non vi è niente da aggiungere, dopo una vita così ricca. Poiché Nacci traccia un elenco, con la levità e la delicatezza dell’espressione che lo contraddistinguono, di tale tenerezza che riconosciamo essere veri e propri tesori quelli che lui porta a dimostrazione del fatto che la sua esistenza è stato un viaggio all’interno della vita segreta degli oggetti: “le multe della biblioteca, \ i segnalibri parlanti di notte”. Avevamo forse sottovalutato la risonante capacità anderseniana di Necci di costruire favole a partire da oggetti di uso domestico: “le forchette spuntate, le tovaglie \ a quadri, le briciole ballerine. \ Le mareggiate nei boccali \ non ti dovranno spaventare, \ né i terremoti in lavatrice”. E che importa se è malcelato il timore che la persona a cui si rivolge lo dimentichi presto. E’ la vita. La vita, appunto. Eppure un dubbio: “ Abbevera i ragni in cantina. \ Nutri le rondini in inverno. \ Apri ai colombi la cucina. \ Parla in balcone ai girasoli”. Questo suo libro non è forse un testamento diretto a se stesso, per non dimenticarsi delle scelte, delle amate cose che rendono sensata e degna la vita?
Luigi Nacci (1978) organizza e partecipa a reading, festival e convegni letterari in Italia e all’estero. E’ curatore della collana di poesia “I libretti verdi” per Battello Stampatore e redattore del blog letterario “Absolutepoetry. Ha pubblicato Il poema disumano, Cierre Grafica.
Italo Testa, canti ostili, Lieto Colle 2007
Italo Testa, “Canti ostili”, Lietocolle 2007
Testi poetici
*
Venezia
galleggiano ancora le ceneri sul tappeto verde
nella prima luce
come dal fondo risalgono arti trasparenti
al richiamo dei fuochi, dei bagliori
della notte in cui si attraversano le acque
*
Sarajevo
prendi un’arancia, prendine un’altra
allinea 365 arance su di un parapetto
365 macchie sul bordo del fiume:
prendi un’arancia, sbucciala a morsi
scoprine il bianco sotto la pelle
macchia di sangue la linea dei denti
prendi un’arancia, apriti un varco
posa la testa sulla pietra del muro:
365 arance dense di luce
Nota critica di Rosa Pierno
Già fin dalle prime righe ci ritroviamo su un terreno instabile, scivoloso, periglioso e non solo perché la scena è quella di un probabile naufragio, ma soprattutto perché le parole che lo descrivono si mostrano simili a cristalli iridescenti, pure lusinghe o elastici metamorfici: “per non cedere ai topazi del cielo, \ ai topi pazzi di un’altra vita”. E la scena descritta è ancor più disarcionante in quanto ci viene detto che il veliero non c’è. La metafora, dunque, diviene ancora più potente se Italo Testa ci mostra il marchingegno in primo piano, quasi parossistico tentativo di svelarci il funzionamento della poesia: l’artificio per cui si può costruire un’immagine che parla di qualcosa assumendo altro.
Il libro “Canti ostili” è, allora, il resoconto di un viaggio compiuto tra gli strumenti dell’artificio, dietro le quinte, in luoghi dove l’effetto di realtà ha un valore iperbolico: gli scenari di guerra o i luoghi espositivi dell’arte contemporanea. Eppure, i luoghi descritti - di cui solo per precisione ipertrofica, l’autore segnala l’ora e i minuti in cui è avvenuta la registrazione del suo passaggio - sono non luoghi: “Questo non è un pullman. \ queste mani non sono mani. \ visti dall’alto: corpi impagliati sui sedili.\ questo non è un pullman. \ questi occhi non sono occhi: \ non sai distinguere la merda d’artista?”. Se siamo nel puro regno dell’artificio e della comunicazione, esistono, tuttavia, diversi gradi di manipolazione dei segni, diversi livelli di scambio comunicativo. Rappresentare e negare il contenuto della rappresentazione (“questa non è una nave. \ questa non è una notte”), descrivere un paesaggio come fosse un quadro (“ dopo Mostar, i mucchi di sabbia e di terra \ scavati, nella luce, senza ombra,”), utilizzare i paradossi (“ e in mezzo, più verde del verde, il fiume \ e i molti bagnanti nell’acqua, come insabbiati”), sovrapporre ciò che si vede a ciò che si immagina (“ ad ogni istante si crede di vedere un gregge \ e ci si sorprende invece a contare i fori, sulle facciate,”) sono gli strumenti utilizzati da Testa che si susseguono sulle pagine del libro come coralli che stiano fuoriuscendo da una collana rotta e che stiano spargendosi imprevedibilmente in ogni direzione sotto gli occhi del lettore. Ma non è un gioco in cui i segni finiscano con lo sfaldarsi. E in questo senso, proprio come accade nell’arte contemporanea di denuncia, il portato comunicativo non si volatilizza, riesce a porgere messaggi precisi contro la guerra e le ingiustizie. Questo libro si schiera per una valutazione della storia che sia strumento di denuncia dei soprusi; è contro la supina acquiescenza. Le operazioni sui segni danno la possibilità di cominciare daccapo, di ricostruire il mondo secondo visuali differenti da quelle propagandate, di sconfiggere una visione abitudinaria e appiattita della realtà. Se “il mondo disarma” non crediamo che Italo Testa resti mai senza utensili.
Italo Testa (1972) ha pubblicato Gli aspri inganni, Lietocolle 2004 e la raccolta Biometrie, Manni 2005. Suoi testi sono apparsi su diverse riviste e antologie.
Luigi Trucillo, Lezione di tenebra, Cronopio 2007
Luigi Trucillo, Lezione di tenebra, Cronopio, Napoli 2007
Trascrizione del commento interpretativo di Flavio Ermini
alla terza Biennale Anterem di Poesia, 17 ottobre 2008.
Scrive Luigi Trucillo in Lezione di tenebra: «... tutto ciò che vive / non nasce da ciò che nasce / ma da ciò che muore»
Cosa vuole dirci l'autore con questi tre versi? Trucillo ci indica che l'origine delle cose non deriva da ciò che ha inizio; bensì dal divenire, dal trapassare.
L'origine, insomma, non deriva dalla nascita, ma dalla morte.
Ma è un'origine che è comunque senza speranza quella di cui ci parla il poeta. Perché dopo il trapassare, accade questo - ascoltate questi tre versi: «le parole dei morti / aspettano i primi albori / inutilmente».
Lezione di tenebra registra con lucidità che l'essere umano è la vera vittima sacrificale della vita.
Se scorriamo le pagine della storia - dal primo uomo ucciso per mano di un altro uomo fino all'attentato nella metropolitana di Londra, entrambi esplicitamente richiamati nel libro - sembra inarrestabile il cammino dell'essere umano verso il vuoto.
Qualsiasi meta raggiunta non risulta che una stazione di un cammino; non appare che come una tappa in cui brevemente sostare.
Trucillo scrive: «Altrove / c'è un altrove / sempre più piccolo, / e poi un altro / ancora».
Ogni meta, dunque, appare come una perdita di senso.
Una catena di eventi, annuncia Trucillo, prelude incessantemente a vuoti che producono contorcimenti e strappi, distacco e fusione, urto e reazione, componendo un graduarsi di forze oppositive e non disgiungibili.
Una catena, appunto.
Qui, ci avverte il poeta, c'è: «un quadrante / dove le lancette corrono / immobili / a divorarsi l'un l'altra».
Questo quadrante è lo specchio dell'esistenza umana. La storia dell'essere si rivela in questo correre nell'immobilità.
Insomma, voi lo capite, non c'è scampo.
Pensare il principio, annota Trucillo, è «come immaginarsi un futuro / e ritrovarsi la morte».
L'uomo, infatti, si muove per un mondo sul quale è caduta ogni pesantezza.
Eppure cammina eretto con estrema eleganza. Forse simula, nel movimento, quel suo desiderio che ancora esprime speranza.
Il fiume ideativo di Trucillo ha molti emissari, ma la sorgente è una sola: il vuoto.
Ma a che cosa ci richiama la sostanza di questo vuoto?
All'amarezza, forse, di vedere i percorsi delle nostre rinascite interiori scadere nei gesti ricalcati, nelle parole che non nominano.
Il lavoro di Trucillo ci trasporta su questi fiumi sinuosi verso uno spazio inerte e senza colore.
Non sappiamo mai con certezza se sotto la parola seminata ci sia sabbia o pietra, mascherata com'è dal discorso dell'imposizione e della violenza.
Ci avverte Trucillo: «Nei tunnel / le uscite somigliano / alle entrate».
Non c'è via che porti alla salvezza.
La morte non ha mai guardato molto per il sottile.
Trucillo lo sa. Anche noi ora lo sappiamo.
Per questo le sue poesie sono impregnate di zolfo nativo.
E questo zolfo costituisce il segno dell'interrogazione radicale che la poesia - tutta la grande poesia - incessantemente pone.
Flavio Ermini
Silvia Bre, Sempre perdendosi, Nottetempo 2006
Silvia Bre, Sempre perdendosi, Nottetempo 2006
Silvia Bre
Sempre perdendosi
Nottetempo 2006
Freccia
Che debole io nel mezzo
a vibrare tra la freccia e il sangue,
disarmato, sfranto, non fosse
per il fiato che mi passa,
per il disegno che lascia da ascoltare,
che trascina, non fosse per il pianto uguale
che ci tiene e vi riguarda
e chiede, e fa che io rimanga.
Ma non capisco. Ho sonno.
Non capisco.
Quello che accade non ha le sue parole.
Non mi serve una tragedia,
basta il coro,
il costante lamento del destino.
Basto io stesso che imploro.
Preso da un grido
senza un argomento da toccare
è per voi che comincio?
Trascrizione del commento interpretativo di Flavio Ermini
Silvia Bre, Sempre perdendosi, Nottetempo, Roma 2006
Trascrizione del commento interpretativo di Flavio Ermini
alla terza Biennale Anterem di Poesia, 17 ottobre 2008.
Cominciamo con il registrare un'esperienza comune a tutti: le parole hanno il potere di rendere visibili cose e accadimenti che un attimo prima si intravvedevano appena.
Ebbene, con Sempre perdendosi, Silvia Bre rivela quella soglia che unisce un'esperienza storica, ben incastonata nel tempo e che tutti noi conosciamo - cioè il martirio di S. Sebastiano -, con un'altra di natura poetica.
Su quella soglia stanno le questioni decisive e costitutive del destino dell'essere umano.
L'uomo.
Badate bene: un essere pensato originariamente come luce, ma che, per come si è rivelato sulla scena del mondo, appare ora come ombra.
Ascoltiamo le parole che l'essere umano pronuncia e che Silvia Bre fedelmente registra: «Io vengo deportato / vengo allo sguardo».
Cosa vuole dirci Silvia Bre?
Ci annuncia che dall'ombra l'uomo sta per tornare alla luce.
Infatti, ecco che l'essere umano aggiunge: «Mi metto in mostra / come una vergogna».
Il ritorno a quella luce iniziale - ed è questo l'annuncio dell'opera, di Sempre perdendosi - può ancora essere compiuto, ma attraverso un cammino che costituisce il problema più grande.
Nel suo incedere verso la luce - una luce che lo ferisce e che lo porta in giro sanguinante - l'uomo non cerca un riparo che lo protegga; al contrario, offre il suo ascolto.
È un gesto di sfida consapevole quello che l'essere umano ci rivolge.
Le sue parole - l'essere umano - ha dovuto prima sentirle come straniere, per poi rivolgerle a noi da straniero, e potersene alfine appropriare come della propria lingua.
D'altro canto noi non possiamo rispondere.
Ci è data solo la possibilità, a nostra volta, di ascoltare. E condividerne il pianto.
Attraverso le sue parole - così come poco fa le abbiamo ascoltate da Slvia Bre - anche noi dobbiamo fare esperienza dell'estraneità, dello straniamento.
Solo nella non familiarità e nel sentirsi quasi stranieri si illumina finalmente l'essenza dell'essere a casa, dell'appartenenza.
L'ascolto. È questo il primo apprendimento all'uscita dall'antro: ascolto come passività nella quale può prendere forma la passione.
Il mondo era prima silenzio. Ora il mondo parla. Si rivolge a noi. Ci parla di un martirio incessante. Ci rivolge un appello
La voce che rompe il silenzio del mondo - poco più di un soffio, di un leggero respiro - opera uno sdoppiamento: noi ci sentiamo rispecchiati in essa.
Tanto da sentirci portati verso un centro vitale inattingibile.
Dove diventa irrilevante sapere chi testimonia e chi convoca; chi è noi; chi è chiamato a sperare...
Bisogna fidarsi della parola e affidarsi a essa.
È necessario accoglierla con il nostro assenso, in questo lungo cammino verso la luce.
Affinché non ci sia più bisogno di un martirio per diventare consapevoli del progressivo impoverimento al quale sottoponiamo la nostra vita.
Flavio Ermini
Anna Maria Farabbi, La magnifica bestia, Travenbooks 2007
Anna Maria Farabbi, “La magnifica bestia”, Traven books 2007
Testi poetici
*
Ho trovato la matria la falda acquifera
l’odore nuovo il suono respirando zitta:
la magnifica bestia nella mollica.
Le ho porto corona e regno:
il mio nome e la mia poesia
senza ululato senza melodia via
faccia e canto:
offro al pane
la soletudine della mia nudità regale.
Oltre le polveri gli acari del vecchio abbecedario
dentro cui il peccato e lo scandalo
il senso di colpa e la vergogna: qui ora:
il viaggio è altro. Oltre.
La bacio
mentre sento il divenire della mia sua saliva
e i semi
di lingua in lingua.
*
Per le cose che sai
barcollo fin dentro casa.
Che manca di tetto e pavimento: è il me
profondo.
L’acqua del cielo prende cadendo
lentamente il vuoto
della mia ciotola
e cresce cadendo
nella creazione di infiniti anelli
che continuano a formarsi formarmi
a sciogliersi sciogliermi.
Il pane nella madia in fondo alla mia cucina offre
odore a tutta la terra. La sonorità del lievito.
Quelle nostre cose case impronte digitali come sai
senti come si aprono ci congiungono ci impastano
ci nascono nella morte.
Nota critica di Rosa Pierno
La mente è localizzata anche nel corpo. E le funzioni vitali possono essere diversamente dislocate: il cuore è nell’ombelico ed è l’ombelico che pronuncia la parola cuore. Cuore “scelto da un fulmine per trasmissione \ di luce potenza e precisione”. La natura è ciò che Anna Maria Farabbi asseconda e accoglie. Si fa coppa per raccogliere la pioggia, ma non sfugge al lettore che essa non viene recepita passivamente dall’autrice. E’ attraverso la percezione e il sentimento che la poetessa sceglie la natura come componente essenziale, letteralmente, parte integrante di sé. Natura che viene captata e inglobata e non estroflessa come componente aliena. La sua poesia è un continuo canto di incitamento rivolto a se stessa per rendersi capace di un ascolto sensibilissimo, fremente, in grado non di accogliere il diverso come simile, ma di sentirlo come componente inscindibile da sé. Diventare uno strumento che registri le più flebili apparenze, le variazioni di colore, il respiro del mare, sentire il battito della terra attraverso i piedi e desiderare che trasmuti - attraverso una vera e propria operazione alchemica - nel suo stesso sangue è progetto che coinvolge tutte le facoltà e in modo totalizzante. L’obiettivo immediato è quello di acquisire la capacità di trasformarsi: “L’acqua del cielo prende cadendo \ lentamente il vuoto \ della mia ciotola \ e cresce cadendo \ nella creazione di infiniti anelli \ che continuano a formarsi formarmi”. Ma è una pratica che ha un doppio obiettivo visto che si propone di produrre testimonianza dell’avvenuta metamorfosi in forma poetica e, dunque, si pone un ulteriore processo di trasformazione. E non a caso la forma delle frasi sembra prosciugata, la sintassi consunta come da una lunga ebollizione, ove accanto a sostantivi, potremmo dire di portata elementare (terra, battito, piedi, corpo), ci sono coacervi non solubili nemmeno da un processo di fusione: “Sale \ in tutto il mio corpo il suo battito. Mi danza \ sangue e liquidissima ambra fossile”. Così che possa sussistere accanto a sangue una liquidissima ambra diviene per il lettore chiave di comprensione del processo a cui l’autrice sottopone il linguaggio attraverso l’immaginazione. Siamo in presenza di una natura ricreata da un essere umano. L’autrice scambia il proprio corpo: “L’invisibile multiforme uccellina \ affonda nel mio petto \ con leggerezza precisa e sibilante”. La precisione con cui avviene la trasmutazione attesta che il processo non lascia scarti. Eppure, è il processo razionale, non alieno da una componente morale, a mostrarsi, al fine, regista occulto di tale operazione. Come può infatti essere esclusa la mente se la Farabbi dichiara: “Per barattarci nell’intimità \ attraverso la creazione. \ Perché fare l’amore \ è agire e ricevere la creazione”. Il cerchio è chiuso. Fra i versi si vedono brillare pagliuzze d’oro.
Anna Maria Farabbi ha pubblicato poesia (Fioritura notturna del tuorlo, Tracce 1996; Il segno della Femmina, Lietocolle 2000), prosa (Nudità della solitudine regale, Zane 2000; La tela di Penelope, Lietocolle 2003), e opere di saggistica con traduzione.
Alessandro Catà, L’ordine del respiro, La Vita Felice 2007
Alessandro Catà, L’ordine del respiro, La Vita Felice 2007
Alessandro Catà, “L’ordine del respiro”, Edizioni La Vita Felice 2007
Testi poetici
*
Tornano fuori tempo
il filo e gli spilli, e un
sangue pieno di vento
è la pianura.
Nel cerchio
dove nessuno arriva
o parte, tu saresti
il mio segreto.
La cena
in cui le posate trattengono
l’universo;
la luce
della finestra di qualcuno.
*
Ricami, e pizzi – cominciano
a cadere le foglie davanti
all’edicola della tua mente –
e svolti su un calendario lento
di pianure; e osservi la riga
di ferro delle partenze.
Tre gradini, per separare
dalla terra una casa.
Un’onda di vetro ha spinto
le sirene al largo.
Impàri il cerchio delle donne.
Dipingi col filo.
Vegli su forme chiuse.
Nota critica di Rosa Pierno
Nella porzione di microcosmo che Alessandro Catà ritaglia di volta in volta per effettuare le sue misurazioni, il risultato è completamente alterato dal fatto che vi vengano confrontati oggetti inconfrontabili e dal fatto che la misurazione venga fatta con bilance non calibrate e con metri di materiale cedevole: è così che ottiene il suo risultato poetico. I paradossi che impila producono un risultato straniante che pare aprire mille direzioni nel nostro spazio abitudinario, sembra sfondare in altri mondi, incongruenti rispetto a questo, ma dotati al loro interno di una ferrea logica. D’altronde, la geometria non-euclidea, al suo nascere, non pareva il lavoro di folli che non si adattavano alle canoniche regole? “ Le \ bilance, a quest’ora segnano zero. \ E non è poi così perfetta \ la simmetria del non comprare o vendere, \ incerto il confine della materia, \ se una bilancia pende \ dalla parte del piatto in cui cade la \ luce”. In un mondo fisico così scombussolato, il polso fermo del poeta guida la materia con grande fermezza. Siamo nel regno della poesia e, dunque, tutto mirabilmente regge. Lo seguiamo in questi percorsi labirintici, in queste dimensioni plurime ottenute non con la proiezione di ologrammi o con la rappresentazione quantistica, ma con le metafore: la vera miniera di ogni cesellatore di versi. Qui, non si può dire che Catà essendo fisico di professione lavori su un terreno per lui più familiare, poiché la fisica da sola non costituisce il sostrato sufficiente e necessario per questo libro. Catà è poeta di professione. E’ soltanto questo che gli consente la duttilità per lavorare la materia, la sapienza della calibratura, la perizia della fusione. “ E vorrei (e ho) una moglie \ che all’aperto non ama le stesse mie \ case degli altri, la luce di \ rimanere piccoli, e ritagliati \ davanti alla carta da parati, \ nella sporgente scena \ di un teatro per sempre”.
A volte con crudele benevolenza, diremmo noi, suoi lettori, oramai già immersi nel suo fare capovolto, Catà prova a far quadrare la realtà in scatole geometriche, dona volume ai pesci, chiude mondi dentro una buccia. Ma è quasi una prova del nove che anziché attestare il risultato, ne dimostra l’inattendibilità. Con quale felicità, lo constatiamo nel brio e nella latente ironia che fuoriesce dai versi come latte non rappreso. E latte non riempie forse il cielo stellato? E le belle bolle non salgono dritte dritte al Paradiso? “Di conseguenza tendeva al biondo l’estetica, a rari insetti di tempo, ai grandi istanti ornamentali.”. Non sfugge ad Alessandro Catà anche la possibilità di utilizzare le parole: insetti \ inserti, istanti \ istinti in un gioco sostitutivo che crea sbilancianti scambi di senso, rotture dell’ordine. Nemmeno il linguaggio quotidiano sfugge all’operazionalità che sembrava possibile effettuare solo su mondi incompossibili!
Per Alessandro Catà: una recensione di Alessandra Paganardi
Alessandro Catà (1951) ha pubblicato in poesia Blocco riassunto, Corpo 10 Editore, il libro di prosa Ascoli, Narciso Editore, e l’antologia poetica La luce, Ila Palma Editore. Ha curato due antologie poetiche per le Edizioni Trifalco ed è autore di scritti e installazioni scientifiche.
Recensione su Alessandro Catà di Alessandra Paganardi
Ordine del respiro è un sintagma singolare, che Franco Fortini, nella nota espressione riferita a Pasolini, avrebbe chiamato – più ancora che ossimoro – “sineciosi”. Il fascino di questo libro di Alessandro Catà sta proprio nel riuscire a rendere la corrispondenza fra materia e pensiero con un’esattezza e una profondità che fanno pensare, più che ad antecedenti letterari diretti, all’ardua lezione spinoziana d’etica, di geometria e di vita. Non deve essere difficile per l’autore, esperto di relatività, pensare e scrivere in termini di precisione matematica: stupisce tuttavia che nulla di questo codice rimanga estrinseco all’esistenza, in un libro in cui la carne non è mai ignorata, anzi si risolve in un pensoso requiem per il padre scomparso, per le molte ombre lontane di amici e antenati. «Ci incontreremo ancora, padre; forse una volta ancora dietro/ l’incandescente geometria dei/ morti, quando verrà, è scritto/ la resurrezione dei corpi». E’ una carnalità non autobiografica, ma universale, dove il linguaggio media vertiginosamente fra esperienza e logos e dove il continuum cronologico consente un emozionante scambio fra le generazioni: così anche il poeta può vedere se stesso come futura radice del proprio figlio, nella reiterata parabola del destino: «Ti cerco con il dolore/ con cui un giorno, cercando/ se stesso, mi cercherà mio figlio».Il tempo è anche una curva ciclica, non lineare, che ci riporta sempre all’inizio. «Futura la mano del figlio/ che ti guidava all’asilo». Se il tempo è relativo, se - come direbbe un matematico - è una serie d’infiniti che converge inevitabilmente nel finito della morte, il poeta può smascherarlo perennemente discronico, sbagliato: settembre, novembre, l’alba, il calendario sono la rappresentazione di fusi orari in continua fuga, in una messinscena tragicamente convenzionale. «L’ora che sgocciola su un mattino/ sbagliato, mentre viene la roccia/ a svegliarti […]». «Settembre non esiste; è consolarsi con le navi/ in bottiglia » ; «Novembre vai a fare/ dietro la maschera/ della preghiera». Il tempo che ci consuma, che ci fa invecchiare e morire, colpisce come uno schiaffo in un qualunque pomeriggio alla finestra, nello spegnere una sigaretta, nel veder composta la nostra immagine allo specchio, «superficie della materia – lo scopo, nel buio,/ di una luce in cui veramente/ gli attori non muoiono». La luce è l’altra grande protagonista, oltre al tempo e alla morte, di questa raccolta; ed è spesso una luce tagliente, microscopica e spietata. Possiamo vedere in essa il correlato fisico della cosiddetta “percezione sottile” (di cui uno dei primi ricercatori, non a caso, fu proprio il matematico e filosofo Leibniz, che elaborò tale intuizione insieme con il calcolo infinitesimale). Questa sensibilità poetica, basata sull’estrema concentrazione visiva, si nutre di uno sguardo mentale simile all’attenzione zen, cioè alla preghiera millimetrica dell’anima. E’ la stessa luce misurata dall’astronomo Arthur Eddington nel 1919 durante l’eclissi totale in Guinea e poi illustrata, a sostegno della relatività generale einsteniana, nello scritto intitolato Il peso della luce. Il poeta, come lo scienziato, non ha il compito di cercare significati nebulosi, ma esatte misure; la parola porta, scrive Catà, dove «una bilancia pende/ dalla parte del piatto in cui cade la/ luce». Il peso infinitesimo converge nell’inavvertibile, lo spiraglio nel limite dell’ombra: per questo Catà, nel poemetto La luce di ognuno (forse uno fra i vertici del libro), può comporre un mirabile canto funebre, in cui lo scatto ultimo coincide con la transustanziazione della materia in energia. «Perché da sempre Natale/ è questo: l’ombra di un vetro, i morti/ passeggiano in giardino. E’ la parte/ femminile del tempo.[….]. La luce della luce di ognuno». La poesia di Catà realizza, per usare un’espressione che fu riferita allo stile immaginativo di Botticelli, una dimensione molto particolare di “lirismo esatto”: nulla è di troppo, non c’è mai spazio per il superfluo o per le dichiarazioni di principio; tutto è trasfuso nella parola. Una lezione che la poesia di ogni epoca dovrebbe saper ascoltare.
Alessandra Paganardi
Alessandro Catà, L’ordine del respiro, edizioni La Vita Felice, Milano 2007
Alessandro Assiri, Il giardino dei pensieri recisi, Aletti 2006
Alessandro Assiri, “Il giardino dei pensieri recisi”, Aletti Editore 2006
Testi poetici
*
La nostalgia ha un suo colore, un bisogno di visi, un’assevirsi alle cose; perché ricordiamo facce e desideriamo assenze. Un’atmosfera furiosa, la nostalgia, dalla quale emergono uomini che avrebbero potuto, ma non hanno osato. Poi, dopo, molto dopo, tra gli effluvi del giorno, affiorano sogni possibili.
*
Dove tutto si sfiora e niente si incontra, là siedo io in compagnia dei miei dei, qualche amico al bar che vola nella leggiadria delle cose, di questa vita incurante delle altrui speranze. Vorrei sapermi innalzare, fosse solo per fuggire dal brusio delle mie moltitudini, il plurale che osservo e questa unità che non riesco a trovare. Angoscia, che nasce allora come sublime paura, che rigetta ogni altro insipido timore, per spalancare il baratro sulla ciclicità dell’esistenza, su quella solitudine che non riesco a chiamare per nome.
*
Ogni giorno si spezza qualcosa, un ramo, una schiena, una vita, un frammento e noi passiamo il tempo nel tentativo di aggiustare, di ricomporre armonie. Siamo piccoli artigiani, con l’illusione della saldatura. Questo scomponimento, che a ogni attimo ci rende più piccoli; esaltazione dell’allontanamento o frenesia della dissolvenza.
Nota critica di Rosa Pierno
Si potrebbe definire una collezione di dubbi, un esperimento in cui agitando le cose, imprimendogli spinta e controspinta si saggino i limiti di resistenza delle stesse. Non è chi non sappia che il poeta che investiga sulle cose effettua la medesima sperimentazione su se stesso. L’autore si sente a tratti rigido, a tratti informe: “peregrinazioni incerte, tra esodo ed esilio. Sì, vago e ne sono consapevole, tra parole espresse e quelle da trovare, tra ciò che vorrei fare e l’amor del progettare”. Il dubbio non nasce solo di fronte all’esistente, ma si estende ai mezzi dell’investigazione e non tarda a coinvolgere lo stesso Assiri che, però, tenace, non si lascia travolgere, ritagliandosi un punto di vista esterno. Alessandro, va così tracciando una sorta di autobiografia, scevra però di scansione temporale (tipica, invece, della forma diaristica). Non manca a questa scrittura la prospettiva morale che illumina con un viraggio particolare ogni suo incedere. Si tratta di un percorso in cui, pur denunciando la vaghezza di uno scopo o di un senso, Assiri pone sempre una luce al termine della galleria (obiettivo, progetto, speranza). Allo stesso modo non manca mai una tenera affezione verso gli oggetti della sua perlustrazione, frutto di un amore per le sensazioni, per le percezioni, per la qualità del vivere: “Stringo le sensazioni, le coccolo, le proteggo, ed è vero ne godo del loro appartenermi”. In ogni caso, siamo in presenza di una indagine che non rifiuta nessuno strumento: vengono convocati sogni, pensieri, nostalgia, memoria. Tutto è indispensabile per tracciare con completezza un ritratto, anche se la fisionomia da ritrarre manterrà sempre uno scarto, una differenza non rappresentabile rispetto alla parte rappresentata. L’immaginazione è un elemento irrinunciabile che tesse legami lì dove apparivano lacune, che annoda il contenuto di lacerti nostalgici. Persino i mancamenti, i fallimenti sono degni di essere conservati con amorevole cura: quanto altri reperti servono a tracciare della via che è stata percorsa e che già solo per questo è degna: “e quel piccolo meccanismo che ci tiene avvinghiati, così simile alla mia codardia, così vicino alla mia incapacità”. Non è solo una via tracciata col sé, è anche una via seminata di dialogo con l’altro, di sincera condivisione. Quando l’altro acquista dignità metafisica, il linguaggio piano, smorzato di Assiri si fa acre, venato di rimpianto: realtà a cui sa in anticipo di non poter accedere: “ Tu sei ed io non sono, in uno strano andamento che, come onda, innalza e sommerge, esisti ad una gloria inaccessibile, alla quale vigliaccamente partecipo”. E’ quasi in un’atmosfera rarefatta che Assiri costruisce il suo libro, ma un chiarore costantemente emana: la sua adesione alla totalità si è compiuta, pur in un mondo dislavato.
Alessandro Assiri nasce a Bologna nel 1962. Presente in diverse antologie poetiche, ha pubblicato Morgana e le nuvole, Aletti Editore e Modulazione dell’empietà, Lietocolle Editore. Collabora con riviste cartacee e telematiche.
Luigi Fontanella, L’azzurra memoria, Moretti & Vitali 2007
Luigi Fontanella, “L’azzurra memoria. Poesie 1970-2005”, Moretti & Vitali 2007
Testi poetici
*
Fra pareti bianche
mentre sugli occhi
un soffio
non s’aspetta
un gesto e via:
poi si è dappertutto
e quanto si vuole.
*
Sulla distesa del mare
“enigma d’azzurro e di morte”
lo scalpitio rosso di un cavallo:
un bambino tocca una pianola
dimenticata agli occhi
del suo angelo bianco. Morire è
di nuovo sentire una stagione
un’aria di cielo.
*
Nota critica di Rosa Pierno
La poesia di Luigi Fontanella è una di quelle in cui più saldo appare il legame esistente tra reale, parola e memoria (ove la memoria venga considerata come la facoltà precipua della cultura). Saldo nel senso di risolto. La fusione è stata tale che i tre elementi appaiono avere medesima materia: “per determinare il tuo viaggio \ di fronte a pilastri fuggenti luci \ che intrecciano il volo con le parole \ bisbigliate nell’aria”. E’ in questo senso una poesia dalla forma metamorfica, ove parole trascolorano e trapassano una nell’altra a tal punto che diviene impossibile rintracciarne i punti di giunzione. Al contrario, il verso, quasi come un argine, ha una misura stabile, sponda che consente alla parola le sue escursioni. Una cadenza costante sostiene anche il passaggio tra ciò che il poeta vede e la riflessione su ciò che ha visto, mai sfondo, ma parte integrante, indisgiungibile: “ e questa \ corsa sull’erba il conto \ a ritroso che non lasca speranza. \ Più facile adesso però capirne \ la forza l’importanza, quando \ a passi d’uomo misuri la distanza”. Il fulcro generatore della poesia di Fontanella è, dunque, una capacità visionaria che trascende il dato visivo in quello immaginativo per cui il treno diviene “in uno sferragliare d’anni e di armi \ antico cavaliere o crociato sublime”. Allo stesso tempo, i suoi versi registrano la sua autobiografia. E si sa che ogni autobiografia è sì invenzione, dato artificiato, ma qui, in particolare, si ha la sensazione di un’aderenza assoluta al sé, forse per un certo velo di mestizia e di rimpianto che accompagna le effimere forme dell’esistere. Ciò che gli occhi vedono è in un istante già passato. Nel percorso che la collezione di poesie srotola, il dato visuale va intensificando la sua presenza fino a divenire dominante e la lunghezza del verso si rastrema quasi a significare una rarefazione dello stesso senso estraibile dal consunto dato percettivo. Come un pittore che guardi la bottiglia che vuole rappresentare, Fontanella scrive: “L’ho fissata a lungo \ fino a che è scomparsa \ effusa \ lieve e trasparente \ rosa cosa dell’aria \ palpito \ o diafana medusa”. Eppure, mai è chiusa la partita dell’incessante dialogo tra segni, realtà e sfera psichica. In uno sfavillare di giochi sonori, parole si rincorrono come riflessi sulla superficie dell’acqua. Lettore rincorre le sfavillanti presenze sapendo di non doversi posare su così mobile e volatile sostanza: “Parola lino di broccato \ vasta scienza in agguato \ pianura \ e rivestimento d’un artificio \ oltre ogni limite fisso \ oltre ogni steccato”. E naturalmente, il tempo qui non può essere che un’opinione, non può che ottenere una definizione personale. Oggi è equivalente ad allora. E lo stesso io appare quasi inficiato da una memoria che “tutto avvicina \ e già svapora”. Ma la poesia, esattamente come la certezza data dal cuore che batte, è battito vitale. E’ una lezione, quella impartitaci da Fontanella, sulla capacità operazionale della poesia di mutare la sostanza delle cose in visione perenne.
Luigi Fontanella (1943), Ordinario di Lingua e Letteratura italiana presso l’Università statale di New York, ha svolto intensa attività giornalistica oltre a essere poeta, narratore e saggista. Dirige dal 1982 la rivista internazionale “Gradiva”.
Camillo Pennati, Modulato silenzio, Joker 2007
Camillo Pennati, Modulato silenzio, Joker, Novi Ligure (AL) 2007
Trascrizione del commento interpretativo di Flavio Ermini
alla terza Biennale Anterem di Poesia, 17 ottobre 2008.
L'essere umano e la natura. Mai come oggi queste due entità sono state così distanti tra loro. È sotto gli occhi di tutti questa lacerazione.
Solo la parola poetica - ai nostri giorni - è forse in grado di farci conoscere la fratellanza che - all'aurora del mondo - univa questi due elementi.
Quando accade? Quando la parola poetica si fa luce.
Lo registra Camillo Pennati in una delle poesie che aprono il volume Modulato silenzio, quando annuncia: «la luce che lambisce il globo / da aurora riabbracciandolo».
Quella luce ha un compito: dislocare la natura nel cuore della parola e da qui tornare finalmente a invadere i sensi dell'uomo.
Questo percorso nella poesia di Pennati si sviluppa per aggiunzioni continue di frasi sospese, echi di sillabe con ritorni all'indietro, ripetizioni avvolgenti.
Lo avete avvertito anche voi - non è vero? - come nella poesia di Pennati il pensiero si sviluppi man mano nel flusso delle parole.
Dalla lettura del poeta si avverte in modo particolare.
Ci troviamo di fronte a una mobilità - una mobilità, a ben vedere, propria della luce - che può espandersi in ogni direzione.
Una mobilità che insegue la sorpresa del dire qualcosa che fino a quel momento non si pensava.
Accade questo. Accade una cosa straordinaria: la natura si fa presente come fatto poetico che dà al pensiero da pensare.
Situare l'immagine primaria non sulla natura ma piuttosto dentro di essa - come fa Pennati - fa sì che la terra diventi il sostegno ideale per la manifestazione dei sentimenti.
Attenzione: si tratta di una terra-tessuto che attraverso l'intreccio delle emozioni impone alla figura umana di generare altri rapporti, altre allusioni, altri sensi.
Tanto da poter a sua volta diffondere la luce della propria essenza.
È allora che l'impegno del poeta si fa estremo, tutto affidato agli equilibri della percezione.
In un mondo di categorie e generi ben definiti, la mescolanza e la coabitazione di molte diversità diventa rivoluzionaria.
È a questo punto che Pennati, in nome della poesia, dichiara l'insufficienza della scienza nella conoscenza della natura, proprio per via di quella razionalità categoriale che la caratterizza.
Razionalità categoriale che Pennati non esita a definire: «quell'ingannevole diaframma».
La luce svela un corpo radioso e insieme le paure che lo aggrediscono.
Svela parvenze, giardini rutilanti, ammassi di pietre preziose.
Rivela un'attenta riflessione sull'avventura umana.
Le pagine assorte di Modulato silenzio si costituiscono come una vera e propria guida.
Ci indicano come attraversare le sensazioni più riposte, quelle sensazioni dalle quali scaturisce una visione avvincente del tempo.
Ma, attenzione, quale tempo? non certo quello progettuale o quello escatologico, bensì il tempo legato ai cicli naturali.
Ma non solo.
Dalla poesia di Pennati emergono con forza le incertezze e le incoerenze della nostra condizione esistenziale.
E questa denuncia impone di aderire senza ripensamenti a tutto ciò che nella natura incessantemente appare.
Flavio Ermini
Evelina Schatz, Amici amati, Karwan Samizdat 2005
Evelina Schatz, “Amici Amati”, Karwan Samizdat 2005
Testi poetici
*
Dov’è il luogo che ha affossato la mia passione
la festa pulsante della carne
ora ingoiato dall’oblio, ma forse anche lì
trova senso senza più stimoli
l’erotismo obliquo e trasognato
Scendere agli inferi da soli si sa è impossibile
pietrificata Musa, vuoi cogliere l’ultima occasione?
*
mercati di Odessa
odore di rombi e sgombri
Goethe, il burattinaio
tirava fili del
pensiero al nascere
Scrittura gotica era poesia
il gioco impossibile
tradizioni sconvolte
frantumi di memorie
schegge catalogabili
negli archivi scomparsi
carovaniere lanciate
nello spazio altrove
piste di partenza,
sempre nuove
Nota critica di Rosa Pierno
I lettori sono immediatamente introdotti dalla prima poesia all’interno di un antro che si perde nella notte dei tempi, perché qui l’elemento paradossale è proprio la presenza del tempo: convocato, ma solo per essere rovesciato nel suo contrario. Che esista un tempo che vada in direzione opposta a quello indicato dagli orologi è di lampante evidenza. La Schatz ce lo mostra come un trofeo di cristallo: significati, nomi, storie sono contratte in astanza: i ricordi si presentificano insieme all’atto del sacerdote egizio che cancellava i segni, come in recenti giorni fa Isgrò. L’asse diacronico è compresso. Esiste solo un punto sincronico ed è profondo come un buco nero. Che la poetessa scelga di fatto che cosa far affiorare dal calderone è nondimeno atto casuale: “a Samarkanda il giorno di battaglia \ si parte per la luna: \ spazio amletico e talmelliano”. Compresenza ha questo di peculiare: coesiste. Si vede solo quello che se ne può vedere, quello che emerge dal caotico ammasso. Come si potrebbe d’altronde realizzare la biografia di un essere umano? Ci sono mille modi per narrarsi e nessuno di essi può esaurire l’argomento, ma ogni parola-mattone costruisce un edificio dal quale non si può prescindere. E l’edificio costruito dalla Schatz ha una particolarità indeclinabile: è costruito con la cultura, l’immagine che si viene formando negli occhi del lettore è fatta di citazioni, frammenti di immagini e di parole che non hanno referente, quasi a voler volgere in ostico atto l’atto stesso della comunicazione, appena illuminato dalla soave scorrevolezza del verso: “a dicembre ad Agazzano nel ripetersi del rito \ luce lene gettata sull’amore \ perenne canto dell’universo al lume \ dell’incanto dell’essere. Così Natale!”. Anche la dimensione della scala è alterata: sono presenti soltanto i due estremi: ciò che si vede, gli oggetti quotidiani, la linea dell’orizzonte e ciò che non si vede, l’infinito, il non immaginabile: “Gioire fino all’infinito \ Festeggiando la propria nascita \ nella perdizione scivolare sullo scivolo \ del sestante di Ulug-Beg”. La Schatz ha costruito il suo libro solo in apparenza con materiali eterogenei, in realtà esso risulta coesissimo, forgiato da una temperatura esistenziale che li ha portati a fusione. Così questo libro, biografia di sé e insieme biografia di amici, di amanti, di conoscenti, è insieme libro dell’infinito: “ quel manto di pelle \ madida calda e sfatta \ mi prendeva nel Suo \ infinito - del dopo - \ l’amore - del dopo \ la morte – grembo \ materno”. Esiste un universo possibile dove l’io si fa con gli altri.
Evelina Shatz è nata sul mare di Odessa. Poeta bilingue, scrive in italiano e in russo. Artista, performer, saggista, giornalista, storico e critico d’arte, regista e scenografa, ha pubblicato in Italia, Russia e altri Paesi, saggi, scritti di narrativa e di teatro. L’opera omnia della sua poesia in lingua russa è uscita nel 2005 per la Casa Editrice Russkij Impuls.
Marco Giovenale, criterio dei vetri, Oèdipus 2007
Marco Giovenale, “Criterio dei vetri”, Oèdipus 2007
Testi poetici
*
si segna avanti al tempo, ai gradi del meccanismo:
dice goniometro, clessidra dall’archivolto, acqua.
l’ombra lecca il corpo che la getta, va e consuma,
lui passa le età, non avverte i granuli
che queste addensano, corpo come lo straccio cancella
e si elide mentre mangia il parlato o disordine
nelle caselle, dato misura densa.
ha l’inesattezza dell’aria
come ogni volta all’origine
l’airone: oriente del fiume
*
tempo fa, le sei di mattina.
si vede appena, in penombra appena
più freddo, cose – cifre, ciglia quasi
o cilindri della luce, bianchi ritti,
le fabbriche e i silos, i capanni vietati,
o ossa seppellite, male. (niente male.
niente dita). (cosa
su cui contare)
Nota critica di Rosa Pierno
Come un fantasma che riuscisse ad infiltrarsi attraverso la tramatura delle cose, fra la sovrapposizione delle materie, e con precisione vedesse ciò che non è visibile agli altri, Marco Giovenale restituisce la forma delle cose attraverso inversioni, rivolgimenti, rovesciamenti montaggi, alterazioni cromatiche, tagli che non mirano alla riconoscibilità dell’immagine: eppure sono tutte operazioni consentite dalla simmetria, dalla geometria euclidea o non-euclidea che sia e paiono spalancare profondità siderali sia nel reale sia nel linguaggio. Non è, infatti, lontano il gioco delle alterazioni prospettiche (da Escher ottenuta con mezzi più poveri) in cui mettendo tutto sullo stesso piano, oggetti ed essenze, e invertendo gli assi, quelli metafisici con quelli fisici, il risultato che si ottiene è la decontestualizzazione di ciò che è consueto: una vertigine ci afferra, e quasi ci fa perdere i sensi. Vorremmo riuscire a far quadrare i conti col senso, risolvere l’apparente rebus di una consequenzialità negata per la volontà di restituire attraverso oggetti reali una latitante interiorità. Qui parole sono pietre, ciottoli accostati l’uno all’altro che formano una tassellazione solo sovrapponendosi, il che nega l’assunto iniziale proprio della tassellazione. Col linguaggio Giovenale costruisce vere e proprie voragini: “o è molto terso e non si avvera \ o cresce doppio in opacità, e allora \ non ha direzione. Il cane gioca \ a eludere per volere \ il cappio che ha”. Un linguaggio sconnesso, a cui siano stati fatti saltare non solo i consueti legami sintattici, ma anche le dimensioni di riferimento semantico, “e toro \ che chiede senza pagare niente \ di esserci, restare” ha, qui, valenza metodologica in quanto l’impeto associativo non lascia molto spazio alla mimesi. In fondo, se pur si parte da oggetti che si trovano in uno spazio naturale: insetti, ardesia, buio, rumori, parco, laghi, il risultato che Giovenale ottiene è una sorta di scrittura quasi liberata dal reale e aperta all’avvicendarsi di porzioni d’immagine, di visioni fratturate, appartenenti a una proiezione esclusivamente mentale. Un linguaggio che abbindola poiché non abbandona la descrittività attraverso i colori, la geometria, “staglia in terra le cose chiare, \ sono tese non rette, bianche, \ coalescenze, andate”, ma che pure si protende inevitabilmente verso una scrittura liberata da ambizioni descrittive. Nemmeno è pensabile riconoscere una sorta di narrazione in un serie di frasi precise, ma senza legame diretto: “il licenziato piange e pubblica, dedica, vende \ dopo quattro anni le vetrate sono nere \ il casale ci si arriva due tre ore \ di macchina, meno se c’è il sole”. Così Giovenale avendo scardinato la consequenzialità del senso e della sintassi, ci mostra un mondo ricreato attraverso regole di pura visionarietà. Fotogrammi, ottenuti con un’operazione al quadrato, si succedono sulla pagina multidimensionale: rappresentazione di rappresentazione.
Marco Giovenale (1969) ha pubblicato “Curvature”, Camera verde editrice, “Il segno meno”, Manni, “Altre ombre”, Camera verde, “A gunless tea”, Dusie.org. Suoi testi sono apparsi in varie riviste e antologie. E’ tra i redattori di “Gammm.org” e “Sud”.
Roberto Cogo, Di acque / Di terre, Joker 2006
Roberto Cogo, “DI ACQUE \ DI TERRE”, Joker 2006
Testi poetici
*
ombre allungate sul verde del pendio
le chiazze rosse dei pochi tetti
s’accendono di tanto in tanto
il vento innalza e precipita i suoni
sfalda la materia fugace
delle nubi
l’inesausto pervadere degli umori
di ritorno con il sogno
di un principio impresso sulle cose
*
altro è l’oggetto del suo precipitare
un piede dolente – la sfida notturna
dell’ego – tutto il non-scritto
del mondo
nella pigrizia del risveglio
ripiomba nel sonno – attraversa finestre
di luce tarlata – il rosso dei drappi
cala il filtro canoro dell’usignolo
sul ramo di fronte
tutta un’estasi di calore che s’adagia
sullo scoglio gelido del corpo
Nota critica di Rosa Pierno
Quando tutto è perduto, si può ricominciare dalle percezioni, ove solo apparentemente la mente arretra: in realtà, essa non utilizza un sistema già formulato, ma si apre alla valutazione come se tutto fosse da riscrivere, come se ogni percezione fosse verifica della precedente, utile per costruire un nuovo sistema e anche gli strumenti utilizzati fossero ogni volta da controllare e da ridefinire. Seguendo i versi piani, pacati, al limite del prosastico o dalla rastremata cifra poetica di Roberto Cogo, ci ritroviamo immersi in un quadro impressionista, ove “velature \ di nubi fluorescenti prospettano \ partenze”, ove, attraverso il linguaggio, ogni elemento viene ricreato. Il referente è confinato nell’evento quotidiano “una famiglia prende posto qui accanto, nessun disturbo, sorrisi di comprensione”, a dimostrazione del fatto che i più grandi esperimenti si possono condurre nello spazio quotidiano della propria esistenza, anche nei suoi momenti più poveri di eventi emotivi e mentali. Sarà procurando squarci al telone dove il reale è proiettato come un film che si accederà ad una diversa visione: “tutto accade come frutto di circostanze particolari, solo lì, in quel momento, esiste, si svela e si riflette nella mente individuale”. Siamo giunti al momento individuale in cui la percezione si fa rivelazione: “torna la riflessione sull’arte, sulla possibile riproduzione, quella pretesa di fare da specchio, non mimesi, ma trasformazione”. Il quadro di riferimento è quello della rappresentazione. Il dialogo si attua tra natura e forme attraverso l’inevitabile memoria che concorre prepotentemente nell’atto creativo. Con Cogo, leggendo, verifichiamo che vivere è dare una forma. Che la percezione è già elaborazione, atto creativo che ha una sua singolarità non opinabile. Che nella percezione sono già entrati in azione il pensiero, la memoria, le conoscenze culturali. Che alla percezioni non è necessario aggiungere più nulla, se non la forma che essa assume nella sua rappresentazione: nel prodotto artistico. Si forma dunque, sotto i nostri occhi di lettori, la pagina iridata da fluorescenze, rivoli, ombreggiature, chiaroscuri e pulviscolo luminoso. Roberto Cogo dipinge la pagina con mille sfumature acquerellate, con bagliori metallici: “nel lucido armeggiare delle onde \ tra le increspature \ si rivestono di mobili corazze i bagnanti”. E’ una pagina ambigua, ove il testo cede continuamente all’immagine e viceversa. Siamo nel dominio dell’ecfrasi: “dare un senso alla descrizione? Puro gusto di annotare e fissare fuggevoli impressioni?”. Inutile chiedersi se la poesia così catturata sia una pesca stabile, se “basterà il ricordo a prevenire ulteriori cadute”. La mente non è pietra, la labilità ne è una componente, forse salutare. Se non ci perdessimo non potremmo ritrovarla. Noi intanto collochiamo in un posto sicuro, dove potremo facilmente ritrovarlo, il libro “DI ACQUE \ DI TERRE”.
Roberto Cogo (1963) ha pubblicato Moebius e altre poesie, Editoria Universitaria e, con le Edizioni del Leone, le raccolte In estremo stupore e Nel movimento, seguite da Il profilo della volpe sul vetro, volume di traduzioni.
Ultima pagina: immagine-poesia di Maria Grazia Martina

vela
L'aria
gonfia la nuvola
La parola trasparsa declina
Insola
a novembrare
Verona
Dice la vita.
Raccolta inedita: poesie dei finalisti e del vincitore, commenti di Giorgio Bonacini
L’inserimento dei testi non ha seguito i risultati del premio ma un percorso che si delinea attraverso le tendenze della poesia contemporanea: tra possibili contiguità, in un itinerario che scorre non solo all’interno di questa sezione ma si connette, nel suo ideale svolgersi, anche alle altre due.
Domenico Cipriano, Novembre
Domenico Cipriano
Novembre
(2005-2006)
Testi poetici
*
ti guardo con occhi
diversi parola risorta
ogni notte udendo
la voce degli uomini
senza più voce, lontani
sfuggiti dai luoghi.
torni di notte, distante
un respiro e lì germini
frasi distorte che
modifico in vita.
poi credo e non vedo.
*
trema la terra, le vene hanno sangue che geme e ti riempie.
è un fiotto la terra che lotta, sussulta, avviluppa, confonde
la terra che affonda ti rende sua onda, presente a ogni lato
soffoca il fiato, ti afferra, collutta, si sbatte, si spacca, ti vuole
e combatti, chiede il contatto, ti attacca, ti abbatte. è fuoco
la terra del dopo risucchia di poco le crepe: la terra che trema
riempie memoria, ti stana, si affrange, ti strema, è padrona.
Nota critica di Giorgio Bonacini
Scrivere in poesia di un evento tragico e terribile (nel caso specifico il terremoto in Irpinia) comporta spesso il rischio di cadere in un realismo superficiale, dove la sofferenza cede al patetismo e il dolore profondo è ridotto ai luoghi comuni del pianto. Nelle poesia di Cipriano, dedicate al ricordo di questo evento, il pathos è, invece, veramente parola dolorosa che si schianta, che sgretola il senso, che smuove e commuove. Perché il nostro autore sa che la poesia è voce e i fatti sono la materia a cui i versi, man mano che prendono forma, danno significato.
Da subito, nella poesia introduttiva, si capisce la capacità di entrare nelle cose cercandone il segno originario, tanto difficile perché la parola risorge “ogni notte udendo/la voce degli uomini/senza più voce...”. Ma il terremoto (e i suoi effetti interiori più che esteriori) prende vita con un uso fonico del linguaggio, efficacissimo nel far risuonare la catastrofe della terra che “ti afferra, collutta, si sbatte, si spacca, ti vuole/.../la terra che trema/.../ti strema/.../è padrona.” E qui non possiamo non notare con quale efficacia le allitterazioni e le assonanze riproducano la forza devastante della terra che spacca le cose e sgretola la mente. Siamo in presenza di una forte immagine in cui gli effetti del terremoto si riverberano sugli esseri umani e viceversa, imprimendo una vera e propria umanità alle cose (feritoia incancrenita; volti tumefatti delle cose), in una trasfigurazione del dolore provata anche dagli oggetti vissuti.
C’è, in questi testi e nel suo autore, una consapevolezza manifesta di quanto la poesia cerchi i suoi sensi nello sguardo stupefatto (nella gioia e nel dolore) dell’infanzia: non come semplice stadio della crescita, ma più profondamente come primordialità nella creazione e svolgimento di significati esistenziali nuovi, dove “solo i bambini riconoscono i gesti degli affetti/e il gioco nel vivere insieme in un non-luogo”. Le macerie reali sono, dunque, un vuoto detto con parole “semplici” ma cariche di senso emotivo inusuale. E, ad un certo punto il nostro autore arriva, con una piccola inversione sintattica, ad arricchire di nuove significazioni il testo, dicendo che “bastano parole poche”. Non dice “poche parole”, che sarebbe un fatto meramente quantitativo; ma, invertendo i termini, dà un alto valore di qualità alla povertà originaria della lingua, che il poeta sempre ricerca e di cui necessita per scrivere. Questa è l’autenticità della voce di Cipriano: una voce ferita che ci porta dentro a un accadimento di morte con parola limpida, sommessa, ma ferma anche nel grido di “un mucchio di nomi mai sentiti.”.
Mario Fresa, Separazione dalla luce
Mario Fresa
Separazione dalla luce
Testo poetico
*
Così tu segui i portentosi rulli di luce
intervenire su di un sorriso nuovo.
Ma inventare si può
soltanto nell’ingrato seminare di orologi
che preparano discordie:
le rose ti consumano la vista.
*
L’anima cade nella vetrata quando muoiono, d’incanto, le
parvenze. Una semplice arena che cresceva notti lunghe:
era il poema violento della vista,
ma ti accorgevi allora di non essere che un inesatto
gesto, un sonno tutto lieve che scuoteva le dimore.
Nota critica di Giorgio Bonacini
Ciò che contraddistingue fortemente la voce e la scrittura di Fresa è l’andamento costantemente evocativo della sua parola poetica. Ma l’evo- cazione non è mai il segno, per così dire, di una scaltra poeticità dove l’alto livello linguistico è solo un artificio di distanza dalle cose basse; no, qui la lingua stra-ordinaria affiora in un corpo dove “non ci sono amarezze nelle parole divenute/incandescenti...” perché la sua voce “è una severa fuga”. Ed è in questo modo che vediamo affiorare vaste foreste di sentimenti: in forme di sogni, desideri, accenni indistinti a un tu sempre presente ma mai afferrato; e ciò in virtù proprio della consapevolezza, ben ferma nel nostro autore, di chi sente la poesia come un rincorrere costantemente una conoscenza diversa, tesa e lacerata, in cui, leopardianamente, ci si sente parte di un reale, concretamente vitale, di leggerezza e sofferenza, di precarietà e bisogni, di forzature e strappi.
Nei testi di Mario Fresa la metafora non è più un piano sovrapposto a quello della lingua normale, ma è la lettera precisa della sua pronuncia e della sua esistenza. E questo perché, paradossalmente, “il linguaggio è co- mune, sempre”, in una sorgente di figure e di significazioni dal tratto tal- mente sensuale da renderle quasi visionarie: tese a dare luce a una condi- zione di opacità e indistinto. Ciò non toglie, però, che la poesia sia sempre pensiero e lingua di precise attenzioni (anche quando è immersa in una pe- nombra sfumata e sfuocata), in un gioco fisico in cui “accecamenti chiari” e “segreti incoronati al buio” lasciano intendere, ma non svelare, la materia con cui la coscienza poetica diventa la forza dei sentimenti e dei sensi.
D’altra parte la ricerca del senso è certamente la prima intenzione che un autore come il nostro mette in campo: con capacità e conoscenze letterarie, ma più ancora facendo vibrare le corde di un io lacerato che sa quanto il poema possa essere violento e ferire. Ma non ci si può sottrarre da questa condizione, perché “Il pianto ha una mano che ha una solenne forza” e chi fa poesia sa quanto ogni gesto sia sempre all’inseguimento, sempre sul- l’orlo di un precipizio dove anche il suono ha odori e lamenti.
Per Fresa la poesia costituisce veramente una presenza interiore che fuoriesce in una sillabazione di lampi, in cui la scansione dei versi, pur fortemente allusiva e a volte inafferrabile, non è mai sottratta al controllo tecnico. Attenzione, questa, presente ma in disparte, perché “Il libro è la terra” “...sotto un albero di verbi”. E sappiamo che chi calpesta questa terra, ricevendo ombra da questo albero, vive in un felice stadio di assedio e di tensioni, nella mente e nel corpo di ciò che chiamiamo poesia.
Gaetano Ciao, Apparire nell’assente
Gaetano Ciao
Apparire nell’assente
Testi poetici
*
Ciò che unisce e separa il presente è l’assente
è il senso dell’attesa, il provvisorio, mentre
l’uno e l’altro si avvicinano e si allontanano
senza sosta, al limite dell’appartenenza
nella parola
*
E’ necessario gettare lo sguardo nell’abisso:
di là viene la voce, di là sale l’urlo che squarcia
le tenebre della lingua degli uomini. L’urlo
della tela rapita attraversa un attimo il buio
e si spegne lontano nel baratro, dopo
l’apparizione nell’assente
Nota critica di Giorgio Bonacini
Una delle chiavi per entrare nella poesia di Gaetano Ciao sta, credo, nella sua estrema (e anche combattuta) attenzione per ciò che la scrittura poetica mette in atto nei confronti dell’esterno: e cioè un’autoriflessività in cui “ l’immedesimazione non è quella della parola/con la cosa fuori di sé, ma della poesia/con se stessa...”. Una parola, però, che pur non avendo refe- rente fuori di sé è continuamente in lotta con il mondo: perché la poesia, nonostante la sua vita in condizioni di separatezza, si accompagna al presente “al limite dell’appartenenza/nella parola”. E questa appartenenza (ma potrebbe anche essere solo una parvenza di legame) permette a chi scrive di aderire alla propria voce in modo quasi fisico, corporeo.
Ma la costruzione del poema non è un’attività su cui si ha facile presa: appena si pensa di averla conosciuta, essa sposta il suo senso altrove. I significati si allontanano, barcollano, slittano, fuggono senza per questo pensare che non si possa afferrarne qualcuno: perché se “i nomi sono corpi”, allora la parola che li nomina realizza in sé la concretezza del reale, avvicinandosi alle cose e a qualche interpretazione della realtà.
Gaetano Ciao si avventura con mirabile leggerezza nei meandri di una ri- flessione in cui parola, corpo, pensiero, erranza, assenza, apparenza e silenzio non sono concetti vaghi e sfumati, ma termini che si sostanziano veramente in parola autentica, aperta e disponibile ad andare in più dire- zioni. Perché il poeta sa che la sua voce è sempre sospesa su un vuoto, e questo vuoto si materializza in un’attesa di “pagine bianche” che la poesia sfigura raffigurando se stessa anche nell’altro: nel suo dire altro.
Ma a volte, quando ci si rende pienamente coscienti che “è il buio il primo dono della vista”, stare nell’oscuro ( non “all’oscuro” che è una sua banalizzazione) non vuol dire essere nel non-significante, ma vedere l’oscurità come senso in sé, e poi leggervi dentro. Per Gaetano Ciao scri- vere è rimanere sui confini del reale, avendo ben presente che anche una piccolissima cosa (la casina del Lago, ad esempio, nella poesia intitolata Sum, ergo dubito), nella sua solitudine di oggetto, è rappresentazione di una multiformità (“uno e plurale il senso”, dice l’autore) che a partire dal silenzio illumina innumerevoli sfaccettature.
Anche la poesia, si sa, è una cosa e parla. Ma parla con una voce che si sottrae, per poter anche solo sfiorare la precarietà della realtà che ferisce e confonde: senza mai, però, in questo suo fare vagante e divagante, separarsi da chi la pensa e la pronuncia.
Francesca Monnetti, In-solite movenze
Francesca Monnetti
In-solite movenze
Testo poetico
*
incontro solo passi di nebbia
sulla soglia stretta
fossi di asprezza
sulla via corrotta
corretta
tetra e secca
non la benché minima parvenza di salvezza
qua e là
inciampo
sputo
spargo
mangio fango
detriti di muta mollezza
ciottoli di storpia stoltezza
insipida – insapida – saggezza
strappo
rattoppo
piango
ciuffi goffi e gonfi
di premoriente pienezza
cascate di irrequieta pochezza
in-gorghi di congrua tristezza
ovunque
vado elemosinando
centellinando
centesimi di autentico calore e purezza
non più colore
o stupito ardore
non pura ebbrezza
...niente
più
bellezza.
Nota critica di Giorgio Bonacini
Non succede spesso di leggere, in un testo di poesia non volutamente metalinguistico (in cui, cioè, si dichiara esplicitamente la poetica o, più in astratto, la teoria dell’autore), una così chiara e netta affermazione di come la poesia si formi. L’autrice, infatti, scrive che ciò accade “a labbra semichiuse/con o senza moti evidenti/di denti, lingua, saliva.../...timidi appigli/...sorpresi/tra rari bisbigli.../vocaboli alla deriva”.
Ecco, questo è il suono di Francesca Monnetti. In pochi versi viene detto tutto il lavoro e la fatica che la lingua deve affrontare (in termini di sottrazioni, riduzioni, soffi sempre più alitati) per produrre una parola che riesca a significare la varietà e la complessità del dire, traducendo il tutto in una propria particolare voce. Questa poesia, nella poetica che la sottende, è un vero e proprio laboratorio di oralità; un canto scritto che riceve ulteriori e più fondanti significati nella presenza attualizzata di una parola-suono. Ogni testo è sostenuto da rime, allitterazioni, consonanze, dissonanze, parole anagrammate, ritmi scanditi in una danza fonica che arriva in superficie da una profondità consapevole dei propri mezzi e dei propri corrugamenti interiori. Ma l’oralità del verso che si fa scrittura e che “s’imbroglia, sbroglia/tremulo s’appiglia/a lordo ciarpame/frammisto a sterpaglia” è però anche l’evidenza del gesto visivo di un segno (a volte divertissement per la vista e l’orecchio) sempre legato alla maturazione di un senso, e dunque indirizzato a un pensiero che indaga e raccoglie.
La parola è la materia della poesia, e Francesca Monnetti è abilissima nel plasmarla per dar forma a una sostanza che dia la possibilità di scavare tra le pieghe della vita (anche nei momenti più quotidiani come i lavori domestici o la convivenza), trasfigurando l’esistenza materiale nella parola che imprime senso. Ecco, allora, che una multidirezionalità di lettura si apre, anche con l’uso di felici espedienti: ad esempio nello spezzettamento di una parola di significato compiuto come “con-versi-amo”, possiamo interpretare i trattini sia come divisione sia come unione, in modo tale che una sola parola riesce a dar corpo a un mondo e a un modo di sentimenti.
Altre volte, invece, è il contrasto visivo tra il significato di un verso e la sua forma scritta a creare una forte ambiguità vitale: “ancora di sé espropriata/... m i r i a p p r o p r i o”, dove si vede quanto e quale è il valore di disorientamento di questa voce poetica; si indica un riprendere a sé (riappropriarsi) nell’atto di aprirsi (lo stacco fra le lettere) per dare o lasciare, perdendosi fino a un “segnato vuoto” che rimette in movimento il dicibile
Paolo Ferrari, Saggio – poema del pensare assente
Paolo Ferrari
Saggio-poema del pensare assente
Per una miglior vita nel passaggio dall’aldiqua
Testo poetico
*
Nello spazio alle mie spalle, un segnale
di ricerca. Verifica d’una punta di realtà
che mi era apparsa troppo silenziosa
per essere vera, com’era. E come s’è
attraverso il comune pensiero di
e di dei, a immagine degli uomini
e disposti a vivere/morire come
non risponde alla sollecitazione spasmodica
del senso del non-avere, non-avere
tra le braccia oblunghe, tre le ferite
che il tempo dell’attuale conferma e
giorno dopo giorno, senza attendere il
passeggero, il nocchiero, la donna e
la venuta dell’essere: a mettere in
la vera, la vera-negazione in morte,
Nota critica di Giorgio Bonacini
E’ possibile una poesia della mente che possa attuarsi concretamente in modo tale da superare le forme conosciute della versificazione (non tanto nella forma evidente, ma nelle ragioni che la generano in quella particolare struttura cognitiva), per approdare a una dimensione teorica che salga in su- perficie con una tensione lirica astratta? Certo è difficile produrre un testo simile: un’opera cioè che sia ancora poema, ma altamente distillato in una formulazione estrema del pensiero. Ebbene il tentativo di Paolo Ferrari, con questo Saggio-poema, va decisamente in questa direzione.
L’opera, che si presenta come un insieme di 260 strofe-pensieri, intesi a dare significazione alla sua idea di Assenza, articola questo concetto nel vortice stratificato di un pensiero originale e arduo, che affonda le sue radici nelle discipline conoscitive più importanti: letteratura, filosofia, psicanalisi, antropologia, neuroscienze, sono poste in azione per indagare un’idea di scrittura che sia veramente un processo pensante. Una scrittura, cioè, che se vuole veramente essere tale, non può non manifestarsi come astrazione di un pensiero flessibile e senza contorno, la cui mancanza non è un annul- lamento, ma “un mancamento mancato” che, “all’origine di ogni azione umana”, si presenta come un’assenza che arricchisce. Infatti nel caso della parola il punto più abissale di senso lo si raggiunge nel silenzio: che non è semplice nulla (anzi non lo è affatto), ma è voce che suona nel rovesciamento “di quel suono che ha in sé il silenzio /.../ da cui deriva e che esso stesso conferma”. E per Ferrari questa condizione di silenzio attivo si precisa non nella lingua in generale, ma più in particolare nella scrittura: dove, a volte, dalle sue profondità anche l’indicibile sale in superficie. E qui, in questo primeggiare della scrittura sulla lingua, ci sembra di vedere un’eco di quel “piacere del testo” di cui Barthes aveva, così lucidamente, scritto. Infatti, ad un punto di questo saggio-poema, si legge che “nella lingua in generale non c’è sufficiente verità. Nella scrittura talvolta questa verità affiora”. E ciò anche se le parole spesso escono strozzate, e vivono nella mancanza di un nome che dia senso alle cose e a una realtà non ancora contenuta.
C’è, in questo testo, un’adesione dirompente ai meccanismi che producono i sensi aperti del pensiero: una ricchezza di percezioni cognitive che possono certamente produrre in chi legge “affaticamento”, ma in totale coerenza con la difficile ricerca, in poesia, di parole dai significati plurimi, non consumati ma rinnovati costantemente. Perché scrivere è certamente fare arte, ma è anche un atto vitale, calato in una realtà che da sola non è mai sufficiente se “occorre una ferita, un’assenza” per fare in modo che sia “possibile ciò che chiamiamo esistenza”.
Tino Di Cicco, Quando i tempi saranno maturi
Tino Di Cicco
quando i tempi saranno maturi
Testi poetici
*
devo tutto alla gioia
alla mortalità anche del canto
al giorno con i suoi mille occhi
e al cuore solitario della notte
non ho dovuto scegliere
tra il grano ed il loglio
non ho dovuto scacciare il nulla
dalla casa del divino
è stato tutto bene
*
dinanzi a noi il tempo pacificato
alle spalle qualcosa come un dolore
poteva anche essere diverso il bandolo
per arrivare fino a noi
chi ha deciso così
sapeva cosa fare
Nota critica di Giorgio Bonacini
Il fare linguistico che si svolge nella parola poetica, appartiene a chi legge e a chi scrive con modalità multiformi, in un mondo di mondi (letterari, sociali, artistici, etici, irreali, civili, ecc.) che appaiono in scrittura in modo lineare, ma di cui nessuno (consapevole o no) può illudersi di afferrare il senso compiuto. La poesia di Tino Di Cicco, pur presentandosi senza evidenti sperimentalismi, ha una precisa coscienza di essere linguaggio altro, non codificato da un’ immediatatezza che è solo appa- renza: perché per l’autore, scrivere o dire è “come difendere nella tua balbuzie/il fremito del logos”. Una dimensione, quindi, in cui la forma dei sentimenti che vengono detti, non nasce dalla superficie di una parola chiara e univoca, ma nelle profondità di un balbettio, un farfugliamento, uno sgretolamento in cui la voce, che dovrebbe pronunciare il discorso, ne autentica e ne concentra le sue tante possibilità: i battiti che fremono nella ricerca del senso.
E in queste poesie ciò è reso reale con una leggerezza di pensiero che si avvicina molto all’haiku: alle manifestazioni zen, in cui l’andamento obliquo della mente è fonte di conoscenza.: “se puoi guardare il cielo/ senza ridurlo a te/allora sei il cielo”. Ecco il tocco, in cui nulla di arti- ficioso appare, ma nemmeno nulla di ingenuamente spontaneo: perché la ricerca poetica è rigorosissima e si avvale di un’autoriflessione e di uno sguardo sul mondo senza sbavature. La meditazione nasce da una contem- plazione lenta, fatta di piccole scalfitture da cui filtrano sguardi interiori, affioramenti particolari di chiara consapevolezza:“potevo essere un papa- vero/invece parlo./potevo pensare come la luna/invece sogno con la gram- matica nel cuore”. Di Cicco sa che la conoscenza che si ricava dal pensiero poetico, che è data dalla scrittura, è attenzione a non tuffarsi in modo maldestro, a non debordare dai limiti che stanno nel suono, nello sguardo, nel movimento, negli attriti con cui il poeta si confronta.
E’ necessario, innanzitutto, trovare la parola significativamente valida per quel momento. Per un poeta è certamente importante lo sguardo, ma questo non deve mai ostacolare la presa sul reale, che è creazione e scoperta, perdita e impossibilità. Il reale non può aderire a se stesso se il poeta non vi si immerge completamente, cioè “se prima tu/non perdi te”. Ma tutto questo con la lucidità, che Di Cicco mostra di avere, che non si può essere altro da ciò che siamo, e che è la poesia a renderci più disponibili perché “non sapendo volare/ camminammo//ma senza rinnegare il cielo”.
Gian Paolo Guerini, Lì vidi: nero, patio, riso
Gian Paolo Guerini
lì vidi: nero, patio, riso
Testo poetico
*
percorrere le vele velate mare e canto di sogno velato urge al vento mirto esiguo che vento urge guidare sentirlo alitare in sere spettrali orme cominciate con triste passo timido simili a fuochi premono al vento simili a sguardi partono come volti arresi vidi la vista che più non parlava sollevare luci afone come fuggite telare giorni movendo piume lucenti nell’abisso in cielo volate ali rotte lodare le mani roventi e ciglia ispide ossi e preghiere si spiegan come manti nella sera arsa follia presso elmi come campane alitano mostrando oscuri atti a dir la cenere (...)
Nota critica di Giorgio Bonacini
Scriveva Roland Barthes a proposito di Sollers: “E’ tempo di raccontare null’altro che la parola infinitamente vasta che giunge a me”, e io credo che sia proprio questo che Guerini fa quando scrive. Egli, più precisamente, non racconta, ma “dice” le sue parole senza fine, ed è molto difficile far comprendere la sua opera se non la si legge materialmente.
Il testo, tripartito, si presenta come un insieme sintagmatico fatto di cellule (frasi, parole, fonemi) apparentemente indissolubili fra loro, ma se la lettura avviene (come deve avvenire anche nel silenzio mentale) nella sua piena oralità, allora qualcosa si apre: “amori senza luce sassi morti d’aculei torti vòlti dentro tristi ascolti...”, in un flusso continuo, una catena significante di richiami in cui la parola, quando si fa voce, trova in sé il senso del mondo e del pensiero. E lo trova trasformando la lingua alfabetica denotata in un corpo di rappresentazioni e di continua riflessione su di sé, capace di “vedere la vista che più non parlava sollevare luci afone”; dove si evidenzia la capacità della parola “incorporea” di diventare oggetto sonoro fisico, con l’uso di tutte le possibilità fonosillabiche, timbriche, fonematiche che la lingua italiana possiede. Fino alla sonorizzazione pura, con sequenze foniche (“sem ques cos... tav tuc tel... inav ostrev ‘nsuov...”) in cui lo spezzettamento delle parole si avvicina moltissimo all’esperienza di poesia fonetica lettrista, aggiungendovi però il senso di un movimento, di una gestualità potenziale ma intrattenibile.
Insomma, Guerini scava dentro la lingua rendendola concreta e liberan- dola dal discorso, alla ricerca di un nuovo intreccio tra il suono e il senso, per arrivare a vedere “una voce arar la chioma torva della gola impregnata d’erba e fiori sventolar sillabe estive”.
Un’ultima notazione che si evidenzia nella struttura in tre parti, ognuna delle quali termina con la parola “stelle”, è un forte (e direi basilare) ri- chiamo dantesco. Tutto il testo è permeato profondamente, nell’andamento ritmico e vocale dalla Commedia; si sente la carne delle stesse parole, che si scoprono sparpagliate e spezzettate in varie parti del testo, e a volte an- che interi versi uniti in un gomitolo (ad esempio l’ottavo canto del purga- torio“lotrepassicredochiscendesseefuidisottoevidiunchemiravapurmecome- conscermivolessetemp...”) che non necessitano, però, di essere sciolti, per- ché tutto deve scorrere, danzare, sventolare possibilità d’ascolto fluide nel tempo e nello spazio; azioni di parola certamente estenuanti, ma mai insignificanti, mai abbandonate, mai lasciate senza autonoma personalità.
Armando Bertollo, Il teatrino della scrittura attraverso i sintomi
Armando Bertollo
Il teatrino della scrittura
attraverso i sintomi
Nota critica di Giorgio Bonacini
Le pagine di scrittura e segni che Bertollo organizza con grande senso dello spazio, intensa lucidità mentale e profonda capacità di significazione visiva, si inscrivono direttamente e perfettamente all’interno di quella map- pa progettuale che si richiama ai concetti di poesia totale: teorizzata, inda- gata e praticata, con entusiasmo e lucidità, da Adriano Spatola. Una poesia di ricerca contemporanea che in Bertollo ha tanto più valore perché egli vi inserisce delle cellule di linearità pensante che indicano (ma non obbli- gano) un percorso: uno fra i tanti che si rendono possibili al lettore. Siamo quindi di fronte non solo a una poesia, ma a un’opera complessa che mette in campo, in primo luogo, la percezione della vista come “possibilità di let- tura, ma non ancora capacità; poi la voce (anche quella silenziosa di chi legge per sé), dove “vista e voce giocano con la loro influenza”; e, ad un altro livello, il pensiero che ne sostiene la significazione e l’impianto glo- bale in una “esperienza individuale che può diventare esperienza del lin- guaggio; infine la segnicità pura che sembra urtare l’equilibrio, quando in- vece lo tiene stabilmente instabile “con il ritmo e il respiro, che discendono dal primo punto come eco”. L’autore, quindi, si affida a parole delineate e aggrappate a linee che divergono o convergono, vanno a zig zag, tratteggiano e si spezzano e sembrano proporre dei percorsi mentali in varie direzioni, che il lettore può decidere di seguire subito o in un secondo tempo, scegliendo in modo autonomo la propria via.
Il testo è allora disponibile ad affermare e afferrare un senso anche doloroso, non solo estetico, perché “si nasce da una ferita” e “ci si deve porre con la disponibilità di esserne i custodi”. Ed è sorprendente come, all’interno di questa sperimentazione totale, Bertollo attivi e incorpori tra le sue forme visive e sonore, nello spazio bianco della pagina (più che mai importante), l’accoglienza di un senso etico/poetico abitato da una lettura pensante, mai degradato a utilità, mai bloccato o afferrato o violato da un unico significato, iniziale o finale che sia. Il senso è sempre (ed ecco il “teatro” del titolo) re-interpretato e ri-conosciuto. Bertollo lo dice esplici- tamente: “...gli elementi segnici e sonori si attivano, diventano teatrino”, esibizione della loro forma: orma e ombra dell’esperienza. E infatti, la spazialità sonora che si fa parola aperta, concede a chi legge le flessioni di un andamento che si trasforma (nella terza parte del testo) in un dialogo tra due corpi astratti, all’interno di stralci di realtà strappati e rimessi in scena.
C’è, alla fine, una necessità di ricerca, nel mutamento poetico, tesa a fare di ogni scelta, di ogni sguardo sull’opera, una vertigine.
Gianluca Giachery, Geometrica passione
Gianluca Giachery
Geometrica passione
Testo poetico
*
Certo mi illumini
quando t’avanzi
con fare lento al canestro
dell’ambigua scelta,
dipanando l’inverso.
Credenza
è solo il nome
fortuito d’un eccesso,
il sillabario
povero
dell’inganno.
Forse più incerto
ora
il tuo respiro
appartiene agli anni
del rimosso:
tenue il correre
verso ogni fuga:
un’attrazione
che repentina scompare.
Nota critica di Giorgio Bonacini
Gianluca Giachery intitolando la sua raccolta di poesie “Geometrica passione”, mette in chiaro un vero e proprio ossimoro concettuale: la passione, comunemente intesa, è in sé una forma di energia caotica e instabile, quindi una forza che subisce le pressioni dell’emotività e del sentimento: il contrario, perciò, di una struttura ordinatamente geometrica e logica. Bisogna allora intendere bene il titolo, e leggendo i testi si capisce che la “passione” è certamente rivolta a persone che condividono momenti di vita dell’autore, ma sembra anche, e forse più, riguardare il suo manifestarsi in poesia; e la poesia, chi scrive lo sa, è un luogo sia di rigorose precisioni formali, sia di vorticose sensibilità. Ci viene in aiuto, a questo proposito, una poesia di Paul Celan che dice: “NON SCRIVERTI/tra i mondi,//tieni testa/alla varietà dei significati,// fidati della traccia di lacrime/e impara a vivere.” Ecco, allo stesso modo per Giachery la poesia è una passione in cui “le risposte che mimano/il significato/non hanno legami incondizionati”, perché il pensiero poetico è una domanda incessante, ma, come in amore, le risposte sono labili: cercano un significato, lo condizionano, tentando di imitarlo e, quando sembrano afferrarlo, questo si scioglie verso altre esperienze. Ed è allora che si possono usare altre parole, un’altra voce; si può trasportare il soggetto di passione in “giochi di rimando” che “affrancano il desiderio”.
Ma Giachery, che ha ben presente le possibilità, le potenzialità e i limiti della scrittura, sa che l’espressione dei sentimenti e delle emozioni non la si può ridurre all’uso della parola quotidiana, ma diventa reale solo nelle ragioni interiori di un’impossibilità. E che per strappare il velo, la parola, deve imprimere a se stessa una sintassi svuotata e poi rinnovata di sensi. In questo modo la poesia, che è voce, diventa un “impronunciabile balbettio” e l’indicibile, in effusione magmatica, prende forma anche nel mutismo. E’ ancora Celan a svelarci (ma tutti i poeti, intuitivamente e intimamente, lo sanno) come la poesia presenti “una forte inclinazione ad ammutolire”, senza però mai arrivare al nulla. Perciò anche il silenzio è suono, e compenetra la parola, nei suoi tratti distintivi, “con voce disincarnata”. Giachery scrive le sue passioni con una lucidità estrema, affrancandosi da ogni psicologismo e dalla facile dizione, consapevole di dilapidare “le ipotenuse contraffatte/dell’amore.” Sa che “dire” in poesia non è un gesto liscio e pulito, ma è una parola irta di difficoltà: a volte di inganni e di apparenze, dove “le fatiche consacrate al silenzio” conducono anche a contraddizioni vertiginose in cui “terribile e vuoto/è il nome,/pienezza d’assoluto”.
Marzo 2008, anno V, numero 9
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
“Carte nel Vento 9” si collega strettamente al numero scorso, continuando l’indagine teorica intorno alla poesia. L’opera di scavo intorno ai versi questa volta è affidata agli stessi poeti, riprendendo un’idea sviluppata alcuni anni fa nelle pagine di “Anterem”.
I poeti che presentiamo - Aglieco, Assiri, Caracciolo, Germani, Lisa, Ponzio, Svampa, Testa, Trucillo, Turra Zan - sono stati scelti tra i partecipanti alle ultime edizioni del Premio Lorenzo Montano e delle ultime Biennali Anterem di Poesia. Ci offrono l’occasione di rivisitare alcune delle opere che hanno tessuto la storia recente del “Montano”, ci indicano le loro nuove ricerche e soprattutto ci guidano nelle ragioni della loro poesia, attraverso puntualissime riflessioni teoriche.
Tutto questo prelude al lavoro che costituirà il fondamento della prossima Biennale, in cui ancora più stretto sarà il legame tra poesia e critica: ciascun poeta invitato a parteciparvi, scelto tra i selezionati dell’edizione del Premio che scade a fine marzo, sarà commentato “in diretta” dai poeti della redazione di Anterem e da critici di provata esperienza.
Ranieri Teti cartenelvento@anteremedizioni.it
Poesia: dalla Biennale e dal "Montano", testi e note di poetica
I poeti che presentiamo sono stati scelti tra i partecipanti alle ultime edizioni del Premio Lorenzo Montano e delle ultime Biennali Anterem di Poesia. Ci offrono l’occasione di rivisitare opere che hanno tessuto la storia recente del “Montano”, ci indicano le loro nuove ricerche e soprattutto ci guidano nelle ragioni della loro poesia, attraverso puntualissime riflessioni teoriche.
Giovanni Turra Zan
Giovanni Turra Zan è nato nel 1964 a Vicenza, e risiede a Dueville (VI). Laureato in Psicologia dell’Educazione e diplomato al Conservatorio Musicale di Vicenza, lavora da diversi anni nei servizi sociali e come counselor professionale, facilitando anche gruppi di mutuo aiuto al lutto.
Vincitore nel 2005 del concorso “Poeti per Posta”, promosso dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio 2 “Caterpillar” e da Poste Italiane, è stato menzionato al premio “L. Montano 2006” e segnalato nell’edizione 2007 dello stesso premio. Nel 2005 ha pubblicato la sua opera prima “Senza” (Agorà Factory), con prefazione di Stefano Guglielmin. Con la silloge “Il lavoro del luogo”, ha vinto la VI edizione del concorso “Pubblica con Noi 2007”, indetto da FARA Editore che l’ha successivamente pubblicata. Una sua lirica è stata selezionata per l’antologia “Il corpo segreto”, di prossima pubblicazione con le edizioni Lieto Colle. La sua nuova raccolta, “Stanze del viaggiatore virale” sarà pubblicata nel prossimo maggio dalle edizioni L’Arcolaio di Forlì.
Giovanni Turra Zan: Nota teorica e poesie edite e inedite
In “Finders Keepers” (“Chi lo trova se lo tiene”, mia traduzione) Seamus Heaney ci offre un cocente resoconto di un attacco d’ansia di cui egli fece esperienza quando, per la prima volta, incontrò la poesia di T.S. Eliot. Ciò avvenne negli anni ’50, in un tempo in cui Eliot era considerato, dai poeti anglo-americani, la Luce e la Via: un nome sinonimo della stessa poesia moderna. Ad Heaney fu consegnata a scuola una raccolta di poesie di Eliot “come fosse un pacco di cibo”, e tuttavia, invece di procurargli un piacere tanto atteso, gli causò qualcosa di più simile ad un attacco di panico. I versi di Eliot viaggiavano ad una lunghezza d’onda così inaudita per Heaney, da sembrargli lo stridio di un pipistrello. I sintomi fisici che Heaney provò (un crescente nodo alla gola, l’irrigidirsi del diaframma, ecc.) non si attenuarono in seguito alle letture successive del testo eliotiano. Al contrario, e per anni, “Eliot mi faceva paura, mi imbarazzava e mi faceva sentire minuscolo; mi faceva venire voglia di invocare la Madre dei Lettori, affinché venisse presto e avesse pietà di me, e mi offrisse la pacificazione di un significato parafrasabile e di una struttura ferma e riconoscibile”. Stava esagerando? Non credo. Nello stesso momento in cui egli ci invita ad identificarci con la triste condizione dello scolaro, Heaney ci dice anche che l’acuta ansia che sta descrivendo non è la semplice reazione di un giovane studente di letteratura. O non solamente questo. Noi tutti apprendiamo da Eliot, così come da altri autori, che una poesia non può mai portarci completamente oltre la sua lingua, in un luogo limpido e precisamente a fuoco, come se la sua “oscurità” fosse acqua torbida che una razionale ed intelligente lettura ed interpretazione potesse rendere trasparente e chiara. “Una poesia deve resistere con successo alla razionalità” è l’affermazione schietta, e abbastanza facile da accettare, di Wallace Stevens. Ma ciò che per me è così attraente in Heaney è la franchezza con cui ammette l’ansia causata dal non comprendere. Quando W. Stevens scrive: “Un uomo e una donna/ sono uno”, lo possiamo capire senza difficoltà. Ma quando scrive: “Un uomo e una donna e un merlo/ sono uno”, questo può sconcertare il lettore. Ci incamminiamo qui in un sentiero fragile, nell’ansiosa speranza di arrivare presto o tardi ad un principale, inequivocabile significato della poesia che includa il merlo. Ma forse, perdere l’orientamento è una parte fondamentale del processo. Il campo da gioco in cui si pone il titolo della raccolta di prose di Heaney, “Finders Keepers”, ha come controparte lo smarrimento, la perdita di qualcosa.
Una dichiarazione, che Heaney fa in un capitolo successivo, riesamina la mia immagine del percorso: “La poesia è più una soglia che un sentiero, qualcosa da cui costantemente ci si allontana e a cui continuamente ci si avvicina, e presso la quale lo scrittore ed il lettore si sottopongono, in modi differenti, all’esperienza di essere allo stesso tempo rilasciati e convocati”. Forse è stata l’immagine dello spazio della soglia, così come il tema dell’ansia e della perdita, che mi ha fatto venire voglia di ridare un’occhiata alla storia, raccontata da S. Freud in “Al di là del principio del piacere”, del bambino e del gioco del rocchetto. Il bimbo, nel tentativo di far fronte alla sofferenza causata dall’allarmante abilità della madre di scomparire spesso per ore dalla sua vista, inscenava un gioco ripetitivo: tenendo in mano lo spago, scagliava con consumata precisione il rocchetto dietro la spalliera a tendina del suo letto, di modo che l’aggeggio sparisse. Contemporaneamente emetteva un suo caratteristico suono, che Freud aveva intuito avere il significato di “via!”. Quindi ritirava il rocchetto dal nascondiglio e salutava la sua riapparizione con un festoso “eccolo!”. Questo gioco così ossessivo rappresentava la presenza e l’assenza della madre. Così almeno ci racconta Freud. Parte dell’attrazione che ha per me questo racconto, viene dall’identificazione che mi piace fare di tale bimbo con la figura del poeta. E’ quindi l’idea che il desiderio della presenza e l’effetto dell’assenza sono interdipendenti, si coinvolgono, si implicano e stimolano vicendevolmente ed in modo continuo. Il gioco del “via!” e del “eccolo!” è un gioco giocato dal poeta nel piccolo teatro che è ogni suo verso. Con la Madre dei Lettori a tenere la mano del poeta, le parole giocano i loro ruoli familiari con una logica rassicurante e consolatoria: lì c’è uno statico sostantivo, là il verbo attivo, più in là ancora gli spazi e le prospettive aperte dalle preposizioni, ecc.. E soprattutto, da questa parte, c’è la rigida dualità e la separazione dei soggetti e degli oggetti. Nei fatti poi, la necessaria grammatica della frase predispone il mondo ad un ordinamento da cui dipende quotidianamente la nostra salute mentale. Questo, direbbe Yeats, è “il linguaggio della sala da tè”. Improvvisamente però, nel flusso rassicurante delle frasi, si creano degli elementi di disturbo. Le parole vengono organizzate in linee, le linee in versi, la sintassi viene aggirata, con inversioni e iperbati, epifrasi a formare pattern di materia fonico-musicale. E questo menzionando solo alcune delle articolazioni possibili, delle “spaccature” che la forma poetica introduce nel linguaggio. La metafora si porta via il senso letterale e la Madre è caduta nella botola, fuori dalla vista. Ci ritroviamo così in una zona paurosa, ma vivida, che Yeats descrisse bene come Phantasmagoria, dove la nostra consapevolezza della soggettività degli oggetti e dell’oggettività dell’emozione soggettiva diviene eccezionalmente possibile. Ed è proprio qui che iniziamo a discernere il senso, ogni volta rifoggiato e ricreato, della poesia.
Da Il Lavoro del luogo, Fara Editore 2007
si preferiscono certo lumi di luce gialla
al ritorno, alla fatica di concorrere
nei tempi: quelli dicevi allora persi.
alzati di buonora il mattino che il mattino è dove
le cose restano fresche nella testa e il cervello ha
la temperatura del caseificio e l’uguale scambio
di materie liquide in idee. non si fa tardi non serve
insistevi che la notte è della morte o dei tralasciati.
un grido, la lingua dei fastidi è saliva
stantia, sputi, stacchi o baci raffermi:
come si fa d’inverno a non vaccinarsi?
con l’umido fai un’immunità e allontani
il sequestro del freddo sotto un piumone;
il convertitore ribalta i chilometri in pianti
tra restare con la casa che si sfa e andarsene
scegli ora, entrambi.
l’origine riflette ogni stasi, l’opera sfuma
e si lascia dietro odore di macero e carta
unta. anche la camera riconta i vuoti.
stai a rivelarci quel giusto mezzo se come sei
procuri maremoti. ricordarti è pena
o si preferisce quella foto in cui stai
in cima ai concimai di fine marzo.
si danno gli ordini, intanto che al macello
ci sono uomini. non so infatti checcazzo
si faccia ora dicevi. ridondano al fine le convinzioni
e non ci sta con la testa, ed è come un vento, oggi.
e c’è la disco-music dietro le carcasse di vacca
e si balla, gesù. si balla come dei matti.
perdona se nel conclave degli orti stavamo
come gentili ad innaffiarci e crescere
mettere radici nei luoghi arresi al pensiero
che non più uno spostamento fosse possibile
una fuga imbranata dal vizio di riaprirsi
comunque considerare che sia spaesarsi
del canto che qui non germoglia. basta il fatto
generato vedi a farci confluire, a catturare
metro su metro la collana dove infilare
le liti. almeno ovunque ne riparleremo
smotteranno cumuli di fango e, cielo, avremo
gli anni dalla nostra.
occorre morire prestino
pensavi, e lasciarti erede del bene
di noi nella storia, tra gli argini dove
libero è il nostro fiume, raccolte le pianure.
prestino, così da permetterti ogni codardia
così che non lasci debiti sul contatore
sullo scatto dei numeri, sul computo
dei registri del pianto e non i figli come
appoggio, ma i nasturzi sul terrazzo,
ed il vecchio galantuomo che sa
di latino e di greco, rimasto a tenerti
le mani.
i contorni formano l’arco dei legni,
il quadrato su cui appoggiare l’ansia
ha la sua rada classificazione
la sistematica
elencazione dei contenuti in un numero
un codice per il prestito della memoria
il cui interno dà sul prato, e se vedi
lampade proiettare l’ombra ti fai serpe
e faina per cancellare il nome dall’elenco
degli esistenti, per lasciare poche tracce
scarseggiando un’asse di risposte sulle leggi
della quiete.
Da “Stanze del viaggiatore virale”
(di prossima pubblicazione con le Edizioni L’Arcolaio di Forlì)
purché sia ragione il volo, siamo noi
ad inquinarne il lampo: o torni o vai,
o lasci l’impero nella rabbia, sfai
le vesciche, gli stomaci e con questi
reggi cornamuse. dove borbotti ora sei
bordone al servizio d’una giga. il calvario:
sul ciglio sosti a raccattare semi e gramigna,
ne fai un erbario che è croce di natura, pannello
di secchezze e mostra aperta ad un incerto orario
la casa frena e sta su lastre di ghiaccio.
all’interno fatiche si posano, appendono
le attese e il sonno sulla stufa a legna
dove la cura del giorno s’incaglia
nei ruggiti dei transistor del dubbio.
cambiano le attitudini, le anime
attive e pare un cantico la vista
del bollito che si affastella sul vassoio
con le bisce a contorno, la scarpa
nella pentola del minestrone, l’ago
da cucito servito sulla trota salmonata,
tuffatosi dal grembiule della sarta.
ci si sta addosso a natale, come
un’ossessione della generazione
che non si estende, che non ha code.
si celebrano qui le indecisioni
le acustiche sibille, gli echi amorfi
nelle miniere. eloquenti saranno
i termini del virus, e il disprezzo.
certo, il virus rimane a riposare
per anni e gramo si rifugia sotto
la parola, nella zona dorsale
di questa: sa il suo anticorpo il libero
radicale. come se la parola
lo accogliesse serpe-in-segno, come se
si dispiegasse nell’antro, sferrasse
l’attacco che diviene tradimento
e cancella le visioni. s’inforna
per posarsi a caldo come vescica
sulla pianura della lingua. il senso
della capitolazione al silenzio.Allì Caracciolo
Allì Caracciolo, poeta e regista, è docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l'Università di Macerata. Sue opere, edite e inedite, sono risultate finaliste ai più importanti premi di poesia. Dirige un Teatro di Ricerca a livello professionale. Tra i suoi libri di poesia figurano: Malincòre (una fonologia del vuoto), Amadeus 1996; English cemetery, Edizioni del Leone 2000; La insomiglianza (quattro poemetti), Ripostes 2007.
Allì Caracciolo: Le ragioni del silenzio. Il testo poetico
0. DEDICA IN FORMA DI ESERGO“Quando tutto è stato detto, resta da dire il disastro”
1. QUASI UNA PÁRODOS
Esprimere una riflessione sull’atto poetico, o della scrittura, è formalizzare un assillo nell’interrogare la Poesia non solo sulle ragioni della sua sopravvivenza nella contemporaneità e sul suo darsi/negarsi, ma in particolare, sul complesso percorso della Parola, sulla sua coincidenza con l’Essere. Interrogarla istituisce una Poetica.
(“Sotto lo sfondo così cupo dell’attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione […]. In tale paesaggio di esibizionismo isterico, quale può essere più il posto della più discreta delle arti, la poesia?”. Così Montale già nel lontano 1975).
2. DIDASKALIKÓN
Troppo spesso non si sa che cosa è Poesia; piuttosto: ‘si sa’. In maniera assertiva ed esaustiva.
Accade che molti sanno che cosa è la poesia: è soddisfazione, tormento, approdo, privilegio, conforto disperante, vanto maledizione esclusione esclusività, appagamento compiacimento realizzazione di sé, suggestione e distinzione, un porto sicuro, una tormentante piacevolezza, una lusinghiera attitudine. E poi è bellezza. Bellezza e bello così come giungono dalle icone sclerotizzate e inamovibili.
Della poesia si può dire con certezza ciò che non è.
Non è un fatto privato. Non uno spazio riservato, lottizzabile mercificabile, non è merce né mercificazione, non è garanzia non è prestigio. Non è consolatorio compenso, evasione dalla cruda realtà, esaltante trasfigurazione delle miserie, produzione di sogni, la casa dei buoni sentimenti.
Conformemente il poeta non è il portatore della verità, l’eletto, il detentore dei segreti, il depositario del verbo.
“Non chiederci la parola che squadri da ogni lato // […] non domandarci la formula che mondi possa aprirti”. Montale avvisava. Non solo demolendo i perniciosi miti della parola-pantocrator, “sì qualche storta sillaba e secca”, ma evidenziando la forza fatica del negativo: “codesto solo oggi possiamo dirti // ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”
3. TEMA
Occorre muovere dalla identità negante per ricavare la positività e la conoscenza di un grado della qualità poetica. Non nella capacità definitoria, ma in tale facoltà di esistere in negativo, di creare in absentia, risiedono la natura intrinseca dell’atto poetico e il suo fondamento etico.
Se poesia è canto (e canto è urlo nel doppio di sé), lo è nella misura in cui ne scrive Maurice Blanchot: “solo col canto Orfeo ha potere su Euridice, ma anche nel canto Euridice è già perduta e Orfeo stesso è l’Orfeo disperso, l’«infinitamente morto», reso tale fin d’ora dalla forza del canto” .
L’infinitamente morto è accesso alla infinitezza, la costituzione in infinito che la forza del canto determina. Canto che non rende immortale Orfeo: non nel senso della tradizione del canto al tempo umano e alla storia, ma in quello più arduo del negato riscatto dall’esistere. È l’essere infinitamente morto di Orfeo/del poeta, che consente al canto l’identità con l’esistenza. E la sua immortalità.
Scriveva Gadamer che “il canto poetico è l’esser-ci” . Poesia “si dà nel concepire e per un concepire” . Essa è la testimonianza dell’esser-ci, in quanto “attesta la nostra esistenza, essendo esistenza essa stessa” .
Esistenza che in sé è coincidenza di deessere, infinita simultanea destituzione dall’esistere.
Parallelamente, una poesia che infinitamente si destituisce da se stessa. In ciò consiste la sua cifra, l’essere esistenza. In quanto coincidenza di deessere e costituzione di sé.
“Se tale destituzione trova fondamento nella tesa coscienza esistenziale, o nella demistificazione di ogni accreditato sapere e gratificante certezza, compresa quella del bello, o nella aspra cognizione della violenza umana e storica, tuttavia, proprio dall’atto stesso, precario ed infinito del destituirsi, la poesia deriva la propria necessità e l’unica possibile funzione” :
( passo da un testo che postula l’idea di poesia come fonologia del vuoto, che cioè trae il suo fondamento dall’atto percettivo di frammenti di suoni che muovono nel vuoto –attestati di energie in un continuum che è condizione del loro muovere e combinarsi– e dal loro costituirsi in parola poetica.
In tale prospettiva, poeta è vehiculum, un condotto in cui le energie si incontrano e conflagrano generando vita della parola.
E non tanto, nella direzione di poesia come atto autogenerantesi, di cui il poeta si fa scriba, ma in una dimensione assimilabile a quella che Foucault indica per la follia: che è “senza soggetto parlante” ).
È il senso di quell’essere infinitamente morto, la sua cifra fonetica.
Si può sostenere, traslato da altro contesto , che Poesia è un linguaggio che torna su se stesso, che ricomincia “senza fine l’atto della propria distruzione” .
Ciò ne qualifica lo statuto ontologico: il silenzio. Che non comporta il paradosso della pagina bianca e simili. Silenzio è la proprietà significante e la qualità della comunicazione della Poesia. La quale non si esprime attraverso il silenzio: si dà quale silenzio. Forse anche nel senso gadameriano di “scrittura che precede il linguaggio […] in modo irraggiungibile” . Ma certo, anche, silenzio in senso cosmico, fratturale, dove si rintraccia l’indifferenziata consistenza dell’esistere nella spaccatura originaria, nel baratro, nella crepa primigenia, nell’evento catastrofico e smisurato della distruzione generante.
L’unico silenzio che non può appartenere alla poesia è quello di ignorare barbarie ferocia le stragi. Tacere davanti ad esse. Omettere di ricordare.
( Poesia è il luogo nel quale non si danno frontiere, il luogo per eccellenza della alterità, ed anche quando i più inviolabili diritti umani, quali il diritto a dignità libertà vita, non costituiscano argomento espresso di essa, in essa sussistono quale sua implicita sostanza e fondante ragione di essere nella storia e nelle civiltà.
Se non è in questi dunque che va ricercato lo statuto ontologico della poesia, certo in essi risiedono la sua dimensione storica e la presenza alla storia, che è legittimazione della scrittura a fronte del prevalere di violenza e misfatto, del suo persistere mentre si consumano crimini contro l’umanità ).
Ne segue il Silenzio come costituzione etica, da cui non può derivare la dispersione della Parola poetica, la sua omologazione, la svendita. La Parola della Poesia è inalienabile.
“Ciò che si scrive risuoni nel silenzio, facendolo risuonare a lungo, prima di ritornare alla pace immobile dove veglia ancora l’enigma” . Così Blanchot, che ne La scrittura del disastro, annota: “Scrivere non solo per distruggere, non solo per conservare, per non trasmettere, scrivere nel fascino dell’impossibile reale, questo lato del disastro in cui sprofonda, salva e intatta, ogni realtà” . Forza cognitiva nella sorta di ossimoro: sprofondare nel disastro salva e intatta.
È in questa identità, che non è semplice compresenza, che si realizza l’essere della Poesia.
4. QUASI UN EPILOGO
Non si dà atto poetico senza la consapevolezza apocalittica della catastrofe, della destituzione da sé di quell’atto. In questo, l’identità di silenzio e scrittura. Ancora Blanchot: “Mantenere il silenzio, ecco ciò che a nostra insaputa tutti noi vogliamo, scrivendo” .
NOTA O IPERBOLE
La creazione poetica spesso la si sente denominare ‘il parto’, anche dagli stessi autori: ‘È avvenuto il parto’, espressione metaforica per dire ‘Ho terminato l’opera’.
Tralasciando la perplessità per l’immagine troppo viscerale, il cui sangue è mestruo e non ferita palpitante (“il discorso poetico prende avvio da una ferita” ), e la nascita meraviglia usata, l’espressione appare impropria, in quanto rovescia la costituzione profonda dell’atto poetico, il quale non consiste nel parto, o venuta alla luce, di un essere generato attraverso due elementi di segno contrario che si uniscono insieme.
Poesia nasce dall’uno che si separa in due contrari, dei quali uno nell’essere negazione dell’altro lo fa essere, e da tale compresenza/opposizione, negazione che afferma, si genera l’atto poetico.
In tale scissione da sé in doppio di sé, nel prodursi nella propria negazione, nel frantumarsi nell’altro, consiste il fondamento da cui prende avvio un significato di distruzione, catastrofe, alterità. Morte che instaura la parola.
Per questo la poesia può essere individuata come il luogo dove l’uno dalla propria frammentazione genera i contrari, ma dove i contrari tendono infinitamente a l’unificante conoscenza, a la indeterminata somiglianza.
Dove altresì conflagrano, generando vita.
Il luogo del vuoto. O dell’assenza.
[1] Maurice Blanchot, La scrittura del disastro, Milano, SE, 1990, p. 47.
[2] Dichiarazione di Montale all’Accademia di Svezia in occasione del Premio Nobel.
[3] Eugenio Montale, Ossi di seppia, Milano, Mondadori, 196713.
[4] Maurice Blanchot, Lo spazio letterario, Torino, Einaudi, 1975, p. 148.
[5] Hans Georg Gadamer, L’attualità del bello. Studi di estetica ermeneutica, a cura di R. Dottori, Genova, Marietti, 1986, pp. 83-84.
[6] Ivi, p. 200.
[7] Ivi, p. 169.
[8] Allì Caracciolo, Malincóre (una fonologia del vuoto), Cittadella (PD), Amadeus, 1996.
[9] Cfr. per il contesto e significato di tale concezione, Michel Foucault, Storia della follia nell’età classica, Milano, BUR, 19887.
[10] Vedi l’indagine condotta da Derrida sul pensiero di Foucault in Jacques Derrida, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1971, specificamente Cogito e storia della follia, pp. 39-79.
[11] Ivi, p. 46.
[12] Hans Georg Gadamer, Persuasività della letteratura, Ancona-Bologna, Transeuropa, 1988, p. 60.
Poesie edite e inedite
Da: Allì Caracciolo, Monologhi ripetitivi con la Poesia (pubblicazione in corso).
[1]
Il luogo
Mentre discende come fosse l’ultima
s’aggetta la sera in plumbee nubi
squarciate ove riflette un peltro lucido
lì
si specchiano le cose una nell’altra
alla ricerca della somiglianza
[2]
L’anima canta stanca
mentre tu taci ricordando il canto
e il ricordo è miseria nella pallida sera
ove talora s’accasciano uccelli a riposare
Se soltanto tornare
la tua voce potesse a le occasioni
le perdute ginestre
le feroci pulsioni, riconoscere in esse
la lenta melodia del sangue che in te scorre
anima mia, dir loro, anzi che questo sguardo
di mancate agnizioni
l’aggirarsi casuale dove il vuoto risuona
il tuo passo d’automa trasognato e disforme
il filo delle labbra una catena che apri chiudi apri senza suono
Forse un segnale,
ripeti versi tra le foglie
[3]
Mentre pentita al bordo del villaggio
attacchi il piede indietro a quello avanti
la linea inseguendo o disegnando
che isola il villaggio dallo spazio
ti vidi batterti il petto anche le spalle
-per lo stolto tuo peccato di essere-
-e per esso-
saltellare festante attorno attorno
ridda invasata sulla linea a calce
che in cerchio isola il villaggio
[4]
Forse la sera, quando le cose vanno al loro posto
per convenzione (non ontologicamente, s’intende)
forse la sera per convenzione (per un sentire indotto, cioè, ma motivato)
la sera forse
le parole che si sono scritte (e nel giorno movevano i pensieri)
le parole sono figure che attraversano la sera
[5]
Franz Liszt
«Non chiedermi quello che io stesso ignoro. Il mistero che vuoi penetrare non mi è stato rivelato. Io vengo da un paese lontano, di cui non mi rimane alcun ricordo».
I movimento
Scrivevi che nulla rimane, nella torpida visione. Come un eunuco, come un fanciullo, il misterioso viandante -un ermafrodito o l’Ermes?- rivela la mancata rivelazione.
C’è un sapere nell’assenza.
Era questo il segreto: che nell’ignoranza, nella scienza dell’ignorare, si cela un’antica sapienza, il segreto, quasi, del cosmo.
«La forza che mi spinge è muta e non m’indica la strada» ti dissuade l’enigma che insegui, l’uomo dalle spalle di tempesta, non seguirmi, inutile speranza.
Era muta, diceva e ti descrisse le meraviglie del sogno, l’incomprensibile colore della sera, l’armonia segreta dei venti, la musica la musica
II movimento
Terra lasciata alle spalle estesa nell’animo in lande traversate dal solenne ricordo di un fiume
tutto tutto attende alla musica nella caverna stanca del viaggio
Volgere alla propria terra le spalle per ritornarvi
il cammino segnato dal filo liso della nostalgia
Visitare città con la metafora della provenienza scandita in note battiti difformi
il suono del suo nome amplificato dalla cassa armonica del desiderio
il pellegrinaggio un ritorno reiterante
III movimento
Se quella forza è nemica, perché questi sogni divini?
ti chiedeva il viandante chiedendo a se stesso, Se benevola perché questa pena che mai trova requie?
«Addio» disse e s’allontanava facendoti riaffiorare in te stesso
come il silenzio, inespressivo, come lo sguardo, vuoto, come la pallida fronte della miseria o della conoscenza, la languente armonia l’ineffabile arte
[Vedi la Lettera di F. Liszt al Signor Lambert Massart, Gazette musicale, 2 settembre 1838]
[6]
vicino allo smalto scrostato del bacile ad un coccio spezzato nomepoesia ti taccio le crepe ai muri i pezzi di calcina il letto stridulo ti taccio un rubinetto perde a ritmo l’attimo d’acqua il tuo nome mi spacca vorrei annientare il tempo che ti ha dato crearti quando voglio come la goccia un attimo disperderti spezzare lo stampo in gesso rubare la voce con cui dici io averti infilata in questa crepa come un filo di paglia fra le labbra una cosa qualunque che per anni è lì poi un giorno uno viene getta via nomepoesia e nessuno s’accorge
così di te vorrei
[7]
Lana di ferro il tuo corpetto
all’abbracciarti urti sul petto l’irriti
e il tuo, trafitto, si imprime di incisioni,
piccola asceta da insensato medioevo
che i fianchi ti cinge scandisce le tue ore scava i cibi
mentre affebbrata ogni sonno ignori
gli occhi perenni dalle fosse muovi tuttintorno
e in avanti forando anche la notte con lo sguardo
o con il mite orrore della tua lunga cerca a piedinudi
A volte la poesia è più grassa, la invitano a cena anche i poeti, gli amanti, cultori, ricchi, gli annoiati, chi se ne intende, i fautori, poi gironzola i bar siede ai caffè, sa stare al mondo al mondo accetta, e nutre il bello
Ma tu, pure se taci sei fastidio, lo sguardo smarrito, riempito da guance cave il silenzio, come su schermo di cinema ti scorre addosso la teoria affollata delle facce che in questo istante muore per fame silenzio lo stupro irrisione, sgozza il cannone o che altro, cadi tra gli astanti come la mosca nello champagne, c’è da gettare via tutto quando arrivi
anche le cose
deliziose
Da: Allì Caracciolo, Malincóre (una fonologia del vuoto), Cittadella (PD), Amadeus, 1996.
[8]
tras-figurazioni sublimi per leggere la vita | divinità del dolore-uomo |
plasticità del vizio | amore perduta nobiltà feroce |
tale
vorrei di te – poesia – ( come a promessa ) e renderti divina ma vieni da
( vivi in ) una mí
seria nuda
e ti stendi sul greto stancamente a vendere quel po’ di amore che ti ricava dalle tue cóscescárne
un piatto di minestra
[9]
l’impercettibile vuoto
dove tutte avvenivano
tutte si perdono
le mutazioni
[10]
Prolusione affidata all’oralità
Non parlerò della mia attività di poeta
per coerenza con una biografia intellettuale scandita dal silenzio: quello
imposto /dalla poesia
\da me
e quello imposto da altri
con la differenza sostanziale della violenza
(l’esortazione cioè quotidiana a vivere senza annunciare la qualità definitoria della parola simultaneamente alla sua precarietà
l’imposizione di un cursus in cui essa –la parola- sancisce qualificando gli adepti escludendo gli esclusi)
La sua irrinunciabile diversità –della parola- è il memento del poeta: la parola come il tempo rovina via, precaria ed irripetibile è teatro che vanisce
Non potrà la poesia mai acquisire la sostanza dell’auctoritas poiché questa istituisce il déjà-dit
L’inespresso, tuttavia, non può sostituire/costituire poesia.
L’unico silenzio è una poesia che si destituisce da se stessa.
Cogliere questo istante è il mio (vocazione imperativo identità) mestiere.
Dal Poemetto Abbozzo per Campana. La Insomiglianza, in La Insomiglianza quattro poemetti, Salerno, Ripostes, 2007. [Finale della II parte, III parte]
[11]
II
[…]
stabilire metafore
tutte
ogni possibile metafora
per rintracciarne una sola
essa
quella che ti fa vivere
oppure si cela nella identità di somiglianze
lontane fino allo sradicamento totale
alla inversa sostanza
alla
ínsomiglianza
scrivevi versi sulle foglie
Sibilla stanca
talora attenui il tuo corso
il gemito dell’antro tutto risonante
tempesta di vento o di sospiri
l’urlo
trascina le foglie non la musa assopita
– sognava danze
o
altro –
l’urlo che imbianca le colline
col rovescio argentato delle foglie
sonagli
le serra
la libertà un filo spinato da scavalcare
le distende argentine
garrule sulla cresta dell’onda
la libertà una ruggine
sonagli
le serra risonanti come la catena
le serra il catenaccio
la libertà
una setticemia dell’anima
III
poesia
evanescenza che non torna
Andare andare
e poi
la muta orgia sbranamento furioso
Venga la morte pallida e mi dica
verrà
l’oscura baccante a divorare
l’ingordigia e il silenzio
tutto
fu taciuto
Andare andare
e tu bagliore
Nel dolor d’infinite morti amare
vanenteuridice ferma all’attimo
in cui tendi le braccia ti dilegui
tu
poesia
………
Da Allì Caracciolo, Stampe da manoscritti apocrifi (pubblicazione in corso).
[12]
Teoria del romanzo o altro
. Il rapporto tra i personaggi. la loro qualità : assenti indecifrabili. definiti una sola volta da un segnale di frase.poi perduti per sempre
↓
che non mira a definire alcun personaggio alcuna qualità.solo a sottintendere una parziale memoria·una presunta allucinazione da cui
il senso -l’unico : parziale·presunto-
dell’esistenza.
. L’assenza di pagine : poiché il numero -o il Numero- c’è -quando c’è-
ma è altro. tuttavia
↓
una numerazione scandita attraverso parole che percepiscono il fieri momentaneo è attestata -talvolta- nella precaria situazione di un capolettera o di un precipizio sulle/delle parole:
piuttosto sulla assenza.
. La capacità -qualcosa di occulto- di contenere uomini animali cose si sottrae : l’atto unico consentito al movimento dal quale dipende tutta la successione-simultanea dell’essere nelle sue metamorfosi. la scansione____una lunga linea interminata stabilita dalla necessità di ricondurre la parola ad una qualche permeabilità con lo spazio
poi:
la condizione asituazionale -schermo·paradosso della asensorietà delle cose. della improbabilità del reale-
. Il tempo____una assunzione del predicato necessitato a coniugare se stesso nei framm enti dello specchio : illusorio passato·frammento·falsofuturo_
una negazione riprodotta ad infinitum nel nulla·assenza e -pure-
riflessione-rifrazione di un oggetto inidentificabile nello spazio che lo produce come necessità ultima della propria credibilità (metafora : bubbone stanco sostituitosi alla materia) tuttavia:
(gli squarci della lirica ne individuano -a tratti- i bordi frastagliati l’umore di ferita l’abisso senza fondo della sua profondità cancrena).
. La sapienza -la ignara sostituta della conoscenza- frantumata nelle piccole pieghe di un particolare ostinato a non trasmettersi e a qualificare il reale : o non piuttosto l’esistenza?
. La legittimità -infine. requisito assente dell’origine : la sua assenza
delegittima l’esistenza. o non piuttosto l’essere?
↓
la autodefinizione attraverso la parola
o attraverso
il silenzio
anche il silenzio -invalso idolo-
un esposto sulle scale del tempio.
Italo Testa
Italo Testa (1972), vive a Milano. Ha pubblicato per la poesia il concept album «canti ostili» (Lietocolle, Como, 2007), la raccolta «Biometrie» (Manni, Lecce, 2005, premio San Giuliano Terme/Poesia Incivile) e il poemetto «Gli aspri inganni» (Lietocolle, Como, 2004). Ha ottenuto per la raccolta inedita i premi Dario Bellezza e Eugenio Montale. Suoi testi sono apparsi in antologie, tra cui «Chaos and Communication» (Link Diversity, Sarajevo, 2001), «Così non ti chiamo per nome» (Empiria, Roma, 2001), «Nodo Sottile 3» (Crocetti, Milano, 2003), «Parco Poesia» (Guaraldi, Rimini, 2003 e 2004), «Il presente della poesia italiana» (Lietocolle, Como, 2006), «Poesia e natura» (Le lettere, Firenze, 2007), «La joven poesía italiana» (Cuadernos del matemático, Madrid, 2007) e su diverse riviste, tra cui «Portals. A Journal in Comparative Literature», «Gradiva», «El coloquio de los perros», «Atelier», «Almanacco del Ramo d’Oro», «Pelagos», «Nazione Indiana», «Il primo Amore», «Poesia da fare». Ha pubblicato saggi in volume e su riviste, tra cui «aut aut», «L’ospite ingrato», «Il ponte», «Reset», «La Società degli Individui». E’ co-direttore della rivista di poesia «L’Ulisse» e, presso Diabasis, della collana di saggistica «La Ginestra».
Italo Testa: Nota teorica e poesie edite e inedite
Dell’etologia poetica
1.
L'impulso all'espressione, dapprima tensione mimetica ad assimilarsi alle cose, si arresta nella cesura formale, con un colpo all'indietro che lo riporta su se stesso. Solo di qui è possibile un ritorno alle cose, ora prossime perché estranee. Così l'adattamento non è puro conformismo, bensì tensione che trasforma, metamorfosi. In questa direzione la poesia supera la forma tradizionale delle architetture verbali, basata sull'opposizione figura/sfondo, e si riallaccia alla concezione topografica figura/figura: diventa elemento sporgente ma fuso nel terreno dell'esperienza. La figura, mentre si integra nella topografia del luogo, insieme ne deforma il profilo, escrescenza linguistica che genera nuove forme di vita, inedite morfologie linguistiche. Come un un'arte del paesaggio essa s'innesta nel terrain vague, tra i margini inselvatichiti di parole e cose, rinvigorendone gli arbusti e rendendo riconoscibile la silva dove prima si scorgeva solo un panorama di rovi e detriti.
2.
Così, con cura biometrica, l'ars poetica continua la sua tessitura, anche quando le strutture consolidate, le tradizioni si sfaldano. Il grado zero della cultura, che in certi momenti sembra prossimo come non mai, è forse anche un'occasione per la poesia che, come pratica istitutiva, non necessita, nel suo fare paziente, di una legittimazione esterna. In questa prevalenza dell'agire, del fare, la scrittura poetica torna alla sua qualifica di ape operaia, di silenzioso e operoso artigianato che tesse una tela mai pienamente aggiudicabile ideologicamente. Certo, vi e' anche la resistenza dai margini e la salvezza dell'esclusione: ma qui la poesia resiste proprio perche' viene meno il lungo errore dell'appartenenza piena. Quando il tutto che la teneva coesa come pratica culturale si dissolve, la poesia continua a sporgere da quel terreno guasto, facendo segno ad altro. Non piu' sorretto o puntellato da un sistema riconosciuto di valori, questo gesto, acme dell'individuazione, torna a poggiare sull'etologia poetica della specie, ma proprio in questa nudità si osserva dal futuro.
Da Come non torni. Quartetti per la fine del giorno, inedito, 1990-1995
INVITO
Silenzioso il cielo sussurra inviti
ad abbandonare l’arsura, lievi
le vostre voci un cristallo raccolga.
Grumo immemore attende nel tepore
di una calda palude: non ala, battito
che franga lo specchio d’acque oscure
anteriori al giorno.
*
Come non torni, che sgocciola
e fa buio, quasi si leva
dai fossi uno spicco d'urlo,
non sai che in povertà
si consumano bosco e cielo,
un ramo che nella nudità t'incarni,
come non parli, del crollo della vigna,
dove nascosto ancora pregavi,
è vuoto il cesto degli aculei
e tu non torni, la stanza è vuota
di un nulla, un’attesa vigile
che un qualche fuoco arda,
perché non mormori la condanna,
il casolare ormai deserto,
solo ombre quelli che ti cercavano,
quell'ultimo rintocco.
CONGEDO
Come la vita che scorre intatta
e attraversa la notte: la perdita
è paglia e il silenzio è dono.
Da Gli aspri inganni, Lietocolle, Como, 2004
I.
Devi fare attenzione, orientare lo sguardo
in direzione del flusso: è bianco il velo
che lambisce i contorni, che accieca:
tu al bianco devi cedere, muto
aderire all’indifferenza delle cose.
II.
Misura il respiro, lascia aderire
alle forme dell’inganno le membra;
le ossa tenere sfiorano il suolo
a cui il peso dei giorni trattiene
come brocche dai cieli bagnate;
raccogli, lascia variare i silenzi
di cui nel vetro dell’aria t’investi;
tu lascia vibrare ancora i colori:
se al docile buio un’ombra t’inscrive
inarca le spalle, al vuoto confida
il resoconto terrestre, gli aspri
inganni delle forme: tu socchiudi
il passaggio, lenta lascia pulsare
distante la peripezia del tempo.
III.
Se cadi e l’ala non sorregge i passi
che nell’azzurro il corpo in volo traccia,
lascia scorrere l’inganno splendente
ogni cosa fa segno all’estraneo;
se nel velo la pupilla si annoda,
coda di volpe l’incanto assopisce
dal manto del giorno schiuma apparenza;
chi perde il sentiero presto fiorisce,
cadendo nel vuoto il taglio richiude
da cui insanguinato un giorno ti levi;
se al suolo un’ombra serena aderisce,
lascia vibrare ancora i contorni:
la misura si compie, il segno traccia
una nuova voluta nell’aria.
Da Biometrie, Manni, 2005
RETINE
Di ora in ora, appena scatta un allarme
da qualche parte una luce si accende
tra le tende il tuo corpo si nasconde
dalla donna che nella stanza dorme.
Poi dal frigo un sibilo si propaga:
imbevuto di una tinta acida
il quadro luminoso della strada
sovresposto sulla pupilla dilaga.
Se un elicottero verde veleno
sovrasta le insegne della notte
battendo ai vetri, dal decimo piano
manda il tuo segno al profilo alieno
fondi la retina al cerchio radiante
del dio in acciaio metropolitano.
SEPOLTO, ASSOLTO
nel limbo di specchi io mi addoloro
su questa pietra tatuata nel gelo
nell’abbraccio freddo della marea mi verso
se dalla schiuma del vetro riemergo:
vedi dell’oscuro le tracce, i lembi
sfrangi, ammutolito, nel buio:
discanti il gelo, nel taglio di un mondo
la semina dei giorni disperdi:
nel sonno, io, sepolto assolto
dall’evento tendo il profilo
la cornea sull’incavo del giorno:
preso nel laccio non vedi figure
nel fondo del sogno scendi, ricadi
frammenti di specchi:
KARL-MARX ALLEE
1.
niente avrebbe detto, quell’intercalare
fatto di brevi sospiri, soffi
nel ricevitore,
alterne attese, ma non c’era
malignità in quelle parole,
anche se avevano
la durezza di un vetro,
quasi gli uscivano senza volere, niente
a che fare con le minacce,
i ricatti che erano
il tessuto di quei colloqui,
niente era
il suo intercalare, e lì, in quel tic,
potevi leggere la conferma di quello
che pensava, lamentoso
o sprezzante: niente
2.
camminavi con gli occhi chiusi,
o con le palpebre arrossate,
come di chi avesse pianto.
Ma non avevi pianto.
Niente hai detto, non è stato niente
un’increspatura sull’acqua, una spirale
sulla sabbia:
ad occhi chiusi filtrava
la forma vuota delle nostre vite
in attesa
la geometria lineare della Karl–Marx
Allee
nel breve declino d’Agosto
due ombre nella fuga di vetrate
tra la polvere dei cantieri: dal niente
la selva di specchi profilava i tuoi occhi
una notte qualunque a Potsdamer Platz
3.
Inizio dell’estate sotto la nuvolaglia
della Ruhr.
Ti dibatti ancora nell’ora
del falso sentire: in proroga concedi i tuoi
giorni, come se il carico
fosse inesauribile
è ai doveri verso te stesso cui sfuggi
perché di te stesso disperi.
Ti allontani, vorresti uscire dal sentiero
per incamminarti nel folto:
detriti di stelle
osano ricoprirti, come artigli
si configgono
Da Canti ostili, Lietocolle, Como, 2007
DISARMATI
ostili, sì, alla vita
sbandiamo sulla traccia
illuminata a giorno
intorno si dirada
il folto della macchia
sull'altopiano arioso
ad altro è inteso il chiodo
puntato sulla tempia
nell'ora che si sfalda
e rapinoso un volto
rimanda svelto un cenno
che al mondo ci disarma
IMPLACATO
il sangue che non hai versato
alla battuta d’armi
sui calanchi franosi: sbanda nella luce, gira e cade
ma la neve, dice, la neve…
l’amore che non ha dato
frutto alla terra
in gesti netti e operosi:
è il 24 aprile, ma cade, cade…
la paura che non vi ha stretto
addossati ai muri
sotto i colpi esplosi: così al campo, che ha arato
offre le labbra e confida
II
qui, nei vostri poderi,
ricalcando i passi
dove la storia ha fissato
una tranquilla dimora,
prendiamo possesso, noi
di un tempo che frana,
per una traccia andiamo
che a voi ci riconduca:
e fiutiamo, se il vento gira,
con le narici umide di brina
un sangue, implacato, nella neve: ma canta il dolore che accomuna
e una lepre, in fuga, sotto i gelsi
(Monte Falcone)
SARAJEVO TAPES
VI [16 luglio, spalato: h. 9]
un bagno d’ocra, di rocce, di scaglie t’accoglie
muri a secco e alle fermate d’autobus
murales stinti con bottiglie di pepsi
per vie d’acqua, confluendo la macchia verde
si penetra all’interno
il perimetro del mare ritaglia in occhi verdi
laghi cinesi, una cartolina dal mondo:
lasciati invadere dall’inganno dei colori
lascia scorrere i profili
gli occhi degli uomini furono fatti
per guardare: e lasciateli guardare
***
VII [per mostar: h. 16]
mi dicono che i tuoi occhi sono vuoti
mi dicono che i tuoi occhi sono stupefatti
segui lo sventolio dei drappi
il rosso, il bianco, il blu
distesi tra le rocce, sulle case
in costruzione a fianco della strada
mi dicono che i tuoi occhi non vedono prati
mi dicono che i tuoi occhi s’incantano
conta, ad uno ad uno,
i parallelepipedi bianchi
le bianche distese, da ogni lato
l’abbraccio del paesaggio
fitto di cippi, giallo di luce
mi dicono che i tuoi occhi si dissipano
mi dicono che i tuoi occhi, i tuoi occhi
a seguire le cave di sabbia sul fiume
dopo mostar, i mucchi di sabbia e di terra
scavati, nella luce, senza ombra,
per ogni gruppo di case una distesa
di pietre bianche, erette, immobili
Nicola Ponzio
Nicola Ponzio è nato a Napoli nel 1961. Vive e lavora a Torino.Poeta e artista, ha esordito pubblicando suoi testi poetici in varie riviste letterarie italiane, tra cui Nuovi Argomenti, Galleria e Atelier.
Suoi versi sono presenti in diverse antologie, ultima, Il presente della poesia italiana, a cura di Carlo Dentali e Stefano Salvi. (Lietocollelibri, Como 2006).
Ha pubblicato le seguenti raccolte poetiche: Gli ospiti e i luoghi (Nuova Editrice Magenta, Varese 2005), L’equilibrio nell’ombra (Lietocollelibri, Como 2007), l’e-book Esercizi del rischio (Biagio Cepollaro E-dizioni, 2007)
Nicola Ponzio: Nota teorica e poesie edite
Appunti e contrappunti di poetica1
Guardi un albero e dici: bisogna radicarsi nella terra, per volgere lo sguardo verso il cielo. Ed ecco che l’esigenza di una poesia ctonia, terrestre e interrogante, si rivela in tutta la sua energia mortale, entropica. Mai separata dall’idea di doversi confrontare con la nuda brevità dell’esistenza.
2
La poesia, ovvero, il ritmo come forma del respiro. Scrivere per me significa cercare un ritmo che coincida col respiro, un continuo tra mente e corpo, materia e pensiero, visibile e invisibile, che superi il sistema binario delle rappresentazioni. Da qui il difficile equilibrio di una scrittura che pare sempre sfuggire di fronte al proprio referente. L’alterità che cerco così di rappresentare (mai di descrivere) è colta dall'interno della sua eterna e presente contraddizione. Specchio di ogni agire umano.
3
L’esperienza del vuoto, di fronte alla pagina bianca, determina il conflitto con la necessità. Nasce così l’urgenza di stabilire delle priorità rispetto alla propria ricerca. Rigore, consapevolezza, ascolto. Ancora, una scrittura poetica che non si confronti anche con il corpo di una comunità in divenire, oltre che con la caducità inerente alla propria biologia ed esperienza mortale, rischia di apparire infeconda, arida. Conseguentemente è probabile che non produca frutti autentici, ma solo surrogati di maniera.
4
Etica ed esperienza devono necessariamente coincidere, per rompere il silenzio. Soltanto in seguito si appresta la parola. La lingua poetica diventa così territorio privilegiato d’indagine, meditazione e pensiero. Analogamente alla natura che le fa da specchio, nella sua molteplicità ed erranza. Lingua e natura, quindi, connaturate all’uomo e identificabili alla stregua di un’interrogazione enigmatica intorno al senso dell’essere e al divenire, al destino e all’alterità.
5
Ma la poesia è anche silenzio. Pausa. Inspirazione, espirazione. Assenza e separazione. Veglia. Attesa. Rotta. Oblio.
6
Nell’aperto l’universo metamorfico della poesia si manifesta in tutta la sua crudeltà e bellezza. L’aperto, ovvero la natura ignota e liberatrice, ci espone al rischio dell’erranza totale, al nomadismo definitivo e inafferrabile. La coincidenza degli opposti si fa esplicita, nel fuoco dei possibili alfabeti.
7
Abitare le parole necessarie, ricavandone un’icona del dolore.
Sottrarre e sottrarre, sempre, e senza tentennare. Vigilando sul respiro e sul silenzio. Ubbidendo a un comando. Aggiungere il giusto sostanziale perché l’osso non ferisca ma affratelli. Come un talismano appeso al collo.
8
Pensare obliquamente rispetto alle categorie logiche del sapere scientifico. Curare le relazioni tra gli enti interrogando le parole con umiltà e coraggio, confrontandosi con la tradizione e ponendosi in ascolto con l’alterità.
La poesia si espone all’apertura spazio-temporale dell’ossimoro e della contraddizione, offrendo la possibilità di esplorare gli abissi della coscienza umana e della percezione del mondo. Senza pretendere salvezza né conforto.
9
Dove finisce la mia poesia comincia quella di un altro.
Dove comincia la mia poesia?
Dove finisce la tua poesia?
Tornare per partire per tornare.
10
La coscienza della dissipazione dovrebbe essere compresa in ogni autentica poesia. Non desidero specchiarmi sulla carta, piuttosto sprofondarvi per riemergere diverso, dopo una lunga apnea. Dall’uomo all’uomo, da un respiro a un respiro firmando una rotta, nella consapevolezza di non pretendere nessun compenso, nessun onore che già non sia connaturato al dono di poter scrivere qualcosa di umanamente autentico, in una forma che passerà.
11
Diciamo addio a ogni poesia che ci consoli. Basta! Occorre affrancarsi definitivamente da questi limiti. La caducità dell’esistenza, il momento presente e continuo del distacco, andrebbero accettati senza rivalse sul reale. Il vuoto a venire è già presente nelle orme di un bambino che cammina sulla sabbia. O dentro gli occhi di una gazza, dove si specchia il mondo. Questo accettare. Questo cantare. Senza pretendere salvezza o compromessi.
12
Si scrive sempre da un esilio, da una separatezza, affinando le parole in un abbraccio che sia partecipe di ogni cosa del mondo: i riflessi dell’alba su un filo d’erba, le ombre tremolanti sulla neve, il fuoco lungo i margini di un bosco.
Rinunciare all’attaccamento a se stessi come se questa fosse la più umana delle priorità. Nessun intimismo, quindi, tanto meno patetici soggettivismi lirici dettati dal narcisismo più bieco.
La poesia oggi non può essere altro che dissidenza. Dissidere, ovvero sedere separatamente, ascoltando con umiltà ma senza cedimenti. Rispondendo con l’apparente fragilità della parola poetica alle iniquità che ci assediano.
13
Si dice piede d’accento, non mano, non cuore, non occhio d’accento, ma piede. Forse per voler sottolineare l’attaccamento dell’unità ritmica alla terra, e quindi al respiro.
Piede = cammino = respiro = ritmo = nomadismo = erranza = poesia.
Da GLI OSPITI E I LUOGHI
Dalla sezione Il falegname Zimmer
Cedere in silenzio fino a eccedere,
nel silenzio dell’alba. Convertirsi
alla luce e della luce convertire
con coraggio, con pietà le sue radici.
Le sue monete d’oro e d’ombra.
Custodirne l’alimento
nel visibile dominio che protegge
l’ostinata carità di questa carta.
***
Ti metterò alla prova separando
la viltà dalla tua vita.
Dove sbocciano le api alla speranza
di parlare con gli umani,
in questa casa.
Dalla sezione Gusci
Comunitario è chi con cura riconosce
nella propria alterità
quell’apertura necessaria a condividere
con gli altri la sua fame.
***
Pensare per frasi rotte
con la bocca
del sole che purifica i raccolti.
***
Vivere di espedienti,
per estinguere quel debito contratto con la luce,
nella stessa planetaria economia
di fame e usura.
***
Parlato l’albero nessuno
parla più.
Sconveniente è il dialogo.
***
Scrivere forse è sottrarre dal buio
l’identità dell’alba.
Premessa che pacifica negli occhi
una sintassi più terrena, responsabile.
Promessa che fa fronte alle menzogne
con la forza di un impegno.
Da L’EQUILIBRIO NELL’OMBRA
dalla sezione Oscillazioni
Gelsi e il prato un miracolo,
nel gesto di riempire con il cielo
la distanza della carne. L’esile
materia più gelosa.
Scegliere nel nome
di ogni cosa la più giusta decisione.
Credere è questo.
Allontanarsi da sé per ritrovare
la scrittura della vita
in una gioia da disperdere.
***
Coraggio delle scelte mattiniere,
non attardarsi a discutere
che cosa sia più giusto
designare.
Il tempo è nell’anticipo
del falco.
Nel suo respiro
di meteora.
Si danno nomi al mutevole
del cielo senza ipotesi
plausibili per l’erba che rinfranca.
Come se tutto qui dovesse vivere
per noi la stessa gioia,
l’insostenibile esperienza
di un convito
di parole dentro l’erica.
dalla sezione Gli invisibili
Voglio parole forti.
Concrete.
Simili ad un seme che s’infila
nella crepa
di una ripida parete di granito.
***
Una chiarezza così estrema
non permette
di comprendere la luce
che si maschera di pagine
e di cenere,
per essere vicina ed invisibile.
***
Parlare delle nuvole per dire del dolore
dei mortali.
Mutevolezza
dell’inchiostro che dissimula così
la sua efficacia.
La sua perseverante adolescenza.
dalla sezione La pagina, il fuoco
Ergersi più audaci dentro il fuoco
di parole che vivificano il cuore
delle scelte.
Impegno che determina
chiarezza.
Nell’estrema libertà di contraddirsi.
***
Una poesia che non ci sappia provocare
si smentisce nell’alone
derisorio
di un pensiero inappetente.
***
Meglio gli scacchi che esaltarsi
per le mezze verità dei merlettai.
Riannodano nel canto per se stessi
le parole dette piano agli impiccati.
Da ESERCIZI DEL RISCHIO
Esiti, - dove si ostinano parole
e resistenza.
Rotoli in preda al silicio,
tra segni elettronici persi
nel vuoto del web.
Ora insisti
sui versi, - ti avviti
sugli input, desisti…
Se nel monitor vibrano impulsi vitali
o già morti, - dati al ritmo di bit
Dalla sezione Ambienti
Improvviso il rasoio
di un lampo separa gli aironi
serali dall’ampia risaia.
Cromosfera di un’ombra
remota che duplica i pioppi
inclinati irradiando la vista.
Le acque lungo l’asse provvisorio.
***
Incoerente è la fede, improvvisa
la virata di una tortora, - dice
di un luogo il sigillo diurno.
Poi, se sfiorendo si assolve
da sé il paradigma intravisto, - il legame
di luce che svela gli abbrivi, le foglie, -
pure il testo si evolve,
contrasta.
Segue a domanda
domanda, una cura agli indizi
sabbiosi, alle trame di un mandala.
Dalla sezione Esercizi del rischio
Più debole è la forza che si ostenta.
Ma forte della stessa debolezza
è la forza che arretra con arte
ulteriore, - esponendosi al rischio.
***
Ora maschera – innesta – poi sostanzia
e dispera di sé mentre vira
molteplice un verso di vita.
Il lavoro degli anni, - l’umile
vista o la brina al fermento di credere
vero il volersi felice.
Controversia e primizia.
Disciplina che dura un istante
ulteriore, - distante
da sé e da quel che segue.
***
Mente che mente
e poi s’inluoga – deriva
dalla stessa ambiguità
delle parole questa crescita
di senso.
Come una prima nascita, la rima
intermittente delle acacie.
Avanguardia
di luce che duplica il dubbio
radente una lingua inventata.
Mauro Germani
Mauro Germani è nato a Milano nel 1954. E’ stato fondatore e direttore responsabile della rivista di scrittura, pensiero e poesia “Margo”, che ha diretto fino al 1992.Ha pubblicato i volumi di narrativa Racconti segreti (Forum, 1985) e Il prescelto (Alberto Perdisa Editore, 2001), e i volumi di poesia L’attesa dell’ombra (Schema, 1988), L’ultimo sguardo (La Corte, 1995) e Luce del volto (Campanotto, 2002).
Suoi testi sono apparsi su varie riviste, tra cui “La Corte”, “Anterem”, “Atelier”, “La clessidra”, “Capoverso”, “Poesia”.
Mauro Germani: Nota teorica e poesie inedite
All’appello che viene dall’ombra risponde la scrittura, l’ineluttabile rovina della luce e della storia. Si tratta di una parola senza protezioni, senza difesa. Chi l’accoglie sa del suo silenzio e del suo mistero. Si accinge a scrivere dall’esilio del suo ascolto, come sospeso tra due abissi: un fondo oscuro e segreto che si spalanca alle proprie spalle e qualcosa che da sempre attende come un destino. Ciò che resta è la traccia di una scomparsa, il segno di una voce perduta e di un desiderio, la risposta ad una chiamata antica.La poesia è gettata nel mondo, è delicata e potente al tempo stesso. Nasce ai bordi dell’inesprimibile, tra salvezza e perdizione, tra memoria ed oblio.
Il poeta è colui che vive in sé la frontiera, il margine, l’inquietudine di un’alterità inafferrabile che sente nell’ombra. Sperimenta l’assenza dell’Altro e nel contempo ne ricerca la voce, una voce che da sempre tace nel suo dire, che si sottrae nel suo essere qui, nella carne e nel dolore dell’esistenza.
Che cosa può costruire allora il poeta?
Nel testo c’è sempre un altro testo perduto, tutta l’incompiutezza della scrittura. La costruzione avviene sulla sabbia delle parole, sul deserto di una lingua che frana. Come ha affermato Edmond Jabès, “per lo scrittore ogni parola scritta nasconde un’altra parola del tutto inafferrabile ma incessantemente differita e infinitamente più essenziale. Verso questa parola egli tende”.
E proprio questa tensione mai placata definisce a poco a poco lo spazio della scrittura, una zona che è per noi lontananza ed intimità, spaesamento e familiarità, costruzione e maceria.
*
Scrittura
d’ombra
e d’esilio,
capovolta
aurora
di pagine
perse.
Dov’è
il vento
che chiama
le labbra,
il raggio
bianco
che scuote
la terra?
Dov’è
la voce
perduta
del sasso,
l’eco
ammutolita
del cielo?
Tutto
si cancella
dove tutto
perdura.
*
Spegnere
un nome
eppure
vederlo
amarlo
senza
ritegno.
Finire
adesso
il mai
cominciato.
E sapere
le notti
che non sanno
e invocare
il cielo
prima
del cielo.
Aspettare
il silenzio.
Scrivere.
Scrivere
sempre
il già
cancellato
*
Persa
raccolta,
persa
memoria.
Catastrofe
dove
il tempo
barcolla
e tace
la notte
tace
il volto
che guarda
l’abisso.
E tutto è
un salto
d’addio
un gesto
solo
aperto
nel vuoto.
Maria Paola Svampa
Maria Paola Svampa è una laureanda in Letteratura e Filologia Moderna e Contemporanea dell’Università di Macerata. Si interessa di poesia di lingua inglese ed italiana del 19° e 20° secolo, scrittura delle donne, e di studi comparatistici. È in programmazione l’uscita di un articolo sul Sublime kantiano nella poesia di Letitia Landon, presso Literature Compass (Blackwell Publishing). Attualmente si sta occupando dei rapporti ideologici ed editoriali del Rinascimento Americano con la poesia Vittoriana.
Maria Paola Svampa: Nota teorica e poesie inedite
Solvitur Ambulando. La poesia come incontro.
Io non ho un programma, squadrato in bianco e nero, piegato netto in tasca, da squadernare a piacimento. Al massimo – passeggio – leggo, e prendo appunti. E tra i miei appunti – tre punti mi stanno a cuore – il corpo, la performatività, e l’incontro.
Doppia chiave
Che la scrittura delle donne sia una scrittura del corpo non vengo certo a dirvelo io. La “questione” sta semmai in come questa chiave (di lettura, e legatura) venga usata, ed abusata. Come tutte le chiavi, la si infila per aprire, ma anche per chiudere.
La porta della mia stanza è una di quelle vecchie porte a doppia chiusura, con chiave e chiavistello non comunicanti. Un chiave esterna serra e disserra a capriccio la stanza – e all’interno tiene un chiavistello, che stringe la stanza da dentro, e si schiude solo per scelta. È questa incomunicabilità, di chiusure ed aperture, che genera la relazione. Con una sola chiave, con una sola serratura, non si dà tensione, ma rapporto di potere – dentro, fuori – non si dà comunicazione.
La parola del corpo ha avuto il merito di schiudere l’ingresso al laboratorio dell’esperienza poetica. L’errore sta nell’usare poi questa parola del corpo come serratura singola ed inerme, da aprire – e soprattutto da chiudere – a chiave, da fuori, senza considerare la controparte interna. Far riferimento sempre, comunque, ed acriticamente al linguaggio del corpo quando si parla di scrittura delle donne è una seduzione macchiata di cattiva coscienza. Non fa che perpetrare l’antica equazione “donna uguale corpo”. L’insidia sta nel fatto che essa seduce la stessa parola delle donne, spegnendone il carattere. L’adulazione programmatica e normativa della “specificità” della nostra parola ci incasella – la chiave ci chiude in cella, ancora ed ancora ed ancora: fine dei giochi. Se la parola delle donne è automaticamente una parola del corpo, allora c’è poco d’altro che essa possa dire. Come se la “mente” esistesse fuori dalla carne, e come se anche gli uomini non pensassero da “dentro”.
L’errore sta nel pensare che la scrittura delle donne parli semplicemente del corpo – e come tutti sappiamo, ogni brava donna se ne sta prima di tutto dentro al suo corpo, a fare l’amante, la mamma, la vergine. Questo rende la parola delle donne irrimediabilmente e costitutivamente isterica, e ne stronca la portata trans-gender.
Le donne non parlano del corpo – parlano dal corpo. Parliamo da un luogo ineludibile ed incancellabile, con la consapevolezza che quando si parla – o si legge – non si è mai originariamente illibati, intoccati dall’esperienza, e che quest’esperienza avviene solo nel corpo. Il corpo non è solo il corpo femminile – ma è la modalità dell’esistenza e della riflessione umana. Il corpo non è una chiave di lettura, ma la carne ineludibile e calda dell’esistenza, ed anche dell’esistenza del testo. Il corpo non è uno strumento critico, ma dato fattuale e pulsante. “My body is not your battle-ground”, dice Mohja Kahf nelle sue E-mails from Scheherazad. E non va trattato come tale. Nè sulla pagina, né sulla piazza.
La parola delle donne ha il merito di aver aperto e reso centrale l’essere materialmente “locato” del soggetto parlante. A chi legge non spetta una preoccupazione definitoria e circoscrivente, non l’uso arbitrario e rassicurante di una chiave. Chi legge è tenuto, è chiamato ad oltrepassare la porta, a scoprire il proprio pensiero come irredimibilmente locato nel proprio corpo. La novità della poesia delle donne, semmai, sta nel “pro-vocare” il lettore a ri-conoscersi come soggetto incarnato.
Prendere la parola
Una parola che nasca consapevolmente ed intenzionalmente dal corpo impone per coerenza una riflessione sulla stessa sul fenomeno della produzione linguistica. La parola poetica, e forse non solo essa, non nasce come parola astratta, come puro pensiero tradotto su supporto materiale. La parola poetica è di natura fisica già nell’istante del concepimento. Il verso nasce come pensiero in ritmo, e cioè come spostamento sonoro, e quindi fisico, sensoriale, attraverso il cronotopo.
Ma un verso, per realizzarsi come tale, deve ovviamente essere fruito, e riconosciuto come tale. La lista di personaggi da scomodare in materia è infinita, e passa per Sartre e Marziale. Un verso allora, se nasce come unità ritmica, come nodo indistricabile di carne pensiero ed azione, e se si compie solo attraverso la fruizione, può essere valorizzato dalla performatività.
Ma con performatività non si intende solamente “l’offrire pubblica lettura di un testo poetico”, attività peraltro utilissima ai fini di riattivare il rapporto con il pubblico. La performatività è una struttura profonda del testo poetico. La parola, ed in particolare la parola poetica, nominandole, chiama le cose all’essere. Questa è la natura prima e costitutiva della performatività del linguaggio poetico (e non solo). La parola poetica nasce come stringa ritmica il cui movimento sonoro attraverso lo spazio ed il tempo costituisce elemento fondante della significazione.
È a questo punto piuttosto difficile immaginare un testo poetico che “non funzioni” nella performance, o un autore che “non sappia” leggere se stesso. Quando questo accade, siamo di fronte ad una mancanza. Una mancanza che può essere intenzionale, e che quindi diventa strategia (anti)comunicativa, rientrando così nell’ambito della performatività; ma che spesso, purtroppo, è solamente una mancanza inconsapevole.
Pensare alla lettura, e perché no, anche alla lettura a voce alta, e alla lettura reiterata come avvicinamento al testo non significa solamente prendere atto della natura del testo poetico come pensiero materico. Significa anche aprirsi al fruitore sin dall’inizio, sin dall’atto creativo, ammettere alla coscienza che la creazione è un atto sociale, liberandosi così dalle mitologie solipsistiche.
La poesia in cammino
La parola è un’arte impura – e sporca è la poesia. La parola sarà anche ombra di un’idea – ma porta addosso l’odore del mondo e di ogni luogo in cui è stata. La poesia s’impasta fango d’albero e sputo di seppia, asciugato dalla polvere della via, perché tutto – è – materia. Soprattutto in poesia, fatta di ragioni, misure, metri, piedi...
La “ragione” di un testo poetico è nel suo libro conti, elenco bruto, economico, ponderato, valutato, misurato. Nel libro di conti s’incontrano calcolo e materia; la sua misura sana la frattura (tutta immaginaria) tra l’astratto ed il concreto, tra un passato di cui dar conto ed un futuro da programmare – proprio come avviene nel testo poetico. Il libro conti possiede tutta l’oggettività d’uso che gli viene concessa da chi lo usa, da chi lo interpreta. Il libro conti non sta a sé ma, legato alla “realtà”, lega chi lo redige e chi lo legge.
La poesia è fatta di misura. È fatta di movimento – scorre, s’impunta, ristagna, procede a salti, si sustanzia solamente nello spazio e nel tempo. La misura è un palmo di strada, uno dopo l’altro, scopo, ragione e mezzo costituente del viaggio. È la misura fa il viaggio – e la poesia, che si fa viaggio. La misura è una curva percorsa, la misura è carne numerica, la misura ci fa, e ne disfa il senso.
La scrittura dunque innesca un incontro tra pari, in cui chi legge conta tanto quanto chi scrive, chi dispone del testo conta tanto quanto chi lo propone; essa genera una democrazia della differenza, della donazione di senso, dell’ascolto, della costruzione. Il testo è una strada, ed è su questa strada, in questo viaggio, che avviene l’incontro, o meglio molti incontri. Incontri combinati, a volte; a volte appuntamenti al buio.
Se mettersi attorno al testo – leggerlo, scriverlo, parlarne, anche solo osservarlo – significa mettersi in strada, allora tutto ciò che possiamo sapere del testo non è che conoscenza di viaggio, o meglio, conoscenza in viaggio. Non possiamo parlare di viaggio (fisico o meno che sia) dal centro di una fissità, senza aver accumulato miglia e miglia nei piedi e nella mente, senza accettarne il carattere precipuo di incontro in movimento. E se la poesia è un viaggio, non possiamo accostarci ad essa muniti di concetti “incellophanati”: per andarle incontro dobbiamo essere disposti ad intraprendere ogni volta un viaggio, con tutti i rischi e le rivoluzioni che esso comporta. Perché un viaggio interroga le origini, e talvolta le modifica. E così se la teoria legge la poesia, oggi la poesia usa la teoria, la piega, la celebra e la sbeffeggia – le getta il guanto di sfida. Oggi, sta a noi lettori raccoglierlo.
Non si tratta di abbandonarsi all’impressione fuggevole di una “esperienza” passeggera, ma di mettersi, ogni volta, in umile ascolto del testo. “Rimanere presso il lavoro” diceva Cézanne. Io sto dalla parte del lettore. Avvicinandoci al testo non siamo mai vergini. Né possiamo “uscire” da noi stessi, spogliandoci della carne del nostro vissuto e delle nostre conoscenze. Ma non possiamo limitarci a leggere il testo come uno specchio entro il quale troviamo conferma delle nostre teorie e delle nostre conoscenze acquisite. Un testo è una chiamata ad un incontro – sta a noi metterci in cammino, e intraprendere il dialogo. Un testo si scioglie solo percorrendolo.
I testi che seguono sono delle missive, degli appunti di viaggio, ponti caracollanti, dialoghi forse impossibili tra i soggetti, ma tentati – tra il testo e il lettore. Le miglia marine e terrestri sono il segno di una distanza incolmabile eppure cercata, ribadita come autoaffermazione, esuberante o ripiegata. Tipi e generi di una tradizione (auto)ironicamente usurpata e miscelata in fondante ambiguità non hanno il valore di un compiaciuto capriccio combinatorio. Questo è un tentativo, seppur barbarico, di rimettere in moto nel testo le tradizioni, i generi, i pensieri, le parole, la carne, così come essi sono simultaneamente all’opera nel reale.
Testi poetici
la selvaggia sul ponte
Distesa coll’odore appena amaro • che amo incassato in faccia • io - sono - Berthe • Berthe dai begli occhi - Berthe la fraintesa - Berthe la disprezzata - Berthe bambina cattiva • che non ha mai scritto a te • Berthe rotonda e nera - tranne che al sole • bestia di questa terra • di sera - di nodi di lana verde • spighe e rivoli di fuoco - orlati di spighe ancora - spighe e fuoco • dentro e intorno agli occhi • Berthe che abita il mare • quel mare che per te era vacanza per me era l’unica via • e mentre tu giocavi con le vele - io mi aggiustavo gli alamari spianavo la mia giacca blu e consunta• come tintinnano dorati • i miei crini d’Achille - le mie ciglia bionde • Berthe piccina e nera - rotonda e nera • m’avvio lungo il molo • per saluto una risata • perché solo legata • al grande albero di pino bianco • Dio com’è bianco - d’alabastro diritto polito e mio • mia ancora - mio arpione - mio rostro in ogni senso • soprattutto in quello che non sai – capire – carpire • perché Berthe da piccola era Greta • e sosteneva che fosse già morta • ma era solo una scusa per non comportarmi bene • per tagliare quadrati di mare • e dare la colpa al gatto - si sa che ogni nave ne ha bisogno prima o poi • Berthe o forse Bertha • che porta il fuoco nei sogni • considerate le parole che inseguo - presto più presto • trafiggile con una freccia – la mia freccia d’ebano e calda • prima che s’acquattino nel buio – sotto la luna • le mie perle le mie - collane di perle • che da sola tendo tutt’intorno - alle impurità del mondo - a non ferirmi la carne • e non sono le vostre collane • angelo ninfa e musa no grazie • a me • lasciate • il desiderio • ad essere una pagina bianca – e nera • non mi sono ancora • arresa • Berthe la malappresa - Berthe rotonda e nera • nena • Berthe l’ispanica – dai capelli rossi • Berthe che ha come sempre • troppo sole spalmato addosso • e ne brucia l’aria d’intorno • finché non s’affievolisce il fiato • e allora ride – mistero superiore • di sé – di te – e di tutto il resto
la strada per roma
vent’anni dopo · la strada per roma è ancora lì · bianca intatta immaginaria immaginata impercorsa · solo che stavolta · si allunga ancora più in là · segue il corso degli imperi · quest’impero del sonno · questa lana verde e dorata · che i tuoi occhi azzurri che la tua pelle rossa · amavan tanto · non si è mai destata · il grande sonno · nella luce di sorbetto della sicilia · non c’è mai stato · ma puoi trovarlo qui · nelle pieghe grasse e antiche · imberbi · nell’ombra di pioppi sulle nostre guance · ed ora · nel bianco scheggiato · di questi campi scoscesi scosciati indecenti · east of nowhere · da qui · siamo sempre dovuti fuggire · fuggire dalla terra ma l’argilla · ci rimane sulla pelle · puoi annusarla · nello sguardo sbarrato e spento nell’accento greve su ogni pezzo di carta dell’impero · ai confini dell’impero · noi ci siamo per statuto · dimenticati nella norma · con la nostra malinconia la nostra fatica cupa e muta · chiusi come le nostre valli · il limite ce lo portiamo in bocca · in questa lingua che non conosco · ma il cui retrogusto · persiste · è il vinello dei poveri · la nostra rassegnazione · è istituzione · la portiamo scritta · nel nome · nella dimenticanza · questa terra che non sappiamo lavare · ibridi inutili marginali · nessuno · ci ha mai · accolti · e qui · non abbiamo spazio
Alessandro Assiri
Alessandro Assiri, nato a Bologna il 24/07/1962, da molti anni residente in Trentino. Presente in diverse antologie poetiche, ha pubblicato per Aletti Editore "Morgana e le nuvole" e "Il giardino dei pensieri recisi", con la prefazione di Paolo Ruffilli. Per Lieto Colle "Modulazione dell'empietà", con prefazione Alberto Mori. In uscita sempre per Lieto Colle "quaderni dell'impostura"con la prefazione di Chiara de Luca.
Collabora con riviste sia cartacee che telematiche.
Alessandro Assiri: Nota teorica, Poesie edite e inedite
Credo che ogni parola oggi sia principalmente parola contaminata e che compito del dire poetico sia il ricondurre al tentativo di accasarsi in un senso . La cultura dell'accelerazione ci fa credere sia necessario evacuare emozioni, espellere da sé, quasi fosse una cultura del rigetto, l'imperativo di far spazio non per produrre significati, ma per introdurre speculazioni inservibili In questo scenario, la parola poetica diventa oggetto da smaltire, perdendo per strada la primaria funzione di essere destinata all'ascolto.Fondamentale è prendere atto che in questa riconsiderazione del reale il pensiero è come costretto a pensare l'irrimediabile, frantumando l'intimità in schegge di malessere che diventa necessario catarticamente rigettare per sopravvivere, ma dire per non soccombere esaspera la parola facendola scadere in un grido che non dice che non chiede altro che aiuto.
Sembra che oggi sia diventato comprensibile solo diffondere o preservare, senza prestare attenzione a quale sia l'oggetto da difendere, a quale sia la merce che a ogni costo deve essere commercializzata. Ritengo che il poeta sia chiamato a cercare, oggi più che mai, di ritrovare autenticità, senza dimenticare che autenticità è darsi la possibilità di rintracciare il
percorso delle proprie idee.
Riportare la poesia all'ascolto, riportarla dove non arriva semplicemente perché non parte, perché perde di vista quel prerequisito che è quello di essere udibile. Ritrovarsi come bambini stupiti e non come orfani impauriti davanti a un testo è attribuire un senso chiamato: meraviglia. Ricondurre la
poesia allo stupore della rivelazione improvvisa è darsi in questo tempo una possibilità di riscatto.
Poesie inedite
1
Soltanto parla
ma è già senza vita
poco prima di essere abbattuto
un pensiero finalmente
2
...e a te che ti ricordi non riesco
mica a dire: sopravvivi
ma solo a tenere quel tono
scortese
adesso che l'attesa
rimarrà in eterno
sono solo sei scrupoli senza
senso
3
incontri improvvisi
per l'appunto
come amori tra l'asfalto
in imbarazzo
attieniti all'amore
luogo geometrico
di rapporti sciolti
Da “Modulazioni dell’empietà”, Lietocolle
2.
Accarezzai l'idea
molto prima del tuo viso
Misi da parte la velocità
di una vita invadente.
Scrissi la trama di un addio
con parole di niente.
15.
Le discese troppo corte
per sciogliere l’affanno,
assorbendo gli odori
di ruggine e polvere.
C’è sempre una parola
che respira in tutte le altre
come il bacio di una madre
prima di dormire
una carezza leggera che sazia la notte.
C’è sempre un segno verso la fine
una ruga profonda che ieri non c’era
una rondine che si appresta a partire
nell’accorciarsi di luce
della stagione finita.
18.
Io sono un incerto addio
Tutte le turbe dell'espulso
I malori del rigetto
Qualche acuto tenta di levarsi
Forse qualcuno vuole primeggiare
li riporto a un brusio
a un sommesso chiacchierare
se vivessi di spalle camminerei all'indietro
verso l'anonimato
un paio di spalle larghe
sovraccariche di vita
che si incurvano sotto un peso
una fatica.
Luigi Trucillo
Luigi Trucillo è nato a Napoli nel 1955. Ha pubblicato Navicelle, Cronopio, 1995, Carta mediterranea, Donzelli, 1997, Polveri, Cronopio, 1998, Le amorose, Quodlibet, 2004, Lezione di tenebra, Cronopio, 2007. Una scelta delle sue poesie è apparsa in Germania, sulla rivista Akzente.
Luigi Trucillo: Nota teorica e poesie inedite
Sono sempre stato attratto dalla sintesi, il repentino processo attraverso cui il mondo ci si dà. Così mi è sembrato naturale tentare di creare con i miei versi una più complessa sintesi derivata dalla contrapposizione dell'elemento percettivo con quello analogico e astratto.
All'inizio della mia ricerca poetica, quando cercavo uno spessore allusivo della singola parola che attraverso la precisione arricchisse di significati l'essenzialità del verso, mi sono imbattuto in una definizione di Ezra Pound dell'Imagismo che per me è stata fondamentale. "Un'immagine - diceva - è ciò che rappresenta un complesso intellettuale ed emotivo in un istante di tempo." La fulmineità del potere evocativo della parola poetica adombrata in questa frase, e l'istantanea liberazione dalle barriere spazio-temporali ad essa inerente mi sono subito balzate agli occhi, convogliando i miei sforzi sull'elaborazione di un'immagine non astratta, immediata e frutto dell'intuizione. E quindi, per deduzione, su un'immagine attraversata dall'irradiamento preciso della brevità.
Con coerenza intellettuale, inseguendo una forma visiva e immediata in cui un oggetto esteriore riuscisse a saettare in un movimento soggettivo, Pound si era avvicinato alla "poesia di una sola immagine" dell'haiku orientale, e cioè a quella cristallizzazione di sintesi sensibili che tanto mi affascinava anche da un punto di vista epistemologico. Ciò mi ha inevitabilmente condotto a uno studio dell'ideogramma cinese. Val la pena di ricordare che i primi ideogrammi nacquero come imitazione dei segni che comparivano sui gusci di tartaruga. L'ideogramma veniva quindi immaginato come il prodotto dell'autoscrittura di un cosmo che si rivelava in figure. Nasce così l'dea della scrittura come calligrafia: il poeta deve immedesimarsi nel soffio nascosto delle cose, essere in consonanza con la vibrazione invisibile che le sostiene, per manifestare poi questo contatto in una calligrafia che non rappresenti il soffio stesso, ma direttamente lo divenga. Ciò crea una parola-figura che coglie l'istante in cui significante, significato e referente sono tutt'uno. Il senso ultimo di questa parola-figura non va individuato nel contenuto, ma coincide con la materia significante (il col,ore dell'inchiostro, per esempio, o lo specifico tratto calligrafico: istanti in cui il cosmo si rivela segno di se stesso).
Qui si può solo accennare come la nascita del nostro alfabeto occidentale, quello greco che sviluppava il sillabario fenicio, isolò le vocali per trascrivere meglio la poesia epica (fondata proprio sulla scansione delle vocali) che veniva vista come voce della verità. In Occidente la scrittura appare subito, quindi, come trascrizione di una verità che si manifesta al di fuori della scrittura stessa. Da ciò deriva che la scrittura si manifesta come un sistema di differenze tra la verità e il discorso dove non è mai possibile una coincidenza tra il soggetto pensante e l'oggetto pensato. In poche parole, come un'interpretazione deviata.
Queste le coordinate. Poetare la sensazione e non il termine astratto: ecco il suggerimento di un ideogramma che anche in Occidente può essere riformulato attraverso delle nuove sintesi sensibili. È facile comprendere quanto la strada orientale aperta da Pound nella sua fase imagista contenesse già in sé la poetica germinale dell'stante creativo poi sviluppata, ad esempio, da René Char. L'ipotesi di un'immagine non stazionaria che smuovesse la centralità dell'io lirico ha convogliato la mia ricerca poetica facendola sfociare nei paradigmi della tradizione orientale: l'irradiazione, la condensazione, la ricerca dell'implicito, il contrappunto con il vuoto, la risonanza sensibile, l'immanenza sorgiva. E soprattutto la brevità.
Una poetica in cui "lo spirito aderisca all'atto nel momento del suo presentarsi" (Char) è necessariamente fondata sulla brevità. Che potrei definire come una formulazione direttamente pensata dalla lingua. Ma è anche basata sulla sensibilità, intesa come spazio della risonanza tra significato e significante, tastiera invisibile che attraverso lo stimolo delle allusioni decifra ed evoca l'inarticolato. Nella stesura dei miei versi è sempre presente il fantasma di un ascolto, proprio perché considero la sensibilità uno stato di percezione linguistica rivolta ad afferrare nel ritardo (penso al ritmo di Barthes) un'esperienza vissuta dei segni.
Attraverso la propria potenza di spostamento la brevità focalizza: restringe cioè il campo d'azione del linguaggio in un dettaglio istantaneo carico di aura che condensa l'eccedenza dei significati rispetto al singolo significante. Il tentativo di alludere a questa zona "bianca", all'irradiazione delle potenzialità non ancora formulate del linguaggio, si esprime con evidenza nei miei primi tre libri. La ricerca tuttavia di una versificazione più ampia a partire da Le amorose non coincide con l'abbandono di una tematica della brevità, convinto, come ho scritto, che "breve è ciò che, staccato, rivela una lunghezza." E cioè che la forza abbreviativa possiede una propria intrinseca autonomia. Attraverso l'essenzialità ho voluto rivelare come anche nel formularsi della rappresentazione si annidino cellule e schegge linguistiche capaci di isolarsi in un processo di autocondensazione. Anche nel fitto di un tessuto più disteso la singola parola può alludere a uno spostamento che apre un passaggio verso una presenza cognitiva primaria, l'apparizione di una risonanza sensibile che dilata il proprio effetto.
Sestante
Come un nume esiliato
Qui
nasce dall'angolo
stellato.
Avanzamento
Nuvole,
come un esempio di passi
ventosi.
Lo straniero
Un favo trasparente
carico di api
e miele.
Jaipur, monaco su un torrione
Cercava con lo sguardo
il giaciglio dei venti,
là dove si deposita
l'intuito.
Napoli, molo di Mergellina
Celeste la dieta
di chi impara
a cibarsi di mare
come un alga.
Palermo, bambino che sbeffeggia
L'asprezza
di una mora
su un fiocco
di bambagia.
Donna dall'ortolano
Nel folto dell'aria
la sua espressione incerta
e il rosmarino
profumano
come un unico
mestiere.
I sandali
Aperti
come i freschi sconcerti
infantili.
La bitta
Sui vecchi moli
con che puntiglio trattiene
zitta zitta
l'orizzonte sbiadito,
il celeste che slitta.
Vienna, giardini dello Steinhof
Preziosa è l'immagine
di un cane
quando dei denti
azzannano.
Heimat
Soffio
d'embrione,
la mia Atlantide
in punta di piedi.Sebastiano Aglieco
Sebastiano Aglieco è nato a Sortino (Siracusa) il 29 gennaio 1961. Vive a Monza dove insegna nella scuola elementare. Ha fondato “Teatro Naturale”, un’associazione per l’espressività dell’infanzia e dell’adolescenza.È autore di diverse raccolte poetiche, tra cui citiamo Dolore della casa (Il Ponte del Sale, Rovigo, 2006) e Giornata (presentazione di Milo De Angelis, Edizioni La Vita Felice, Milano, 2003). Vincitore nel 2004 del Premio “Montale Europa”. Interventi sulla poesia e inediti sono apparsi su varie riviste e in pubblicazioni collettive.
Dirige il blog “Radici delle isole”. È redattore del semestrale «La Mosca di Milano».
Sebastiano Aglieco: Nota teorica e poesie edite e inedite
La responsabilità della scrittura
Quando incominciamo a scrivere cerchiamo una voce che ci assomiglia; parole che abbiamo sentito e dalle quali vogliamo ricominciare. Questo è il primo contatto con i maestri, nella vicinanza o nella distanza dai loro scritti e dal loro insegnamento: distanza attraverso i libri, vicinanza nel sogno che ricostruisce e trasforma le parole in altri sogni.
Fare poesia, dunque, è l'atto collettivo del percepire e dell'essere percepiti, del
chiedere e del dare conto; ricompensa o abiura non importa. E' la parola come sacrificio, cioè tramite del rendere possibile; dell'alzare il velo dell'apparenza che abitiamo.
Se la poesia è, in fondo, un dialogo col Nulla, con la natura deperibile delle parole e delle cose, essa deve prima attraversare l’umanità tutta, non c’è scampo. Forse è in questo attraversamento che si logora e nello stesso tempo si rende necessaria. Da questo punto di vista, dunque, non si scrive per narcisismo - è pura illusione - ma per attraversarsi. Attraversare il mondo.
Sento sempre di più questa necessità del ricevere attestazione e conferma; scrivere poesie presuppone il gesto della consegna, che è dono nella gratuità, e investe il lettore di un compito. Il lettore è colui che prende visione dei segni incisi, graffiati - questo vuol dire letteratura nella sua accezione etimologica - e se ne fa carico. Egli, tradendo il testo, consegna la tradizione del testo; ne permette il passaggio, il giudizio, nei tribunali della Storia. Il testo si fa giudicare.
La letteratura desidera ritornare a una sua concretezza. Desidera le cose reali, consegnate ai segni, all’immagine astratta dei segni. Questo desiderio non è più, s’intende, materia e carne delle cose, ma il nostos, la nostalgia di un ritorno impossibile. La condizione più naturale della scrittura, dunque, non è la scrivania, il salotto buono, e neanche il computer. La scrittura è ancora atto del graffiare sulla materia sensibile, dello sporcarsi le mani nei segni e disegni incisi nel grande libro dove la foglia è il foglio sono la stessa cosa.
La scrittura è transeunte: permette il passaggio e non rimane, ma rivive, nell'urgenza del nostro tempo, del nostro essere qui, ora.
Se è vero che ogni cosa, mentre vive contemporaneamente muore, la poesia non si sottrae a questo tragico destino e accetta di essere traccia cancellabile e labile. Ma non può rinunciare alla sua necessità, alla sua ineluttabilità: che non è ricerca di nuovo senso – sempre le foglie, noiosamente, cadono e rinascono – ma necessità del suo ruolo.
Ecco perché, a un certo punto, non servono più i maestri, non serve più la letteratura. Scrivere poesie è un gesto che improvvisamente ci lascia soli, nudi di fronte alle cose, agli altri, a noi stessi. Davanti al compito del dire senza gioco, inganno, ma con gli occhi puntati addosso.
Ho scritto libri senza necessariamente pensare a questo. Ma per presagio. Poi ho capito questo dalla lettura che gli altri hanno fatto dei miei libri. Lettore, ipocrita lettore, fratello.
Da La tua voce, inedito
All’insaputa della notte
quel fumo rappreso sul davanzale
portava i canti delle falene morte
il masso sospeso sulle teste
a ricordargli della fine
il primo villaggio
lo strato più intimo sotto
il taglio del lago.
Tu non conosci la pietra
e il segno di quella mano che
rovina nell’attesa.
Dietro le nostre sere, di
una piazza scolpita nelle parole
scivolata ancora più lontana
acerba nei ricordi dei poeti
- perché non sono mai stato come voi
perché non vi ho mai conosciuti
perché non mi siete mai appartenuti -.
Viscida, schifosa nella luce
mostrata veramente come la cena
della sera, qui, nel cerchio, e
consolato dalla durezza
estraggono a sorte, spaventano una
voce aprendola alla Storia.
Così disse, così rivide quello che
non aveva mai veduto, il ramo del
pianto, secco, l’indurita sentenza dei
poeti, questo sei tu, luce
inappagata, ombra rifranta.
Da Giornata, La Vita felice 2003
Tu non ridere di questo sconforto,
della pazienza persa, dei visi che mi
guardano e se ne vanno. Numi tutelari
hanno tracciato strade verso un silenzio
di ritorno, verso un niente che ritaglia gli occhi.
Non voglio più scrivere poesie;
da queste parole in vedetta
ci sarà il tempo di perdere tutto
il resto, tutto il niente che
non abbiamo ancora visto, tutto il
niente che non abbiamo ancora detto.
*
Terra incominciata, sei apparsa verso
sera in mezzo alle parole ed è finito
il mare. Il viaggio si ritrae per altri
anni, ma ora dobbiamo stare, finire il
lavoro che abbiamo incominciato.
Voglio parole in me, senza la musa
oscura che mi ha generato, senza la luce
dell'angelo. Omettere quell'oscuro presagio:
sulla soglia della casa ti perderai.
*
Esiste un ordine e un tempo,
cerco questo in questo tempo:
macerie all'inizio della Storia
un bambino prima di essere bambino.
Guarda cos'è stato il giorno
nelle ore della pioggia: qualcosa è
accaduto e ci siamo già dimenticati.
Esiste il finire di un luogo
l'imparare a morire come all'inizio.
*
Perdonami, non sono all’altezza,
non so dove andare.
Eppure devi restare
devi sorgere dalle lenzuola
devi capire, nell’amaranto delle fragole,
il sangue del crocifisso che ci schizzò in faccia,
ricordi? in quella scena dell’infanzia.
Avremmo dovuto distruggerlo per quella nostra
promessa, trapassare i suoi occhi come nei sogni
fondare una parola che dicesse il dolore
che valesse per sempre.
Ma ora dobbiamo restare
ora che la distanza è netta
ora che ci giudicano e
non accettiamo il giudizio
non vogliamo essere degli altri
come gli altri.
*
Allora qualcuno capisce che tutto è sbagliato
che le parole ci hanno ingannati,
uscendo da una gora
o forse semplicemente volevano dire
che non ci apparteniamo.
Sulla carta il pensiero è violento
calma simulata
fiato trattenuto per non ingoiare il mondo
contenuto, è ingannato dalle forme
per dirle ci separa, ci fa scannare.
*
Scrivo nel lampo che il fiore imprime in me
preceduto dal respiro e dalla calligrafia.
Allora è il vento che mi respira , fratello,
incredulo di un ascolto che a tratti mi governa.
Non c’è più tempo per l’armamentario di
me e della vita mia.
*
NERO SEPPIA
In questo paesaggio
rimangono due mani che vangano la terra
un albero gira ed è tutta la preghiera.
Vorrei essere semplice nel dire
come questo tuo parlare senza colore
l’inizio del segno, o solo la sua conclusione.
Gli uomini sono nel mezzo.
Qualcuno si è allontanato e
ci ha lasciati soli
i poeti rimangono in un cappotto
sono attenti, nella distanza delle mani.
Chi è necessario dice ciò che resta
e non vuole niente.
*
Occhi appena detti nella veglia
liberarsi dall’incanto della neve
delle figure che tornano e pretendono.
Non c’è niente che ci renda felici
non esiste un canto per onorare tutti:
i morti che ci hanno preceduti
i vivi che ci hanno accompagnati.
Chiudere le porte. Ora basta.
Ma i bambini, i bambini in un’aula dove
un mondo è possibile, dove i debiti
saranno rimessi, i bambini che insorgono e
ci chiedono di spiegare il dolore del mondo!
*
Di questo non voglio niente
della casa e del rito degli affetti
delle contese e della storia in un luogo
dove tutti vivono
della chiarezza che pago a peso d’oro.
Costruisco ogni volta un senso coi bambini
li porto a guardare
ciò che saranno e in parte accetteranno:
sciocchezze, riti dello stare e del perdersi.
Di questo non voglio niente
il mondo si ferma e ride di me
o in un sogno reciproco ci desideriamo.
*
Ora sei il poema di me
vita finalmente libera
sei questo pensiero che ho sognato in segreto
il più debole e puro
che non ho realizzato:
essere prova di sé
nell’inganno del mondo
o nella sua salvezza
nei corpi che chiedono ristoro
nelle menti che desiderano una cosa.
Ma questo non sarà possibile
e niente sarà privo di dolore.
“Qui ingannati si sta bene” *
ma un po’ lontano io resto
in una casa protetta dal contegno
mura coatte, distacco e pavimento
un po’ in voi e un po’ ancora
in questa terra dove fallire è una vittoria.
*
Ma una parola nuova è solo una promessa
sospetto un inizio senza conclusioni
per lento soffocamento della parola,
una visione che a malapena prende forma.
Né sguardo, né bellezza
ma solo un vento che cancella e poi ritorna.
*
Io sono felice nell’estate forte
senza respiro
senza visione delle cose
senza il tempo della fatica
che chiede di essere onorata.
Un fermo confine
mostra la separazione
per preparare la preghiera.
Dio della voce ora calmaci
calmaci e custodiscici
dal vero nemico celato nelle parole.
Potenza delle azioni
che liberano e ci salvano:
“non voglio essere amato
voglio amare”.
*
Sei adesso
quello che nessuno dice e non ricordi.
Un baule di poesie sarà lanciato in un pozzo
verso una luce contraria.
Il viaggio è duro e finisce con un’asta
appartenuti a carne trattenuta
(neanche nostra).
Ci attende un fallimento
e le parole ci bruciano
una mano le sotterra
i versi anelano a una prosa chiara e limpida
ma è ciò che chiamiamo
"lotta dura e persa".
Appartenere:
solo questo ha senso
solo a questo passaggio senza senso.
*
Io non voglio niente
di tutto questo non voglio niente.
Nella casa l’odore dei gatti e di una cena
distante il cuore, è più forte ciò che preme.
Ma occorre imparare che
sono quello che non credono e non perdonano
sono una mente sotterrata e palpitante.
Da Dolore della casa, Il ponte del sale 2006
Ma questo sarà detto e
giustificato davanti al tuo dio
nell’incedere del tempo.
Queste parole che consumiamo
saranno pesate e disperate
e daranno tempo per tempo
pezzi di carne per un nuovo universo.
Ci sarà ancora il dolore
ci sarà l’attesa e un forte risentimento
le anime di nuovo dietro tutte le nostre parole.
*
UNA SERA HO PRESO LA BELLEZZA
Ora finalmente ti devo lasciare
devo imparare a dire
da questo distacco della
terra — il sole è giallo.
Nella mia carne ti riconosco e saluto
la bellezza che appassisce, ti
sacrifico le mie ultime parole e
non ti servo.
Muore chi deve morire
uccidimi, se vuoi, nell’ora dei vivi
colpiscimi con forza sul punto più alto
della testa, fallo nella piena luce
senza l’ombra delle parole
rinuncio a qualsiasi salvezza
a qualsiasi perdizione.
*
OLTRE IL GIARDINO
Tutto duro, di qua o di là
da una preghiera tra lo steccato e il
pane — movimento di un muro
crollerà l’universo sulle mie ossa e
rideranno di me questi piccoli capi
asserviti al potere di una scrivania.
Cerca il senso dove c’è stupore, e onore
impara che la morte è promessa
nel destino di tutti gli occhi. E allora
non temere le insegne del potere
e quando ti dicono: rinuncia
scendi a patti, accetta la perdita
dell’innocenza, abiura l’ingenuità
non fare l’offeso
accetta questo mondo o vattene.
*
AVVISAGLIE
Ma tu sei questo, questo soltanto
osso ben piantato nel cuore del mondo
e nella mia testa, nella visione di un mondo.
Accetta il colpire per dovere
- l’essere colpiti per dovere.
Ripeterò nella testa ciò che è taciuto
sotterrerò la pietà dei vivi per necessità.
Fuori: attesa e respiro
il racconto del mondo.
*
TI SARAI SVEGLIATO
Mettersi gli occhiali, guardare bene
per non sprecare le parole.
Ma il male è nelle parole che
vogliono dire il mondo e lo confondono
nelle parole che colmano una voce
sottratta per forza alla sua calma.
Accetta, allora, una breve bellezza
non cercata, sguardo indifferente
nelle cose incustodite.
Custodiscile finché non avranno
timore, indica la strada della loro
disillusione quando le luci, infine, verranno
accese e saremo liberati dal sonno.
*
CITTA’ NOTTURNE
Ti guardo e non parlo.
Era il dolore nei sogni antichi
erano i paesaggi notturni
del mio brancolare senza ali
altezza della fatica
nei pensieri segreti.
Erano città notturne incustodite e
vive, lasciate dagli uomini
assenti, in un altro luogo.
Una luce, questo ricordo
un battesimo di stelle che
chiedono l’ascolto di una voce.
Se scrivo di me, per me, è per tutti
perché non vi conosco, perché non
mi conoscete, come in tutti.
*
PICCOLA TREGUA
I
Ecco, ora hai finito di scrivere, hai ritagliato un
senso, scagionandolo da queste menti
c’è un tempo che sa accoglierci, più mansueto.
Poche immagini per dire ancora: casa
giardino, steccato. O per fermarti
difenderti dalle nuove migrazioni.
Alberi frontali, sentinelle di un cielo
sereno hanno una giustizia per tutti.
Qui siamo al sicuro
il vento di ponente non passerà.
II
Léggere, senza dolore, le immagini degli
alberi, le pietre miliari, le infinite
partizioni. I visi ci precedono nella corsa dei
fiumi — cammino nella campagna, appena
toccato dall’acqua scura.
Parlavi del nulla, delle parole sottratte al
timore delle foglie; guarda, sono calme
dicevi, la tempesta non si alzerà
gli argini sono alti, serrati.Tommaso Lisa
Tommaso Lisa (Firenze, 1977). Esordisce in Nodo sottile 2 (Fiesole, Cadmo, 2002) e nell’antologia Ottavo quaderno di poesia italiana contemporanea (a cura di Franco Buffoni, Milano, Marcos y Marcos, 2004), pubblicando poi, in volume, Pornopoemi (Arezzo, Zona, 2004 con allegato CD del gruppo fonografico Rapsodi) e rebis.periferiche (Pordenone, Old Europa Cafe, 2005 + CD reset) realizzato in collaborazione con l’ingegnere del suono Bad Sector (di prossima uscita i due libri-oggetto periferiche/terminali + emulazioni/appercezioni). Nel 2006 è uscito il canzoniere a sei mani Trilorgìa (Arezzo, Zona) scritto con Lorenzo Durante e Federico Scaramuccia ed è stato incluso - con Postreme. Cronache del quinquennio 2001-2005 - nell’antologia Poesia del dissenso II. Dopo aver coordinato la rivista letteraria “L’Apostrofo” (Firenze, Chegai, 2001-2004) ha diretto, insieme ad Alessandro Raveggi, il progetto editoriale “Re;” (www.re-vista.org). Dottore di ricerca in lettere, tra le altre sue pubblicazioni critiche: Scritture del riconoscimento. Su ora serrata retinae di Valerio Magrelli (Roma, Bulzoni, 2004); Poetiche contemporanee. Colloqui con dieci poeti (Arezzo, Zona, 2006); Pretesti ecfrastici. Edoardo Sanguineti e alcuni artisti italiani. Con un’intervista inedita (a cura di Tommaso Lisa, Firenze, SEF, 2004); Le poetiche dell’oggetto: da Luciano Anceschi ai Novissimi. Linee evolutive di un’istituzione della poesia del Novecento (Firenze, FUP, 2007). Suoi testi e saggi sono uscite in rivista (“Atelier”, “Nuovi Argomenti”, “Semicerchio”, “Trame” e “il verri”, dove ha curato i numeri 31 e 32 dedicati a I diari di Luciano Anceschi) e su alcuni siti (AbsolutePoetry).Tommaso Lisa: Reset (doppio set di sette settine)
Reset
(doppio set di sette settine)da istmi appaiono le isole
tra uffici e docks del porto
sull’orizzonte a giorno
cereo scolora il cielo
e oil terminal al vento
cloro e piscine e radar
in nebbia che dirada
a strisce flesse e fratte
per l’irritante sole
fra terre di riporto
i cartelli nel giorno
curvano l’oltrecielo
argentei dentro il vento
colloso sottovento
in tornanti digrada
l’asfalto e ferme effratte
scontrate sotto al sole
le auto verso il porto
occultano nel giorno
lunotti sotto al cielo
gli eurofighter in cielo
sibilano nel vento
in formazione rada
su necropoli e fratte
e off-shore scagliano al sole
tra scafi da diporto
sponsor in gare a giorno
tra crisofite il giorno
dirada gonfi in cielo
cumulonembi al vento
sopra la steppa brada
degli slum catafratte
dalle lenti da sole
dei militari al porto
jeep coi tanks di supporto
a guerre d’oggi giorno
antenne verso il cielo
e rondini nel vento
in trame di contrada
graffitate a spray fratte
le firme vuote sole
crew di skaters al sole
bassifondi del porto
il traffico ogni giorno
di fusoliere in cielo
tra voci chiocce al vento
sottomarini in rada
dighe foranee fratte
tessuto arato a sbalzi
dalle robinie brulle
le involute sui colli
righe dei campi dietro
le postazioni a parte
lo sfondo al cielo immoto
zigzagare di moto
smog imbrunito e fosco
grigioferroso a balzi
di selve ingenti brulle
balle irte mucchi e colli
sopra i piazzali dietro
ad un tir che riparte
da altoparlanti a parte
suona un jingle remoto
e ambulanze nel fosco
pulvirulento in sbalzi
sirene bluastre brulle
zone e zombie tracolli
luminescenti dietro
insegne police dietro
a volanti appartate
e pattuglie di moto
tra le rinfuse e il fosco
inseguendo a sobbalzi
contrabbandieri in brulle
dune aride e tracolli
turbinano in decolli
gli elicotteri dietro
alla stazione in parte
rotta dal terremoto
sventaglianti nel fosco
saracinesche a balzi
per bonifiche brulle
frastornate le brulle
spiagge e i mugli sui colli
dal night-club chiuso dietro
gli ombrelloni in disparte
gialli gommoni in moto
con scafisti nel fosco
solcano il mare a sbalzi
grigi i gabbiani a balzi
planano in rocce brulle
guano burrasche crolli
di infrastrutture dietro
le impure scorie sparte
e un aerostato immoto
staziona in cielo fosco
scuotono in scrosci al suolo
in porpora e oro fine
i dipluri dai rami
di stecchite piante oltre
basi nucleari scisso
tra scie di cirrostrati
in molteplici strati
slabbrati e cupe reti
arso il crettato suolo
in crepe e ghiaie e fine
l’intricarsi di rami
dal cimitero oltre
l’isolato rescisso
vira in verdeblu scisso
per alcali e acidi a strati
il cr 6+ in greti
su orti e banchine al suolo
nascoste dalla fine
stria di ossidati rami
cola in sintesi oltre
avariate scorie in coltre
viscosa viola scisso
vitreo il brago a strati
tumescenti e arboreti
diramano sul suolo
vibrando in modo affine
versicolori rami
tra i tetti di ferrami
sparsi su sponde oltre
spurî cascami scisso
e idistinto su strati
celle e rulli di reti
di fabbriche sul suolo
il laminato fine
e il pretrattato a fine
lavorazione in rami
d’assemblaggi posti oltre
questo increspato e scisso
susseguirsi di strati
tra gli impianti segreti
si ritorce sul suolo
in magazzini e al suolo
il fango e scoria fine
tra gru e putrelle e rami
in architetture oltre
rilieva un reale scisso
dai polimeri a strati
nelle invasive reti
antri e alti altari tra anse
di database in diedri
settori e scansiti echi
elementari il tetro
nero circuito d’oro
ricalca un suono muto
scuro orrido spremuto
tra relé in ombra sbanda
driver dischi di danze
irti attrattori e diedri
dentro campionati echi
stampati in stretto tetro
flusso colore al fluoro
in card suonano in coro
le tracciature e muto
a alto voltaggio blanda-
mente rapprende astri e anse
in brevi brusii e diedri
foreste in suoni in spechi
deframmentando tetro
solchi e sorgenti al tetro
spandersi di ioni in oro
circuitato il premuto
tasto onde contrabbanda
triggerazioni oltre anse
e i resti di poliedri
bisbigli al plasma echi
nei video-tape altri echi
dal desktop dentro il tetro
siliceo spettro d’oro
di sinapsi ago muto
per celle in larga banda
tra arborescenti anse
pulsa oltre orli e diedri
in set suddetti i diedri
dentro agli espansi echi
rudi i rumori e il tetro
spunto di selce e cloro
rossastro nel bismuto
clonando in sarabanda
cavi coassiali in stanze
tubi al neon tiltati e anse
trasformatori in diedri
dilatati in micro echi
masse blu in buio tetro
cristalli e astri in atro oro
dentro dendriti muto
sistri e settori in banda
di residence tra cose
formicolanti in varie
strade e curve nel terso
proliferare in giro
confondendo la spoglia
cifra di skyline e murmuri
di tv accese e muri
azzurrati la luce
si sgrana tra le cose
disposte in pose varie
dentro uno schermo terso
pixel slot bite a giro
nella silicea spoglia
delle schede si spoglia
in camera tra i muri
e gli armadi la luce
che staglia fioche cose
messe nel frigo varie
cogliendo il filo terso
dei contorni nel giro
di oggetti sparsi a giro
in una stanza spoglia
tra le muffe sui muri
vividi prismi in luce
allungano ombre e cose
in parabole e varie
insegne al neon deterso
dal temporale il terso
orizzonte in un giro
chiude una terra spoglia
con i pod dietro i muri
recintati nella luce
leucemica viscose
dai sensori in avarie
di strumentazioni varie
tracce di radon terso
odore acre in giro
di diossina che spoglia
fulvi i rovi sui muri
in crepuscoli e luce
riverberata in cose
mutate vorticose
accatastate e varie
stilla rugiade il terso
filo spinato in giro
sui gates veste e spoglia
la calce sopra i muri
di shelter calda luce
dai telescopi ai lati
cupole chiare a scacchi
di osservatorî in gusci
proiettano strie e file
sui dossi dietro i monti
cittadine nel verde
e l’afa d’ocraverde
secca asfittica in spire
sparge le nubi ai lati
di caseggiati a scacchi
miriapodi tra i gusci
dei cassonetti in file
attorniano i tramonti
lattiginosi i monti
rigati in grigio-verde
e i resti tra le spine
di ferri affastellati
gas acidi in scaracchi
sotto i fari tra gusci
effervescenti in file
le cave vuote e file
di atri teatri di monti
la moto al cross nel verde
che sgomma torba in spire
truce stremata ai lati
dietro recinti a spacchi
nella melma che sguscia
ai bordi chiuse in gusci
celesti luci in file
sulle piste oltre i monti
scandite in luce verde
tra gli infrarossi e spie
le scritte nato ai lati
su derive alte a scacchi
arbusti e luci e stacchi
e romboedrici gusci
nel buio fredde file
di radar sopra i monti
dove la terra e il verde
increspano luci di spie
soldati posti ai lati
e in cielo decollati
scintillano a scacchi
dopo rullaggi i gusci
di jet catafratti in file
i falò sopra i tramonti
barbagli in mezzo al verde
brividi e bluastre spie
siti presso una fonte
radioattiva la sera
tra punte di palme astri
riverberati dentro
al buio botro in zone
su cui stanno tra i raggi
di luna nei paraggi
elicotteri apache
posti sui pad al fronte
strati sterili a sera
e scavatori a nastri
nel giacimento dentro
i fanghi delle zone
dei derricks in azione
pozzi e gallerie a raggi
un bulldozer capace
che sta sbancando il fronte
tra gli hangar una serra
e i bunker su pilastri
e tubazioni dentro
flares di torce da dentro
gli oleodotti zone
con i monitoraggi
d’inquinanti rampe e space
frame in piste di fronte
a atterraggi di sera
di aerei-spia fra gli incastri
di barene olivastri
mucillaggini dentro
acri e salmastre zone
restano in scuri raggi
catrami senza pace
campi minati al fronte
nel caldo effetto serra
posti di blocco a sera
sotto agli infiniti astri
brillanti scorre dentro
tubi posati in zone
desertiche a raggi
il petrolio acre e pece
su rena e sabbia in fronte
a caserme la fonte
di fumi densi a sera
tra i soldati grigiastri
investe cortei dentro
mimetizzate zone
scuotendo a gruppi in raggi
bandiere della pace
frangenti azzurre i campi
anabbagliando clivi
con flash fluorescenti e albe
nel riverbero stinto
di sterpeti e improvvisi
boati e esplosioni in nubi
friniscono tra nubi
per subsonici a notte
propulsori sui campi
e incursioni dai clivi
a bassa quota in albe
rivelano uno stinto
stabilimento e avvisi
di divieti tra i visi
mimetizzati nubi
offuscano la notte
da anticarro nei campi
e batterie sui clivi
fioriti in chimiche albe
stazioni meteo stinto
appare un indistinto
scavo edile divisi
azoti ossidi nubi
booster in stadi a notte
sganciati sopra i campi
da capsule e declivi
in immagini ir albe
su autoblindo tra scialbe
traccianti nel distinto
sparire d’indivisi
bagliori ufo le nubi
s’addensano di notte
la scoria imbianca campi
smottando in cretti i clivi
benne e antenne proclivi
ai crolli autosilo in albe
sfumate in uno stinto
seguirsi di preavvisi
di rossi stop tra nubi
nel cuore della notte
e logistici campi
corazzati tra i campi
minati che dai clivi
schermano in algide albe
fioco il bagliore stinto
di contraeree invisibili
missili tra le nubi
mentre scende notte
guerre urbane nel fondo
di vie i blindati e celle
l’assetto a scudo ferma
spari a salve fra i pali
registrazioni a chiazze
e interferenze radio
rumore della radio
risuona tra le carte
dei giornali lo sfondo
in vetrine e asticelle
di ponteggi che fermano
calcestruzzi coi pali
su attici i fiori a chiazze
nella scarpata chiazze
bruciate e brulle a gradi o
distributori e carte
il suburbio profondo
compresso tra le celle
di campo resta ferma
l’ira che svelle i pali
viali auto antenne pali
squatters in gruppi a chiazze
la mattina alla radio
la città è insonne e scarti
di graffiti fan sfondo
a un bus sotto facelle
che al supermarket ferma
intirizzita ferma
gente in quartieri e i pali
tensostrutture a chiazze
negli showroom le radio
tra i tendaggi e le carte
la pattuglia di sfondo
stornata da procelle
black-block chiusi in celle
la polizia che ferma
corduli infranti e pali
manganellando a chiazze
news di g8 alla radio
l’estintore tra carte
un morto cade in fondo
coi no-global a sfondo
pestaggi nelle celle
simmetriche aria ferma
il siderurgico i pali
campetti stenti a chiazze
impianti e raggi radio
per spente prese scart
dietro i palazzi in centro
un autobus che arriva
schiacciando cose a terra
carte e bottiglie rotte
ventoso alza una veste
nei viluppi del flusso
d’aria spinto nel flusso
che oscura sotto al velo
il cosmo senza centro
tecnici sulla riva
scavano nella terra
tra cavi e linee rotte
fluorescente la veste
antinfortuni investe
le file in mezzo al flusso
dei fari dentro il velo
di smog in vie del centro
e i rifiuti sulla riva
dal mare spinti a terra
tra le alghe e cose rotte
avariate e corrotte
tra gli inquinanti investe
il mutevole flusso
di merci quasi un velo
che stringe al centro
il black hawk in deriva
che svisa e scende e atterra
e la scura scia a terra
rintracia rette e rotte
tra casse e scatole e investe
l’ipermarket nel flusso
delle merci in un velo
di smog dal centro
si dirama verso riva
in catena corriva
tutto va sotto terra
nel gioco di ininterrotte
scene che investe
nel vento e sparge un flusso
di polverone a velo
spostando il baricentro
per i lavori del centro
il camion svolta e arriva
tra betoniere e terra
e calce in mura rotte
un alone riveste
il collidente flusso
dei versi in vacuo velo
fregate chiatte brezza
sottomarini e schiuma
chiudono ormeggi in rade
ridde di radar sparte
tra i sonar sulla sponda
missili Trident in guerra
e fra trincee di guerra
oltre torrette a schiera
Boeing stanno nella brezza
e ferri e affusti e schiuma
affastellati a rade
maglie saldate e in parte
obsolete fan sponda
fotocellule a sponda
reticoli di guerra
è vietato da schiera
spinata iridea brezza
oltrepassare schiuma
a bolle il brago in strade
tra i cumuli in disparte
sotto a stelle in parte
l’asfalto che sprofonda
per cingolati in guerra
e le uniformi a schiera
bandiere nella brezza
la mimetica schiuma
che il marrone sorrade
su insenature e rade
sfuocate nella parte
a est i palloni-sonda
lasciano scie di guerra
gli aerei-spia a schiera
stratofortess in brezza
nerastra che si sfuma
e l’acquafan la schiuma
su riviere e autostrade
le strobo si dipartono
dalla disco alla sponda
bruciata nella guerra
racket di bande a schiera
armate spari ebbrezza
sugli spiazzi la brezza
leva cinerea schiuma
stralci e tabloid abrade
rossi occhi in ogni parte
ricevono di sponda
gli effetti della guerra
in tv i morti a schiera
di raffinerie e nubi
rafferme in una forma
si addensano sui prati
tra cisti e auto in sosta
nelle pieghe del reale
un trattore spento
su zolle trite spento
ara le zolle in fumi
solchi e stridii tra nubi
rintraccianti la forma
d’opima terra ai prati
e i divieti di sosta
nell’atmosfera irreale
di alti pilastri il reale
sugli svincoli spento
il semaforo e i fumi
di tangenziali in nubi
giunture fuori forma
copertoni sui prati
rugginoso risosta
sgorga in bitumi e sposta
scoli acidi e iperreale
cumulo di coils spento
per materassi e fumi
ingrossa grasse nubi
tra assi marci che sformano
sfardellando sui prati
in lai rai dai bui prati
lucidi i led di sosta
la tradotta del reale
su di uno schermo spento
saettano i fuochi in fumi
matrici mute e nubi
protozoi in una forma
rappresi e scuri a forma
inquinanti nei prati
bifidi rami in sosta
macerati dal reale
oltre a un ammasso spento
tra le rovine e fumi
di proiettili in nubi
rosse galassie e nubi
ombre che il cosmo sforma
umide sopra i prati
scuri reparti in sosta
sul collasso del reale
e freddo frinire spento
le scene spente in fumi
rappresa i tenui fili
viscosi e scarti e resti
lavorati di vetro
in lamine e fogli e
il poliammide sparso
che cola nello stampo
le poliestere in stampo
stirato in grigia nassa
di canaline e fili
nel capannone i resti
tele screziate in vetro
lattice gomma a sfoglie
insuffla gas sparso
asettico tra le cose sparso
canceroso lo stampo
costretto dalla nassa
mixa additivi in fili
calandrati tra i resti
scure scaglie di vetro
e coadiuvanti a sfoglie
abscissione di foglie
sintetiche cosparso
si ripete lo stampo
di monomeri in nassa
craking fenoli a fili
saturi eteri e resti
addizionati in vetro
laminati di vetro
coloranti su foglie
lubrificante sparso
poliuretano in stampo
raffredda in una nassa
polivinile a fili
tra polimeri e resti
di propileni agresti
bianche schegge di vetro-
resina gonfiano foglie
stelle a spilli cosparso
termoindurenti in stampo
sulle falde la nassa
termo-processi e fili
quiete resine a fili
unici eterei resti
estrusi e orditi in vetro
negli stireni a sfoglie
e l’eposside sparso
attratto nello stampo
unito in una nassa
all’ingresso in un lampo
la pareti di casa
crettate tra le croste
l’armadio appare vuoto
e dei cd la gamma
tra poltrone coi buchi
le macchie scure e i buchi
nello specchio le cose
dal pc in rete un lampo
password violate in casa
nel salotto le croste
di pane sparse e il vuoto
cavi seriali in gamma
l’evanescente gamma
dei prodotti e coi buchi
le giacche scarpe e cose
una cerniera-lampo
vestiti smessi in casa
s’attaccano le croste
tra cibi in sotto vuoto
lenzuola e un letto vuoto
sfatto e sporco la gomma
sui mobili e nei buchi
gli shampi in bagno e cose
peli e pettini un lampo
nei corridoi di casa
equorei umori e croste
sui soffitti le croste
e dentro il frigo vuoto
dai prodotti ingromma
confezioni coi buchi
cibi in cucina e cose
su stoviglie in un lampo
gli odori della casa
nelle stanze di casa
la moquette e le croste
tra cicche spente un vuoto
lampadario che inganna
in salotto ombre e buchi
gli ombrelli luci e cose
che svampano in un lampo
di pubblicità il lampo
un jingle nella casa
con stracci e moci e croste
ha il corridoio un vuoto
Aperto sulla gamma
muta di prese e buchi
per soglie intrecci cose
Tommaso Lisa: Enchiridion (poetica)
Reset (doppio set di sette settine) è in parte già edito in rebis.periferiche (Old Europa Cafe, Pordenone, 2005) libro con allegato cd reset del musicista e ingegnere del suono Bad Sector. Il nucleo di testi si inserisce in un programma più vasto: due libri-oggetto pluriversi (leggibili indifferentemente in diverse direzioni) periferiche/terminali e emulazioni/appercezioni. Tra le motivazioni di questi testi c’è il piacere di un lavorio artigianale con le parole, imprescindibile dalla natura iconica, tipografica, del testo; una volontà di trattare i materiali verbali, assemblare le sillabe come cose per ottenere artefatti retorici, al contempo bizzarri e algidamente neoclassici. Nelle intenzioni agisce un gioco formale - esplicitato negli acrostici-omaggio - racchiuso nella struttura della “settina” di settenari. Una feticistica passione per il catalogo entomologico, la miniaturizzazione fermodellistica, l’agonistico sfoggio atletico della muscolatura del metro, l’ibridazione e la mescolanza di stili, la campionatura di quanto è reputato notevole all’interno del repertorio della letteratura universale. Un costruttivo impegno critico verso il linguaggio stesso, per ottenere uno stile, un meccanismo funzionante con regole interne coerenti e conformi. Vi agisce la necessità di assemblare citazioni dalla tradizione, lessico tecnico e letterario, situazioni reali - quotidiane e esperite - insieme a fantasie immaginarie, allucinate, frammenti mnestici e lacerti abrupti. Mappatura, disegno, alessandrina ecfrasi che spazia dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, passando attraverso molteplici soglie: dalle galassie alle strutture subatomiche, dal paesaggio all’interno domestico, dallo schermo televisivo, al chip al silicio, alla carne dell’individuo. La recitazione del testo pone in risalto l’aspetto multiversale dell’artefatto, in quanto dovrebbe risultare coerente - ugualmente significante e insignificante - la lettura sia dalla fine che dall’inizio, o da un qualsiasi punto intermedio. Il macrotesto, infatti, dovrebbe costituire un grande calligramma mandalico, disposto in cerchio, come un ouroborus, (e così sarà, non appena verranno acquisite le necessarie competenze di grafica vettoriale). Reset si propone quale miniatura documentaristica del medioevo digitale dell’inizio del nuovo millennio, sospesa – apparentemente senza storia - tra imminente catastrofe ed eterna rigenerazione. Ricetta o istruzioni per l’uso, queste note non intendono esaurire il senso potenziale dei testi: non è l’unico modo di scrivere, neppure il migliore (ne sono consapevole; mantengo infatti attive molte scrivanie, altri opifici letterari, per creare testi anche molto diversi da questi) ma è sicuramente un modo demiurgico per ricreare altre possibilità, una diversa cosmografia.
(lunedì 25 febbraio 2008, mattina)
Il “Paradiso” tradotto in francese da Jean-Charles Vegliante. Con un sonetto inedito di Yves Bonnefoy ispirato dal "Purgatorio"
Dopo “Inferno” (1996) e “Purgatorio” (1999), anche “Paradiso” è stato pubblicato in Francia (2007), sempre nella versione di Jean-Charles Vegliante. Qui viene presentato con un omaggio di Yves Bonnefoy: un sonetto inedito ispirato dal Purgatorio e tradotto da Fabio Scotto.
"Paradis" - traduzione della IV di copertina
Una pallida luna, dove - in modo provvisorio - appaiono le prime anime beate, secondo una sembianza nostra riflessa in acqua limpida, ci accoglie e familiarizza con la terza cantica del Poema sacro : la più sorprendente a vari titoli. Siamo "là 've s'appunta ogne ubi e ogne quando" (XXIX, 12), un non-luogo ineffabile che il poeta viaggiatore ha nondimeno l'incarico di transmetterci, raffigurandolo sotto delle apparenze accessibili ai nostri sensi. Forse anzi a tutti i sensi, come cercasse già di "trovare una lingua" (Rimbaud), e sarà quella degli angeli. Cosicché acceleriamo con lui, trascinati dal riso sovrumano della sua Beatrice, filiamo dietro di loro nel vortice enorme della luce, attraverso gli otto cieli dei pianeti e delle stelle, foriamo il nono cielo cristallino (primo mobile) vertiginosamente mosso dai cori angelici, su fino alla specie di eccitamento cosmico della "candida rosa" visitata senza tregua dai messaggeri dell'Amore divino, colma nella pace immutabile della vera presenza degli eletti, fuori di ogni ingenua rappresentazione. Lontano dalla pochezza di un mondo "che ci fa feroci". In mezzo a quell'empireo di quieto avvampare, ove Beatrice con tutte le altre anime ha ripreso posto, una guida ultima, san Bernardo, condurrà per finire - non senza l'intercedere della Vergine regina - alla brevissima eppur interminata contemplazione di Dio.Come per i due libri precedenti, la traduzione tenta di seguire quel continuo slancio attraverso lo spazio aperto e gli interstizi d'una lingua altra, anch'essa capace di stabile base e d'invenzioni inaudite, di variazione, di colori e ritmi regolati, di poesia per coloro i quali, leggendo, vorranno riceverne "l'onda / che si deriva perché vi s'immegli".
Il testo originario, rivisto dal traduttore sull'edizione critica del Petrocchi, è tra quelli al momento disponibili uno dei più affidabili.
Sonetto inedito di Yves Bonnefoy
Facesti come quei che va di notte...Il secouait une sorte de torche
Dont l’étrange lueur déconcertait
Ces autres qui cherchaient derrière lui
À ne pas avoir peur, le long du gouffre.
Guide, pourquoi n’as-tu, sur ton propre corps,
Rien de cette lumière que tu offres?
N’as-tu aucun besoin de percevoir
Le vide qui se creuse sous tes pas?
Mais tel est le destin de l’allégorie:
Qui parle ne pourra ni ne doit savoir
D’où vient et où s’abîme sa parole.
Son pied cherche le sol à même le vide,
Sa voix hésite et tourne dans ses mots,
Flamme de moins de rêve que sa cendre.
Copertina del libro "Paradis", Imprimerie nationale, 2007


Giovanni Raboni, frammento di recensione
(dal “Corriere della Sera” del 13 ottobre ’96)"Siamo agli antipodi della traduzione-spiegazione, della traduzione-parafrasi, che scioglie i nodi, i grumi, le oscurità delle figure e delle immagini come se le metafore fossero altrettante metastasi e il compito principale di chi traduce fosse quello sostanzialmente sanitario di guarire il testo poetico della sua poeticità per fornire al lettore, non importa se in prosa o in similversi, una sorta di replicante quanto più possibile sterilizzato, inodoro e insaporo. / Poeta prima che italianista o, per essere più precisi, italianista anche e soprattutto in quanto poeta, sebbene le sue credenziali linguistiche e filologiche siano con ogni evidenza impeccabili, Vegliante sa che una poesia o non si traduce affatto o si traduce con un'altra poesia, che non esistono soluzioni intermedie; e la sua scommessa - la via stretta nella quale ha visto, giustamente, l'unica via percorribile - sta nell'aver affrontato il poema per quello che a dispetto dei crociani di ieri e di sempre, intenti a disarticolarlo in polpa lirica e ossame o cartilagine intellettuale, esso in effetti è : un immenso - eternamente irriducibile e, proprio per questo, eternamente fruibile - "individuo" poetico. (...) a sorreggere, a ispirare il poeta-traduttore è stata, in ogni scelta di metodo e in ogni scelta concreta, la musa della densità..."
Cfr. anche saggio di Vegliante "Ridire la 'Commedia' in francese oggi", /DANTE/ n° 2, 2005, pp. 59-79.
Biobibliografia di Jean-Charles Vegliante
Nato a Roma, Jean-Charles Vegliante vive a Parigi dove insegna alla Sorbonne Nouvelle. Poeta e traduttore, si è occupato dei testi francesi di Ungaretti e di teoria della traduzione (D’écrire la traduction, 1996). Ha pubblicato di recente Rien commun (Belin, 2000), Voci (bilingua, Forlì 2002) e Nel lutto della luce (Einaudi, Torino 2004).
Una poesia di Jean-Charles Vegliante
Una variante di Jean-Charles Vegliante1. /F. nel sonno/
amici, vivo con voi ormai,
non mi offende più arido asfalto:
è vero, nostre parole volano,
vischio e nidi lungo l'autostrada,
a quel ricordo di cadenza in me.
2. /In sogno, o quasi/
Amici vivo con voi ormai,
non mi offende più arido asfalto:
è vero, nostre parole volano
(vischio e nidi lungo l'autostrada
orrenda) e tutto ritorna aprile,
e un ricordo di cadenze in me.
(fine del 1994)
Testo inviato al Centro di Documentazione “Lorenzo Montano” nell’ambito dell’iniziativa legata alle “varianti” poetiche.
Traduzione di Fabio Scotto
Yves Bonnefoy«Facesti come quei che va di notte…»
Agitava una sorta di torcia
Il cui doppio bagliore disorientava
Quegli altri che cercavano dietro di lui
Di non aver paura, lungo l’abisso.
Guida, perché non hai, sul tuo stesso corpo,
Nulla di quella luce che offri?
Non hai alcun bisogno di avvertire
Il vuoto che si scava sotto i tuoi passi?
Ma tale è il destino dell’allegoria:
Chi parla non potrà né deve sapere
Da dove viene e dove sprofonda la sua parola.
Il suo piede cerca il suolo annaspando nel vuoto,
Il suo volo esita e vira nelle sue parole,
Fiamma che è meno un sogno della cenere.
Traduzione inedita di Fabio Scotto
Anticipazione inedita da una raccolta poetica d'imminente pubblicazione in Francia.
Copyright Y. Bonnefoy per l'originale francese, F. Scotto per la traduzione.
Teoria: Giorgio Bonacini, Gaetano Ciao, Marco Ercolani & Lucetta Frisa
Prosegue la pubblicazione di Oscurità di Giorgio Bonacini, giunta al quarto capitolo. Gaetano Ciao propone un saggio teso tra corporeità e immaterialità, mentre Marco Ercolani e Lucetta Frisa scrivono del Progetto Arca.
Giorgio Bonacini, Oscurità II
Fare poesia è avere in mente che il corpo (anche il corpo delle cose) non è sempre un linguaggio catturabile, ma nemmeno una dimenticanza pura e semplice; il linguaggio del corpo esiste anche in funzione di un corpo di linguaggi da cui attingere per scrivere qualcosa: chiamarla “poesia” è solo una questione di modalità contingenti. Nel caso specifico (l’ingresso mentale, ma anche simbolico, nell’uni-verso della poesia) è l’incertezza conoscitiva, l’indecidibilità di una risposta. Alla fine del percorso, che cosa so dell’immagine del mio corpo? Forse solo un sentimento di astrazione o la fluidità di un linguaggio martellante.
La parola sale da una congiunzione all’altra e non si arresta: dimentica di essere al servizio di un pensiero. Posso chiedermi, però, se la poesia sia in grado di sopportare il peso di una dimensione fortemente cognitiva. In altre parole: qual è il senso della metafora nella logica di questo mondo?
Wallace Stevens scrive (e dunque scopre) che “Agli antipodi della poesia, buio inverno,/ quando gli alberi brillano di ciò che li spoglia,/ il giorno eva- pora, come il suono udito da un malato.”*1 Io ne convengo, senza per questo dogmatizzare un senso o limitarmi a quella forma.
Dunque il paradosso è estremo: la poesia può fare a meno del mondo, ma il mondo non può fare a meno della poesia. E ciò senza ironia, perché il mondo non lo sa e se ne infischia della mente poetica; e ancor di più si disinteressa del corpo poetico e della sua risoluzione nella parola. Ci si può ammalare, si può morire per questo?
In ogni caso, pur nell’affaticamento, si affronta l’impresa (le impennate, l’instabilità di un appiglio...) perché il mondo della poesia è convincente: è un atteggiamento teorico, vivo, un modo di fare pensiero che non nasconde le sue difficoltà, ma le risolve in un’astuzia del corpo.
Così come il silenzio è un’astuzia della parola, il mondo è un’astuzia della poesia. Qualcuno dice il contrario. E’ vero anche questo, ma nello stesso modo in cui, per una scala, la salita e la discesa sono la stessa cosa. Dipende dallo sguardo o, più naturalmente, dal salire e dallo scendere.
Certo, si può essere ancora più sottili e riconoscere le disfunzioni di una simile idea: ma è la necessità di non salvarsi da niente a produrre i motivi del senso. In questo modo è possibile allora affrontare con lucidità anche il sentimentalismo, anche una certa pateticità.
E se in tutto questo si parla di vivere, allora la sua pertinenza conduce lo scrivere ad una valenza poetica: l’apparente immobilità dei versi funziona
perché scorpora ogni aggancio con la realtà (ma non con “il reale”, come già detto). Ciò che rimane è il giudizio: e questo ha a che fare con i feno- meni possibili, non solo quelli esistenti.
In definitiva, il rapporto tra il corpo fisico presente e la fissità o fluidità del linguaggio appartiene sempre più alla metafora in sé, alla sua letteralità: che è la consistenza di una finzione recuperabile all’interno di una retorica culturale, non strettamente artistica.
Ma c’è dell’atro: così come spesso non è convincente il racconto del sogno (meglio meditare sulla funzione del sonno), anche il corpo, nella sua estesa profondità, viene indicato enunciando “l’interiorità, senza concedere l’intimità”.*2 Ciò significa concentrarsi sulla poesia per rivelarne il pensiero, forse la fonte originaria, se mai esiste.
Marco Ercolani e Lucetta Frisa, Il progetto Arca
“E che altro potevo opporre al nulla se non questa arca nella quale ho voluto riunire tutto ciò che mi era vicino?
Danilo Kis
1
I libri dell’Arca hanno una storia lunga e complessa. Il «progetto Arca» - ideato da Marco Ercolani, Lucetta Frisa, Giuseppe Zuccarino, ai cui nomi si sono aggiunti Massimo Morasso e Luigi Sasso - nasce per la prima volta nel 1991, sotto forma di samizdat in buste in quaranta copie per quaranta amici, e si attua in questa forma – Arca prima serie - fino al 1997. Così Giuseppe Zuccarino descrive questa prima serie della rivista (in cui appaiono, tra gli altri, testi di Blok, Beckett, Rilke, Shakespeare, Char, Masson, Foucault, Nerval, Blanchot, Tal Coat, Mallarmé): «All’inizio del 1808, Clemens Brentano e Achim von Arnim fondano una rivista, destinata a durare solo pochi mesi, alla quale danno un titolo piuttosto singolare: «Zeitung für Einsiedler» («Giornale per eremiti»). La formula è spiritosa proprio in quanto appare intrinsecamente contraddittoria. Come dovrebbe essere – viene da chiedersi – un giornale, per poter sperare di suscitare l’interesse degli eremiti, ossia di persone che non si identificano con i valori correnti della società in cui vivono, e che hanno scelto la solitudine come forma di fedeltà alle proprie idee? (…)
A un tale, improbabile, «giornale per eremiti» si è portati a pensare in relazione ad «Arca», i cui lettori sono appunto necessariamente rarissimi (vista l’esigua tiratura della rivista) e dispersi in vari luoghi, perlopiù periferici, della Tebaide letteraria italiana. Così come i redattori sono costretti ad essere selettivi nell’identificare, uno per uno, i propri lettori, sperano di esserlo anche nella scelta dei testi da proporre. (…) Una rivista come «Arca» ha un carattere essenzialmente privato, fondandosi su quella pratica ardua e gratificante che chiamiamo amicizia (e l’amicizia, come ricorda Pascal Quignard, «è l’unica vera società segreta»). Tra autori e lettori – ma i due ruoli sono tendenzialmente reversibili – si stabilisce dunque un dialogo, che serve a rendere conto delle rispettive esperienze di scrittura. È vero infatti che chi lavora ad «Arca» (al pari di chi la riceve) si pone consapevolmente nel ruolo dell’eremita, e dunque accetta di rendersi invisibile per i più, ma ciò non toglie che egli avverta la necessità dello sguardo, al tempo stesso complice e impietoso, degli amici. Come diceva una volta André Malraux, «è difficile, per chi vive fuori dal mondo, non andare in cerca dei suoi».
2
Dopo il 1997 Arca si organizza in rivista “tradizionale” e pubblica dieci numeri, fino al 2004. Arca seconda serie assume una precisa veste grafica ma la poetica resta sempre identica: individuare opere, marginali ma significative, in cui l’artista affronta le problematiche del suo operare.
Arca, in questa nuova forma, si divide in cinque sezioni. Segnali: poesie, saggi o racconti di classici e contemporanei. Destini: un omaggio ad autori fraintesi o trascurati dalla critica ufficiale. Variazioni: un dialogo su temi e problemi introno alla scrittura. Sinopie: testi di e per pittori. E infine Graffiti, dove un artista propone alcune delle sue immagini esclusivamente create per Arca.
In questi sette anni Arca pubblica autori come Ernst Meister, Louis-René des Forets, Maurice Blanchot, Emilio Villa, Philippe Jaccottet, Jean Fautrier, René Char, Antonin Artaud, Robert Walser, Francis Bacon, Paul Celan, Jean Starobinski, Robert Desnos, Yvan Goll, Henri Michaux, Varlam Salamov, Pascal Quignard, Roland Barthes, Michel Leiris, Alberto Giacometti, Dario Capello, Claudine Bertrand, Osip Mandel’stam, Alejandra Pizarnik, André Breton, Jean Dubuffet, Yves Bonnefoy, Ted Hugues, Tatjana Bek, Emile Cioran, Stéphane Mallarmé, Victor Hugo, Luchino Visconti.
3
La nuova forma di Arca è oggi una collana editoriale: I libri dell’Arca, ospitati dagli amici delle edizioni Joker, Gennaro Fusco e Monica Liberatore e Mauro Ferrari, sviluppano ulteriormente certe premesse che sono sempre state la base del lavoro della rivista.
-Scegliere dei testi di qualità, nell’ambito della scrittura del novecento contemporaneo.
-Utilizzare lo strumento della traduzione (dal francese, ma anche dal russo, dall’inglese, dal tedesco.)
-Esercitare una particolare attenzione verso la poesia contemporanea.
I libri dell’Arca individuano testi di autori che concepiscono la scrittura come pulsione estrema, in stretto rapporto con l’esperienza della follia e l’ossessione dell’arte. Intento della collana è sviluppare una rabdomantica curiosità per scritture minori, spesso sommerse o poco visibili, del Novecento europeo. L’attenzione si orienta verso questi testi, frammentari, marginali e non troppo noti nella biografia intellettuale dell’autore, che sembrano parlarci, oggi, con maggiore intensità e autenticità delle opere più note. Nostra convinzione, sulle tracce di Thomas Bernhardt, è che la scrittura contemporanea sia solo un «grande e gigantesco frammento».
Il progetto è indagare, con prove narrative o poetiche, in grande libertà, attorno a temi estremi e comuni come la follia, il sogno, la poesia, la scrittura del limite e dell’oltre. Il desiderio della collana è definire una cartografia di questi terreni, sempre marginali e sempre reali, dove l’artista vuole spingersi sempre un passo più in là, nella sua ricerca costante di un nuovo sempre attento alla tradizione.
I libri dell’Arca si dividono in due sezioni: L’arte della follia, in cui è preminente l’attenzione a saggi di critici e di poeti che intrecciano arte e follia, e Isola delle voci, dove trovano spazio voci poetiche contemporanee, più in particolare, nell’area di lingua francese, e libri collettivi di artisti e poeti.
***
“L’arte, o è deforme o non è”. “Chi fa morire il folle che ha dentro di sé muore senza voce”. Queste due affermazioni di Michaux orientano la nostra ricerca. La sproporzione rispetto alle regole e la capacità di preservare un nucleo autentico di follia stanno alla base del nostro lavoro. Il titolo di uno dei libri della collana - Noi lavoriamo nelle tenebre – richiama volontariamente l’affermazione di Henry James, citata da Blanchot, che definiva così il lavoro dello scrittore in generale. Nelle tenebre, è possibile incontrare punti di luce, prospettive nuove. Solo chi è nel buio vede e desidera la luce con maggiore intensità.
***
Questi sono I libri dell’Arca pubblicati dal 2004 al 2007:
Marco Ercolani Il tempo di Perseo
Bernard Noël Artaud e Paule (a cura di Lucetta Frisa e Marco Dotti)
Luigi Sasso Fuori dal paradiso
Flavio Ermini Antiterra
Maurice Blanchot Noi lavoriamo nelle tenebre (a cura di Giuseppe Zuccarino)
Sylvie Durbec Fughe (a cura di Lucetta Frisa)
Giuseppe Zuccarino Grafemi
Bernard Noël L’ombra del doppio (a cura di Lucetta Frisa)
Di prossima uscita:
Pasquale Di Palmo I libri e le furie
Dieter Schlesak Poesia: una malatta pericolosa
Più in dettaglio:
In Artaud e Paule, Bernard Noel, uno dei massimi poeti contemporanei francesi, scrive un testo essenziale sul rapporto tra l’ultimo Artaud e la sua giovane amica Paule Thévenin. Inoltre la collana ospita uno dei volumi più significativi del poeta, L’ombra del doppio.
In Antiterra Flavio Ermini raccoglie in volume diversi editoriali della rivista Anterem.
In Noi lavoriamo nelle tenebre sono tradotti, di Maurice Blanchot, alcuni brevi saggi su Michaux e des Forêts e certi illuminanti interventi degli ultimi anni di vita, apparsi anche su quotidiani francesi.
Luigi Sasso, in Fuori dal paradiso, orienta la sua ricerca saggistico-narrativa verso importanti ‘scrittori della follia’ dell’Ottocento e del Novecento europeo, tra cui Gerard de Nerval e Robert Walser.
Silvie Durbec, in Fughe, si pone sulle tracce di artisti che hanno scritto molti libri e percorso molte strade, da Lenz a Sébald e ancora a Walser, ripetendo materialmente i loro percorsi, sovrapponendo il suo personale sguardo al loro.
E ancora, Pasquale di Palmo e Dieter Schlesak, nei libri di cui è imminente la pubblicazione, orientano la loro attenzione ancora verso gli intrecci tra arte e follia.
***
Gaetano Ciao: l'incorporeo
(ITINERARIO TRA CORPOREITA’ E IMMATERIALITA’)Ciò che corporeo non è, non può esulare dal corpo: non può farne a meno, non può trascenderlo. L’assenza dell’uno sarebbe l’assenza dell’altro: il nulla.
Prima che un corpo muoia, ciò che è incorporeo si estende ad altro corpo, o a più corpi. Tale estensione non conosce limiti, né di tempo, né di spazio; è possibile anche dopo l’esistenza del corpo, nel quale l’incorporeo si è generato.
Esso si espande, anche coniugandosi con l’incorporeo in altri corpi convivente.
Se ciò che incorporeo non è finisce, ciò che corporeo non è vive, e si estende e si moltiplica.
La parola ha in sé l’uno e l’altro: la corporeità che muore, e l’immateriale che vive; tale è l’incorporeo del corpo dell’uomo. L’uno non può sussistere senza l’altro. Così vive l’uomo.
Unità inscindibile, indissolubile, inconsolabile.
L’uomo, come la parola, è questa indivisibilità.
E’ l’indiviso, come la parola.
L’estensione dell’incorporeo da un corpo all’altro, non è senza sofferenza.
L’incorporeo, nella nuova sede, deve trovare la sua giusta collocazione; per sussistere, deve essere assimilato nell’indiviso dell’unità corpo-incorporeo.
All’inizio, esso è il nulla, l’estraneo, lo straniero, il dissimile, l’incompreso.
L’assimilazione determina la sofferenza, inattesa fino a che il suo permanere non diviene esso stesso elemento dell’unità, che non è mai pacificazione dell’indiviso
Non è possibile la vita dell’incorporeo senza riconoscere le sue origini nel nulla che è nel sacrificio del corpo, nel pianto che è al confine dell’indiviso.
L’immateriale, immanente nel corporeo, emergente dalla materia, è l’altra parte dell’uno.
Occorre scavare nella morte ciò che è, ciò che non muore: l’incorporeo.
Ciò che è, ciò che non muore, vive in ciò che muore.
L’immortale abita il mortale. Esso adorna l’incompiuto della sua dimora. Esso stesso è l’incompiuto, l’incorporeo nel corpo, l’indiviso per sempre.
La locazione può essere temporanea. Spesso esso occupa altri spazi, rimanendo inquilino di se stesso, come se fosse nella dimora originaria. Spesso l’abitazione diviene piccola, insufficiente, per ospitare la sua incorporeità. Ma esso non può sottrarre tutto lo spazio al corpo, suo coinquilino: cresce su se stesso, quanto più si espande; i suoi confini, ospitali, imprecisabili, vanno oltre la sua dimora: sono quelli imprevedibili dell’apertura all’altro, all’insperato, che non ha confine. Ciò si verifica anche in tutti gli altri corpi che, avendolo ospitato, ne sono divenuti compartecipi. Partecipi dell’incorporeità.
Privato surrettiziamente della corporeità, privato dell’incorporeo, l’uomo perderebbe la sua unità: in tal modo non potrebbe mai giudicare se stesso, né altri potrebbe farlo per lui. In realtà il distacco, la separazione non è possibile. Non sarebbe equo il processo di valutazione in assenza del corpo. Corporeo e incorporeo non possono essere scissi. Occorre giudicare l’indiviso, sempre.
Il giudizio sull’indiviso non dovrà attendere la fine del mondo, la fine dei secoli.
L’umanità dell’uomo è l’indiviso di corporeità e incorporeo.
Il giudizio su ciascun uomo, dopo la sua morte, sarà determinato anche dall’incorporeo trasmigrato in altri viventi, ossia dal valore intrinseco da esso apportato al mutamento e alla crescita della loro umanità.
Il confine dell’incorporeo è nel corpo stesso dell’uomo, così come quello del corpo è nell’incorporeo. Il corpo, come materia, cerca di superare la linea di confine, ma l’incorporeo resiste.
Il confine è comune a entrambi, ma non è fisso, né prestabilito. E’ mobile, ed è l’uomo stesso, ciascun uomo, a determinarlo per se stesso.
Più si addentra il confine nel corporeo, maggiore diviene lo spazio dell’incorporeo, e viceversa: maggiore diviene lo spazio del corpo, minore sarà quello dell’incorporeo. Mai però potrebbe scemare la corporeità, mentre è possibile il contrario, la mancanza, l’assenza dell’incorporeo in un corpo che in se stesso ha il proprio confine. Un confine che segna il nulla, il nulla del corpo, ma anche la possibilità da cui l’uomo può partire, o ripartire, per cercare l’incorporeo e farlo proprio.
Incorporeo e corpo coabitano. La coabitazione non è semplice compresenza, ma condizione perché sul corpo possa innestarsi e crescere l’incorporeo. Per questa ragione la loro coesistenza si configura come indiviso, mentre l’identità dell’uno resta del tutto differente da quella dell’altro.
La loro separazione definitiva avviene solamente con la fine dell’esistenza del corpo. L’incorporeo, però, come si è detto già, sopravvive componendosi con l’identico, o col non dissimile, di uno o più corpi.
Dell’incorporeo dell’uomo è parte, come elemento costitutivo, la parola, intesa come arte e cultura. La sua coabitazione col corporeo della lingua, quella comune del parlare, è solo apparente. Parola e lingua non coabitano, il loro confine non è comune.
La parola, di fatto, ne spezza in più punti le catene che sono causa di soggezione e di asservimento dell’uomo, e ne circoscrive il potere di annebbiamento delle coscienze.
L’una e l’altra hanno spazio diverso: quello della lingua è chiuso; in realtà non muta molto, resta definito nelle sue stesse dimensioni, che sono identiche anche se sono mutabili i componenti linguistici. Il mutamento è determinato dalla loro usura e/o da ininfluenti incrementi lessicali o modifiche formali, esteriori. La lingua, per l’arbitrio dell’associazione significante-significato, non può esprimere la realtà, quella vera, l’incorporeo. Solo la poesia, solo l’arte, può indicare i sentieri difficili, impenetrabili, spesso impercorribili del vero, dell’essere che si fa, identificabile nella sua impossibile identificabilità.
Lo spazio proprio della parola muta e si espande su se stesso. La parola, nel proprio autonomo e libero farsi, crea forme nuove e vie di comunicazione ignorate, che hanno transiti esclusivi e possibili solo nell’incorporeo, di cui moltiplicano e amplificano l’area della conoscenza, quella che non ha confini, come quella aperta all’altro.
La parola è l’indiviso di linguaggio e reale: nell’indiviso si manifesta l’impenetrabilità dell’essere, ossia una realtà in cammino. In essa linguaggio e reale, incorporeo e corporeo, sono la stessa cosa, si identificano; inoltre, nella loro indivisibilità, sono mutevoli e vari.
La lingua invece crede di potersi identificare col reale del mondo e delle cose che sono fuori di sé, e non s’avvede che tutto ciò che non è in sé, è del tutto privo di autenticità. E’ falso, proprio per il presupposto arbitrario di identificazione del segno verbale, o di altra natura, con la cosa.
La lingua, chiusa nei suoi limiti, fissi, immobili, rimane tale. Non possiede porte che consentano l’apertura all’altro, all’imprevedibile, al non detto, all’in-nominato: il disertore, l’in-fra. Ciò comporta incomprensioni e chiusure invalicabili tra le genti, sparse per il mondo, che hanno smarrito il senso originario del rapporto incorporeo-corporeo.
Occorrerà trovare altri itinerari, altri tragitti, che permettano incontri possibili, accettabili, ravvicinati all’indiviso.
03.03.2007
Il lavoro di un Premio: Rosa Pierno su Bona, Guantini, Isella
Rosa Pierno prosegue il lavoro apparso nel numero precedente, proponendo ulteriori chiavi di lettura per alcuni poeti giunti in finale nella scorsa edizione del premio Lorenzo Montano.
Rosa Pierno su “La cospirazione” di Ermanno Guantini
Rosa Pierno su “La cospirazione” di Ermanno Guantini
Ci si immerge, in quanto lettori, in un testo che è magma fratturato, in via di raffreddamento, ma da cui emanano ancora bollori. Volontarie sgrammaticature, aggettivi non accordati nella forma ai sostantivi, rendono più aspro il paesaggio vulcanico. Eruzione ha un respiro geologico. Cospirazione sarebbe, allora, respirazione a cui l’uomo si adegua. Tale co-respirazione mima un dialogo. Dialogo tra natura e cultura. Lievi variazioni su ritmo, lentissimi scarti, effettuati da un essere umano, se non spaventato, guardingo, in attesa: monitoraggio di eventi lo si direbbe, eppure, solo all’interno della lingua. Lingua: amata, irrinunciabile mostruosità.
Il dialogo s’intesse attraverso lo sguardo e l’udito e intercetta sfilacci di filosofia, lacerti di chimica e di fisica, osservazioni geometriche tranciate: “nel clamore arido della deduzione, in un avvertimento, sterile fasto, precisa composito, inesauribile abitudine al dicembre, inerzia” Non arriva a formarsi alcun pensiero in questo assemblaggio eppure sublime: è forma perfetta e forma non realizzabile insieme.
Aggettivi si accompagnano forzatamente a sostantivi altrettanto recalcitranti. Quasi un sistema leibniziano in cui non c’è contraddizione solo perché tutte le contraddizioni vengono viste come variazioni di grado della complessità e risolte a un superiore livello d’unità. Se “l’equilibrio non dipende dalla sanità, ma all’occasione, abbandono in diligenti diottrie o nuda ricreazione”, il lettore è tentato di pensare al testo come a un meccanismo formato da tessere di puzzle tutte uguali: tutto si può ricomporre con tutto, oppure non collimare mai, che è la medesima cosa. A questa collezione, collazione di parole, di risonanze, di echi che si riconfigurano a ogni passo scandito da virgola: “la ribalta nell’anfora deserta, lo spicchio, la coscienza di equilibrio, il taglio d’oro nel pregevole cosmo”, Guantini affida il suo persistente, indimenticabile respiro tutto umano. Respiro mediante linguaggio.
Rosa Pierno su “Corridoio polare” di Gilberto Isella
“Corridoio polare” (Book editore, 2006) di Gilberto Isella, è un libro che inizia tiepidamente, dando al lettore le coordinate di riferimento, ma poi finisce con lo scottare fra le mani. Coordinate: l’Io come congettura o ipotesi, ma soprattutto dato culturale. L’Io confuso tra tutti gli altri elementi che compongono l’universo e contemporaneamente creatore di universi. Non privo di paesaggio, di dati biografici, di dettagli fisici. L’Io in quanto eccezione nel cosmo ruba il posto al dio creatore.Il libro inizia, dunque, con una precisissima collocazione dell’Io fra le cose e della sua assoluta preminenza come percipiente.
L’analisi delle facoltà conoscitive conduce Isella a comprendere che ratio e follia non sono facilmente separabili e che tutto questo ha una conseguenza sulla conoscenza delle cose, sul modo di vederle: “questa notte in corsia l’ultimo/ lenzuolo si è gonfiato per la polvere che matte lune soffiavano oltreparete, ha coperto una schiera di omiciattoli uguali, soldatini di plasma,/ dove ho visto qualcuno che mi somiglia/ dove mi è apparso il primo gradino/ o, forse, un equivoco/ della scala”.
Col pensiero si può porre una meta ideale, ma non la si può raggiungere se non tradendo la propria lucidità. Follia funziona qui anche come sinonimo di ambiguità. Saggia ambiguità da preservare contro ogni tentativo di assolutizzare o di rendere monotematico il significato. Descrivere la realtà con linguaggio matematico non è forse l’orma che lascia la follia nella nostra mente?
E d’altronde come negare valore conoscitivo alla follia, al tentativo di risolvere l’assurdo, il paradossale in unità? Non è forse questo un atto matematico e poetico insieme?
E’ come un dazio pagato per l’ingresso nel regno del possibile. Poesia dispiega, ora, un universo di fatto prima inesistente.
E tutto questo movimento di pensiero è reso da Isella con una splendida variazione di stile: ora abbecedario, ora dottissimo, ora misto: “mi pigiavo in creme algose che dai fondali risalivano, presenze e scorie ischeletrite aggallavano per sommergersi, sacche dal volto scimmiesco squaquerante..”.
Ci troviamo dinanzi a una poesia mirabile, che reca un vero piacere fisico: il suono, il senso, le immagini che fanno meraviglia.
Ma Isella come una macchina che misuri le più piccole oscillazioni registra anche mancamenti, balbettii, baratri d’insensatezza che inevitabilmente affiancano ogni perlustrazione linguistica. Se Isella indaga le due aree, quella scientifica e quella umanistica, è ben vero che lo fa è sempre situandosi nelle loro zone di confine, di dialogo, di promiscuità. Lì nasce e si forma compiutamente il senso.
Lo sviluppo del testo coinvolge il lettore in maniera fisicamente partecipativa: è come se ci si trovasse su una caldaia che sta per esplodere, ma che intanto produce bollori rutilanti, tensioni, polifonici rumori: “Ora è salciccia muta su piatto di peltro,/ steso lì a causa di altre braccia gagliarde/ da folla trina e unigenita armate/che infuria su ruote solleva radici/ e ne fa clave e punte d’uragani..”. Isella ha dato la stura a un’immaginazione che non vuole freni e che nel suo lussureggiante darsi offre caleidoscopiche forme. Pirotecnico linguaggio, poliforme e duttile. Come se alla fine del viaggio-libro, Isella avesse optato non per la follia messa a confronto con la ratio, ma per l’immaginazione, in quanto sintesi dei due inconciliabili termini. Sì, il libro bolle, ma, con calcolata mossa, proprio quando il lettore giunge alla fine.
Rosa Pierno su “Signora dell’intimità” di Giorgio Bona
Rosa Pierno su “Signora dell’intimità” di Giorgio Bona
Una scrittura che non si pone limiti nel prelievo da ambiti linguistici specialistici o da lingue estere e nemmeno nell’evitare l’uso di punteggiatura e di pause e che si snoda, eppure ritmicamente, lunghissima catena. Il lettore sente scorrere sotto le dita i grani del rosario, il lunghissimo periodo, e con i polpastrelli può far scorrere le frasi o può frenare sulle parole di giuntura: poiché una parola costituisce il passaggio di volta, la chiave, per la frase successiva, per l’installazione in un altro contesto, di altro punto di vista, che vira il senso: “porta un messaggio l’aria mi spinge agli incavi del tartaro che plana luna ramata vai a questa profondità ma sì l’utopia sei tu che ami l’orizzonte”. Se la catena è composta da grani di incertezza, quasi un inventario di luoghi culturali, è anche vero che Bona è da una posizione ben salda che parla: si avverte la totale consapevolezza dei valori e dei desideri che lo animano e da cui registra ciò che non gli si attaglia o ciò che lo rende felice.
Il linguaggio, che ricorda il movimento della scrittura beckettiana, appare come uno strumento d’investigazione sugli stessi strumenti linguistici utilizzati: “è il modo dei corpi di star compatti il mio ritmo lingua nuda furba sveglia sotto in fondo senso e giudizio non hanno storia ma più sotto anche i tuoi occhi puoi pensare nel clamore per iniziare dal principio come spingere i fatti da fuori”.
Ogni testo usa un lessico diverso che forma l’impalcatura dell’investigazione condotta sui propri dati sensoriali, emotivi e razionali. La scienza o i testi di Omero vengono trattiti allo stesso modo con prelievi che sono incastonati nel tessuto esistenziale dell’autore, le cui ossessioni sono reiterate, affiorano come scogli perigliosi e si rincorrono per tutto il libro: parole che sono indagate come non innocenti e che costituiscono l’ossatura del libro: “vuoto”, “aria”, “movimento”, “delfini”, sotto il vestito”, “la tua bella voce”, “verità”, “nuvole”...
Resta tra la rete delle dita un pescato concretissimo, vero tesoro per il lettore.
Le recensioni di Marco Furia
Marco Furia su “Bisogni” di Davide Campi
Poetici bisogni
Nel caso di “Bisogni”, di Davide Campi, testo pubblicato sul n° 73 di “Anterem”, si è in presenza di una complessa composizione (trentacinque versi suddivisi in sette parti) in cui il susseguirsi degli articolati, enigmatici, costrutti obbedisce ad esigenze interne allo specifico idioma proposto: un “perno” trovato “negli altri resti dal sapere”, “… un cerchio che spinge lontano/ più al sicuro nell’ altrove dove porta”, “un determinato specchio/ aperto ai generici suoni” risultano immagini, ricche di valenza allusiva, non riferite, certo, a comuni modelli, bensì evocanti la presenza di un ineffabile, vivido, quid.
Attento ad elementi, anche minimi, connessi in maniera tale da costruire assiemi tanto coerenti quanto aperti su insondabili entità, il Nostro si rivela ben conscio del fatto di poter disporre, con vantaggio, di non aprioristiche opzioni idiomatiche, le quali, nel riconoscere i propri limiti, conducono a individuare, proprio in virtù del sollevamento di ottenebranti veli, la via, percorribile, di affidabili consapevolezze poetiche.
Non è dato oltrepassare certi confini, ma è possibile riconoscere la presenza degli stessi, è possibile, addirittura, riuscire a non considerarli, in senso stretto, siffatti, giacché strettamente connaturati, intrinseci, a un modo di essere: rigorose prese d’atto sono in grado di superare ogni giudizio precedente, di condurre a diversi apprezzamenti e, perciò, a nuovi valori.
Con piglio sicuro, dotato di non comune perizia nel muoversi entro spazi linguistici considerati quali àmbiti in cui mettersi in gioco quale (tenace) costruttore di versi, opponendo, così, a qualsiasi altro possibile atteggiamento l’ offerta delle proprie parole e di sé, Campi mostra come le faglie, più delle superfici in apparenza intatte, costituiscano fecondo terreno di poetiche indagini.
Non mancò leggiadro dinamismo.
(Davide Campi, “Bisogni”, in “Anterem” n° 73, pagg. 72-73)
Marco Furia su “La bontà animale” di Alberto Cappi
La notte nel taschino
“La bontà animale”, di Alberto Cappi, cui i raffinati disegni di Pietro Lenzini aggiungono il fascino di un leggiadro contrappunto, costituisce sequenza di brevi componimenti d’ intensità non comune, poetico frutto di coerenti ricerche svolte per via di un’ opzione linguistica intesa quale strumento evocativo anziché logico-esplicativo.
I lindi accostamenti di parole, collocate con determinazione tale da impedire di immaginarle disposte in diversa maniera, capaci di catturare energia, restituita, con sapiente lavoro, da un suggestivo svolgersi incline ad alludere alle sue magmatiche origini – l’ identica attenzione nei confronti di temi grandi e piccoli, nella consapevolezza dell’ assurdità di qualunque gerarchia istituita tra varie espressioni dell’ esistere – il richiamo, già presente nel titolo, ad una dimensione biologica considerata non limite, ma fecondo àmbito del divenire – un diffuso senso di enigmatica attesa vissuto con profonda accettazione, senza inibire, perciò, altrettanto intensi sentimenti di fiducia – un assiduo rimando, di vocabolo in vocabolo, ad alterità ritenute, piuttosto che separato altrove, parti costitutive dello stesso essere – una grazia accorta, partecipe d’ intendimenti rivolti a trattenere, a evitare anche minime, non consone, tracimazioni, secondo un’ idea di gesto poetico quale istanza dotata di spiccata, rigorosa, autonomia: questi, in sintesi, i componenti precipui di una verseggiatura in cui la mai apatica eleganza delle pronunce risulta sempre attenta, vigile, non certo ignara di come il più scrupoloso controllo sia indispensabile al fine di giungere non tanto a una spiegazione, bensì a una presa d’ atto degli ineffabili fondamenti della lingua.
Tutti, davvero, “abbiamo la nostra notte e/ la teniamo nel taschino”.
Marco Furia su “Interni d’immolazione” di Domenico Cara
Consci, instabili giorni
“Interni d’ immolazione”, di Domenico Cara, offre al lettore una fitta trama di elaborati versi nel cui àmbito l’ esistente viene considerato, nei dettagli esterni come nelle sensazioni e nei pensieri, secondo multiformi, asimmetrici aspetti.
A contatto con contesti cittadini in via di progressivo degrado, il Nostro, lungi dal reagire operando nella direzione di raccogliere eterogenei materiali al fine di presentarli e abbandonarli alle loro automatiche interazioni, nonché dal rifugiarsi in fallaci speranze opponendo una pur generosa offerta di sé quale dolente, sterile, testimonianza, il Nostro, dicevo, di fronte ai suddetti guasti metropolitani, propone originali scelte poetiche quali possibilità di salvifici percorsi a partire da chiare consapevolezze, frutto di acute riflessioni sull’ umano destino.
Non è tanto l’ implicazione sociale in senso stretto, sebbene avvertita come rilevante, a interessare il poeta, è, piuttosto, la precisa cognizione dell’ inadeguatezza dei quotidiani usi linguistici a costituire, per lui, stimolo: si parla sempre di più, dicendo sempre di meno e la perdita di spessore, d’ incisività, conduce a tediosi appiattimenti che immiseriscono, assieme all’ idioma, l’ esistenza medesima.
Non troppo incline all’ invettiva, Cara svolge la sua versificazione con misurata passionalità, affidando spesso agli aggettivi il compito di riferire su circostanze per nulla serene: ma, se l’ottimismo è bandito, non si assiste a capitolazione.
“E noi attraversiamo dentro fossati una linea / degli enigmi, dove l’ immanenza si fonde al disperso” paiono versi indicativi: non superiamo l’ enigma, non lo sciogliamo, piuttosto lo “attraversiamo dentro fossati”, ossia ne siamo parte, ci confondiamo con esso.
Siffatta consapevolezza può vincere lo sconforto e indurre a continuare: non fittizie illusioni potranno aiutarci, ma perspicue prese d’ atto in grado di favorire l’ emergere di opportuni atteggiamenti.
Con originali, ritmici tocchi consoni a un progetto di grande respiro, abile nel proporre immagini secondo cadenze suggerite da una dovizia di pensieri i cui sbocchi, sulla pagina, risultano sottoposti ad assiduo vaglio, insomma, con la mano ferma e l’ occhio vigile di chi sa come distillare precise indicazioni, Domenico Cara offre un peculiare esempio di zelo poetico, volto, in ultima analisi, a promuovere possibilità di condurre più degne esistenze.
Consci “giorni instabili”, davvero.
(Domenico Cara, “Interni d’ immolazione”, Edizioni I MUTAMENTI DEL GIALLO, Roma-Milano, 2007)
Marco Furia su “Lo spostamento degli oggetti” di Alessandro De Francesco
Passionali oggetti
Con “Lo spostamento degli oggetti”, Alessandro De Francesco sorprende per una spiccata attenzione verso gli oggetti (e i fatti) quotidiani: non si tratta di mero intento denotativo, né di atteggiamento di gusto pop più o meno impegnato, né di surrealismo di maniera (mentre una genuina vena richiamante le idee bretoniane fa capolino qua e là), si tratta, davvero, di (poetica) riflessione sulla vita e sulla morte.
Richiamato Wittgenstein (“Gli oggetti contengono la possibilità di tutte le situazioni”), con citazione posta in corrispondenza della sezione intitolata come l’ intera raccolta, svolgendo, sicuro, suggestive sequenze di elementi diversi concatenati in una sorta di, talvolta spiazzante, eterogenea omogeneità, il Nostro intende mostrare (e vi riesce) che oggetti siamo anche noi, ossia che tra uomini e mondo esistono interscambi continui, incessanti, non rigidi confini:
“ ti cercherò nelle aperture della materia / nelle bolle che s’ incanalano tra gli attimi / mi costruirò la tua presenza”.
Ma, quanto costituisce (enigmatica) vita richiama inevitabilmente il suo termine:
“la fuoriuscita imprevista / dell’ idea di morte quella mattina davanti allo specchio”.
Nemmeno poi tanto “imprevista”, poiché:
“cos’ è la morte ci sono sempre gli oggetti a ricordarcelo”.
Questa poesia constata, prende atto di uno stato di cose e il dato affettivo, pur manifesto, si presenta non nelle tipiche forme di argomento esterno, bensì quale entità tendente a confondersi con lo stesso discorso.
Ne scaturisce, così, un fecondo esempio di come una versificazione attenta e perfino succinta, priva di sbavature, possa giungere a esiti di alta concentrazione emotiva in virtù di propensioni d’ affetto riferite agli stessi oggetti in quanto osservati e vissuti da un io partecipe, a tratti sofferente.
Oltre le frontiere della vita stessa, certo, non ci si può avventurare e tale assoluta invalicabilità suscita sensazioni e parole intense, non tenui: ebbene, De Francesco riesce a rendere testimonianza del comune, estremo, limite per via di vigili, controllate, scansioni in cui nondimeno l’ apatia, per originali vie interne alla lingua, risulta senza riserve bandita.
Gli oggetti, davvero, dicono: il poeta sa ascoltarli.
(Alessandro De Francesco, “Lo spostamento degli oggetti”, Opera prima, Cierre Grafica, Verona, 2008)
Marco Furia su “Mimi e sonnambuli” di Vincenzo Di Oronzo
Obliquo oboe
Conscio dell’ ambiguità insita nella comunicazione linguistica, nonché dell’ umana attitudine allo scambio idiomatico, Vincenzo Di Oronzo, con “Mimi e sonnambuli”, offre una raccolta di versi in cui vividi impulsi verbali ispirano pronunce rigorose e calibrate, quasi a contenere (suggestive) fughe dal senso presenti, con evidenza, nello stesso accostamento delle parole (“Abiti vuoti si accoppiano in ottagoni blu”).
Né mancano laconici richiami allo svolgersi di azioni in apparenza quotidiane (“Questo scorrere di cani bianchi al guinzaglio”), toni di stampo espressionista (per esempio il martellante ripetersi, nella poesia che inizia con il verso appena ricordato, dell’ aggettivo dimostrativo “Questo”), cortocircuiti linguistici tali da rivelare inclinazioni a definire, chiarire, un urgere intenso, non represso, destinato a rimanere entro enigmatici àmbiti (“I visitatori seduti/ Sulle panchine barocche”), tratti di liricità vivace, mai debordante, dagli esiti addirittura denotativi (“Bagliori di sandali/ Le ragazze oscillanti nella sera”), echi di fenomeni naturali riportati sulla pagina con evocativi, affascinanti, effetti (“Vuoti di vento”).
Il tutto a mezzo tocchi decisi, eleganti, capaci di suggerire la presenza di una ineffabile entità, ìndici di ostinate scelte espressive nel dipanarsi di esistenze in cui “Dentro” e “Fuori” risultano distinti quanto fusi e “Un oboe obliquo” è “la mente”.
Di allusiva leggiadrìa l’ immagine proposta in copertina da Bruno Conte.
(Vincenzo Di Oronzo, “Mimi e sonnambuli”, Edizioni Empirìa, Roma, 2007)
Marco Furia su “attraverso interni” di Daniela Cabrini
Vitali soffi
Avvertibile, “vitale il soffio” spira assiduo sulle intense pagine della raccolta “attraverso interni” di Daniela Cabrini, le cui nitide scansioni, frutto di attenta, appassionata ricerca, inducono davvero a (pregnante) riflettere.
Se non si possono violare certe estreme frontiere idiomatiche, si può essere in grado, tuttavia, di offrire un linguaggio proprio, diverso, capace di meglio riferirsi a vividi impulsi non assoggettabili a esegèsi, ma, almeno, suscettibili di evocazione secondo specifiche modalità disposte ad accettare un senso differente, promuovendo quella peculiare specie di rapporto comunicativo tipico della poesia.
Consapevole di ciò, la nostra poetessa, lungi dal rinunciare al dire, confida senza riserve nell’espressione verbale, tanto da proporne una qualità del tutto inedita: non si rassegna, insomma, di fronte agli eventi massimi e minimi del quotidiano stare al mondo e, quasi ingaggiando con essi linguistiche battaglie, evita di affidarsi a ulteriori inelastici modelli, presentando, sicura, eleganti opzioni aperte, tali da mostrare come la lingua possa ben differire da viete concatenazioni.
C’è una risposta, una via percorribile.
Se “così io parlo e tu rispondi ma le parole / pedine di due distinte scacchiere a caso / si fondono in un gioco senza significato” e se “troppo presto rincorrere una voce / male udita è troppo facile”, non certo l’ indifferenza e il pessimismo dovranno prevalere, poiché una via di scampo esiste: è il gesto creativo capace di avvicinare poeti, artisti e scienziati agli altri individui, in quanto inaugura una condizione specifica non aliena dal legare, anche con persistenza, tutti coloro i quali si trovano a essere, a qualunque titolo, coinvolti.
Con accenti limpidi, tali da offrire, risoluta e precisa, sorprendenti combinazioni verbali senza mai deflettere dal rivolgersi a un quid avvertito come assiduo e ineffabile, fiduciosa in un gesto poetico teso a rendere testimonianza e, nel contempo, a mostrare una direzione lungo cui procedere, Daniela Cabrini, accostando, spontanea, immagini del tutto quotidiane (“caffè tra noi”) ad altre, per così dire astratte, ricche di suggestiva incisività poetica (“il tempo mescola cerchi concentrici”), Daniela, dicevo, induce a seguire affascinanti itinerari nel cui inconfondibile àmbito l'atto del conoscere risulta più prossimo al gesto, al modo di essere, che al discorso raziocinante.
Esiste miglior maniera, per “chi vive”, di sopravvivere “allo spavento”?
(Daniela Cabrini, “attraverso interni”, Lieto Colle, 2007)
Marco Furia su “Il bene della vista” di Mauro Ferrari
Pensarsi liquidi
Con “Il bene della vista”, Mauro Ferrari presenta una strutturata, ma fluida, raccolta nel cui àmbito l’itinerario realtà – poesia è percorso, nel contempo, in tutti e due i sensi, secondo un’idea di versificazione non disgiunta dalle comuni modalità dell’esistere, bensì alle medesime connessa in maniera indissolubile.
Un intento come il suo, mirante, per empatia, a rendere maggiormente partecipi e consapevoli, non può non muovere da origini di vera e propria passione civile: spetta alla lingua poetica denotare, soffermarsi e, con i suoi slanci, con le sue pregnanti immagini, porre meglio l’ accento su quanto avviene, su quanto ci circonda, ossia sulla nostra stessa vita.
Un vita che, intesa, senza riserve, quale unitaria oltre ogni schema, ogni paradigma o concetto, emerge sempre, anzi nemmeno emerge, è già.
Il mezzo espressivo adatto a questi scopi deve uscire dai modelli d’uso comune, spesso ridotti a meccaniche sequele prive di originalità e incapaci di suscitare interesse, deve, cioè, mettersi in condizione di rendere perspicuo quanto ci circonda, ciò in cui siamo immersi, aiutandoci a capire quello che siamo: non occorre (nessuno, nemmeno il poeta, lo potrebbe) sciogliere l’enigma, ma renderne chiara testimonianza, così da sapersi meglio muovere in e con esso, procedendo nella nostra umana condizione.
Occorre, come il Nostro, pensarsi, sentirsi, liquidi, fluidi, sciolti nell’esistenza per coglierne gli aspetti anche meno evidenti o, meglio, per illuminarli con i raggi repentini e persistenti di un divenire poetico in grado di farci scoprire, alla fine, che quelle sembianze non erano poi tanto celate, ma si trovavano lì, disponibili a essere oggetto di uno sguardo più penetrante.
Con versi ordinati e vivaci, attenti a quanto è minuto come a quanto costituisce avvenimento di notevole rilevanza storica, sapienti nel rendere conto di ambedue le dimensioni senza mai cadere in retoriche di tipo crepuscolare o meramente celebrativo, svolgendo, coerente, una poesia tale da offrirsi al lettore senza mai cedere nulla quanto a precipua originalità, insomma con il (risoluto) riguardo tipico di chi, sicuro, non sente la necessità di ricorrere ad alcun artificio, Mauro Ferrari convince per la propensione a rendere sulla pagina dimensioni individuali e collettive non dissociate, coese proprio a partire dagli infiniti elementi che le costituiscono.
Furono, davvero, umani versi.
(Mauro Ferrari, “Il bene della vista”, Edizioni Joker, Novi Ligure, 2006)
Marco Furia su “Quantum poem” di Shigeru Matsui
Quantum Poem
“Quantum Poem”, di Shigeru Matsui, si presenta già a prima vista quale linguaggio: i segmenti, uniti o meno, formanti, talora, strane figure geometriche, disposti secondo un andamento simile a moti ondosi scomposti in schemi lineari, inducono a pensare a un idioma.
Un linguaggio, dunque: ma non veicolante significato nel senso comune del termine.
La lingua quotidiana, certo, nulla pare possedere di arcano: tutto sembra filare via liscio nell’àmbito di normali processi comunicativi condivisi da una comunità attenta al rispetto di regole.
Ma, a chiedersi come questo complesso reticolato si sia andato formando, come taluni impulsi ne provochino l’assiduo uso, quale sia la sua, non soltanto storica, origine, cioè quale energia induca ogni parlante a rompere, più o meno spesso, il silenzio – a porsi, dicevo, tali (e altri) quesiti, compaiono in risposta vivide entità del tutto enigmatiche.
Troviamo tali entità alle radici del gesto di Shigeru Matsui?
La risposta è positiva.
Non si tratta, nel caso in esame, di successioni originate da un autocompiacimento fine a sé medesimo o, peggio, della caduta in sterili intenti decorativi, bensì della messa in atto, della costruzione secondo fattezze non certo ordinarie, di espressioni articolate.
L’ esclusivo uso di tratti (segmenti rettilinei), dissimili soltanto nelle dimensioni, rende lecito pensare a elementi costitutivi non casuali, frutto di precise scelte tese a porre in essere griglie idiomatiche complesse e unitarie, capaci di attrarre proprio in virtù delle loro affascinanti strategie compositive.
La nostra comunità, senza dubbio, non parla quella lingua, ma questa è caratteristica che accomuna tutta la poesia: il poeta opera sempre uno scarto, la cui mancanza annullerebbe la versificazione stessa.
Quanto, poi, ai 347 testi, risulta impossibile resistere alla tentazione di osservarli concentrandosi su ciascuno o anche scorrendoli velocemente, di seguirli secondo l’ ordine numerico o per salti, come sollecitando i meccanismi di uno strumento poco conosciuto per verificare se sia affidabile.
Un’ affidabilità che, alla fine, scaturisce proprio dall’ avere così operato, ossia dall’ essere divenuti consapevoli di un’ originale consistenza espressiva, familiarizzando con essa.
Ancora una volta, insomma, un artista della parola e del tratto, un vero cultore della visual poetry, riesce a sorprendere e a indurre a riflettere: thank you, poet.
(Shigeru Matsui, “Quantum Poem”, Aloalo International, Tokyo, 2007)
Una poetessa dentro la cronaca nera: La vita e l'opera di Delmira Agustini (1886-1914) raccontate da Enrico Pietrangeli
Una storia di cento anni fa, dall’altra parte del mondo. La vita, l’opera e le immagini della poetessa Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914) raccontate da Enrico Pietrangeli
La bibliografia
DELMIRA AGUSTINI [1886 – 1914] BIBLIOGRAFIA
Opere:
El libro blanco (Frágil). Montevideo: O.M.Bertani -1907
Cantos de la mañana. Montevideo: O.M.Bertani - 1910
Los cálices vacíos. Montevideo: O.M.Bertani – 1913
Parra del Riego, Juan, Antolog?a de Poetisas Americanas
Claudio Garcia, editor. Montevideo. 1923. P?ginas 27-52.
Obras Completas - Tomo I - El rosario de Eros
Maximino Garcia, Editor. Montevideo. – 1924
Obras Completas - Tomo II - Los Astros del Abismo
Maximino Garcia, Editor. Montevideo. 1924.
Obras poéticas. Ed. Raúl Montero Bustamante. Montevideo: Edición Oficial, 1940.
Delmira Agustini, Editorial Ceibo. Montevideo, Uruguay. 1944.
Correspondencia íntima. Ed. Arturo Sergio Visca. Montevideo: Biblioteca Nacional, 1969.
Poesías Completas. Ed. Magdalena García Pinto. Madrid: Cátedra, 1993.
Poesías Completas. Ed. Alejandro Cáceres. Montevideo: Ediciones de la Plaza, 1999.
Crítica:
Burt, John R. "The Personalization of Classical Myth in Delmira Agustini." Crítica Hispánica 9.1-2 (1987): 115-124.
Escaja, Tina. Salomé Decapitada: Mujer y representación finisecular en la poesía de Delmira Agustini. Amsterdam: Rodopi, 2001.
Horno Delgado, Asunción. "Ojos que me reflejan: poesía autobiográfica de Delmira Agustini." Letras Femeninas. 16.1-2 (1990): 101-11.
Kirkpatrick, Gwen. "The Limits of Modernismo, Delmira Agustini y Julio Herrera y Reissig." Romance Quarterly 36.3 (1989): 307-14.
Machado de Benvenuto, Ofelia. Delmira Agustini. Montevideo: Ceibo, 1944.
Molloy, Sylvia. "Dos lecturas del cisne: Rubén Darío y Delmira Agustini." La sartén por el mango. República Dominicana: Huracán, 1985. 57-69.
Prego, Omar. Delmira. Buenos Aires: Alfaguara, 1998.
Renfrew, Nydia Ileana. La imaginación en la obra de Delmira Agustini. Montevideo: Letras Femeninas, 1987.
Rodríguez Monegal, Emir. Sexo y poesía en el 900 uruguayo. Los extraños destinos de Roberto y Delmira. Montevideo: Alfa, 1969.
Silva, Clara. Genio y figura de Delmira Agustini. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 1968.
Stephens, Doris T. Delmira Agustini and the Quest for Transcendence. Montevideo: Géminis, 1975.
Varas, Patricia. "Modernism or Modernismo? Delmira Agustini and the Gendering of Turn-of-the-Century Spanish-American Poetry." Modernism, Gender and Culture. A Cultural Studies Approach. Ed. Lisa Rado. New York and London: Garland, 1997. 149-60.
VVAA. Delmira Agustini. Nuevas penetraciones críticas. Uruguay Cortazzo coo. Montevideo: Vintén Ed., 1996.
Delmira Agustini y el modernismo: Nuevas propuestas de género. Ed. Tina Escaja. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2000.
La copertina di “Los càlices vacìos”

La copertina di “Los càlices vacìos”
Una poetessa dentro la cronaca nera
DELMIRA AGUSTINI [1886 – 1914] di Enrico Pietrangeli - 2006
L’Uruguay: l’altra parte del globo, eco risorgimentale di tempi eroici per “due mondi” campioni, ma solo con la Rimet, rispettivamente nel ’30 e nel ’34. Primo novecento: il presidente Ordoñez è in carica e, nell’ultimo lustro (1911-’15), anche il “batllismo” ha contribuito a rendere questa terra in qualche modo illustre. Numerose leggi sociali sono state già promulgate e, a tutti gli effetti, l’Uruguay diviene il paese più progressista d’America. Otto ore lavorative conseguite nel 1915 e previdenza sociale, incluso per indigenti, approvata nel ’19. Governa un partito “Colorado” non privo di riferimenti al socialismo, ma anche liberale, di tendenza laica ed anticlericale, prossimo agli interessi della borghesia urbana. I “Blancos”, nel locale bipartitismo, sono l’opposizione storicamente legata al latifondo e principi conservatori. Partiti minori, come quello Socialista e l’Unione Civica, pur costituendosi da inizio secolo, qui non avranno mai un consistente seguito. Una legislazione della famiglia all’avanguardia, con l’introduzione dello strumento del divorzio fin dal 1907, è una realtà già tangibile in questo paese. Il 5 giugno del 1914 Delmira Agustini ottiene un pronunciamento di sentenza e, da quel momento, Enrique Job Reyes diventerà il suo ex marito. Lo stesso mese, il 29, avviene l’attentato di Serajevo e la conseguente prima guerra mondiale. Una settimana dopo, il 6 luglio, a Montevideo è una sera come le altre che vede Delmira dileguarsi, col favore della penombra, sulla Calle San Josè, dove era tornata a risiedere con i genitori. Un passo sostenuto, a tratti affrettato; va, a testa bassa, decisa, con un’espressione malinconica ed incompresa stampata sul volto, in un rituale che sembrerebbe essere stato già consumato molte altre volte. Traversa tre isolati, poi volta sulla Calle des Andes e s’intrufola in uno stabile, luogo di un probabile appuntamento. Di lì, non ne uscirà più viva. Poco più tardi, una sequenza di spari richiamerà l’altrui attenzione: scatta l’allarme. Giungono sul posto autorità e stampa. E’ nuda, prossima al letto, con le calze ancora scese; capace ancora, per i tempi, di suscitare meraviglia e scandalo. Enrique, trovato in fin di vita insieme a lei, non c’è più, è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove morirà un paio d’ore più tardi. Resta Delmira, sul pavimento, freddata con due colpi in testa all’istante: la sua foto subito immortalata dai giornali. “Dramma orribile e strano” è il commento nello sgomento dell’epoca per il fatto e disorientati si resta anche oggigiorno per talune conclusioni improntate dai cronisti: “I due si amavano, erano la coppia ideale”, suona, a dir poco, retorico ai nostri tempi. Inoltre, scartabellando scartoffie, si scopre che il divorzio è stato da lei richiesto poco dopo il matrimonio e con procedura d’urgenza per “agravios graves”. Delmira conosce Enrique a ventidue anni, una relazione che dopo un quinquennio culmina con un matrimonio, separazione e divorzio, pronunciato dopo appena sei mesi. Sua madre, per la cronaca, è contraria alle nozze. La coppia, in ogni caso, continua a vedersi clandestinamente durante tutto il periodo del processo. Stesso grado sociale, ambedue provenienti da famiglie borghesi ed agiate ma, mentre Delmira va sempre più affermandosi come poetessa di gran talento tra gli intellettuali dell’epoca, Enrique è tacciato di essere poco incline al mondo artistico e lei stessa, separandosi, lo definirà un “vulgar”. Ipotizzabile, come del resto hanno concluso in molti, che il movente sia la gelosia. Di certo vivevano grandi difficoltà nel loro rapporto amoroso e, forse, il “vulgar” aveva tanta sensibilità che non riusciva a trovare comprensione nei suoi confronti. In una lettera di Delmira, emergono i ricordi di come lui si oppose a possederla, quando fu lei a proporglielo. Uomo, in ogni caso, di un altro secolo, un sanguigno appassionato in una Montevideo che, nel non lontano 1995, Sandro Veronesi percepiva ancora in una “concezione orgogliosamente antimoderna della dinamica sociale, fatalista, quasi risorgimentale”. Nessuno ha potuto confermare appuntamenti di Delmira con altri uomini oltre a quelli con Enrique, il tutto limitato alla deduzione che, se fosse successo, la stampa lo avrebbe diffuso. Ma avrebbe mai permesso una famiglia importante, come quella di Delmira, una cosa del genere? Lei, non aveva di certo mancanza di pretendenti, aveva una grazia tale da abbagliare gli uomini, oltre indiscusse doti di comunicazione. Di fatto, Manuel Ugarte, scrittore argentino, viaggiatore e a sua volta seduttore, nel 1913 soggiorna a Montevideo e si vede con lei. In agosto partecipa, insieme ad altri intellettuali, alla cerimonia nuziale e come testimone della sposa. Di lui, con il quale mantiene fitta corrispondenza, Delmira confiderà più tardi a Dario, padre del modernismo ed amico di entrambi, che è stato il tormento della sua prima notte di nozze. Molte delle lettere inviate da Delmira ad Ugarte sono andate perse privandoci per sempre d’importanti documenti. Taluni affermano distrutte dalla moglie di Manuel. Alberto Zum Felde non ha dubbi e la dichiara casta per tutta la vita precisando che “mai nessun altro uomo, oltre suo marito, ha avuto tratti carnali con lei”. Carlos Vaz Ferriera si limita a commentare: “com’è arrivata a sapere come a sentire quanto ha messo in certe pagine è qualcosa di completamente inesplicabile”. Resta l’ipotesi di una probabile relazione frustrata e tracce di reticenza da parte di Ugarte, uno spirito avventuriero che sembrerebbe non volersi troppo compromettere. A proposito di gelosia, tarli, fantasmi o presunti tali, nel 1882, in uno dei suoi più bei racconti intitolato “Le fou”, Maupassant scriveva: “Ero geloso, ora, del cavallo muscoloso e veloce, geloso del vento che le accarezzava il viso quando andava di corsa pazza; geloso delle foglie che baciavano, passando, i suoi orecchi; delle gocce di sole che le cadevano sulla fronte attraverso i rami; geloso della sella che la portava e che stringeva con le cosce”. Ma torniamo ancora più indietro, Delmira lascia un altro uomo, Amancio Sollers, per iniziare il suo fidanzamento con Enrique che, da quanto si evince dalle sue lettere a Dario, sembrerebbe non coinvolgerla troppo. Poi, durante il divorzio, nella corrispondenza come nelle poesie, trapela un forte trasporto, si notano timori e coinvolgimenti, tutti incentrati sulla sua vita privata. L’amore, attraverso una passione ardente e controversa per Enrique, sembrerebbe venir fuori alla fine, trasformando suo marito in un amante attraverso incontri clandestini. Maupassant, il suo risvolto novellistico, lo descrive così: “gli avvicinai la canna della pistola all’orecchio… e lo uccisi… come un uomo. Ma caddi io stesso, con il viso sferzato da due colpi di scudiscio; e poiché ella si avventava di nuovo contro di me, la colpii nel ventre con l’altra pallottola che restava. Ditemi, sono pazzo?”. E’ la morte che giunge restando sospesa tra la crudezza degli eventi ed un mondo visionario, sensuale e lirico. Una morte a lungo sedimentata nella ragione, come nella brama, di una coraggiosa ricerca dell’amore, quello più completo, tanto viscerale quanto etereo, comunque perfetto.
DELMIRA AGUSTINI [1886 – 1914] di Enrico Pietrangeli - 2006
Un’esistenza dissociata nella poesia [2° parte]
L’Uruguay, molto prima del resto del mondo, accetta il divorzio, il rispetto per la dignità della donna (nel ’38, mentre noi vinciamo il secondo “mondiale”, qui le donne vanno a votare) ed una più ampia tolleranza verso il prossimo ma resta, tuttora, un paese relativamente piccolo e con qualcosa di conservatore. La famiglia di Delmira, al di là del fatto di essere altolocata e di principi moderati nella Montevideo dell’epoca, adora “la nena”, appellativo preservato da Delmira anche crescendo, e non c’è cosa che le impedisca di fare. Ma “la nena” si direbbe anche ubbidiente: è la bambina di casa in una famiglia funzionale e stabile. Il padre si occupa, prevalentemente, di mantenere una posizione benestante, mentre la madre s’inorgoglisce in un’idolatria verso la figlia, in un rapporto che, inevitabilmente, crea dipendenza tra le due. Personalità protettrice e dominante è la figura materna mentre, puritanesimo e rettitudine, caratterizzano il padre. Rinchiusa nella comoda vita famigliare, rispettata nei suoi isolamenti di poeta, l’educazione avviene all’interno del nucleo famigliare. È la madre che provvede all’educazione basica della figlia. Il padre la istruisce in musica e pittura. Vive così lontano da una vita di relazioni sociali, senza andare a scuola e giocare con altri bambini. Inizia a prendere lezioni esterne soltanto con l’adolescenza, specializzandosi in francese, musica e pittura. Affettuosa ed incline alla malinconia, è una bambina bella, bionda e con due occhi chiari, intensi ed espressivi che, stando alle testimonianze di taluni, assumono colorazioni dal celeste al verde secondo la luce. Scriveva fin da allora, sotto la rigida vigilanza della madre che, oltre ad essere autoritaria, aveva risvolti morbosi di gelosia nei confronti della figlia. Sembra che sia il padre a ricopiare, con pazienza, i disordinati quaderni de “la nena”. Nel tempo si ritroverà a trascrivere i versi sempre più erotici che Delmira man mano compone. Ma “la nena” cresce e, oltre ad essere intelligente e colta, assume anche un aspetto sempre più attraente, marcatamente sensuale. Ha un corpo appariscente e, soprattutto, uno sguardo carico di erotismo, tanto da risultare imbarazzante e mettere in soggezione persino i genitori che non potevano, di certo, ignorarlo. Alejandro Caceres insinua un progetto famigliare corredato di particolari consegne per prendersi cura della figlia prodigio e che includeva, tra le altre, pratiche anticoncezionali. Silvia Molloy commenta l’infantilismo deliberato che l’autrice utilizza come maschera di convenienza e protezione. Martin Lopez, il suo insegnante di musica, ci conferma che era sottomessa a sua madre da sembrarne incatenata. Alberto Zum Felde afferma che, in presenza della madre, si mostrava ricattata ed esemplare cambiando completamente attitudini quando se ne andava. Non si può dire, quindi, che viva in un’urna di cristallo, ci risulta che ha rapporti con sue coetanee, mantiene un’amicizia personale con la scrittrice Maria Eugenia Vaz Ferriera e corrispondenza con diversi altri letterati contemporanei tra cui Ruben Dario, che poi conoscerà personalmente. “La nena”, che non verrà mai meno, risponde agli schemi della società del momento ed è una forma che Delmira preserva nella vita privata, mentre, dall’altra, la scrittrice si cimenta piuttosto esplicitamente in tematiche sessuali. Si comporta molto diversamente da quanto espone nei suoi versi, perlomeno così lascia intendere. La critica del tempo, non a caso, ha in qualche modo velato questa sessualità che si pretende inesistente per le donne dell’epoca. Nel tempo, molti studiosi asseriscono che Delmira aveva una doppia personalità, alcuni addirittura multiple. Ofelia Machado, in uno studio pubblicato nel 1944, realizza ricerche e raccoglie testimonianze tra le persone che hanno avuto contati con lei. Tutto sembrerebbe coincidere in un modello esemplare dalla condotta impeccabile: amabile, rispettosa, attenta e cordiale, simpatica e brillante ma senza essere provocatoria. Stando a quanto fin ora riportato, viene naturale, al giorno d’oggi, interpretare il suo erotismo come un desiderio frustrato, frutto di passioni amorose inappagate. Raramente, nelle sue poesie, possiamo identificare un uomo, un volto, un’identità definita; qualcuno ha cercato di spiegarlo in un amante ideale ed astratto. E’ la poesia, in ogni caso, a dominarla: una forma mistica del desiderio esposta con destrezza allegorica, qualcosa che una donna doveva, per forza di cose, imparare in quei tempi. Convive in lei un erotismo poetico che non corrisponde all’immagine della bambina cresciuta, quella inibita dalla forte pressione famigliare, soprattutto da quella che la vede assoggettata alla figura materna. “La nena” si direbbe anche donna ed impiega immagini audaci e davvero poco convenzionali per lasciarcelo intendere, immagini che manifestano i suoi impulsi amorosi, in forma attiva, identificandosi perciò all’uomo. Ma “La nena” non interagisce soltanto con i genitori, poiché è in questa veste che è solita relazionarsi anche con Enrique, suo marito. Lui vive la Delmira che gli scrive lettere utilizzando espressioni puerili, ma ignorando, probabilmente, l’altro aspetto della sua personalità, quello che sopravvive, tormentato ed intellettuale. E’ quello della donna che scrive poesie e si confronta con diversi artisti e critici dell’epoca (Ruben Dario è il prediletto, in quanto da lei considerato suo maestro); dove la forma con cui si esprime scorre in uno stile più attento e profondo rispetto l’altro, vezzoso ed infantile. “La nena”, sottomessa ed affabile, e la donna, ardimentosa e libera. La sua è una vita scissa, una dicotomia tra una condotta irreprensibile e l’altro aspetto, quello innovativo ed inquietante, fatto di celebrazione erotica nella poesia; un dualismo che si riscontra nell’intimo, in pulsioni condivise e osteggiate tra corpo ed anima e nelle quali si ritrova impigliata senza trovare un equilibrio. La sua è un’esistenza dissociata nella poesia, una poesia pregna d’immagini che riflettono contraddizioni: domina una costante lotta interiore, si vive in una ragione opposta al sentimento, in un piacere tanto estatico quanto carnale ma mai disgiunto dal dolore. “Riposa del suo fuoco, si purifica della sua fiamma” sono le parole con cui la salutò Alfonsina Storni, allora ventiduenne, in occasione della sua morte. “Preferirei quasi che non scrivesse” è un significativo commento, o strano presagio che si voglia, attribuito alla madre.
DELMIRA AGUSTINI [1886 – 1914] di Enrico Pietrangeli - 2006
Un caso nella poesia ispanoamericana [3° parte]
L’Uruguay, attraverso la figura di Delmira Agustini, apporta nuova linfa al contesto letterario ispanoamericano, è il paese dove si ravvisano i primi palesi tratti erotici nella poesia femminile. E’ qui che si rende possibile quel substrato culturale, contraddittorio ma permeabile, affinché un personaggio come lei prenda consistenza. Icona di progresso, emancipazione ed indipendenza, nondimeno femminile, fragile e sensibile; è considerata una delle più straordinarie voci tra le donne e non solo della modernità latinoamericana. Per la cronaca, da noi le donne nel ’46 andranno a votare, mentre per i “mondiali” gli uruguaiani dovranno attendere quelli del ’50 (strano intreccio compartito tra “due mondi” quello delle prime quattro edizioni della coppa Rimet). E’ Ruben Dario in persona a dare solennità al caso Agustini e, nel ’12, durante il suo soggiorno a Montevideo, commenta a tal proposito: “Tra quante donne oggi scrivono in versi, nessuna mi ha impressionato nello spirito come Delmira Agustini, per la sua anima senza veli ed il suo cuore in fiore. E’ la prima volta che compare in lingua spagnola un’anima femminile nell’orgoglio della verità della sua innocenza e del suo amore, per non essere Santa Teresa, nella sua esaltazione divina”. Con “Los calices vacios”, ultimo libro pubblicato in vita da Delmira, lo stesso Dario curerà l’introduzione ribadendo l’aspetto mistico del suo erotismo e sottolineandone lo spessore quale raro esempio d’intuizione e genialità. Sono versi “ sinceri e poco meditati” è la definizione che ne dà la stessa Delmira in una nota alla prima edizione del ’13. Arturo Sergio Visca, a proposito della sua scrittura, ci dice: “la sua non era una poesia mistica, bensì di sesso puro". Alberto Zum Felze, che realizza uno studio critico per l’edizione completa delle sue poesie, nega sensualità alla poetica dell’autrice definendola intollerabile i tempi. Sostiene che, chi vede in Delmira soltanto una poesia erotica, è preda di un grosso errore; nei suoi versi c’è un profondo erotismo, ma che trascende la carne come pure la comprende. Al di là delle interpretazioni, c’è una mistica del sesso che riporta alla memoria Anaïs Nin: tutta la volontà di affrontare e determinare il proprio destino di donna e artista dando coraggiosamente forma all’irrazionale, liberandosi da falsità e convenzioni. Ma qui siamo già nel pieno del ventesimo secolo e, attraverso il femminismo, cadono, palesemente, veli ed allegorie. L’autrice, pur essendo saldamente ancorata a valori e riferimenti del modernismo, risente di certi modelli europei formativi, soprattutto francesi, e di un linguaggio “intossicato” dal romanticismo, dove l’erotismo libera spirito e corpo superando i limiti della ricerca vincolata al solo divino, al puro ideale. Il fenomeno modernista, perseguendo un desiderio di conoscenza della realtà attraverso la rivelazione delle forme ed interpretandone allo stesso tempo il mistero, è un percorso che agevola e sviluppa fortemente la trascendenza nel dialogo tra carnalità e spiritualità intrapresa dall’Agustini. El libro blanco (Frágil) e Cantos de la mañana, rispettivamente del 1907 e del ’10, sono gli altri due precedenti libri pubblicati da lei in vita. Molte delle poesie contenute in queste raccolte sono già uscite su riviste ed alcune sono state già tradotte anche in francese. Ma è nel 1902 che Delmira inizia la sua attività artistica attraverso la rivista “La alborada”, dove tiene una rubrica scrivendo sotto pseudonimo di Joujou. Ha solo sedici anni, ma inizia toccando subito temi sociali, come quella del distacco delle donne dal mondo culturale (altro argomento tanto caro ad Anaïs Nin in tempi più recenti). La sua è, indubbiamente, una famiglia borghese colta, in grado di darle supporto e strumenti fin dalla più tenera età, e che, come per gran parte della popolazione dell’area, è di origini miste con ascendenze italiane. Nello specifico, ci sono tracce di un nonno francese, l’altro tedesco, mentre le due nonne sono già considerate come uruguaiane e la madre ha sangue argentino. Era solita comporre di notte, al lume di una candela o nel parco, dove si recava a passeggio oppure mentre suonava il piano, testimonianza, quest’ultima, resa a Machado dal fratello, unico e di cinque anni più grande di lei. Dieci anni dopo la sua morte, nel 1924, Maximino Garcia, amico di famiglia, pubblica due volumi inediti: “El rosario de Eros” e “Los Astros del Abismo”.Nell’edizione de “El rosario de Eros” l’editore include un racconto sulla vita di Delmira intitolato “Rumbo”, dove si limita certa propensione all’esagerazione sentimentale e che, apparentemente, si direbbe redatto dalla famiglia. Sia come donna che come poeta, tutto converge in un'unica ricerca, affrontata oltre ogni limite e ragionevole rischio, tanto da trovare una tragica morte ad attenderla nel suo cammino, e questo “tutto”, per lei, altro non era che l’amore. Aveva nella sua anima un’ansia della conquista dell’inconquistabile, il desiderio di un amore perfetto, abbagliante. “Tu che puoi tutto di me / In me devi essere Dio!” sono versi di una donna che potrebbe rivolgersi a Dio come se fosse un uomo e ad un uomo come se fosse Dio. Sono tematiche che non la vedono per niente così lontana, se non geograficamente, dalla mistica di Rumi, il quale osa rappresentare Dio come “Sposa” mettendoci però anche in guardia dalla misteriosa, totale ed assoluta forza che l’amore è capace di sprigionare. Delmira celebra il mistero dell’erotismo, traversa le paludi di un antico binomio: amore e morte. Vive con dolore il desiderio amoroso, una frustrazione che l’accomuna con l’antico modello di Saffo. Lambisce, più che conseguire, un livello mistico per un’innocente predisposizione del suo cuore ma, tuttavia, n’è a sua volta vittima in una follia intima ed implosiva, in tutto il masochismo che asseconda nel tentativo assoluto di conseguire amore. Eros, non a caso, viene da lei definito “padre cieco” e finisce col manifestarsi come una drammatica rivelazione. In “Otra estirpe” ci sono immagini forti, che scorrono attraverso la fisicità ed i relativi simboli, con piene allusioni ad un corpo ardente di passione, trasgressione e voluttuosità espressa nel linguaggio degli uomini, una linea che vedrà poi scrittrici come Juana de Ibarbourou (oltremodo Delmira è considerata anticipatrice delle tematiche del postmodernismo) ma anche Sylvia Plath e la stessa Sexton… Passione che, nondimeno, è espressa con un ideale d’innocenza, come nel caso di “En silencio”, aspersa tra i sogni, per infonderci della sacra ebbrezza (“La miel”) ma che è anche regale e oscura, progenie di una specie che si nutre di pianto (“El vampiro”). Valutare i confini tra la sua esperienza carnale e l’erotismo fantasticato, è argomento lontano dal nostro attuale mondo e modo di pensare, quindi da percepire in quel contesto, nell’alone di leggenda che quei tempi hanno reso comunque possibile. Resta, dopotutto, quel che doveva restare: i suoi versi, mai logori al di là del tempo, sempre sublimi e disarmanti, qualcosa di misterioso e che non si potrà mai fino in fondo spiegare. Resta una spontanea grazia devoluta in tutta la sua ossessione erotica, la memoria di una donna molto audace, un’anima tempestosa e spettacolare, capace di portare alla luce il più remoto intimo rendendone partecipe il lettore.
Le poesie, con testo originale
Le poesie di Delmira Agistini
¡Ven dolor!
¡Golpéame, dolor! Tu ala de cuervo
bate sobre mi frente y la azucena
de mi alma estremece, que más buena
me sentiré bajo tu golpe acerbo.
Derrámate en mi ser, ponte en mi verbo,
dilúyete en el cauce de mi vena
y arrástrame impasible a la condena
de atarme a tu cadalso como un siervo.
No tengas compasión. ¡Clava tu dardo!
De la sangre que brote yo haré un bardo
que cantará a tu dardo una elegía.
Mi alma será el cantor y tu aletazo
será el germen caído en el regazo
de la tierra en que brota mi poesía.
Vieni dolore!
Colpiscimi, dolore! La tua ala di corvo
percuote la mia fronte e il giglio
della mia anima rabbrividisce, meglio
mi sentirò colta dal tuo aspro pugno.
Versati nel mio essere, entra nel mio verbo,
disciogliti nell’alveo della mia vena
e trascinami impassibile alla condanna
di legarmi al tuo patibolo come un servo.
Non avere pietà. Conficca il tuo dardo!
Del sangue che sgorga farò un bardo
che canterà un’elegia alla tua freccia.
Sarà la mia anima il poeta e la tua ala,
vibrando, sarà il germe caduto nel grembo
della terra, laddove germoglia la mia poesia.
La copa del amor
¡Bebamos juntos en la copa egregia!
Raro licor se ofrenda a nuestras almas,
¡Abran mis rosas su frescura regia
a la sombra indeleble de tus palmas!
Tú despertaste mi alma adormecida
en la tumba silente de las horas;
a ti la primer sangre de mi vida
¡En los vasos de luz de mis auroras!
¡Ah! tu voz vino a recamar de oro
mis lóbregos silencios; tú rompiste
el gran hilo de perlas de mi lloro,
y al sol naciente mi horizonte abriste.
Por ti, en mi oriente nocturnal, la aurora
tendió el temblor rosado de su tul;
así en las sombras de la vida ahora,
yo te abro el alma como un cielo azul.
¡Ah, yo me siento abrir como una rosa!
Ven a beber mis mieles soberanas:
¡yo soy la copa del amor pomposa
que engarzará en tus manos sobrehumanas!
La copa erige su esplendor de llama...
¡Con qué hechizo en tus manos brillaría!
Su misteriosa exquisitez reclama
dedos de ensueño y labios de armonía.
Tómala y bebe, que la gloria dora
el idilio de luz de nuestras almas;
¡marchítense las rosas de mi aurora
a la sombra indeleble de tus palmas!
Il calice dell’amore
Inebriamoci, uniti nell’insigne calice!
Raro liquore in offerta alle nostre anime,
rivelino le mie rose la règia frescura
all’ombra indelebile dei tuoi palmi!
Fosti tu, nella silente tomba delle ore,
a destare la mia anima assopita;
a te il primo sangue della mia vita
nelle coppe di luce delle mie aurore!
Ah! La tua voce, vino a ornare d’oro
i miei tenebrosi silenzi; tu rompesti
il gran filo di perle del mio pianto,
all’alba dischiudesti il mio orizzonte.
Per te, nel mio levante oscuro, l’aurora
distese il rosato fremito del suo tùlle;
tanto che ora, nelle ombre della vita,
spalanco l’anima come un cielo azzurro.
Ah, mi sento aprire come una rosa!
Vieni a suggere i miei regali mieli:
sono, dell’amor, la coppa sfarzosa
che si poserà tra le tue mani divine.
Il calice innalza il suo splendor di fiamma…
Che sortilegio nelle tue mani sarebbe!
La sua misteriosa delicatezza reclama
dita di fantasia e labbra di armonia.
Prendilo, che nella gloria s'indori
l’idillio di luce delle nostre anime;
le rose della mia aurora si velano
all’ombra indelebile dei tuoi palmi!
El Vampiro
En el regazo de la tarde triste
Yo invoqué tu dolor... Sentirlo era
Sentirte el corazón! Palideciste
Hasta la voz, tus párpados de cera,
Bajaron y callaste y pareciste
Oír pasar la Muerte... Yo que abriera
Tu herida mordí en ella ¿me sentiste?
Como en el oro de un panal mordiera!
Y exprimí más, traidora, dulcemente
Tu corazón herido mortalmente,
Por la cruel daga rara y exquisita
De un mal sin nombre, hasta sangrarlo en llanto!
Y las mil bocas de mi sed maldita
Tendí á esa fuente abierta en tu quebranto.
…………………………………………………
¿Por qué fui tu vampiro de amargura?
¿Soy flor ó estirpe de una especie obscura
Que come llagas y que bebe el llanto?
Il vampiro
Nel grembo della triste sera
invocai il tuo dolore…Sentirlo era
coglierti il cuore! Impallidisti
del battito delle tue palpebre di cera.
Scesero e tacesti, sembrasti
sentir passar la morte…Che aprissi
la tua ferita addentandola, mi sentisti?
Come mordessi nell’oro di un favo!
E, dolcemente, strinsi forte, traditrice,
Il tuo cuore già mortalmente ferito
dalla crudele spada, rara e squisita,
di un male senza nome per sanguinarlo in pianto!
E le mille bocche della mia sete maledetta
si protesero alla fonte nel tuo strazio aperta.
…………………………………………………
Perché fui il tuo vampiro d’amarezza?
Sono fiore o stirpe di una specie oscura
che divora piaghe e si nutre di pianto?
La miel
Busca en la miel de lo sueños
Sagrada Embriaguez. Sin ceños
Se abre a ti la mar dorada.
Boga, Simbad de lo sueños!
Peregrino de una hada
Cruza climas halagüeños
Lleva tu boca enmelada
Al beso de miel del hada.
¡La suma miel! Mas tú toca
Un punto la maga boca
Y alza un dique de diamante
Entre ella y tu golosina.
-Goza la flor un instante
Y... cuidando de la espina.
Il miele
Cerca nel miele dei sogni
la sacra ebbrezza. Senza più crucci
ti si apre un mare indorato.
Voga, Simbad dei sogni!
Peregrino di un’incantatrice
che attraversa lusinghieri stati
porta la tua bocca addolcita
al mieloso bacio della fata.
Eccelso miele! Accarezzi
un punto della bocca fatata.
Si erige una diga di diamante
tra lei e la tua prelibatezza.
- Gioisce il fiore per un istante
….facendo attenzione alla spina.
Otra estirpe
Eros, yo quiero guiarte, Padre ciego...
pido a tus manos todopoderosas
¡su cuerpo excelso derramado en fuego
sobre mi cuerpo desmayado en rosas!
La eléctrica corola que hoy despliego
brinda el nectario de un jardín de Esposas;
para sus buitres en mi carne entrego
todo un enjambre de palomas rosas.
Da a las dos sierpes de su abrazo, crueles,
mi gran tallo febril... Absintio, mieles,
viérteme de sus venas, de su boca...
¡Así tendida, soy un surco ardiente
donde puede nutrirse la simiente
de otra estirpe sublimemente loca!
Un’altra stirpe
Eros, voglio guidarti, Padre cieco…
chiedo alle tue onnipotenti mani
Il suo eccelso corpo cosparso in fuoco
sopra il mio, consumatosi in rose!
L’elettrica corolla che oggi dispiego
brinda al nettare di un giardino di Sposi;
per i suoi avvoltoi la mia carne consegno
in tutto uno sciame di colombe rosa.
Alle due serpi del suo abbraccio, crudeli,
dà il mio febbricitante stelo…Assenzio, miele,
versami nelle sue vene, nella sua bocca…
Così protesa, sono un cocente solco
dove nutrirsi potrà la semente
di un’altra folle, sublime stirpe!
El silencio...
Por tus manos indolentes
Mi cabello se desfloca;
Sufro vértigos ardientes
Por las dos tazas de moka
De tus pupilas calientes;
Me vuelvo peor que loca
Por la crema de tus dientes
En las fresas de tu boca;
En llamas me despedazo
Por engarzarme en tu abrazo,
Y me calcina el delirio
Cuando me yergo en tu vida,
Toda de blanco vestida,
Toda sahumada de lirio!
Il silenzio…
Per le tue indolenti mani
Il mio capello svigorisce;
soffro ardenti vertigini
per le due tazze di moka
delle tue pupille calde;
più che mai pazza divento
per la crema dei tuoi denti
nelle fragole della tua bocca;
tra le fiamme mi logoro
per legarmi al tuo abbraccio,
e mi calcina il delirio
quando mi ergo nella tua vita,
tutta di bianco vestita,
aromatizzata al giglio!
Traduzioni di
Le foto

Delmira Agustini: 1894 (8 anni) “La nena”

Delmira Agustini: 1904 (18 anni)

Delmira Agustini: 1908 (22 anni)

Delmira Agustini: 1911 (25 anni)

Delmira Agustini: 1913 (27 anni) ritratta durante il matrimonio con Enrique Job Reyes

Delmira Agustini: 1914 (28 anni) ripresa dai giornalisti accorsi sul posto dopo la sua tragica fine
Poesia e internet / 4: Nabanassar e Viadellebelledonne
Estromessa dalla carta stampata quotidiana e periodica, la poesia è entrata significativamente nel mondo di internet, con un fiorire di iniziative che fanno capo a siti, blog, riviste on-line, aggregatori. Tutto questo, se da un lato testimonia la sua vitalità, al passo con le nuove tecnologie e con i tempi, dall’altro pone esigenze di comprensione e studio del fenomeno.
Per capirne potenzialità e limiti, per offrire nello stesso tempo una chiave di lettura e una mappa, un’istantanea della situazione, dal numero 6 “Carte nel Vento” opera una sorta di ricognizione in rete, attraverso i principali operatori della poesia nel web.
Nei numeri precedenti:
Vincenzo Della Mea, Un colpo d’occhio sulla rete della poesia
Christian Sinicco, Qual è il centro? Internet, tra passato e futuro
Claudio Di Scalzo, In sintesi
Luigi Nacci, La grande proletaria dei poetinternauti s’è mossa, o no?
Marco Giovenale, I vicini (quasi non) ci guardano
Massimo Orgiazzi, Poesia e web: esperienza diretta, riflessione e punti chiave per un’evoluzione futuraNabanassar: Della Rete o del Dilettante
Cosa giustifica l'ascolto? La speranza di assistere ad un capolavoro, quel brevissimo periodo nel quale "senti le farfalle", come dice Ronnie O'Sullivan a proposito del suo ultimo 147: http://www.youtube.com/watch?v
In “Werther” il passaggio da Omero ad Ossian, dall’idillio alla catastrofe. Dove la nostra catastrofe? L’iperrazionalismo oscuro de “La nuova Justine” (ancora di più in “Juliette”), tutta la fiducia ribaltata in terrore; solo la consapevolezza di un’impossibile risoluzione modifica i linguaggi e il panico diventa l’occhio lucido della disillusione. L’assenza (in questo caso d’illusione) porta alla constatazione che per riempire il vuoto occorre accettare la sua evidenza come unica realtà consistente. l’unico punto fermo è la nostra instabilità che in termini etici è un’effettiva necessità. È tempo velocemente consumato, questo, di aerei caduti e scatole nere disintegrate; nelle case non vi sono salvadanai. Insomma, si è finiti, a fischi e peti. Accade perché si sogna di fare lo scrittore. E credo sia proprio questa pellicola vischiosa che imporpora gli occhi a rincitrullire. Non si comprende il diafano e abissale sversamento di “tragico”. È il mestiere – ci soccorre il Sogno dello Scrittore. Il sensazionalismo “calibrato”, volta per volta, dà loti piccini, e allappanti. Ed infatti, ci si interessa a tutti, si aprono le gabbie, ci si crea il pubblico, lo si fidelizza con la buona parola. Minima pubblicità.
Riscoprire il ruolo dell’educatore, maschera di una professione. Far bene, fare il proprio dovere (riallacciandoci alla perdita di responsabilità dei lavoratori descritta negli esempi di Magrelli su Nuovi Argomenti n.40, ottobre-dicembre 2007). Gli scrittori sensibili sono civili, sono scrittori civili; non hanno paura del dardeggiamento, quindi. Noi, invece, siccome crediamo che la civiltà segua vie dirette, men che meno “esortazioni” tirtaiche (A. Seri qui http://lapoesiaelospirito
http://www.nazioneindiana.com
Pasciuto è un aggettivo un po’ lontano da una certa afflittiva retorica poetica, ma non occorre molto per potercisi identificare: una cultura da scuola superiore o universitaria, un pc da un paio di centinaia di euro e una buona connessione internet sono molto più di quanto tre quarti del mondo può sognare. Il “terzo millennio occidentale” è quindi un ottimo recinto nel quale operiamo volentieri (www.nabanassar.com), consapevoli di essere appunto pasciuti e disposti a restituire almeno parte dei vantaggi, sotto forma di condivisione dei testi. Per anni abbiamo avuto dentro di noi il pensiero che ci fosse bisogno di una "classe poetica", di gente competente, ma soprattutto seria. Se la "classe critica" dovesse essere quella che vien fuori dalle facoltà di Lettere e svolge questo mestiere con cognizione di causa, va benissimo. Il Dilettante è il blogger, la casalinga, l'amatore, ma anche il narratore che sfonda la sua misura e firma appelli credendoli arte o dovere: mentre non lo sono perché stanno fuori il discorso, non lo seguono, non stanno nel solco degli strumenti ad essi stessi minimi e necessari; sono un calco smorto di ciò che è già stato esorbitato e nemmeno vogliono sentirselo dire; stanno incollati ad un indistinto letto plastico e non biodegradabile che urla presenza, presenza, presenza.
Antonella Pizzo (Viadellebelledonne): Fino a qualche anno fa
Fino a qualche anno fa della poesia non mi importava niente, conoscevo gli autori che avevo studiato alle superiori, ho studiato ragioneria e poi mi sono iscritta in Economia e Commercio. Il programma scolastico si concludeva con una veloce scorsa ai contemporanei, e per contemporanei allora si intendeva fino a Montale e Pasolini. Dopo non ho più saputo niente di nessun poeta fino a quando vidi in televisione la Merini, mi colpii molto la profondità della sua voce, delle sue parole. Ho provato ammirazione per lei, per questa donna che aveva sofferto e che aveva sublimato la sua sofferenza nella poesia. Non ricordavo di poetesse donne, i poeti che avevo studiato a scuola erano tutti maschi. Manzoni, Foscolo, Pascoli, Dante, Cavalcanti, Petrarca. Avevo sentito parlare di Saffo, ma la sua figura era spesso associata all’amore lesbico, quindi in un certo senso, qualcosa di assimilabile all’universo maschile. I poeti li pensavo tutti morti, estinti, invece esistevano ancora, li pensavo tutti uomini e invece erano anche donne.
Incidentalmente incontrai la poesia, un giorno scrissi con urgenza ciò che volevo dire nell’unica forma in cui mi fu possibile farlo, in forma poetica. Così cominciai a cercare la poesia su internet, scoprii i gruppi di discussione, nello specifico it.arti.poesia e it.arti.scrivere. I gruppi erano e sono una sorta di forum-bacheche dove si pubblicano i propri pezzi e poi si sta lì ad aspettare che qualcuno ti legga e ti mandi un commento positivo o negativo, una sorta di laboratorio dove si discute su un verso, su una parola, su una quartina, su un accento, spesso si litiga e altrettanto spesso nessuno ti commenta. E’ stato lì che ho incontrato virtualmente molti poeti: Massimo Orgiazzi, Simone Lago, Roberto Ceccarini, Enrico Besso ed altri. In seguito alcuni di loro hanno aperto dei blog molto conosciuti in rete, ad esempio Massimo Orgiazzi ha aperto Liberinversi, Enrico Besso ha fondato Poetilandia, Ceccarini ha aperto Oboe Sommerso. La mia esperienza di poeta è prevalentemente internettiana, infatti, se si escludono le serate di premiazione a certi concorsi di poesia, non ho mai partecipato a letture pubbliche, slam poetry, convegni, incontri. Credo sia questa l’aspetto positivo di internet, nel bene e nel male, favorisce la scambio.
Se vado in una libreria della mia città faccio fatica a trovare lo scaffale dedicato alla poesia, e quando lo trovo i titoli sono quelli dei pochi poeti affermati o poeti morti da anni, non c’è poesia nuova e se vuoi un titolo di un autore contemporaneo lo devi richiedere (in verità chiedo con molta vergogna, come se richiedessi dei libri porno e scandalosi, così ora acquisto solo su internet) per richiedere un libro prima lo devi conoscere, ne devi aver sentito parlare. E dove, se non su internet?
Internet però è un marasma, ti devi saper muovere, devi saper scegliere, ci sono tantissimi luoghi dove si pubblica poesia ma pochi dove se ne parla. Al contempo è una torre di Babele dove ognuno parla la propria lingua. Alcuni blog, invece, sono come delle roccaforti, inaccessibili, esistono le conventicole e i gruppetti, le bande di quartiere, i cecchini pronti a spararti se non fai parte del gruppo o se dissenti, ma è così anche nella vita reale e quindi la cosa non sorprende più di tanto. Per potermi orientare senza perdermi nel marasma mi sono di aiuto gli aggregatori poetici, vedi Poecast di Vincenzo Della Mea e l’aggregatore di Absolute Poetry. Ultimamente se voglio trovare buona poesia so che posso trovarla, oltre che nei siti che ho sopra menzionato, nel blog di Francesco Marotta “La dimora del tempo sospeso” e su “Blanc de ta nuque” di Stefano Guglielmin; spesso quest’ultimi, oltre a pubblicare la migliore poesia, inseriscono anche dei cappelli critici ai testi e ciò aiuta a comprenderli meglio. Sono luoghi accoglienti e sereni, gestiti da persone generose che mettono a disposizione il loro tempo e il loro sapere per amore della poesia e ne fanno dono agli altri. Accanto a questi voglio ricordare: La costruzione del verso, Farapoesia, Anterem, quest’ultimi sono siti di editori.
Internet è uno strumento eccezionale per la divulgazione della poesia ma per la sua natura non può essere null’altro che questo, è un mezzo veloce che raggiunge tutti ma la velocità, se da un lato è un pregio, dall’altro è un difetto, perchè i testi pubblicati si bruciano subito, per il solo fatto che si leggono sullo schermo perdono potenza, i post scorrono uno dopo l’altro, i blog con la stessa facilità con cui si aprono, chiudono, muoiono. Tutto diventa poco importante, tutto si perde nel prossimo post. La rete, inoltre, non consente l’approfondimento. Se intendi conoscere meglio l’autore che ti ha colpito, che ti interessa, è necessario passare alla carta, comprare il libro, mettersi tranquilli e leggere, studiare, meditare, assorbire, elaborare, digerire. Ci sono, però, dei siti dove si possono trovare delle raccolte poetiche in formato pdf che puoi scaricare liberamente e poi stampare, che puoi conservare e usare come fossero dei libri veri e propri, se ne trovano molti e quasi tutti di ottima poesia ad esempio nel blog di Biagio Cepollaro “Poesia da fare”, in quello di Giovanni Monasteri “Feaci Poesia”, su “Kult Virtual Press” e, ultimamente, anche su “Paginazero”. Pare che i blog che si occupano di poesia vengano letti solo dagli blogger, pare che tutti scrivano e che nessuno legga, probabilmente non si riesce a orientarsi e a leggere tutti perché troppi scrivono; quando nel mercato l’offerta supera la domanda i prezzi crollano, si ha il crack. Si rischia dunque l’estinzione della poesia per iper produttività? Esistono moltissime piccole case editrici che pubblicano centinaia di titoli l’anno, libri che vengono comprati dagli stessi autori e poi vengono utilizzati come gadget ad altri poeti o inviati a critici con la speranza di una qualche recensione. Le grandi case editrici pubblicano pochi poeti e tutti nomi conosciuti, che generalmente vendono quel tanto che a loro basta per soddisfare quella minima richiesta del mercato. Io penso al poeta come una persona sola; nella vita reale, quella che facciamo tutti i giorni, nei luoghi di lavoro, nelle cene fra amici, di poesia non ne vuole sentir parlare nessuno. Il poeta parla e nessuno lo ascolta, allora si rivolge ai poeti ma spesso i poeti sono impegnati a parlare a loro volta e non hanno voglia e tempo di ascoltarli. Insomma le poesie e i poeti non mancano, mancano le letture, critiche e non. Personalmente trovo che il livello della poesia circolante nei luoghi che ho citato, escludendo i casi di cuore sole amore, sia tutta della buona poesia, ma forse è livellata, è tutta buona poesia ma manca la voce che si erge sopra tutte le altre, che ti fa gridare al miracolo, che ti fa dire questo non l’avevo mai letto, il genio che stravolge e ti travolge insomma, ma forse il genio e l’eccelso ci sono e nell’eccessiva nebbia della quantità offerta non si riesce a distinguerne i contorni. Ma aldilà del genio che tutti aspettiamo come il messia della parola poetica, la poesia, benché sia un fare, non è un prodotto, è una manifestazione dell’uomo che ha una sua vita autonoma, come fosse un’entità indipendente, vivrà sempre dentro l’uomo e non morirà mai, fino a quando esisterà l’uomo con ciò che aspetta di dire dentro, ci saranno poeti, e viceversa. Attualmente frequento viadellebelledonne, nato a giugno del 2007 da una mia idea, il blog si ripropone di raccogliere e riunire le voci femminili poetiche disperse qui e là, è un blog letterario collettivo gestito totalmente da donne ma aperto anche a collaboratori esterni, dove, assieme a pezzi di prosa, attualità, arte figurativa e altro, vengono pubblicate poesie di autori e autrici di diversa nazionalità, ma anche pezzi nostri, un blog libero da condizionamenti, dove l’unica cosa che conta è il dire e il fare della poesia, un luogo di scambio e di crescita, di ascolto. Nel blog abbiamo organizzato un concorso di poesia “Un fiore di Parola” dal quale è scaturita un’antologia, abbiamo pubblicato dei quaderni in pdf monotematici. Osip Mandel’Stam componeva nel campo di prigionia e mandava le poesie a memoria perché non poteva scriverle, la Merini al manicomio scriveva col dito sulla polvere, Ungaretti scriveva dentro una trincea, in mezzo ai topi e ai compagni morti, scrivevano e non pensavano al mercato editoriale, alle vendite, alle letture critiche, al successo, al guadagno, ai blog, alle visite, a chi mi legge. C’erano loro e la loro poesia. I pdf, gli e-book, si propongono di evitare la dispersione, ne faremo altri e scriveremo nei blog fin quando ci saranno, poi scriveremo dentro le trincee, nei campi di prigionia, col dito sulla polvere, perché alla poesia poco importa la visibilità, il mercato, l’internet, la poesia esisterà sempre.
Antonella Pizzo
Novembre 2007, anno IV, numero 8
Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura di Ranieri Teti
Il senso di un premio
Un premio di poesia è un osservatorio molto privilegiato: consente al gruppo di lavoro che lo organizza di attraversare le varie tendenze della poesia a noi contemporanea e di cogliere – al di là degli esiti – le diverse ricerche poetiche in atto.
Il Premio Lorenzo Montano ha radici solidissime, fondate sull’esperienza letteraria della rivista “Anterem”. Grazie a tale esperienza nel corso degli anni i poeti della redazione hanno sempre svolto un’attenta indagine critica su tutte le opere pervenute.
Al fine di condividere con i nostri lettori il piacere dell’analisi teorica sui testi, a iniziare da questa edizione abbiamo deciso di rendere pubblica una parte del lavoro critico svolto.
Il risultato è racchiuso nel presente numero di “Carte nel Vento”, in cui è possibile leggere le interpretazioni critiche svolte dai poeti della redazione di “Anterem” su finalisti e vincitori di tutte le sezioni: Angioni, Azzalin, Bona, Celli, Comoglio, Di Cicco, Donelli, Ferraris, Fontana, Frisa, Fusé, Ghignoli, Guantini, Guglielmin, Infelìse, Isella, Marotta, Pepe, Pontiggia, Ricciardi, Rofena, Roncari, Rossi Precerutti, Sala, Solimine, Spataro, Vezzali.
Un'altra parte del lavoro critico si è svolta nei licei, dove gli studenti delle ultime classi sono stati invitati a scrivere brevi saggi su alcune opere, e si è inoltre propagata per più giorni presso gli abituali frequentatori della poesia in città.
L’indagine teorica è diventata successivamente oggetto di un’intera giornata della recente “Biennale” in cui è andato in scena l’incontro, e il confronto, dei poeti segnalati e menzionati dalla 21^ edizione del Premio con i critici.
Il “Montano” indica che il senso di un premio può proseguire a delinearsi anche dopo l’assegnazione dei riconoscimenti. Quando tutto potrebbe essere terminato, può insistere a cercare l’ascolto di quella parola che – come segnala Celan – chiede di mettersi in viaggio verso se stessi.
Il viaggio, naturalmente, continua.
Ranieri Teti (biobibliografia)
cartenelvento@anteremedizioni.it
Giorgio Bonacini: “Oscurità” III
Continua la pubblicazione del saggio sulla poesia scritto da Giorgio Bonacini.Le parti “V” e “IV” sono uscite nei due numeri precedenti di “Carte nel Vento”.
Giorgio Bonacini: Oscurità (parte terza)
III
La poesia, in questo modo, diventa una necessità della mente: una rifles- sione sul significato di un bisogno che ha a disposizione la sua materializza- zione poetica. Ciò significa che la necessità della poesia è la poesia stessa, come atto di invenzione, di trasfigurazione, di riflessione e di conoscenza
Ci si può concentrare su un oggetto e condividerne l’incomunicabilità. In ciò è il significato di un’attività pensante: una perversione formale che non rinuncia mai alla scena, e in cui la condizione stessa della sua determina- zione può portare a un malessere per troppa esattezza.
E’ un concreto andamento di vagabondaggio, ma anche un’assoluta fermezza contemplativa in cui viene rafforzato il significato di un bisogno di esistenza: ed è qui che la necessità di scrivere diventa la cosa scritta, indi- pendentemente dalla sua nascita o dalle sue conclusioni.
Certo, all’inizio è sempre una mancanza, un’ellissi soggettiva, ma tutto ciò che ne consegue non subisce né oppressioni né obblighi: nemmeno il fasci- no dell’ingenuità (che è una rete di sottigliezze innaturali e preziose) è in grado di determinare il segno della poesia.
Bisogna distinguere però fra bisogno e necessità: bisogno di una scelta, ma necessità della sua separatezza. Può essere che non esista l’uno senza l’altra, ma quale venga prima e quale dopo è un problema irrilevante, imper- tinente. E’ l’immagine di una felice (e forse eccessiva) solidarietà.
E se nessuno leggesse le mie poesie? Inutile fingere: la necessità di una corrispondenza esterna interagisce con il bisogno di scrivere. Perciò i versi alludono alla speranza di una loro lettura (forse un’appropriazione indebita): ma nessun poeta si illude che la poesia comunichi, è sufficiente che indichi.
Che cosa chiedere allora alla necessità di un bisogno? Che illumini un sapere? Che dissemini l’io? Che ricrei una realtà? Niente di tutto questo. Semplicemente che la parola sopporti la metamorfosi: l’incedere ostensivo di una voce, tra il disagio del presente e il suo clamore.
Pensare in poesia. Correggere il tiro dell’insignificanza, dove anche l’idea di vuoto non sopporta la sua uniformità. Rimbaud capì l’inutilità reale (non retorica) della poesia: ma per chi non è così visionario e sufficiente percepisco alcune cose e scriverne. Nient’altro.
Ribadire uno stato di necessità: la progressione immaginaria nel dinamismo o nella lentezza, nell’euforia o nell’ansia. Rifinire continuamente e di-
stribuire l’esecuzione, la soddisfazione di un senso. E’ difficile dire a chi in-
teressi tutto questo, ma credo che sia importante provarci.
Non sempre però si è in grado di capire fino in fondo se i fondamenti della poesia siano il prodotto di una conseguenza di scrittura o cos’altro. Per fortuna le scorrerie interiori disturbano i significati, i luoghi comuni, la stupidità; ma non sempre la poesia aiuta a convivere con il disinteresse.
Ancora una distinzione tra necessità e bisogno. Necessità della lette-ratura: di averla fra le mani, in modo cinico o adolescenziale, ma senza averne veramente bisogno. Dobbiamo qualcosa ai libri, possiamo anche crederci uno di loro, ma è una nuvola a inquietarci veramente.
Che tipo di immaginazione, allora, estrarre dalla tecnica di una pagina o concedere alla sua sembianza? L’incongruente (e a volte tenera) sfaccettatura dei suoni e dei pensieri ci fa credere che solo la poesia della mente sia capace di ricomporre fisicamente l’illusione.
Note critiche degli allievi dei Licei “Cotta”, “Fracastoro”, “Maffei”
A partire dalla 19ª edizione del Premio Lorenzo Montano abbiamo istituito un riconoscimento riservato agli allievi dei Licei che collaborano con il Premio componendo parte della Giuria dei Lettori per l’Opera edita. A questi ragazzi, oltre a leggere e votare il preferito tra i tre volumi vincitori per determinare il “supervincitore”, chiediamo di produrre una “nota critica”, individuale o di gruppo, sui libri letti. Le prime tre, prescelte da un’apposita giuria, vengono premiate con “buoni acquisto libri” per una somma di 500 euro.Liceo “Cotta” di Legnago (Vr), prof. Cristina Ferrazza
A commento di “lineamadre” di Maria Luisa Vezzali, Donzelli 2007Di Edoardo Birbini, Vanessa Guarneri, Chiara Melotto, Gianluigi Viviani
Liceo “Cotta”, Legnago (Vr), classe II A b, insegnante Cristina Ferrazza
Nota critica II classificata
Ho sentito le parole farsi brivido,
uscire dalla carta e invadere il cuore,
come raramente accade.
Ho chiesto alla Poesia di farsi comprensibile
e di dialogare con la mia anima di ragazzo
a volte disattento, ma mai tanto
da non cogliere il profondo che si agita;
Le ho chiesto ancora di dialogare con l’anima del mondo
che si è persa
e di indicare ancora qualche strada...
Intirizzito sul terrazzo
un angelo stasera ha trasformato qualche mia ferita in musica
mentre ti leggevo.
A commento della poesia “Bellezza” di Maria Luisa Vezzali
Di Giulia Bottaro, Alessandro Soave, Andrea Zemignani
Liceo “Cotta, Legnago (Vr), classe III A s, insegnante Cristina Ferrazza
Ogni individuo, dotato di fantasia, ha sognato almeno una volta di possedere un paio d’ali per spiccare il volo su terre sconosciute, incontaminate, libere dalla guerra e da qualsiasi disgrazia. Per poterne ammirare la pura e dolce bellezza naturale...
Per poter vedere con i propri occhi luoghi visitati solo nei sogni...
Per antonomasia, quando si pensa a volare, si pensa immediatamente all’aquila reale, il più nobile volatile della terra, un animale in grado di solcare le onde, i monti e le pianure.
Le ali dell’aquila raggiungono luoghi che nessun altro essere può raggiungere e i suoi occhi possono perforare le barriere dettate dalle distanze. Essa infatti possiede una vista telescopica, ma è allo stesso modo incapace di cogliere ciò che un uomo può invece contemplare. La capacità di un uomo di leggere il viso e il comportamento di un altro, per rilevarne le caratteristiche più profonde, è unica di quel genere di persone che vedono attraverso gli occhi.
Occhi e ali d’aquila, e sensibilità umana: il connubio migliore. Questa poesia parla dell’infinità del mondo, della molteplicità degli ambienti e delle più diverse esperienze che si vivono nella vita.
Le brevi strofe, scritte in versi liberi e lasciate sistematicamente in sospeso, spronano il lettore a perseverare nella lettura. Le continue immagini evocate dalla Vezzali alimentano ad arte il clima della poesia: la suggestione è alta, tanto che attraverso la lirica risulta più facilmente comprensibile il sentimento di fondo che l’autrice vuole trasmettere.
Il lettore sembra quasi “trasportato” nel mondo della scrittrice. La poesia è in grado di attanagliare il lettore, proiettandolo verso nuovi orizzonti, verso i mondi nei quali ognuno, nei propri sogni, vorrebbe vivere.
Sorvolandoli con ali d’aquila, osservandoli però con occhi di uomo.
Liceo “Fracastoro” di Verona, prof. Donatella Regazzo
Di Alessandro Adda e Ilaria Miglioranzi, 5^ F
Quando la morale incontra la scienza
Leggendo le poesie di Giorgio Celli, abbiamo avuto l’impressione di sederci spettatori di fronte allo spettacolo maestoso della vita. Ci parla con metafore sceniche, con un linguaggio tecnico ma fortemente emozionale, ci fa gioire con la natura e soffrire con lei.
La lode al DNA ci ha esaltati aprendo innanzi al nostro sguardo un sipario sul mondo in evoluzione, una coordinazione quanto mai armoniosa tra la scienza e le attività vitali dell’universo, in quanto è il DNA stesso, eterna guida degli eventi, a condurre tutto verso il suo destino.
E così l’uomo si sente debitore nei suoi confronti, sente che tutto ciò che gli sta intorno non è nato per caso, ma è da ricondurre inevitabilmente allo stesso eterno principio, lo stesso che, dice Celli, “ha piantato nei mitocondri d’Eva il seme di senape della nostra umanità”.
L’impressione che abbiamo ricevuto ci ha ricordato la ciclicità dell’esistenza, il dinamismo della natura nel suo perenne dualismo: da un lato, amica e “madre”, dall’altro impetuosa e vendicatrice, come l’acqua, elemento che troviamo nel creato, nel nostro interno così come all’esterno, forza vitale che circola nel nostro organismo e dinamica quando precipita nelle cascate mostrando tutta la sua potenza.
La poetica di Celli coordina armoniosamente natura, filosofia, scienza, matematica, come parti inscindibili di uno stesso sistema grandioso, geniale, ma esprime contemporaneamente la preoccupazione per il destino del mondo, manipolato indebitamente dall’uomo “senza ragione”, dai “servi dell’atomo”, e l’abbiamo apprezzata per l’immediatezza delle immagini che propone e per le sensazioni che trasmette, da cui traspare la volontà di fornire un quadro intenso del mondo fisico rapportato con l’uomo, con l’animale, con l’elemento, come parti di un insieme “vivo” che è la Terra.
Di Alessio Graldi, 4^ H
Giorgio Celli, irriverente demiurgo
Nuova “collana di perle” la raccolta “Percorsi” di Giorgio Celli, in cui l’indiscussa bravura di questo scienziato-artista crea una poesia concettualmente legata ad un mondo naturalistico, tuttavia formalmente amalgamata con espressioni e modalità della poesia classica e contemporanea.
Celli, docente all’Istituto di Entomologia “Guido Grandi”, presso l’università di Bologna, svolge da molti anni, oltre ad una carriera politica di elevato spessore (egli è infatti parlamentare europeo dal 1999) anche una brillante attività scientifica, con notevoli partecipazioni in gruppi e ricerche ambientaliste. Svolge inoltre anche un intenso e significativo lavoro letterario, correlato ad ambiti naturalistici e di grande interesse sociale. Vale la pena ricordare la sua partecipazione per cinque anni al Gruppo 63’, e il suo nutrito curricolo che annovera un premio Luigi Pirandello nel 1975 con l’opera “Le tentazioni del professor Faust” e diverse messe in scena delle sue piecè teatrali al Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Nei suoi “Percorsi”, noi giovani riconosciamo il linguaggio della nostra epoca, la nostra esperienza quotidiana.
Giorgio Celli, è per noi un“irriverente Demiurgo” perché capace di plasmare una materia arida e spigolosa come la scienza, abile nel fondere, con precipua originalità, elementi di due materie differenti, sia in composizioni poetiche sia nella vita di tutti i giorni;
Giorgio Celli, è per noi un “mirabile alchimista” perché coniuga una matrice oggettiva, quasi di stampo naturalista, con una rivelazione poetica di elevato spessore.
Ci è piaciuta tanto questa raccolta di poesie che trasmette la passione del poeta per il mondo in cui vive, un mondo teso al progresso, ma strettamente legato alla sua natura madre.
L’immenso infinito fra le sudate carte
Una riflessione sui testi di Gilberto Isella
Di Roshan Youssefian, 4^ H
La musica è arte. La pittura è arte. La poesia è arte.
Ecco, proprio la poesia, finestra di emozioni e pozzo di sentimenti, arte senza inizio e senza fine. Una espressione che permette al lettore non solo di poter concepire le potenti folate di pensiero che essa trasmette, ma anche di aggrapparsi a mondi e concetti sovrasensibili e ultraterreni.
L’arte è indubbiamente una scala che porta al cielo, ma come possiamo compiere questo cammino, salire scalino per scalino, senza che in questa arte non ci sia una vera sensazione spirituale? Continuiamo a ripeterlo: “Ma in che mondo stiamo vivendo?”, “Non ci sono più valori”, “La gente non si eleva più da discorsi inutili”. Eppure c’è chi ci prova:
In una vetrina di psicofarmaci
svolazzano tafani e mosche,
giunti lì per cunicoli a essi solo noti.
I loro umori battono le ali
e si confondono con gli altri umori
vaporanti dai barattoli,
sollevano precipitati, attirano molecole
con sottilissime antenne
e calamite.
Oh, come pulsa la vita
tra larve meccaniche e vetro
mentre aliene minuzie si accoppiano
e ritmi primaverili intrecciano
ronzando intorno a un “sì, bé” molle
che alla follia in sordina dice
”vade retro”.
G. Isella
In questa poesia, Gilberto Isella cerca di innalzarsi, come un aereo che decolla, verso un sentimento elevato, un concetto più chiaro. Purtroppo questa pista è piena di sporcizia che impedisce a questo pensiero di prendere il volo: il materialismo, le inquietudini dell’uomo, le ingiustizie, gli umori ansiosi come un frenetico battito di ali. Percorrere la scalinata dell’arte è impossibile, finché non ci si distacca completamente da ogni inutilità mondana. Certo, l’espressione poetica può anche essere la trasmissione di sentimenti strazianti o semplicemente di pensieri momentanei, ma la vera sensazione di compiacimento la si trova solo quando arrivi all’ultimo scalino, non a metà della rampa. La mescolanza di cose apparentemente molto materiali, come gli psicofarmaci, assieme ad un concetto spirituale, quale la voglia di vivere creano un grande divario che il lettore stenta a capire. Questo continuo sbalzo, tra sole e terra, luce e buio, aria e fango, non aiuta il nostro sentimento a decollare verso un vero e soddisfatto completamento morale della nostra anima.
Di Scala Mattia, IV H
Gilberto Isella: "Corridoio Polare"
Gilberto Isella, nato a Lugano il 25 giugno 1943, ha studiato lettere e filosofia all' università di Ginevra. Dal 1974 insegna lettere al liceo di Lugano 1 e alla SUPSI.
Nel 1979 è stato promotore di una rivista culturale, chiamata "Bloc Notes",di cui ora è coredattore. é anche saggista e ha dedicato molti studi su autori del passato, come Dante, Boccaccio o Ariosto, o contemporanei, ma ha analizzato soprattutto poeti.
Ha seguito un antologia di Mario Marioni, scrive articoli di critica letteratria al 'Giornale del Popolo' e partecipa ad attività culturali dell' "Associazione Alice".
Dal 1989 ha pubblicato molte opere poetiche: "Le vigilie incustodite"(1989), "Leonessa"(1992), "Discordio"(1993), "Apoteca"(1996),"Baltica"(1999), "I Boschi intorno a Sils-Maria"(2000), "Lichene o terra"(2000), "Nominare il caos"(2001), "In bocca al vento"(2005), "Autoantologia"(2006) e infine "Corridoio Polare"(2006).
In questo suo ultimo libro, il poeta inscena una sorta di dramma poetico-filosofico, in cui abbiamo in primo piano il suo alter-ego che cerca di ritrovare la sua identità in un mondo di contraddizioni. Isella trova semplicità, che a volte sembra coincidere con l'ordine geometrico delle cose oppure con la visione della realtà naturale, e follia, che opponendosi gli impediscono di vivere liberamente. Il poeta è dunque prigioniero della necessità, che diventa un ossessione nella vita quotidiana. "Si era messo in salvo oltre il corridoio polare ionico"è il primo verso dell' opera, in cui Isella ci fa capire che attraverso questo corridoio, lui ricerca libertà e serenità.
"Corridoio polare" è dunque un poema governato dall' impari lotta tra follia e semplicità, tra armonia e disarmonia in cui il poeta affronta un percorso di gelo, di solitudine e di follia.
Le poesie presentate nell' opera sono difficilmente accessibili e ricche di metafore e immagini, che ci aiutano a comprendere l' idea del poeta, ma non ci trasmettono, a mio vedere, lo stato d' animo e i sentimenti dell' autore.Liceo “Maffei” di Verona, prof. Luca Bragaja
Nota critica III classificata
Di Giulio Bogoni, Leonardo Cazzadori, Lorenza Cristanini Mion, Prisca Saporiti, Enrico Zucchi, Classe 3^ C
Due viaggiatori solitari camminano nel cuore della notte, inconsapevoli della presenza dell’altro. La donna completamente avvolta nelle spire, negli grovigli insondati della città; osserva incuriosita, cercando di capire il perché degli avvenimenti, ritrovandosi a scrutarli dall’interno. Alcune immagini l’accompagnano nel suo viaggio attraverso la riva asciutta dei viali: s’immerge fra donne belle e schiave, distributori di benzina, ossa di biciclette, oasi di parcheggi, accompagnata dal canto delle cicale, in uno spazio sordo; le appaiono donne-pesce, mostri millenari che riaffiorano dalle ombre, non più dagli abissi del mare, dove un tempo, un’altra notte, forse, rapivano con il loro canto i marinai. Una notte infinita, popolata da mille personaggi nascosti che vivono all’interno di grandi automi spenti, tra mura di fumo e di sassi.
Seduto ai margini di questa città, come fosse sospeso sul precipizio delle stelle, l’altro, lontano, freddo, distaccato, osserva i vari fenomeni e i gesti della quotidianità con un sorriso critico e con la semplice voglia di rimanere fermo a guardare, nonostante talvolta la malinconia, rassegnata e dolce, sfumi la sua prospettiva fin troppo lucida spingendolo a lasciare libero sfogo ai ricordi. La parola è misura, per quanto affollata, che può servire a soppesare, demistificare, chiarire. La scrittura è un viaggio attraverso la vita. Ma lo distrae dal disincanto e dalle riflessioni la comparsa della donna, non ancora al termine del suo cammino, che lo induce a parlare così.
GIORGIO: non mi aspettavo di incontrarti, sembri apparsa d’improvviso. Ma devo dirti una cosa, non so perché. Non sento la mancanza di cosmo, ovunque è il cosmo; tu invece vuoi raccontare le fantasie della tua anima. Il corpo è un museo di storia naturale, e i nostri atomi non sono piccoli figli di Dio, ma piccole parti di noi. Parti del cosmo! Il corpo è una macchina, sta sempre sullo spirito come un ragno sulla mosca, ma non piangere, stirpe di Adamo ed Eva; il tuo pensiero è orribile, sopprimilo!
MARIA LUISA: il mio pensiero è fragile, incerto, ma non lo ucciderò, non so ancora dove sfocerà, e così è anche la mia voce, si fa trascinare, lo ammetto, da brevi immagini, senza una precisa dimostrazione da disegnare e raggiungere o dalla quale partire con sicurezza, con ironia. La sicurezza a volte è stucchevole. Vedi, la mia città non è lontana, mi avvolge come un sudario, mi travolge come un corso d’acqua, e non riesco a liberarmene, forse è ancora presto per me...
Maria Luisa Vezzali e Giorgio Celli, due sguardi diversi sulla realtà, una diversa poesia. Lineamadre, un flusso continuo, con creste di onde, viaggio tortuoso che si biforca non si sa se per riunirsi, che cerca una strada, che fatica a farsi comprimere nel letto del fiume poetico, indisciplinato più per natura che per volontà, un cumulo di quesiti irrisolti che si accavallano e si sprofondano l’un l’altro, elementi che si compenetrano, che si fanno strada allentandosi e riavvicinandosi in una deriva, cercando ognuno un proprio spazio, una propria identità, dispersi e salvati nell’universo caotico che è il cosmo, in cui la parola senza freno si fa padrona del poeta, in cui il poeta si lascia portare sulle strade sconosciute della parola per una notte non destinata a sparire, finché ciò che è resta è il fiore del regno.
Liceo “Fracastoro” di Verona, prof. Emma Cerpelloni
Relazioni della classe 3^ C, divisa per gruppiInsegnante: Emma Cerpelloni
Per Giorgio Celli: lode al DNA
Di Federico Leso, Michele Martini, Matteo Matteucci, Zeno Montagnani, Enrico Nicoletti, Paola Spola, Stefano ZamboniSu Giorgio Celli, Lode al Dna
La poesia “Lode al DNA” è unica nel suo genere in quanto unisce in sé due tipi di linguaggio diametralmente opposti: quello della poesia e quello della scienza. Anche se l’accostamento può sembrare azzardato, Celli potrebbe essere collegato a Catullo, per come usa un linguaggio diverso da quello poetico. Come Catullo mescolava linguaggio alto e il “sermo plebeius”, Celli mescola quello poetico con quello scientifico. Il poeta però, non ha inserito la scienza nella poesia solo usandone i termini specifici ma, come ha detto, utilizzando anche metafore che, allo stesso tempo, hanno creato questa “varietas” e hanno mantenuto in trasparenza le origini etimologiche dei termini. La poesia risulta di difficile comprensione non per il modo con cui viene espressa la lode al Dna, ma per i termini usati, così specifici da non essere accessibili a tutti.
Il testo presenta una struttura poetica molto semplice e atipica rispetto alla poesia classica. L’uso delle strutture poetiche tradizionali è limitatissimo; infatti non vi sono rime e i versi sono liberi; ampio invece l’uso delle metafore presenti in grande numero. In che cosa consiste, allora, l’aspetto poetico? Per rispondere dobbiamo scrollarci di dosso la visione romantica della poesia: non serve la commozione per cogliere la bellezza di immagini come “pallottoliere di noumeni” o “hai sognato di me, di me nell’ameba” ( a proposito, qui c’è un’anafora), ma si può rimanere colpiti dall’arditezza di questi accostamenti logici. Dove abbiamo trovato questo modo di poetare? La risposta, per noi studenti di terza liceo scientifico, è facile: in Dante, in quello del viaggio di Ulisse, dove si descrive la poesia della ragione.
Riflessioni su “Lode al DNA” di Giorgio Celli
di Matteo Azzini, Alessia Fedrizzi, Luca Aloisi e Nicola Salvagno
Si possono conciliare scienza e poesia? Giorgio Celli, poeta (ha fatto parte del “Gruppo 63”, caposcuola dell’avanguardia poetica degli anni Sessanta in Italia, cercando nuovi linguaggi per la poesia del suo e nostro tempo), e etologo-naturalista, a questa domanda risponderebbe di sì. Anzi risponde con il recente volume intitolato “Percorsi”.
Ma come si conciliano in Celli scienza e poesia? Per rispondere a questa domanda analizziamo quella che riteniamo la più significativa delle sue poesie “Lode al Dna”. In questo testo, alcune immagini sono molto significative per spiegare questo accordo.
Ad esempio, il dna “che fa danzare l’ape nel suo bugno” è particolarmente efficace, poiché l’accostamento di termini scientifici con l’immagine stilisticamente raffinata dell’ape che danza, crea toni molto suggestivi. Ma questo testo non va letto come una poesia del “cuore” e non va interpretato in chiave romantica, ma come “poesia della ragione”.
In questo componimento, Celli mette in evidenza il ruolo del dna, nella nascita, nell’evoluzione, nell’intelligenza dell’uomo. E ci dice tutto questo usando termini scientifici, lontani dal linguaggio poetico romantico. Del resto, anche Dante nella Divina commedia introduce il linguaggio teologico, e Catullo, ancora prima, ha messo nelle sue poesie d’amore termini del linguaggio dell’economia ed espressioni del sermo cotidianus. Insomma, un lessico apparentemente anti-poetico. Così come Celli fa poesie sulla scienza con il linguaggio della scienza. In questo sta il talento del poeta.
In “Lode al Dna” troviamo espressioni come “Algoritmo della vita”, “Spartito del carbonio” e “Pallottoliere di noumeni”, ma anche termini come echinodermi, eone, pterodattili, anomia, inferenza, entropia.
Una parola come echinodermi può entrare in un testo poetico? Celli ci mostra che è possibile, e noi scopriamo che si può, perché questo lessico nelle poesie serve come evocazione, come richiamo. Cosa c’è di più lontano dalla poesia del lessico scientifico? Niente, avremo risposto prima di leggere le poesie di Celli. Ma, dopo aver conosciuto i suoi testi, abbiamo scoperto che qualsiasi termine scientifico può diventare poetico.
Per Gilberto Isella: le immagini dell'anima
Le immagini dell’animaLa vita riflessa tra la filosofia greca e Shakespeare
Di Martina Bragantini, Deborah Bressan, Giovanna Corsini, Leonardo De Paoli, Elisa Laiti, Ilaria Tommasi,
Con una bella edizione, proposta da Book editore, Gilberto Isella è tornato sugli scaffali delle librerie con “Corridoio polare”: brevi frammenti in prosa e poesia della visione pessimistica del mondo.
Come il poeta stesso ci spiega nell’introduzione, il “corridoio polare ionico” è un misterioso viaggio verso un luogo puro e isolato per sfuggire al pessimismo del mondo. Fra le numerose tracce che Isella lascia nel ghiaccio del corridoio, salta all’occhio quella composizione che si propone di dare una definizione dell’anima: “L’anima dilunga l’energia nelle cose che stanno sotto il cielo”. La filosofia presente, intrisa di figure retoriche e dotata di una spiccata musicalità, salta all’occhio sia dalle “cose che stanno sotto il cielo”, in rimando all’ “Amleto” di Shakespeare, sia dal “granaio dell’essere, che rivela nella danza qualche chicco luminoso”, riferito alla classicità greca.
Ma che cos’è l’anima, per Isella?
Il poeta interpreta il motore dell’esistenza, servendosi di immagini tratte dalla natura come il “canto degli uccelli quando al volo portano via gli integumenti per farne musica e preghiere”, che simboleggia la libertà e la continuità della vita attraverso la morte con riferimenti storici alla divinazione aruspicina, e come la “chiocciola che è passata con bruscoli di senso”, simbolo del tempo che trascorre e lascia le proprie tracce ben visibili. Tutti allora, animali e piante, hanno un’anima che ha la funzione di “dilungare l’energia delle cose che stanno sotto il cielo”. Ma l’energia può essere intesa come energia vitale, e quindi come felicità? Sì, lo si capisce dalla bellezza e dalla tranquillità che infondono le immagini retoriche riferite. E allora qual è il rapporto dell’anima con la natura? Quando l’anima è “punta dal sole”, “aspira e si incrementa” e quindi infonde quell’energia vitale che dona la felicità e la tranquillità.
Per Gilberto Isella: nell’era glaciale, l’atomo della salvezza
Gilberto Isella: Nell’era glaciale, l’atomo della salvezza
Di Michele Mauroner, Riccardo Meglioranzi, Carlo Solimani e Damiano Zampieri
Nella sua visione pessimistica dell’umanità, Gilberto Isella, nella raccolta poetica intitolata “Il corridoio polare”, crede che l’uomo possa ritrovare la salvezza attraverso il suo corridoio polare ionico. Quest’ultimo aggettivo è ciò che più caratterizza questo luogo metaforico, attraverso il quale il poeta “si era messo in salvo”. Un atomo sovraccarico di elettroni va in cerca di un altro atomo che, al contrario, ne ha necessità. Una volta che si sono incontrati, il primo cede il suo elettrone di troppo al secondo, legandosi con esso. Entrambi ricavano un beneficio da questo scambio che è detto legame ionico. Come collegare queste informazioni scientifiche con la poesia di Isella? Con la constatazione che le persone dovrebbero imparare a non essere in contrasto tra loro, ma invece aiutarsi a vicenda, così da creare un mondo migliore: chi ha di più deve dare a chi ha meno, in modo da poter convivere felicemente. Questo è per noi il significato del “corridoio polare ionico”.
Al di là del corridoio dove si è messo in salvo, il poeta si è creato un mondo puro e parallelo “in una sorta di estasi nordica”, come scrive il critico.
Come un messaggio in una bottiglia, lasciato da uno sconosciuto, Isella scrive le poesie per lasciare tracce scritte del suo sistema.
Queste riportano ai pensieri filosofici complessi e articolati, che trattano di argomenti come l’uomo, i problemi che lo affliggono, l’anima, l’esistenza, il pensiero. Alcune riflettono appunto problematiche relative all’essere nel mondo, altre invece denunciano la negatività del sistema da cui vuole scappare.
Complicata e intricata come le altre, la poesia “In una vetrina di psicofarmaci …” esprime la totalità della meccanica follia, senza senso, dell’esistenza. Una sfida continua per l’uomo intento a resistere e a salvarsi dal disordine che lo circonda. Il freddo del “corridoio polare” del poeta, ghiaccia il mondo esterno e con esso tutti i suoi mali. Crea un distacco e una tregua.
Per Maria Luisa Vezzali: una foto, un ricordo...
Stati d’animo su “Cinque settembre duemiladue” di Maria Luisa Vezzali Di Valeria Nanci e Laura Girolomoni
Alcuni giorni non sono solo giorni, ma restano per sempre. Io li chiamo ricordi.
Quei passi, quelle mani e quel sorriso riempivano il silenzio che accarezzava le nostre labbra imbarazzate, coloravano il buio di luci senza durata, mettevano a fuoco soltanto noi in quella foto indelebile che ci distaccava dal resto del quadro.
Soli, ma insieme, riuscivamo a riscaldare la fredda indifferenza di quello che accadeva intorno a noi e tutto ciò con la minima consapevolezza del forte nodo che ci stava legando.
O forse ne eravamo consapevoli.
Avevo paura … paura del silenzio, paura di parlare. Avevo paura di te, di noi, di me e della mia fragilità. O forse non avevo nemmeno il tempo di chiedermelo.
Non avevo bisogno di altro: né di domande o di risposte, o dubbi o certezze … ma soltanto di te!
Ricordo tenerezza, timidezza, innocenza. Ricordo quel senso di serenità, quel silenzio … il tuo silenzio!
Ricordo quei respiri … quei sospiri!
Ero felice? Sì, lo ero!
Ma cosa è rimasto di quella felicità?
Una foto sfocata … un prezioso, ma ormai lontano ricordo … l’attimo fuggente di una felicità sbiadita dal tempo.
Dedichiamo questo nostro testo a Manuel
1 settembre 2007
Poesia e internet 3: Marco Giovenale e Massimo Orgiazzi
Estromessa dalla carta stampata quotidiana e periodica, la poesia è entrata significativamente nel mondo di internet, con un fiorire di iniziative che fanno capo a siti, blog, riviste on-line, aggregatori. Tutto questo, se da un lato testimonia la sua vitalità, al passo con le nuove tecnologie e con i tempi, dall’altro pone esigenze di comprensione e studio del fenomeno.Per capirne potenzialità e limiti, per offrire nello stesso tempo una chiave di lettura e una mappa, un’istantanea della situazione, dal numero 6 “Carte nel Vento” opera una sorta di ricognizione in rete, attraverso i principali operatori della poesia nel web.
Nei numeri precedenti:
Vincenzo Della Mea, Un colpo d’occhio sulla rete della poesia
Christian Sinicco, Qual è il centro? Internet, tra passato e futuro
Luigi Nacci, La grande proletaria dei poetinternauti s’è mossa, o no?Massimo Orgiazzi, “Poesia e web: esperienza diretta, riflessione e punti chiave per un’evoluzione futura”
1. L’ESPERIENZA DIRETTA – UNA SORGENTE
Ho scoperto Internet nel 1994, quindi in tempi non sospetti. La Grande Rete, per usare un epiteto allora piuttosto comune, era allora molto diversa da oggi. Appena quattro anni dopo la nascita del World Wide Web, storicamente avvenuta in Svizzera presso l’università di Ginevra, quasi tutto il traffico era allora mediato attraverso protocolli poco interattivi e senz’altro neanche somiglianti a quelli attuali così permeati di grafica, come si dice in gergo user-oriented o, usando un termine poco politicamente corretto, idiot proof, letteralmente a prova di idiota. Si parlava allora di trasferimenti di file «via FTP», di «Gopher», di «Telnet», si parlava in chat uno ad uno con interfaccia completamente testuale e si era ben lontani dall’aspetto patinato odierno, così pieno di pubblicità, sempre più somigliante alla TV. Il processo doveva essere, si diceva, di incontro: rendere la TV sempre più interattiva e la Rete più semplice da usare, ma sembra che al momento ci troviamo a seguire una direzione dove l’orientamento unico di tutti i media è solo vendere. Sotto questo diktat sembrano piegarsi tutte le linee evolutive dei sistemi e dei mezzi di comunicazione.
La Rete nella prima metà degli anni ’90 in Italia aveva ancora molto dell’infrastruttura originaria dell’Arpanet voluta dal dipartimento della Difesa USA negli anni ’60 per scongiurare il black out comunicativo derivante da eventuali attacchi atomici nella bassa atmosfera. Ben presto questa rete nata con scopi di difesa si era tramutata in una vitale e rigogliosa rete di contatti tra centri di studi universitari e aveva permesso il fiorire di nuove relazioni veloci, di interconnessione e condivisione per ogni genere di discipline, scientifiche ed umanistiche. Ricordo ancora viva l’emozione di poter ricevere via mail, su richiesta, delle bibliografie direttamente da atenei sparsi per il pianeta: la possibilità di contattare persone lontane con competenze fino ad allora irraggiungibili, poter reperire finalmente «informazione», nel suo significato più pregno e ricco, riuscendo così a soddisfare curiosità ed interessi.
Questa premessa descrive l’esperienza di chi in Italia non aveva mai potuto usare questi mezzi prima; la Rete, appoggiandosi allora quasi solo su sottoreti universitarie (nascevano solo allora i primi Internet Service Provider privati), replicava quasi esattamente la crescita avvenuta negli anni ’70-’80 negli Stati Uniti e dava modo di toccare con mano una libera comunità aperta che molto traeva dalla filosofia dell’Open Source di Richard Stallmann e che nulla aveva a che fare con la commercializzazione di qualsivoglia prodotto. Questa premessa anche e soprattutto per mostrare un modello originario, una sorgente e cercare di chiudere un cerchio al termine di questa trattazione.
2. L’ESPERIENZA DIRETTA – LA CORRENTE
La mia esperienza di scrittura in rete e poi, se vogliamo, il tentativo di fare, in termini figurati, “letteratura” in rete, avviene però in tempi decisamente seguenti e si appoggia su uno strumento ancora legato alla dimensione originaria di Internet. Siamo nel 1999: I forum elettronici, i gruppi di discussione, i newsgroups come vengono chiamati, alla fine degli anni ’90, in Italia hanno ancora un ruolo preminente nel traffico totale, che possiamo definire a buon titolo asfittico se confrontato con quello attuale. I gruppi di discussione letterari sono pochi e due sono quelli che si dividono la grande maggioranza di utenti: si tratta di it.arti.scrivere e it.arti.poesia, nella designazione che ancora mantengono oggi. Sono gruppi frequentati da un centinaio di persone alla volta, con numerose rotazioni e avvicendamenti, di modo che si possa stimare una partecipazione globale all’epoca di circa un migliaio di persone. Il funzionamento dei gruppi è semplice come la dinamica dell’uso che se ne fa: si “posta”, ovvero si spedisce un articolo, un messaggio al gruppo, contenente una poesia, un racconto breve che viene appeso in bacheca; dopo di questo si aspetta un responso, una lettura, un commento; nella migliore delle ipotesi, la nascita da esso di un thread, di un intero filone di discussione. Questo dà la possibilità di condividere quel che si scrive, di parlarne, di avere un parere, di ottenere un orientamento di base. Tuttavia nel dibattito interno nasce presto l’autoriflessione sul carattere chiuso di questo meccanismo: si comincia a parlare di “cricca”, per indicare il gruppo di utenti sempre presenti e legati tra loro da affiliazione più antica. Anche se non esiste moderazione, in questi gruppi si scorge ben presto un carattere che scorgeremo più tardi su scala più vasta: l’autoreferenzialità. Ci si scrive e ci si legge in un ambiente chiuso e si finisce ben presto per scrivere e leggere quasi completamente sul gruppo stesso e sulle sue modalità di operare. Il «periodo d’oro» dell’entusiasmo per un nuovo mezzo che dà potere di condividere la propria scrittura si esaurisce presto in polemiche, in interferenze esterne, in dispersione. Più tardi si cercherà di dare a questi gruppi una moderazione, ma senza risultato. L’evoluzione del mezzo non c’è: rimane bacheca spesso vuota di commenti, dove si spera di ottenere un giudizio e si ha voto di scambio. Certo, l’utilità di base, quella comunicativa, rimane, ma questo non risolve i problemi che nascono da considerazioni evolutive come l’archiviazione (i post vengono progressivamente persi), l’organizzazione (le directory sono ad albero ed è difficile orientarsi o ricercare informazioni) e la sistematizzazione di un lavoro.
Da questa esperienza segue la pubblicazione del mio primo e unico libro, al momento: una raccolta di racconti brevi per lo più discussi e riscritti nei gruppi di discussione. Come la stragrande maggioranza delle esperienze di pubblicazione, anche questa esce dalla Rete per entrare nel già ben rodato meccanismo editoriale a pagamento, non vende copie, non viene distribuita, non troverà mai un pubblico.
3. L’ESPERIENZA DIRETTA – IL CASO
I tempi in cui sono transitato ad un passo successivo di esperienza sono invece decisamente sospetti. Siamo nel 2005: la rete è completamente cambiata, il World Wide Web è ormai quasi l’unica interfaccia attraverso la quale si accede in gran numero ad Internet. La sua struttura è variata in funzione di enorme vetrina commerciale: ogni attività e interscambio ha un corrispettivo in un sito internet. La banda si è potenziata a tal punto che sulla rete possono viaggiare immagini e film: ci si può sentire in tempo reale in viva voce e vedersi via web cam da una parte all’altra del pianeta. Da alcuni anni, circa sei, è nato un fenomeno che si chiama blog: una sorta di piattaforma web semplicissima, standardizzata, basata sul web e che come carattere distintivo rispetto ai siti convenzionali ha il carattere cronologico e diaristico degli inserimenti. Lo stesso nome blog è una contrazione della locuzione inglese web log, ovvero «diario, registro del web». Esso diventa da subito uno strumento realmente di massa per rendere disponibili in rete i propri pensieri in quelli che ben presto diventano diari personali commentati e seguiti da un pubblico.
Nel luglio del 2005, quando apre LiberInVersi, lo spazio blog che ho creato, le directory e gli osservatori registrano nel mondo già più di 40 milioni di blog. L’esperienza alla base dell’apertura di LiberInVersi è la continuazione di quanto fatto e visto nel mondo dei forum elettronici, con l’intento di superare i conflitti, l’animosità e se possibile l’autoreferenzialità del fenomeno. La creazione cioè di uno spazio aperto che consenta l’incontro tra persone con gli stessi interessi, ma ancora di più, deciso ad integrare questi interessi per mettere insieme conoscenze, suggestioni, spunti e note per fare la differenza, generare archivi, percorsi “storici”, letture. La creazione insomma di entità bibliograficamente rilevanti in senso documentale, che rappresentino una possibile fonte di citazione ma anche risorsa per approfondimento e conoscenza.
LiberInVersi nasce così come strumento dapprima di divulgazione (il suo sottotitolo iniziale è “Divulg(azione) poetica dal mondo dei gruppi di discussione”), cercando di imporsi proprio come il blog di un gruppo di discussione in particolare it.arti.poesia, nel tentativo di trascinarne il pubblico su un mezzo e su una piattaforma diversa e più gestibile, non esattamente moderata, ma capace di costituire una sorta di “punto base” per un incontro con presupposti diversi e più titolati di quanto accade sui newsgroups. Ovviamente anche nei blog la velocità di mutazione è elevatissima e il gruppo che originariamente sottende LiberInVersi si sfalda, si divide e si auto annulla, cominciando a disperdersi in una prima generazione di altri blog, secondo un meccanismo comune al mezzo, ovvero l’apertura di altri spazi più calibrati, a volte anche solo sulla propria personalità e la propria cerchia di lettori. Il percorso che LiberInVersi tenta da un certo punto della sua storia è quello dell’invito di autori diversi, l’ospitalità per un certo numero di giorni dei suoi testi (al principio 3 giorni) e la discussione su questi, con l’auspicio che il confronto possa essere il più vivo possibile. Da questo percorso si origina così l’intenzione di creare una mappatura della poesia contemporanea, pur calcolando gli enormi limiti e difficoltà insiti in questo compito. Il successo è abbastanza riconosciuto e riconoscibile: LiberInVersi cresce in lettori e commenti per giorno, toccando le 300 visite quotidiane e le 1000 pagine visualizzate. Di questo conteggio, comune a molti altri ambienti in rete, spesso nei vari meeting organizzati in Italia si riflette quale sia la percentuale di nuovi utenti, quanti siano i reali lettori, quanto invece incidano le visite ripetute degli stessi visitatori di sempre. Ma al di là della speculazione che al giorno d’oggi ha risposte abbastanza precise con gli strumenti statistici come ShinyStat, la vera esperienza di LiberInVersi non è la raccolta di consenso e di lettori, quanto la possibilità di mettere a contatto voci diverse, possibilmente quelle della poesia da un lato (che innegabilmente c’è, fin troppo, nella produzione) e quella che potrebbe configurarsi come voce critica di primo livello, almeno elementare. Ciò che LiberInVersi comincia a proporsi gradualmente è, attraverso una certa dose di divulgazione, l’«educazione dell’utente a diventare lettore», laddove si percepisce, a fronte della pletora produttiva, una scarsità di lettura e di dibattito articolato.
Le potenzialità del mezzo fanno sì che in poco tempo si sviluppi un discreto entusiasmo e che l’attività ferva: ecco allora incontri, discussioni animate ma sempre nei limiti della correttezza, qualche episodio di sabotaggio. Tutto questo sino ad una certa massa critica, superata la quale inevitabilmente (e forse naturalmente) si generano ancora nuove duplicazioni e replicazioni del mezzo, moltiplicazioni dei contenuti, sempre più difficili da tracciare.
La mutazione di LiberInVersi in un collective blog, ovvero in un blog multi utente è solo la penultima fase ormai dettata da sollecitazioni esterne che mirano in qualche modo ad aggregare risorse e redattori. Oltre alla mappatura, LiberInVersi, dal luglio del 2006 si propone anche di allargare gli orizzonti alle scritture straniere, attraverso la collaborazione di autori e traduttori italiani residenti all’estero o in Italia. Si propone anche di ampliare i contenuti a maggiori trattazioni saggistiche e di opinione: diffondere cioè idee, creandole sulla superficie di lettura già rodata. Anche l’ultima fase, datata luglio 2007, che prevede di creare una prima antologia ragionata di un minimo numero di autori ospiti a partire dalle selezioni dei redattori, insieme quindi ad un tentativo di creare «selezione del buon testo», setacciatura e non solo mappatura, anche quest’ultima fase però, non fa che confrontarsi periodicamente con un calo di interesse e una sempre maggiore moltiplicazione dei contenuti che genera. Spesso questa è l’impressione: un certo livello sempre crescente di dispersione. Nonostante manchi la volontà di arrogarsi il diritto di distribuire i contenuti migliori o superiori, spesso la percezione di questa dispersione è evidente e i fenomeni di aggregazione sembrano non attenuarla.
Esperienza significativa legata al tentativo di ridurre la dispersione e aggregare i contenuti, è senza dubbio quello degli aggregatori di feed. Questi ultimi, utilizzando la tecnologia RSS, sono in grado di aggregare in tempo reale e raccogliere i titoli delle ultime uscite del blog, costituendosi così come veri e propri canali che permettono di tenere sotto controllo la produzione quotidiana dei diversi spazi e siti che supportino tale tecnologia. Il caso emblematico è PoEcast, aggregatore “specializzato” in siti di poesia creato da Vincenzo Della Mea, a seguito di richieste per avere un ambiente web con queste funzionalità (essendo in genere gli aggregatori delle applicazioni client più flessibili ma non funzionanti su web). La creazione di PoEcast è un possibile inizio della costituzione di una comunità che legge e “ascolta insieme” anche gli altri, riproducendo su scala più ampia quanto accade in un singolo ambiente/blog: la conferma in questo senso viene del fatto che tutti gli owner e tutti i lettori di un singolo spazio on line quasi sempre frequentano PoEcast per essere aggiornati sulle uscite e poter intervenire sugli argomenti di maggiore interesse.
4. AUTOREFENZIALITA’ E IPERPROLIFERAZIONE
A fronte dei numerosi benefici che Internet genera nella poesia, primo fra tutti la liberazione dall’isolamento di scritture che meritano di essere portate alla luce e l’incontro tra queste ed un pubblico seppure limitato e disperso, ci sono però alcuni difetti o punti deboli intrinseci del mezzo. Come già visto per i newsgroups, anche per i blog si generano fenomeni di moltiplicazione eccessiva e di ulteriore auto isolamento in piccole comunità. Dal principio della Rete ad oggi si sono creati anche innumerevoli siti letterari in diverse lingue, ma in quanti di questi si supera l’auto lettura vicendevole, magari spesso condita da adulazioni reciproche dovute alla conoscenza da lunghi periodi ? In quanti si supera la mera archiviazione di testi senza supporti di lettura, almeno blandamente critici e con una certa inclinazione ad una organizzazione sistematica del materiale ? Il fenomeno dell’autoreferenzialità è abbastanza comune e intrinseco alla comunità letteraria anche astratta dal mezzo informatico: tuttavia in questo mezzo pare che quanto si origina, sia tendente ad amplificare questo genere di fenomeno.
In un continuo processo di nascite e morti, mentre sto scrivendo questo articolo, le statistiche Technorati1 registrano nel mondo più di 70 milioni di blog, con una velocità di crescita però ormai rallentata rispetto agli anni in cui il fenomeno ha preso il via (si parlava a marzo 2007 di circa 110.000 blog aperti al mese, rispetto agli oltre 200.000 di maggio 2006). Molti di essi, come si è già detto, prendono origine da costole di blog precedentemente creati: molti altri “muoiono”, dove per un blog il concetto di morte equivale a quello di dimenticanza. Quando un blog viene dimenticato, spazio ormai vuoto e senza più accessi, è definitivamente morto.
Il successo del lit-blog (che sta per literary blog) è dovuto al fatto che lo strumento blog ha successo in tutto. Il blog è strumento così versatile che tutti sono in grado con pochi clic di aprirne uno ed usarlo con flessibilità invidiabile per la condivisione di qualsiasi contenuto. Essendo letteralmente un Content Management System, un sistema di gestione di contenuti, qualsiasi argomento, disciplina, evento si presta ad essere inglobato in esso. Oggi ogni giornalista e politico che si rispetti ha un proprio blog, ce l’hanno noti comici come anche la nostra vicina di casa adolescente che racconta in simil-pagine di diario piene zeppe di fotografie ed immagini sbarazzine la propria vita privata di quindicenne. E ci sono i blog di letteratura, che mai come altro si sono visti riproporre il meccanismo che già abbiamo incontrato nei newsgroups: condivisione di contenuti, contatti, incontro. Il gioco è fatto. A Macerata nel 2006, riflettevo al meeting organizzato da Filippo Davoli a margine della locale rassegna di poesia, come un lit-blog, che pure si presuppone trattare argomenti, sia detto tra virgolette, ampi e profondi come quelli letterari, possa essere accomunato al blog organizzato da un circolo di pesca a mosca. L’uniformità del blog, la tendenza ad ugualizzare attraverso il mezzo, la reperibilità dell’informazione senza ostacoli, fa sì che visto da fuori, sul mare magnum dei contenuti, qualsiasi contenuto sia assimilabile ad un altro.
Autoreferenzialità, quindi ed iper-proliferazione (che equivale a dispersione dei contenuti non organizzati) sono due problemi che minano alla base non l’operatività della letteratura su mezzo informatico, ma la stessa necessità delle scritture, a cominciare dall’entusiasmo e dalla motivazione di chi le tenta.
5. L’AUCTORITAS E IL CIRCUITO EDITORIALE
Con il crescere del dibattito sull’opportunità della letteratura in Rete e dei suoi possibili sviluppi, un tema più recente e più articolato emerso nella discussione è stato quello intorno all’auctoritas del lavoro operato dai vari siti, spazi e blog. La riflessione, originatasi specialmente durante l’Absolute BlogMeeting2 di Monfalcone nel marzo 2007, verte sul confronto tra scritture, poesia e possibile critica sviluppate in rete da un lato e accademia, editoria e canone dall’altro. Si può ricordare qui la polemica nata sulle pagine di Liberazione, Corriere della Sera ed Espresso tra Nanni Balestrini, Giuseppe Conte ed Umberto Eco nell’agosto del 20063. Sebbene si parta dal presupposto dell’ingiustificabile pletora editoriale e dalla necessità di formalizzare e classificare in qualche modo tutta la scrittura italiana contemporanea tentandone una scrematura (e alcune voci del citato scambio d’opinioni indicano la Rete come il futuro delle scritture), nonostante questo il parere generale di accademici e “titolati” è che la gran parte del lavoro letterario in Internet sia “spazzatura”. Ne è anche dimostrazione il fatto che l’autore non attivo in Rete e che raggiunge una certa notorietà editoriale (che per la poesia non si misura che oltre le poche migliaia di copie vendute), evita sistematicamente l’attività on line. Alcuni esempi, possibilmente mascherati con una scarsa dimestichezza con il mezzo, si possono annoverare anche nella lunga lista di autori di LiberInVersi.
Sebbene alcuni esempi di lavoro letterario in rete, per il carattere sistematico e preciso della ricerca, rappresentino un’ottima prospettiva di evoluzione, ogni risultato è però ancora difficilmente integrabile, cumulabile e perfino “citabile”. Manca, per dirla con una parola, l’autorevolezza del lavoro operato per una intrinseca difficoltà tecnica e normativa da un lato e per una mancanza di volontà ad operare per un unico obiettivo dall’altra. Alcuni progetti4 (compreso un tentativo ormai abbandonato nato in seguito al BlogMeeting di Monfalcone) hanno tentato di costituirsi in questo senso come fonti attendibili ed organizzate, fornendo link permanenti e una codifica di citazione, oltre a farsi garanti di una selezione approfondita dei testi su base condivisa. Le difficoltà, però, si misurano proprio sulla base dei fallimenti nell’essere rete globale, unica e operativa in un senso unico. Questo ovviamente andrebbe anche contro ovvi e necessari presupposti di pluralità, ma è comunque ancora e sempre lontana la nascita di una vera e propria rete letteraria che costituisca un panorama almeno simile a quello che fino agli anni ’60 del secolo scorso nasceva e cresceva intorno all’autorevolezza di certe riviste (Menabò, forse, come spartiacque storico).
6. CONCLUSIONE E PROSPETTIVE FUTURE
E’ difficile arrivare ad una conclusione ed analizzare prospettive future per un argomento così complesso. La letteratura e le scritture in rete (o la poesia in web, per riprendere il titolo di q uesto pezzo, forse troppo riferito ad un particolare) si confrontano con flussi e sistemi esterni forse ancora più instabili:
- Le riviste cartacee che, nonostante meritori, solidi e decennali esempi, contano un numero esiguo di lettori ed abbonati.
- L’editoria e la pletora di pubblicazioni orientate al consumo verso l’alto, e allo sfruttamento delle risorse dell’autore verso il basso (e non veicola l’opera al suo possibile fruitore).
- L’accademia quasi assente dalle realtà menzionate sopra e anche dalla rete.
Quanto potrebbe in un prossimo futuro costituire la rete per le scritture è una rinascita della comunità originaria, così come ricordata ad inizio trattazione, ma al di fuori dell’infrastruttura accademica: una rete di punti e nodi nevralgici che lavora per l’archiviazione, lo studio, l’organizzazione, la condivisione, la citazione e lo sviluppo di testi, critica, tecniche e canoni. Questa visione avrebbe come risultato salutare anche un possibile recupero di tutte le scritture sommerse ed isolate: quelle che spesso, a torto o a ragione, sono state definite “letteratura di serie B”. Un recupero di questo genere sarebbe solo positivo per la società tutta: avrebbe come prerogativa anche la rinascita di una critica militante, la maggior calibrazione dell’opera letteraria e l’indirizzamento della stessa verso un suo possibile pubblico. Per raggiungere tutto questo o almeno avvicinarsi per approssimazioni successive e facendo perdere alle scritture i tignosi connotati di hobbismo, serve da un lato la consapevolezza del ruolo, alla quale si arriva solo superando l’autosegregazione e l’autorefenzialità da un lato, e la precisione e il rigore del lavoro dall’altro. Se con una visione di insieme, lanciata e rilanciata spesso in questi ultimi anni, è possibile in qualche modo diffondere questa consapevolezza, a contrastare il processo tutto (ben possibile se si pensa al lavoro di molti siti in rete e di molte riviste cartacee) è però la mancanza di risorse e in cima alla lista della risorsa tempo.
Tutto si giocherà quindi in futuro sulla possibilità di reperire quest’ultimo, anche da una sempre maggiore (possibile) condivisione e suddivisione, oltre che da un abbandono delle logiche dell’audience, del consumo e dell’infinita riproduzione di modelli fine a se stessa o alla propria inutile glorificazione personale.
Il discorso è estremamente complesso: deve necessariamente fare i conti con le realtà esterne alla rete e alle possibili evoluzioni, tuttavia gli esempi e le esperienze ci sono. Il lavoro è già in atto. Ai suoi protagonisti, dunque, la ricerca e l’obiettivo di un ruolo sempre più utile nella società delle lettere e non solo.
Bibliografia elettronica essenziale
Sui BlogMeeting e sui simposi intorno all’argomento:
- http://poesiainternet.splinder.com/. Spazio blog dedicato all’incontro BlogMeeting di Bazzano, 28 aprile 2007.
- http://lattenzione.com/2007/03/30/absolute-blogmeeting/. Atti e note a margine dell’Absolute BlogMeeting di Monfalcone, a cura di Massimo Orgiazzi, L’Attenzione, 30 Marzo 2007
- http://lellovoce.altervista.org/spip.php?article782 e link correlati: La Macchia Nera, serie di inchieste ed interviste su Poesia e Internet a cura di Christian Sinicco.
- http://liberinversi.splinder.com/tag/poesia_e_internet, raccolta di articoli sull’argomento apparsi su LiberInVersi.
- http://lattenzione.com/category/numero-sette/. Numero monotematico su Poesia e Internet della rivista on line L’Attenzione, Aprile 2007
- http://lellovoce.altervista.org/spip.php?article896. Riflessioni sull’autorevolezza della letteratura in Rete, Christian Sinicco, AbsolutePoetry, 24 aprile 2007
- http://www.tellusfolio.it/index.php?cmd=v&id=2774&prec=%2Findex.php%3Flev%3D119. Poesia e BlogMettings di Stefano Guglielmin su TellusFolio, 10 aprile 2007
- /poesia_e_internet_1. Poesia e Internet, Christian Sinicco e Vincenzo Della Mea su Carte nel Vento, Febbraio 2007
- http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/08_Agosto/05/montale.shtml. Oggi Montale pubblicherebbe su Internet, da Corriere della Sera del 5 Agosto 2007.
Marco Giovenale, “I vicini (quasi non) ci guardano”
1.
il campo definito di volta in volta dalle tecnologie e dagli oggetti e soggetti di informazione [che sono sempre a mio avviso dei moltiplicatori/demoltiplicatori di una tendenza, avviata nel ‘700, a materiare in meccanismo i movimenti del pensiero e della riflessione estetica] è un campo così cangiante, metariflessivo, sfuggente, a volte irrazionale, da sottrarsi a tutte o quasi tutte le nostre velleità di definizione – come di lamentela e perfino militanza.
ogni volta che schiacciamo il tasto F5 la situazione è diversa. (cirrocumuli, strati, cristalli che continuamente migrano). essere ‘militanti’ in rete significa rischiare a ogni bit di mancare quel che di invisibilmente rivoluzionario o perlomeno spiazzante e interessante sta succedendo nell’area vicina a quella su cui si accaniscono gli sguardi.
una parte di attività – e riflessiva e filosofica e ‘relazionale’ – è svolta poi direttamente dalle macchine, in legame stretto con individui e gruppi, oggi. senza che ciò significhi pura espropriazione del pensiero da parte di strutture di vendita.
[ consideriamo Myspace o Facebook, o tutte quelle piattaforme articolate, come LiveJournal o Flickr o YouTube, che partono da un ‘servizio’ – p.es. il blog o l’hosting di immagini – per poi tenere in legame molte persone diverse, e offrire una serie di altre opportunità che possono non chiudersi nel cerchio delle ‘applicazioni’, dei ‘banner’, della ‘pubblicità’ ]
2.
la rete cambia in parte anche la percezione dell’oggetto poesia. MA in questo va ad intervenire su una situazione matura (per il cambiamento, e per le direzioni esplorabili) dove una cultura poetica nel tempo si è modellata in senso non troppo discontinuo, ossia in molti paesi del nord Europa, e certo in area francofona e anglofona.
al contrario, là dove alcune fratture hanno interrotto il corso di certe ricerche e di alcuni linguaggi (dove cioè una miserabile potatura ha lasciato solo poche forme sedicenti ‘eterne’), come in Italia, la situazione può essere disperante se non comica.
ci troviamo così di fronte a burloni che impugnano il laser per disegnare bisonti nella caverna, o si tuffano in acrobazie xhtml per miseramente calligrafare sonetti caudati su schermate in finta pergamena, con tanto di penna d’oca gif.
la lingua è la spia di questo stato di cose. relitti italiani e neoformazioni inglesi:
in inglese esiste da tempo la [ormai indispensabile, e viva=usata] parola “vispo”, che contrae “visual poetry”; come esiste “langpo”, che sintetizza “language poetry”. in Italia abbiamo ancora una splendida (ultra)quarantenne “poesia visiva”, raramente utilizzata; e per far riferimento a aree di poesia sperimentale quasi non si dispone di vocabolario.
chi dice sperimentale in Italia sembra possa dire soltanto “Neoavanguardia” o “Gruppo” (con numeri a seguire).
ytalya, paese di lotterie.
come se le straordinarie esperienze di «Testuale», «Anterem», «MarcaTre», Geiger, Zona, Lerici, Manni, D’if, Lombardelli (per citare senza completezza né ordine) non fossero esistite né esistessero.
è ovvio che in una situazione del genere, nella generale miopia o indifferenza verso sedi e siti di sperimentazione, l’arrivo della rete dà o rischia di poter dare soltanto una manciata di bytes a una gabbia mentale ancora e sempre immarcescibilmente petrarchesca, petrarcaica (quando va bene).
da tale status viene quello che leggiamo nel 90% (o più) dei siti che sembrano occuparsi di scrittura.
3.
la mia è allora una “lamentela” ? contraddico quanto detto al principio del § 1 ?
se è lamentela, è divertita. per niente accigliata. anche perché uno dei vantaggi della rete consiste nel mostrare del tutto chiaramente e felicemente che una cosiddetta cultura cosiddetta nazionale quasi non è necessaria. si possono passare mesi estremamente proficui senza aprire una sola volta siti italofoni.
chi voglia sbizzarrirsi e verificare quanto scrivo trascorra qualche giornata a esplorare le centinaia di link (con percentuale minima di .it) raccolti nella comunque incompletissima rassegna su http://gammm.org/index.php/links/
4.
ancora. a monte.
mi trovo del tutto d’accordo con un’osservazione fatta da Gherardo Bortolotti in altra sede (che non rintraccio: ma forse si tratta di conversazione via mail, privata), che dice: mentre negli USA e in parecchi paesi europei i lettori [si intenda la categoria generalissima] esistono, e dunque creano un pubblico, un insieme eterogeneo ma non inafferrabile e anzi consistente di sguardi, in Italia accade che la scarsità di lettori, nonché la ‘depressione’ del segmento individuato come poesia, e il mercato librario tarato sugli input televisivi, sul pietismo pop, sul fast food delle grandi (e attestate) catene distributive, siano dati di fatto determinanti.
dunque, mentre negli USA la presenza della poesia in internet è una sorta di volano aggiunto, un distributore-diffusore in più per qualcosa che esiste già ed ha forze e un pubblico (che si occupa di sperimentazione e non solo di quella), in Italia la rete assume l’aspetto – non esclusivo ma incisivo sì – di un’alternativa, di un canale sostitutivo o, se va bene, correttivo e quasi ortopedico per le cadute le malattie le disfunzioni e i collassi dell’editoria, della distribuzione, delle librerie, dei lettori (scarsi in due accezioni). è o può risultare insomma un farmaco, non un integratore.
le riviste e i libri non vendono? si spostino online.
scherzando si potrebbe allora dire: nel nostro paese dovrebbero ancora accadere, sovrapposte o nell’ordine, le seguenti cose: creazione del soggetto lettore (onnivoro, aperto), sua moltiplicazione e crescita quantitativa, arrivo degli anni ’70, feste & abbondanza di esperimenti, passaggio di questi esperimenti nel sentire (letterario, artistico) comune, superamento di alcuni codici e invenzione di altri, ulteriore moltiplicazione e crescita quantitativa di lettori e scrittori che hanno introiettato (non prelevato da archivi) tali codici, e infine movimento e migrazione e intrecci di codici e lettori in rete. (immaginare qui un emoticon sorridente).
in sostanza abbiamo bisogno forse di una storia che non c’è. chi se l’è procurata (per vicenda personale) fa già il suo lavoro, se vuole o può, come può, e pesca negli esteri. (Emilio Villa, ovviamente e non casualmente, docet).
l’invito di Rimbaud, l’esortazione a essere assolutamente moderni, non è una prescrizione medica. chi vuole può vivere benissimo senza. è quello che da oltre trent’anni fa la stragrande maggioranza degli scrittori italiani. i blog – quasi tutti – ne sono traccia chiara.
cambieranno forse. ma non è importante. la rete è molto più ampia dell’orizzonte (della lingua) nazionale; e anzi in un certo senso ne è proprio il positivo superamento. è anche per questo che, con gli amici di gammm, abbiamo inventato anche the flux i share.
maggio-settembre 2007
Marco Giovenale è nato a Roma, dove vive e lavora. È stato organizzatore di mostre. Ha vissuto per un breve periodo a Firenze. Si è laureato con una tesi sulla poesia di Roberto Roversi. Il suo sito è www.slowforward.wordpress.com. Con Massimo Sannelli cura la lettera-dono aperiodica «bina». È redattore di GAMMM (http://gammm.org), IEPI (International Exchange for Poetic Invention: http://poeticinvention.blogspot.com), e altri spazi in rete: se ne trova una sintesi in http://liensliens.blogspot.com. Collabora con recensioni di poesia e letteratura alle pagine culturali del «manifesto». Testi in riviste: su «Nuovi Argomenti», «Poesia», «Rendiconti», «Semicerchio», «Private», «l’immaginazione», e altre. Libri di poesie: Curvature (Camera verde, 2002), Il segno meno (Manni, 2003; edizione per il premio Renato Giorgi), Altre ombre (Camera verde, 2004), Double click (Cantarena, 2005), Criterio dei vetri (Oèdipus, 2007), A gunless tea (testi in inglese, Dusie, 2007). Prose: un e-book è uscito nel 2004 per Biagio Cepollaro E-dizioni: Endoglosse. Venticinque piccoli preludi; e nel 2006 Arcipelago ha pubblicato un libretto di nuove “endoglosse”: Numeri primi. Una mutevole opera/blog con testi in inglese è poi Differx, in rete su http://differx.blogspot.com. È tra gli autori inclusi nel Nono quaderno italiano di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 2007, a cura di Franco Buffoni) e in Parola plurale (Sossella, 2005).












































































































































































































































































