

"Nuova Limina" è una collana di raccolte di poesia nata nel 2020, come scelta di continuità e di rinnovamento. Soprattutto come vero e proprio gesto poetico. Rivolto alla collana Limina, da cui prende il testimone. Così come all’editrice Anterem, rinnovata e ampliata dopo la chiusura della rivista. Soprattutto è un gesto rivolto alle autrici e agli autori, a cui la collana è destinata, finalisti al premio Lorenzo Montano nella sezione Raccolta inedita. E, attraverso loro, è un gesto dedicato alla poesia. Alla poesia contemporanea, che la qualità delle opere pubblicate consente di mostrare nella sua ricchezza di temi e di stili: lineare e sperimentale, lirico e filosofico, plurilingue e visivo. Opere che abitano poeticamente il pensiero. Che spaziano oltre le forme note. Che cercano un’altra lingua.
NUOVA LIMINA
Collezione di Scritture
Daìta Martinez, Liturgia dell’acqua, prefazione di Maria Grazia Calandrone (2021)
Bianca Battilocchi, Herbarium Magicum, con una nota dell’Autrice (2021)
Silvia Comoglio, Afasia, postfazione di Elio Grasso (2021)
Sofia Demetrula Rosati, La dimora del ritorno, prefazione di Giuseppe Martella
con scritture asemantiche dell’Autrice (2021)
Federico Federici, Misura del sonno (e altre ricerche verbovisive) (2021)
Paola Silvia Dolci, Dinosauri Psicopompi (2022)
Davide Racca, L’ora blu, postfazione di Alessandro Baldacci (2022)
Claudio Salvi, Sequenze, con un disegno di Elia Gobbi (2022)
Alessandro Ghignoli, Ostrakon (2022)
Ianus Pravo, Il cervo giudicato, postfazione di Maria Grazia Insinga (2022)
Armando Bertollo, Volumi immaginari (2022)
Michela Gorini, I Blues (2023)
Marco Balducci, Terzo repertorio, postfazione di Igor De Marchi (2023)
Alessandra Greco, __ _ (2023)
Ermanno Guantini, La distanza (2023)
Enrico De Lea, Cacciavento (2024)
Giovanni Campi, Luna mura altera (2024)
Francesco Marotta, Polvere (2024)
Daniele Poletti, I taglienti (2024)
Lella De Marchi, Le stanze di Emily (2024)
Paolo Artale, Allusione alla flora (2024)
Di prossima pubblicazione
Salvatore Marrazzo, La dimora di Eraclito (2024)
Daniele Vergni, Fitte (2024)
A Silvia
Per “Afasia” di Silvia Comoglio, postfazione di Elio Grasso, Anterem edizioni, 2021
Giorgio Bonacini, Laura Caccia, Mara Cini, Stefano Guglielmin, Maria Grazia Insinga, Ranieri Teti

Una scena immaginativa fonda le sue basi dentro un sentire tanto inusuale quanto più pulsante di meraviglia. Tale da farsi carico, quando la poesia sostiene la persistenza del suo esserci, di ogni relazione di senso e di ogni sua direzione, che sia visiva, uditiva, evocativa o visionaria, lineare o contrastante, come “luce a eco rivoltata”, scrive Silvia Comoglio. E’ così che il titolo Afasia si connota non per incapacità espressiva, ma per i riverberi che si intrecciano tra scrittura e dire, quando la parola, fluttuando, si imprime tra i segni del reale.
‘Afasia’ è colma di voce: in dialogo e in partitura. In un molteplice e incantato musicarne il silenzio e il sonoro, le pause e il flusso interminabile, dentro, e fuori, la pagina. Nel suo vocare aperto. Rivolto all’alterità, alle voci che tessono il rovescio dello spartito. Come nel suo intenso invocare. Pregno di interrogazioni, in una relazione diretta con l’enigma, sollecitato e amato in quanto tale. E ancora nel suo evocare meravigliato. Denso di immagini che svelano universi insieme onirici e reali, fiabeschi e familiari, terreni e metafisici. Nell’amore di una ‘chiaroveggenza’ che fa i conti con impotenze e illusioni, ma disponibile a schiudersi “a primo soffio, tenuto in fede di parola”. Una voce, quella di Silvia, insieme prossima e tesa all’oltranza. Colma di mondo e di ‘antimondo’. Amante del dettaglio e dell’intero. Danzante a ritroso e all’infinito. Una voce da cui farsi coinvolgere e trascinare, seguendo la ‘luminescenza’ che musica.

Un giorno ho incontrato per caso Silvia Comoglio all’angolo di una delle vie principali della mia città. Silvia Comoglio abita a 350 chilometri da qui, io vado molto raramente nella mia città ma, per caso, ci siamo incontrate. Adesso la incontro in questo suo Afasia. Nelle pagine trovo spicchi di parole specchiati in conche e gusci. Nelle fessure soffi, suoni e altro. Impronte di respiri, spillati. Lucore di vite minime cucite all’orecchio, all’occhio. Ancora echi. Dove passaggi, dove dettagli liquidati, dove germogli e rincorse. Dove incontri non per caso.
Afasia inaugura il suo viaggio nell’acquoreo della lingua, tra sentire e significare, chiedendo attenzione ai riflessi morgani che in quell’andare cantano o disturbano, a seconda che il senso appaia o confonda. Comoglio tende al massimo la possibilità del dire, lo torce seguendo grammatiche remote o di là da venire, piega logica e semantica all’immaginazione, dando forma all’enigma, natura magica della poesia originaria. La poesia è sfinge, ci dice, che però non pone domande né inganna il mondo, ma ci apre al mistero del qui e ora, del reale già sempre in balia dell’apparenza, e viceversa. La parola poetica, ci dice ancora, si ferma prima della cristallizzazione significante, è il seme del controcanto, l’a privativa che addita una via differente alla parola del potere, all’atto del dire che domina. In questa sua voluta assenza di mimesis dell’ordine e delle gerarchie, la parola di Silvia svela la propria natura anarchica e ci invita all’esercizio dell’abbandono dei nostri sensi alle innumerevoli sfumature fonetiche e ritmiche della lingua; una lingua piena, multiforme, non ancora ridotta a veicolo utilitaristico.

Silvia Comoglio, sin dall’esergo di Borges, porge al lettore chiave ed enigma della sua poetica. Hanslick, citato dal poeta argentino, nel “Bello musicale” parla di un bello specificamente musicale per il quale possiamo affermare che così come la musica, anche la poesia non significa altro che sé stessa. Ecco che le hanslickiane forme sonore in movimento di “Afasia” appaiono nel loro drastico significato di struttura e nomenclatura imprescindibile alla visione; ecco il cubicolo della lingua che richiama la guarigione del lebbroso nel Cubicolo di David; ecco il divieto di dire la guarigione e al tempo stesso il dire come trasgressione del divieto. Forme che traggono forza da parole recise da un trattino inaspettato, da parentesi che isolano e potenziano le avversative, da accenti di parola che non era necessario segnare sulla carta se ciò non fosse, invece, profondamente necessario all’oralità di una scrittura che fa del puro suono l’architettura di un significato puro: quello della poesia, arte afasica capace di accedere alla realtà inconoscibile nel tempo di parola che non dicendo, dice, come il pesce d’oro di Afanes’ev, qui, nello stagno gridato a fior di loto.
Questo libro, innervato da una costante e forte maturità espressiva, è una partitura per voce sola, voce narrante, dialoghi, suoni cristallini. Come “luce a eco rivoltata” le parole si trasformano in una grande, inedita sinestesia, resa ancora più percepibile dal variare di corpi e spazi testuali, come fossero toni differenti della voce e pause, brevi prese di respiro. Con la precisione dell’orafo, Silvia costruisce una filigrana verbale ricca di intensità, ricostruisce un mondo vero e finalmente reale, senza le tante maschere delle apparenze. E pagina dopo pagina, l’apeiron, l’indefinito, da un “cubicolo di lingua” prende forma e sostanza. Afasia, antimondo, chiaroveggenza, luminescenza, sono i punti nodali di quest’opera. Passaggi che ci portano dove non eravamo mai stati.

La scrittura di Martinez si diversifica visibilmente da forme poetiche più tradizionali, fin dall’impaginazione; centrati e squadrati in diversa ampiezza, i testi, all’occhio, presentano diverse lunghezze, e per lunghezza va intesa propriamente la dimensione orizzontale di questi versi con impaginazione spesso giustificata: come se stessimo guardando delle figure geometriche proposte per blocchi più o meno ampi, molto spesso quadrati o rettangoli. Già una disposizione tale propone una riflessione: è possibile parlare davvero di “verso” per Martinez? Se canonicamente intendiamo un verso concluso grazie all’uso dell’a-capo non sembra possibile valorizzare i versi dell’autrice. Trovando sul limitare dell’a-capo preposizioni articoli congiunzioni e parole irrilevanti dal punto di vista semantico, sembrerebbe proprio che chi scrive non abbia alcun interesse ad un uso tradizionale del verso. Leggendo i testi, infatti, ci si ritrova immersi in un andirivieni, continuo e magmatico, di artifici, ma raramente essi sono ascrivibili a quelli di posizione incipitaria ed explicitaria dei versi: assenza di punteggiatura e maiuscole, assonanze, consonanze, quasi anagrammi talvolta, quasi paronomasie, rime interne, rime ricche, figure etimologiche, poliptoti, usi transitivi di verbi solitamente intransitivi, neoformazioni verbali, mistura di italiano e dialetto, metafore continue e, a complicare i testi, una sintassi talvolta apparentemente scorretta: in questa scrittura densissima non è agevole parlare dunque di “verso” per come lo si intende tradizionalmente, perché l’uso talora inatteso, improvviso, spiazzante di certi schemi, di testi che generano altri testi spezzando i legami sintattici tra parole e parole, tende a formare non propriamente dei “versi”, quanto più delle circostanze, degli eventi linguistici da cui ne scaturiscono altri, determinandone il senso reciprocamente.
Questo ostinato lavorìo potrebbe richiamare una sorta di ecriture automatique, un improvviso affiorare agli occhi e alle orecchie del lettore, che rimane felicemente sbigottito, ed ha certamente unicità nella poesia contemporanea, se si esclude il caso della straordinaria Amelia Rosselli, da cui sembra attingere la maniera, vertendo tutto se stesso sul concetto originario di ποιέω, del fare poetico, che diviene a tutti gli effetti generazione, e senza tra l’altro mostrare spiccati barocchismi1 . Non per nulla la neonata casa editrice Anterem, la cui storia come rivista è ormai ultradecennale, sceglie di aprire la propria pubblicazione di testi proprio con Martinez, autrice che, grazie a questo suo peculiare uso della lingua, sembra voler arrivare a una forma primordiale, che si situi in una posizione precedente all’uso della stessa parola.
Sembra quasi di affondare (e affogare) nella composizione di chi scrive, e a tale proposito giunge utile una citazione della stessa Rosselli, tramite la quale potere comprendere meglio questo stile; ella scriveva così nel tentativo di spiegare la generazione dei testi: “Tentai di osservare ogni materialità esterna con la più completa minuziosità possibile entro un immediato lasso di tempo e di spazio sperimentale. Ad ogni spostamento del mio corpo aggiungevo tentando, un completo “quadro” dell’esistenza circondantemi; la mente doveva assimilare l’intero significato del quadro entro il tempo in cui essa vi permaneva, e fondervi la sua propria dinamicità interiore”.2 Che sia questa la tecnica per scrivere dell’autrice palermitana non è dato saperlo, ma a conferma di quanta vicinanza ci sia con la Rosselli è possibile applicare un commento della Enciclopedia Treccani alla Rosselli stessa:
“[…] Il testo è composto attraverso la retorica della ripetizione, della variazione e dell’opposizione: all’interno della logica sintattica s’innesca così un’interazione associativa che punta a rifondare la ragione occidentale senza l’esclusione dell’irrazionale. L’inevitabile oscurità che ne deriva è rotta da illuminazioni spesso lancinanti.3”
L’autrice siciliana genera un fluido verbale entro il quale stordirsi, una osmosi spazio-temporale, sonora, visiva, olfattiva, tattile: un confluire di evocazioni multisensoriali e isocrone. Martinez offre una sua, e sembrerebbe unicamente, egoisticamente, visceralmente propria poesia, al limite del disinteresse verso il lettore. Ma “per chi vuole ascoltare”, come scrive nella esilissima prefazione Maria Grazia Calandrone, la musica di Martinez suonerà sì molto distante dai pattern regolari e noti della poesia canonica, ma non per questo priva di una propria “armonia tendenziale”, come titola una delle sezioni di Liturgia dell’acqua.
Si propone una breve antologia di passi dai quali sia possibile evincere sia lo stile peculiare che, nell’apparente caoticità delle parole in gara tra loro, immagini e tematiche trattate già in altri volumi editi: l’infanzia, le figure genitoriali, l’amore, la città di Palermo; a conferma di una voce decisamente personale e che va proseguendo il proprio cammino poetico.

p.29
a mano recidere dovrebbe qui silenzio
e s'allaga e s'ombra e non muove da
muovere che s'inverna minima chiosa
la cena dentro l'arcata al di dentro dei
limoni tondi rotonda una caduta tonda
ripasso sparso lì sparso che si dice sia
l'avverbio a frugare tra le gambe il sole
bambino per strada e qualche moneta
avvolta sulla pancia di una trottola la
primissima volta di un bacio il risvolto
del soggiorno la luce di traverso come
ombelico mangiato d'un fiato col fiato
morbidissimo la tazzina del caffè quel
primo piano dimenticato che nascosto
si lascia ninnare dalla tenerezza di Dio
p.36
l'immobile l'assoluto più preciso
bacio punto della rosa o dispersa
sposa crocevia a spinta di gambe
allentata quasi regola il miracolo
ch'io s'arrotola ch'io accresciuta
sfusa la condanna avrebbe capito
insazia lontananza tuttora invoca
*
trattenere l'attenzione in un petto
fermo alla stazione s'accresce la
limpida mostura d'un incontro né
l'ultimo ridà loro cinte le pupille
quasi campo assolato nel grembo
proteso l'incline pigolìo del cielo
p. 37
indipendente dormendo ascende
l'argomento il particolare del no
esistente dimentico da nessuno i
minuscoli secondi l'intimità con
qualcuno dentro la casa isolata e
le pesche i fiori a cornice l'erba
dalla palpebre cresce nascosta ai
santi sulla piazza oggi poco fa si
è accesa l'ultima lanterna e dalla
strada assale l'infanzia del vento
la precisa irrealtà di una distanza

Le sensazioni vissute dal lettore possono essere spiazzanti, ossimoriche: rifiuto, incomprensione, abbandono, catarsi. L'autrice non lascia al lettore alcun punto di riferimento, non gli offre la possibilità di scegliere, se non arbitrariamente, quale parola sia legata alla successiva o alla precedente, o quale sintagma spesso in forma metaforica meglio si adatti a esprimere il senso del discorso, a riprova della fluidità di testi che si possono agilmente adagiare entro forme diverse, qualità inconfondibile di ogni fluido.
A questo punto è possibile fare un gioco con i testi di Martinez; gioco serissimo: tentare di ricomporre in versi liberi i testi che, come quello a p.49, sono in prosa. Stesso tipo di lavoro era possibile svolgerlo, e critici di epoche passate lo hanno fatto già, con parecchi testi dell'Allegria di Ungaretti. A p.49 mi sono permesso di barrare con degli a capo quelli che a mio personalissimo parere potessero essere versi singoli, senza star lì a conteggiare sillabe e sinalefe per forzare sulla metrica tradizionale: mi sono soltanto permesso di inserire barre e andare a capo; il testo così avrebbe una sua lettura, con pause e riprese, con un respiro dettato dal lettore. Ciascuno può giocare così con quasi tutti i testi di Liturgia dell'acqua. Ma il limite di quest'operazione risiede proprio nel fatto che tale atto, benché non del tutto arbitrario, (è l'autrice a permettercelo, non offrendo al lettore nessuna indicazione tramite segni di punteggiatura o a capo specifici) rimane esattamente del tutto arbitrario: perché dare rilievo maggiore tramite una pausa a una parola anziché ad un'altra significa scegliere; e la scrittura di Martinez in diversi luoghi, come in questo a p.49 non sceglie: se la scelta comporta necessariamente uno scarto e, nella poesia, un limite metrico (il precipizio dell'a-capo), l'autrice preferisce il flusso, (la liturgia è dell'elemento fluido non a caso in rimando al titolo) lasciando poi eventualmente a chi legge il piacere di arrovellarsi con la pregnanza (maggiore o minore) di un passo, di un periodo, di un sintagma, di una parola, di una pausa.
Dalla raccolta Il rumore del latte infine è possibile estrapolare una sorta di dichiarazione di poetica. In esergo alle pagine sinistre si trova una parola o un breve sintagma: ricomponendole viene fuori il seguente testo.
Sottosopra l'affondo dall'ombra spioggia appena alba sospesa primula bambina a bassa voce d'inesistenza duole e cade impertinente finità dando controvolto tutt'intorno discende assenza voltarsi andando imperfetti dentro uno specchio toccarsi nell'unico intervallo una carezza nel grembo sovraposto.
“Sottospora” è il modo di lavorare spiazzante di Martinez: esso prende spunto da un vicolo, da un profumo, da una qualsiasi sensazione per snodarsi e diramarsi improvviso lungo inattese altre sensazioni o ricordi. L'“affondo dall'ombra” è il movimento di ricerca del sé proveniente da una oscura (non per questo macabra o tetra) profondità dell'essere, la quale riesce “appena” a “spioggiare”, neologismo interpretabile quale momento che segni la fine della pioggia: ad esso segue un momento luminoso e incerto una “alba sospesa”, assimilabile per analogia del tutto intuitiva ad una “primula bambina a bassa voce d'inesistenza”, voce quasi impercettibile che rasenta l'io poetico dell'autrice, la quale “duole e cade” ecc. Si potebbe molto congetturare sull'interpretazione semantica di alcuni passi come questo sopra citato, ma nuovamente la scelta l'autrice la lascia in ultimo al lettore; certo è invece che in questo testo in filigrana emergano continuamente tematiche affini se non costanti delle opere di Martinez: l'infanzia, l'ostinazione nella ricerca, l'assenza, il voltarsi indietro, verso il passato, l'intuizione dei brevi attimi di felicità vissuta, talvolta in assonanza con una o con entrambe le figure genitoriali, talaltra con la città di Palermo, i suoi odori, le sue luci, i suoi spazi, il tutto in una scrittura che cerca di risultare “una carezza” all'interno di luoghi vagamente fantasmatici e sovente chiusi, quasi claustrofobicamente riversi in sé stessi, in posizioni di percezione straniata, in un “grembo sovraposto”.
1Benché di aura baroccheggiante abbia parlato in prefazione al Rumore del latte Lucio Zinna, sostenendo che ci sia un surplus immaginativo che permetta all'autrice di sperimentare se e fino a che punto possa dilatarsi la metafora, dichiarando poi (citando anche Nicola Romano in prefazione a La bottega di via alloro) che si tratta non di estenuato, citazionista, ricercato, artificioso, ostentato e tronfio barocco, ma al contrario di un fascino (discreto) della sperimentalità, creando una poesia edificata su proprie fondamenta, illuminata da fantasmagorici richiami assonantici.
2Tratto da Spazi metrici - Amelia Rosselli, in: La parola ritrovata, a cura di Maria Ida Gaeta e Gabriella Sica, Marsilio 1995
3L'articolo completo è al link ROSSELLI, Amelia in "Dizionario Biografico" (treccani.it)


Pagine 46, €10
Per ordinare il volume scrivere a redazione@anteremedizioni.it

Fili, pro-fili squarciano la parola come se l'alfabeto dovesse pagare un debito nei confronti del tratto di glifi, linee rette, curve, configurazioni geometriche prima che la mano arrivasse a ridurre e rimuovere tutta quella esuberanza spaziale e visiva all'interno delle singole lettere del nostro alfabeto, appunto. E quel debito non è solo debito, ma investimento essenziale da riattivare quando l'intellettualizzazione estrema che porta al nostro alfabeto, le 24 lettere in cui risiede tutta la nostra letteratura scriveva Mallarmé, ritrova il soffio che lo spazio contiene e senza il quale lo spazio non è comprensibile e l'umano diventa improbabile. Soffio, movimento che fanno volare sulla pagina le parole come uccelli migranti, per i quale il lettore deve muoversi dai suoi automatismi per ritrovare in fondo a sé l'arte degli aùguri, leggere al di là delle configurazioni linguistiche scompigliate dalle forze che circolano sulla pagina quand'è ancora bianca e alle quali Armando Bertollo ha saputo non solo dare spazio, restituire a loro lo spazio, ma pure la visibilità, un visibile in costante eccesso per rapporto al dire. Fare vedere quelle forze comporta volumi burrascosi fatti dalla materia pensante.
Francois Bruzzo, nato in Francia, professore di lingua, civiltà e letteratura francese, di Storia del Teatro e Teorie dell'arte. Ha insegnato presso le università di Padova e di Feltre e all’università IULM di Milano. È autore di numerosi saggi e volumi. Collabora con Anterem dal 1982.

Questo testo di Federici costituisce per il lettore sia un banco di prova arduo che un’occasione unica per riflettere sul concetto di esperimento all’incrocio di scienza e arte. Personalmente ho sempre nutrito delle riserve sulla nozione di poesia sperimentale anzitutto perché credo che le condizioni di laboratorio dell’esperimento scientifico non siano affatto riproducibili nell’atto della scrittura, e poi perché credo che in poesia si tratti piuttosto di esperienze di vita, che solo in un secondo tempo vanno trascritte o registrate in un media qualsiasi. Insomma, a mio avviso, la sperimentazione va fatta a monte della messa in opera, in “quell’immenso e ragionato sregolamento di tutti i sensi” (Rimbaud) che consente al poeta di farsi veggente e gettare uno sguardo nuovo sulle cose, cogliendone così l’“anima universale”, il disegno nel dettaglio, l’universo in guscio di noce.
E’ nota la dimestichezza di Federici con la fisica che, a suo stesso dire, gli offre la cornice teorica della propria sperimentazione artistica.1 Ma a me pare ancora più interessante l’ascolto della natura, per esempio delle vibrazioni suscitate dal vento o dalla pioggia sulla scorza degli alberi morti, che l’autore ha praticato nel corso degli anni, con l’ausilio di semplici attrezzature tecniche, sì da far scaturire effettivamente dall’esperimento scientifico un’esperienza fenomenica liminale. Le registrazioni di questi esperimenti all’aria aperta costituiscono poi la memoria prostetica e il materiale grezzo su cui l’artista opera nel suo laboratorio di scrittura o dipintura verbale, magari giovandosi una vecchia Olivetti Studio 46, insieme a inchiostro, penna, gomma e matita, per produrre le sue tavole verbovisive che, nel caso del presente testo, vanno rubricate semmai come scritture desemantizzate piuttosto che asemiche, secondo una distinzione da lui stesso sottoscritta in un’illuminate intervista.2
Infatti è la sovrapposizione dei caratteri tipografici e chirografici, dei disegni geometrici e ornati, delle gradazioni e delle sfumature dell’inchiostro a creare quelle tavole verbovisive che, a mio avviso, vanno considerate come delle vere e proprie matrici della composizione di cui qui si tratta. E non tanto nel senso astratto delle matrici della fisica quantistica (che, per il lettore comune che non sia in grado di comprenderne le equazioni matematiche, possono costituire al meglio una vaga e generica analogia) quanto piuttosto in quello concreto e materico delle schede madri di un computer che ne custodiscono la memoria di sistema, ossia “il varco di Tiresia” (12-13), la preveggenza operativa della macchina.
Risulta interessante perciò qui il rapporto fra low e high tech, perché l’autore simula con notevole precisione e sottigliezza, con penna e macchina da scrivere, la tecnologia digitale nella sua caratteristica sinergia di hardware e software. Il “varco di Tiresia” si può dunque anche intendere come il passaggio epocale dalla civiltà della stampa a quella digitale, nonché dal regime della rappresentazione a quello della simulazione del Reale. Questa tavola è pertanto quella su cui si impernia l’intera composizione del testo, che può essere recepito come una vera e propria installazione di videoarte interattiva, ponendo anche così il problema del passaggio dalla bidimensionalità della pagina scritta alla tridimensionalità dell’esperienza immersiva della così detta realtà aumentata. Perciò si potrebbe parlare anche di iperrealismo come dimensione ennesima di quest’opera, in linea con l’intento espresso dal suo titolo Misura del sonno, cioè dell’incommensurabile, un’impresa in via di principio votata allo scacco ma non per questo meno capace di illuminare reconditi aspetti dello stato di veglia. Non per nulla la tavola finale viene poi intitolata “al risveglio”, mentre la griglia di quella immediatamente precedente recita “because of these words whose son you are” (“a causa di queste parole di cui sei figlio”) (52), con un rinvio esplicito al varco di Tiresia dell’inizio, che pertanto costituisce la cesura spazio/temporale dell’intera opera, ossia la crepa madre da cui ne scaturisce la poesia.
Poiché a tal proposito preferisco parlare di “poesia”, intesa etimologicamente nel senso di composizione e manipolazione artigianale (poiein), piuttosto che di “scrittura”, che considero un termine troppo generico, sebbene oggi di moda, per esprimere qualsiasi espressione verbale con intento artistico. E anche perché il concetto di poesia amplia la portata di queste mie osservazioni a coprire sia la tradizione lirica che quella sperimentale. Di funzione poetica o autoreferenziale (Jakobson), se non di poesia tout court, mi pare infatti si tratti sempre, ogni qual volta (almeno da Mallarmé ad Apollinaire, ai giorni nostri) si appresti una partizione iconico musicale della pagina che trascende l’intreccio proposizionale del discorso in prosa a fini meramente comunicativi. Intendo dire che la funzione poetica può innescarsi anche là dove il principio del verso risulti del tutto assente, che non è comunque il nostro caso, perché qui è proprio l’alternanza di versificazione tradizionale e di tavole verbovisive, insieme alla diglossia intrinseca del testo3, a costituire il proprium dell’opera. Con un’interessante inversione del rapporto fra versi e dipinture, in quanto, mi pare, sono i primi a fungere da glosse a margine delle seconde, sottolineando così anche nel contempo lo statuto della scrittura come parergon dell’opera, supplemento e traccia di un irrecuperabile flatus vocis, respiro e spirito della parola creatrice in grado di dare appunto una misura alla magmatica sinestesia di un lacerto di vissuto, inteso come sineddoche cangiante sia dell’esperienza del mondo che dell’universo di discorso che lo esprime. Così come risulta chiaramente nella tavola intitolata “CANTO DI BALENA ADDORMENTATA” (38-39) che costituisce, per quanto possibile, una sorta di correlativo oggettivo della “misura del sonno”, nonché una sineddoche del mare come habitat della vita primordiale, nel gioco marcato di chiaroscuri, segni e disegni, dattiloscritti e scritture amanuensi, ai limiti del visibile e dell’udibile, in uno stato indistinto fra sonno e veglia, vita e morte. In quella natura integralmente anfibia e liminare, insomma, che caratterizza anche l’ineffabile misura del sonno: “la balena/ intera/ una parte del mare/ astratta – astratta/ la sua scia di schiuma si allunga attraverso i mari/ per un po’/ aspetta/ nel frattempo è addormentata/ morta/ nella sua porzione d’acqua ferma/ respira/ polmonipienidiacqua/ una balena – un’ombra di/ alghe sul fondo del mare/ (una balena non riesce a dormire/ una balena non riesce a morire)” (38) Questa tavola riassume perciò quegli “affioramenti ai margini del sonno” (56) di cui l’autore ci riferisce infine in nota.
Se consideriamo anche la densa nuvola d’inchiostro (42-43), contornata di ghirigori e paraffi scritturali pressoché illeggibili, che si può considerare a mio avviso come una macchia di Rorschach su cui ciascun fruitore può esercitare il proprio test proiettivo, allora si comprende che ci troviamo davanti a un percorso interattivo surplace, cioè proprio a una installazione immersiva simulata nello spazio bidimensionale del testo, dove peraltro le variazioni di scala, di frequenza, di intensità e di timbro rappresentano il procedimento poetico di fondo, realizzando quella fusione di esperienza ed esperimento, di cui ho accennato all’inizio, che ne costituisce probabilmente il tratto saliente.

La scrittura di Silvia Comoglio, nel suo uso vario e accurato, di tutti i grafemi disponibili, ( -- - … ( ) [ ecc.), oltre alla normale punteggiatura, si approssima tecnicamente alla condizione dello spartito musicale e, come quello fa con le note della scala cromatica, scompone e ricompone i sintagmi, i lessemi e i fonemi, in una sorta di smembramento cerimoniale (sparagmos) del linguaggio ordinario, per ricondurlo alla base fonica e alla sua traccia grafica.
Questo procedimento viene per giunta messo a tema nel susseguirsi di epifanie e dissolvenze, assoluzioni e dissoluzioni materiche, nel duetto costante fra una voce più aerea e una più grave, fra luna e terra, anima e mondo, cantato e parlato, proprio come accade nel canto parlato (Sprechgesang) del Pierrot Lunaire di Schoenberg, per esempio, là dove “il suono cantato conserva immutata la sua altezza, mentre il suono parlato dà sì l'altezza della nota, ma la abbandona subito, scendendo o salendo.” Un canto parlato tuttavia polverizzato in frazioni di tono, ridotto a onde sonore al limite della indistinzione tra forma sonata e cantata, come accade per esempio in Lux Aeterna di Ligeti. Tale declinazione vocale viene segnalata dalla giustapposizione sulla pagina di versi scritti in caratteri minuscoli e corsivi, ad altri in caratteri tondi e più grandi.
Come ci avverte il titolo, infatti, quello della voce rappresa, contratta e fenomenologicamente ridotta alla sua traccia grafica è il tema principale della silloge, sicché la partitura “musicale” del testo si iscrive nella cesura fra scrittura e vocalità, mettendo a fuoco il difetto costitutivo sia della dizione come dell’ascolto, peccato originale del linguaggio verbale e in particolare della sua funzione poetica di battesimo del mondo: Afasia. Il peccato come carenza creaturale, dunque, piuttosto che effetto di trasgressione di una legge. Il testo custodisce dunque riverberi ontologici e teologici, come armonici lontani degli accordi musicali che simula. Le quattro parti in cui è diviso (Afasia, Antimondo, Chiaroveggenza, Luminescenza) evocano quelle della forma sonata-cantata, in senso lato, sconvolgendola però radicalmente in una continua modulazione e intreccio di motivi, in uno sviluppo aperto, atonale, micropolifonico.
La prosodia e il ritmo della versificazione, dell’andare a capo, evocano qui la cesura onto-logica tra evento e traccia, che riassume quelle tra essere e coscienza, cose e parole, suono e senso. Il testo esplora infatti le soglie dell’asemanticità senza però varcarle, evocando i profili di un antimondo onirico. Questa scrittura costituisce un mirabile esercizio di equilibrio sul filo fra segno e sintomo, senso e sensibilità organica, risolvendosi infine nel simbolo stilizzato della rinascita, “il pesce d’oro” come epifania dell’Altrove. Esso richiama anche il tema della bocca-bacio che ricorre sovente nel testo.
Il taglio dell’opera si concretizza dunque in quello sinuoso delle labbra che si schiudono e combaciano, nell’immagine della bocca, che si apre nel soffio e si chiude nel “bacio”, come compendio dell’esecuzione di questo spartito onirico e come dono dell’antimondo musicale.
Come ci avverte infatti Hanslick nell’esergo iniziale, la musica è di per sé intraducibile e poiché la traduzione è la forma elementare di ogni interpretazione, questo testo “spartito” non si può a rigore interpretare ma solo eseguire. Ma mentre l’interpretazione e il dialogo verbale rientrano nell’economia simmetrica dello scambio, l’esecuzione musicale rientra in quella asimmetrica del dono, del mana e dell’emanazione piuttosto che della creazione intenzionale di un mondo. La rottura di simmetria, la sua declinazione obliqua, costituisce perciò una costante tematico-strutturale dell’opera. La simmetria inversa, il rispecchiamento, nucleo narcisistico della coscienza e del linguaggio (logos e foné), vengono pertanto messi fuori gioco, fenomenologicamente sospesi e ridotti nella filigrana sinuosa della traccia.
Il percorso di senso che corteggia la musica, delineato all’inizio, procede poi per balzi, vuoti e pieni, si allarga in una domanda prolungata, scandita in liturgia, si inabissa in lacune radenti la superficie del suono, sfiorando il silenzio, scolpendolo a tratti. Un percorso annunciato nei frammenti iniziali che si svolge per vortici dal soffio al suono, alla parola, all’immagine e da qui vien poi sempre rigettato indietro, come in una risacca di spuma, dall’orlo della rappresentazione al pulsare sordo che la sottende. Nello spazio incalcolabile del risvolto fra suono e senso, le cose appaiono così rapprese e illuminate insieme, fuse in lampi di luce. Una serie di inizi senza seguito, albe di creazione in vuoti siderei, versi folgorati in punta di domanda. Epifanie, svelamenti, sintomi prima ancora che segni. Il discorso procede per equilibri punteggiati, per abbaglianti sinestesie, giovandosi dei grafemi di cui abbiamo detto come indicazioni armoniche, dinamiche e agogiche della sua sintassi musicale.
Occorre ora marcarne alcuni tratti strutturali e poi dipanarne alcuni fili tematici.
Il testo costituisce una microfisica del senso contrassegnata graficamente dalle avversative e dalle enclitiche in parentesi: (ma), (e), come una messa in mora (epoché) dell’universo di discorso. L’esergo da Borges per cui “l’enigma dovrebbe bastarci”, e l’inciso marginale “cubicolo di lingua/ l’incavo a pura sosta/ issato fuso in gola?” (9), insieme all’epifania del pesce d’oro alla fine, costituiscono la cornice del testo e ce ne forniscono le coordinate di lettura, accennando nel contempo alle questioni di fondo che attraversano la sua aerea e accurata tessitura, e più che strutturarlo lo tengono in una ondulata sospensione.
Il simbolo del “pesce d’oro” ha una diffusione universale e fu adottato dai primi cristiani come segno di riconoscimento. Il termine greco “ichtùs” che significa “pesce” costituisce infatti l’acronimo Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr che in italiano si può tradurre “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”. Esso si materializza poi nel testo, nella metafora ricorrente del bacio come dono delle labbra che si aprono e richiudono a ogni pronuncia dei nomi, atto eminentemente poetico che qui caratterizza la genealogia del dire, dal soffio al suono, al senso e al simbolo appunto.
Le quattro parti (Afasia, Antimondo, Chiaroveggenza, Luminescenza) in cui è diviso il testo possono essere lette come la sua impalcatura numerologica: il 4 infatti simboleggia il tetraedro, la più semplice figura solida, e il tetragramma biblico, cioè le quattro lettere che compongono il nome di Dio, nonché la concretezza e la stabilità della terra, qui ampiamente esplorata in contrapposizione alla eterea variabilità della luna. E se si vuole rinvia al concetto heideggeriano di “quadratura” (Gewiert) come unità originaria dove cielo e terra, i divini e i mortali poeticamente coabitano. E’ dunque il luogo utopico dell’incontro (del combaciare) fra spirito e materia, e fra parola e cosa. Quattro, una per sezione, sono poi anche le cascate verticali di frammenti, grappoli micropolifonici che scandiscono il discorso poetico, spazializzando il suono come accade nella musica postweberniana del secondo Novecento. Costituiscono le colonne liquide che reggono questa architettura trasparente, i vortici e i soffioni magmatici di una terra in perenne gestazione, “terra mutata bosco” (12), spazio fluido del costruire e dell’abitare, casa dell’essere, luogo della parola poetica, che custodisce nel suono “l’ultimo segreto,/ il sonante, e eterno, strisciare delle ali” (38), annunciando la palingenesi sulla soglia del silenzio “bevuto in bacio” (50)
Faremo ora qualche accenno allo sviluppo degli intricati temi dell’opera a partire da quello centrale della bocca-ferita che si apre nel soffio della vocazione e si chiude nel dono del bacio. In una sorta di percorso del respiro poetico dal conato fonico dell’auspicio iniziale, “che salpi ora dalla bocca il lungo --/ stato di paura vibrato in bella lontananza” (11) che si fa “soffio che rò-/ tola nel tempo” (19) e vocazione (in duplice senso): “dimora che sprofonda dentro il mio respiro/ questa lunga ninna che agita la lingua: eco --/ di fine insonnia a metafora di mondo” (20) Bocca che si schiude sulla soglia dell’afasia, per sillabare terra e mondo: “la terra che ripara il tempo in sua fessura, in vor-/ tice che bacia ore di cesura e il mondo” (15). Offrendo, nella diaspora sonora del senso, il dono del bacio: “tondo bacio dondolante/ è l’albero redento a diaspora di mondo”. (17) L’antimondo lunare onirico, nel delirio del logos e della foné, “il delirio di bocche che ti sfioro,/ e tu per loro ordine dissolto, viottolo nell’orto”. (27) Così si concretizza man mano, nella frattura ritmica, la figura del bacio come labile (labiale) combaciare di suono e senso, profilarsi della forma di vita: “(ma): un bacio, un bacio--/ è stato fatto! Dove ora è sopraggiunto/ questo solo cuore e-/ siliato a tempo minimo di vita?” (29) Così la Chiaroveggenza della terza parte, si annuncia in forma di bacio come torsione cosmica della bocca-cesura, “l’inarcarsi ad amen/ di questa stessa bocca rotante a gi-rasole” (36) e poi si espande in una variazione seriale del tema come nello Sprechgesang del Pierrot Lunaire di Schoemberg: “[gli occhi, mi siete-gl’ -occhi,/ del bacio che vi ho dato : cocente --/ voce abbacinata che srotola a miraggio/ l’alba nata sacra in ombre straniate mute…[i vostri scherzosi occhi bacio e vi ribacio,/ varco che mugola di fiaba…tràsudate a labbra di rosso pa-/ radiso”. (38) Si fissa nella sinestesia onirica del bacio dello sguardo: “[udii sogni che fecero degl’occhi --/ alte - e strane case : specchi in cui ti guardi…cuspide di sguardo ùnico d’amore” (43) che si apre poi come un fiore nell’ultima sezione Luminescenza: “mùrami la bocca di lumi liquidi di cielo,/ incontrati di notte per ventura” (47), annunciando un’effimera palingenesi: “nel mondo appena nato,/ sul palmo della mano, a cu-/ spide di sguardo ùnico d’amore” (52), nel fremito che “trabocca” (55) nel grido finale di richiamo all’altrove.
Il tema radice della bocca-bacio modula poi per salti in una serie fitta ramificazioni a rizoma nel costante dialogo fra terra e mondo, essere e coscienza, parlato e cantato. La terra “mutata a bosco” (12) e oniricamente “germogliata”. La terra contratta e rappresa, profonda e misconosciuta, arsa e benedetta, innamorata vacillante eco di respiro, sacrificalmente smembrata e ricomposta nel bosco sacro, nella baudeleriana foresta di simboli, sotto una folle, diffratta, magata luce lunare che assilla e avvolge il Pierrot poeta nelle molteplici pieghe del canto parlato, conducendolo sulla soglia della chiaroveggenza e del primitivo stupore. Cito qui per intero a epitome di questo persistente dialogo:
[amore di impotente chiaroveggenza l’occhio divorato
sempre dal suo mondo: chiglia rovesciata in nugoli di voci
tacite a frontiera, a profonda terra misconosciuta
*
Vacillarvi sul fondo della terra, a giusto
solo peso di un mondo senza mondo,
come se orma cresciuta inconcepita,
al limite di sponde nude di stupore – (41)
la terra ha tua leggenda cullata di rimbalzo,
le forme, stupite a bosco, di un tempo --
trainato a mondo (50)
Soglia, fioritura fra parola e cosa: “qualcosa, qualcosa, ha lo stelo della soglia” (49), soglia dell’oltremondo: “Mondo, Voi mi siete issato in trasparenza oltre” (54). Limite del visibile e dell’udibile nella traccia del soffio-voce nella partitura franta del testo: “l’immagine che traccia il minimo restare/ del fiore sopra l’acqua: linfa a voce sparsa/ rimasta in traversata dentro il tuo sospiro” (44), “luna frantumata nel tempo di parola” (45), “[terra, lieve a terra, la voce che riluce” (51)
Il tema della soglia si fonde poi con la figura ubiqua della sinestesia, scissura e congiunzione di tutti i sensi, fissandosi in versi memorabili, come la “luce a eco rivoltata” (16) e culminando nella sinestesia portante dell’intero testo, quella della Luminescenza come taglio di suono/luce che segna i vari ritorni a casa, gli a capo di una più ampia versificazione che va oltre la parola e la pagina scritta, facendoci intravvedere dietro il testo lo spartito spettrale dell’indicibile. L’evento dell’essere, il disvelamento della terra che si fa mondo sulla soglia del silenzio “bevuto in bacio” nella piega della bocca, “all’ombra curva di silenzio”, “un salto e musica e bagliore,/ e il fuoco che smaschera di pietra la terra --/ eretta dall’amore.” (50) Nel taglio di suono/luce rappreso nella piega sinuosa delle labbra: “mùrami la bocca di lumi liquidi di cielo,/ incontrati di notte per ventura” (47), annunciando la fine del “viaggio che trabocca”, (55) l’alba dell’antimondo “in fremito che urla/ la luce già ghiacciata”. (55)
Così l’esercizio dell’afasia si dispiega sulla soglia del silenzio, dalla promessa del bacio dell’inizio: “la terra traboccata a cuore”, che si schiude nella favola onirica “una terra di legenda, a taglio germogliata,/ la terra che ripara il tempo in sua fessura” (15). In frammenti di suono, lampi di luce, in contrappunto aperto atonale, in una distribuzione quantica di massa ed energia. Arcane matrici delle cose: vuoti di parole. Nell’indicibile taglio fra il verbale e il numerico: anima delle forme, geometria del visibile. Dono d’amore pieno, “a fiato misurato, in frammezzi, ciechi,/ di parole” (18) Esercizio della bella bugia poetica, “imbroglio nato dove esatto è il tempo di passaggio”. (56) Che culmina nel grido, nel richiamo finale all’altrove e si rapprende nel bacio, nell’icona labiale del pesce d’oro, simbolo di fecondità e promessa di palingenesi, compendio dello stile dell’autrice e firma in calce a questo suo testo spartito di inaudita luminosità.

Il titolo della raccolta La liturgia dell’acqua di Daìta Martinez ha il carattere iniziatico della metafora contenuta anche nell’incipit: “Muovo indietro un momento dalle mani e/ c’è un albero di ciliegio anche s’è inverno/ e me di un silenzio distratto spoglio…”(pag.11) La poetessa si sottopone a un rituale battesimale (l’acqua è elemento di purificazione e rigenerazione) per effetto del quale a lei (di qui il carattere iniziatico) è concesso il privilegio di un rapporto particolare e diretto con l’essenza più profonda della natura umana. Il gesto corrisponde a quello compiuto dagli oracoli e dalle sibille nel mondo antico che interpretavano la volontà degli dei lasciando che il vento disperdesse subito i segni del loro messaggio in modo da salvare l’ineliminabile segreto e, come la veggente del mondo antico, la poetessa non può sciogliere del tutto il segreto che avvolge le cose. Arrivata a sfiorarne l’essenza, è in grado solamente di riferire per frammenti ciò che ha intuito per improvvise illuminazioni. “caduta nell’acqua dall’acqua una cicala/ è silenzio indaffarato a memoria il vento/ sperduta gentilezza d’attimo che sfugge…” (pag.17). La Martinez si pone dunque come tramite fra il mondo degli uomini e il mondo della verità: la sua è dunque una missione di conoscenza e di testimonianza allo stesso modo la poesia permette di attingere alle profondità della parola, portando alla luce i segreti che il mare dell’esistenza nasconde negli abissi. “vuoto dolcissimo vuoto il melograno/ s’immerge nel fondo quasi altezza la/ vergine accuccia una nenia sul prato…” (pag. 13). Unico e originalissimo è anche lo stile caratterizzato da un predominio assoluto della parola, cui attraverso la disintegrazione delle unità metrico-ritmiche tradizionali è affidata l’altissima responsabilità per restituire alla parola la sua pregnanza vergine e sacrale, caricata di tutta l’energia della sintesi, esplodendo di luce come un grido avvolto nel silenzio della pagina bianca” la liturgia dell’acqua / pianissimo la bocca/ quasi un senso nudo…(pag.21).
Ogni lettore di un testo poetico guarda al contenuto e mira a comprendere che cosa l’autore vuole comunicare. Ma la lettura dell’opera della Martinez suggerisce che le cure della sua ricerca non vanno soltanto al tono, agli accenti, alla forza ritmica dei testi che scrive ma anche a una piena libertà cromatica del linguaggio, aspetti questi che concorrono a creare la musica della poesia.
L’esperienza originaria da cui si sviluppa l’ opera della Martinez è infatti l’organizzazione armonica delle parole in unità complesse( i versi, le frasi, la punteggiatura ) e non si tratta di una ricerca formale fine a se stessa : la sperimentazione prosodica e metrica sono state impiegate come strumenti per mettere in risalto il valore evocativo e il valore primitivo di ogni parola, ciò che essa è( il suo suono e il suo significato) quando viene pensata e scritta nella sua magica purezza, nella sua nudità.” era stato il silenzio a conficcare l’uva/ era stato il silenzio a scoppiare le ore/ mentre sbocciava a guancia l’apostrofo/ sull’acqua provocata per inconsistenza/ d’un rigo a uno stretto cappotto stretto…(pag.23). Dalla parola poetica così cercata e riconquistata, così nuda, così sola, si vede generarsi il ritmo delle immagini e una lettura il più possibile vicina, diventa la figura di quel ritmo, secondo una metrica interna variante da lettura a lettura e la lettura varia secondo l’animo e l’estro, come dice De Robertis, in uno dei suoi saggi. La natura più profonda del linguaggio poetico, in questa splendida raccolta, è l’energia pura, l’istinto vitale che restituisce un valore autentico a una realtà che sembrava aver perso ogni valore “la fioritura del ciliegio l’incantesimo/ di una cantilena e nella danza di una / trottola il vento tutto sul viso di aziza …” (pag.51). La raffinata architettura sonora impreziosita e come illuminata da significativi accostamenti analogici che accompagna tutta l’elaborazione della Liturgia dell’acqua è lo strumento in grado di valorizzare il nucleo più autentico dell’insopprimibile mistero posto al fondo della conoscenza.

Al di là delle valenze storiografiche più puntuali, resta piuttosto noto ed emblematico il passaggio delle Vite parallele di Plutarco nel quale Aristide contribuisce al suo stesso esilio: «Allora mentre si stavano appunto scrivendo i cocci, si racconta che un tale analfabeta veramente rustico, dando il coccio ad Aristide, come al primo incontrato, gli chiese di scrivere il nome di Aristide. Meravigliandosene questi e informandosi che cosa di male gli avesse fatto Aristide, quello avrebbe risposto: “Nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il Giusto”. Udita una tale risposta, Aristide non avrebbe detto nulla, ma avrebbe scritto il nome sul coccio e glielo avrebbe restituito».
Il gesto dell’auto-ostracismo, che rafforza le qualità morali di Aristide detto il Giusto, è il primo riferimento che viene alla mente affrontando due libri preziosi pubblicati dalla collana “Nuova Limina” di Anterem nel 2022: Ostrakon, appunto, di Alessandro Ghignoli e Il cervo giudicato di Ianus Pravo. Non si tratta soltanto di sottolineare gli appigli etici, letterari e formali di una certa marginalità – Pravo era stato eletto «Re degli outsider» in un importante articolo di Sonia Caporossi apparso su Critica Impura, e questo già dieci anni fa – ma anche di andare a rintracciarne una genealogia che per entrambi gli autori si colloca con evidenza, anche biografica, nelle tradizioni poetiche sperimentali in lingua spagnola. Interrompendo, cioè, quella sorta di “anglo-francocentrismo” che sembra dominare nei riferimenti culturali e letterari del dibattito letterario e poetico italiano, i due autori presentano il portato di influenze eterodosse e lo rielaborano da par loro, senza per questo farsi completamente assorbire dal loro diverso quadro di riferimento.
Nel Cervo giudicato di Ianus Pravo, ad esempio, fa capolino il poeta spagnolo Leopoldo María Panero (1948-2014) – come osserva anche Maria Grazia Insinga nella densa, e intensa, nota finale – e lo fa in vari modi: con il titolo (che riecheggia El ciervo aplaudido di Panero, pubblicato nel 2013) con un esergo (da Himno a Satán, del 1987) e con un verso citato in lingua originale, «aun cuando el musgo es certeza» (p. 49). Per Ianus Pravo, Panero non sembra essere semplicemente sinonimo di isolamento, marginalità o maledettismo, ma – in funzione di una lunga frequentazione non solo umana ma anche poetica e traduttiva – l’autore di un sottotesto che riesce spesso a emergere con forza nel Cervo giudicato, ad esempio in quelle incursioni che vanno al di là della scorza del sentimento religioso, e che, pur muovendosi sul filo della blasfemia, restano bene all’interno dei territori del sacro (si veda, a titolo di esempio, il testo A Cristo manca il Cristo ma lo sfarsi ai corvi, p. 37 o i travestimenti della Noche oscura del alma di San Juan de la Cruz nel testo a p. 25, dove compare anche il “cervo giudicato” che dà il titolo al libro: «Non sa il labbro, scoria, il tremore di carne / che fa la notte oscura, oscura? Oscura la notte?»).
In questo, c’è di più di un semplice rinvio intertestuale all’Himno a Satán o ad altri luoghi della poesia di Panero. Andando alla radice dell’incontro con la poesia dell’autore spagnolo – come quella dei molti altri autori che Ianus Pravo cita nella sua scrittura, senza per questo mostrare quella forma di hybris che è tipica dell’enciclopedismo – la scrittura del Cervo giudicato sembra fondarsi su quella compresenza babelica di tutte le lingue che, secondo una lunga tradizione teorica, muove la pratica traduttiva (ricordata esplicitamente con una citazione shakespeariana, a p. 48: «When mercy seasons justice», da quel Mercante di Venezia che Jacques Derrida ha analizzato a più riprese, parlando di traduzione) ma che riguarda, allo stesso modo, i fondamenti della scrittura poetica. L’esito più immediato pare essere una sorta di plurilinguismo che è a tratti ribelle e sfrenato, però mai del tutto cerebrale né fine a sé stesso; anzi, è proprio tale plurilinguismo a incontrare la propria fine, nel mirabile «Dies Irae de dreit nien» che dà la stura al testo conclusivo, e dove fa capolino, quindi, Guglielmo d’Aquitania, conte di Poitiers, maestro del trobar clus e, qui, del “verso di puro niente”.
Sull’aggiramento di qualsiasi rischio di cerebralismoo, si vedano anche i versi incipitari del primo testo del libro: «Oh la clarté. / La clarté. / Oh la clarté. / Der Trūbung durch Helles. / La voix de oh la larme» (p. 13), che costituiscono un apparente scoglio anche per quel fantasma culturale che è il “lettore forte”, ma che richiamano, d’altronde, La clarté del titolo – una “chiarezza” che è sempre rintracciabile nella poesia di Ianus Pravo, come scrive Insinga (p. 55), magari, a mio parere, con un piccolo sforzo ulteriore di ricerca e di approfondimento, ma senza mai celarsi dietro trappole e infingimenti intellettualistici.
Tra i pochi preziosismi del testo, comunque, c’è la rincorsa imperfettamente omofonica, in castigliano come in italiano, tra ciervo (cervo) e siervo (servo), a sigillare e legittimare una delle tematiche più possenti del volume, il rapporto tra corpo e libertà: «C’è una carne ubbidiente a sé, / la sua libertà è sé stessa. / Ma la libertà è la carne del servo» (p. 21). A questo si lega anche il rapporto della scrittura di Ianus Pravo con il Nome del padre, che viene evocato più volte in una chiave che sembra riprendere e rielaborare la tradizione psicoanalitica lacaniana: «mi è ius la notte e il suo limite, / sono il padre e nascondo il nome di mio padre» (p. 39) e soprattutto «nessuno sa, e io ancor meno, il nome che il padre ha scritto / nel mio corpo di tedio: è il nome a nodo e bianco // concimato morrà come un dio profanato / hapax…» (p. 45). Tale iscrizione corporale, come si leggerà più avanti (p. 50), trova i propri numi tutelari non tanto in Lacan, quanto in Amleto e nel Kafka di Lettera al padre; ancora una volta, però, la rete intertestuale non è in grado, di per sé, di fornire alcuna garanzia. Anzi, è proprio la scrittura poetica a riaprire l’abisso tra il polo della cultura e quello della barbarie. Poli sovrapponibili, secondo la nota riflessione benjaminiana, ma che la scrittura poetica riesce a rendere tragici nella loro frizione, come accade in chiusura del testo appena citato: «lo spazio del salario per non dire, per non / dividere lo scarnire, non aprire l’Auschwitz //che protegge in rubedo ogni Atene dell’uomo, oltre d’Atene ad Auschwitz, l’oltre del padre al figlio» (p. 50).
Come segnala l’occorrenza molteplice del “salario” nel testo, Il cervo giudicato è un testo che si occupa anche di una certa economia, libidinale e politica, esplicando tale processo nel riferimento etimologico all’oikos quale spazio di condivisione domestico che però non riesce a sottrarsi, anzi contribuisce, a quel disciplinamento di legge che norma individuo e società, appunto, in chiave eco-nomica. Anche in questo caso, la poesia di Ianus Pravo pare in grado di suggerire una certa alternativa etica e politica a questo disciplinamento e contenimento della condivisione, appuntata anche da Maria Grazia Insinga quando riscontra «da un lato il nulla che permea l’io, dall’altro la condivisione dell’ultimo noi, noi che moriamo à la clarté des cieux, dell’ultimo cielo, come nel primo testo del libro (pp. 13-17): così, nasce la poesia, tempo primo, unità minima sufficiente di comprensione, linguaggio ineffabile, ineffabile nome, legge» (p. 56). Viene attuata una rifondazione della lirica – «quando l’io e il tu non sono che un egli» (p. 24) è uno dei versi più significativi, in questo senso – che è anche rifondazione della legge: sempre seguendo Insinga, si è costantemente alla ricerca di una «pravé ianuaria (p. 33) che potrebbe essere il riflesso del nuovo nome o del nuovo cielo; del nome stesso di Ianus Pravo, nato in gennaio; il dio bifronte latino unito a un aggettivo che indica “storto, deforme” […] quel pravé – ceco? esperanto? – sembra corrispondere, però, all’avverbio “appena, giustamente, a ragione”. Un linguaggio, quello di Ianus, che riscrive la legge, ne fa cielo: una inedita prospettiva del male del mondo, o meglio, di ciò che il mondo considera male e mostrando l’osceno ha occultato l’osceno (p. 46, ma anche pp. 15, 36)» (p. 56).
Un nome che, tuttavia, fatica a ricongiungersi con il volto – con quella sua peculiare declinazione lévinasiana che, in effetti, molto ha a che fare con l’identità – tanto per la persistenza della maschera («Il volo della maschera ha strappato la faccia, / sulla maschera il sangue ne è simulacro, resti / di faccia sono maschera sulla maschera in volo // perché è il volo alto a non permanere in maschera / ridendo di pietà sulla faccia straziata», p. 44) quanto per quella «inezia del vedere» (p. 30) che è un modo per decostruire l’ocularismo oggi egemone (in attesa che arrivino nuove ibridazioni umano-artificiali dalla diversa sensorialità).
A questo proposito, l’aforistico verso incipitario di un testo di Ianus Pravo qui già richiamato – «Non c’è vedente che assomigli in empietà a un cieco» (p. 24) – funge da buon ponte verso Ostrakon di Ghignoli, libro che si apre interrogando, anche a livello grafico, la specularità delle parole, delle frasi e dei versi, ricorrendo non di rado a quella tradizione poetica delle sequenze retrograde che costituisce uno degli antecedenti più chiari della poesia visiva e concreta affermatasi negli ultimi due secoli. Nel libro di Ghignoli, è la realtà con tutte le sue immagini ad essere chiamata in causa, visto che l’introibo speculare del libro recita, appunto: «THE FOLLOWING IS BASED ON A TRUE STORY / YROTS EURT A NO DESAB SI GNIWOLLOF EHT» (p. 11). È, inoltre, una specularità adeguatamente manipolata, portando a frequenti lacune, omissis o cancellazioni; non c’è, invece, quel dinamismo trasformativo che attiene al movimento dialettico (d’altronde, come si legge nel titolo del testo a p. 13, la follia è una dialettica ordinata).
Si genera, piuttosto, un interesse filologico o pseudo-filologico – rimarcato dall’uso ricorrente di alcune segnature tipiche dell’annotazione dei testi – ma che procede, tuttavia, nella consapevolezza di uno sforzo che diventa tanto più titanico quanto più si avvicina al presente: «la custodia dell’intorno il senso iscritto nella stanza en la estancia / in movimento fino al presente descritto in una sola laus» (p. 15). Ed è la coppia stanza/estancia – quasi omofonica, ma semanticamente assai diversa (al contrario, o forse specularmente, rispetto a quanto accadeva tra ciervo e siervo, per Ianus Pravo), e che quindi rimane, di fatto, a cavallo tra le lingue – a sottolineare in modo plastico la precarietà e vulnerabilità di un tentativo altrimenti gigantesco e pantagruelico. Non è solo un problema interno al linguaggio verbale: acrofonia IV presenta già nel titolo quel gioco tra stimoli visivi e abduzione linguistica (p. 17) che si ripercuote in tutto il libro – all’interno del quale la relazione parola-immagine è fondamentale e, al tempo stesso, di volta in volta scardinata – e la cui soluzione acrofonica è già da subito denunciata come possibile, dal punto di vista tecnico, ma non decisiva, in senso assoluto.
Del resto, Ostrakon è un campionario delle innumerevoli tecniche possibili di combinazione tra testo e immagine: il risultato è quasi sempre post-ecfrastico, non di rado virato in senso operativo (come quando una nota a piè di pagina fornisce la puntualissima bibliografia di un verso mancante: «Roberto Voller, Nel cucchiaio, Salvo imprevisti, Firenze 1976, p. 45», ma chiede di mandare una mail a Ghignoli stesso per poter venire a conoscenza del contenuto della citazione, contenuta in un volume ormai introvabile, p. 21) oppure ludico. D’altra parte, questa moltiplicazione delle operazioni di manipolazione dell’iconotesto si allontana certamente dalla «teoria della teoria» (p. 38), che magari affligge altre scritture di ricerca, ma crea, al tempo stesso, l’esigenza di una conferma della ricerca individuale perseguita da Ghignoli, il quale non a caso cita la «trasmutanza» (p. 31), rinviando a un suo precedente libro dallo stesso titolo (Sigismundus, 2014), e successivamente, la «mesopotamia» (p. 38) che dà il titolo ad un’altra sua opera poetica, ancora inedita.
Salvata la coerenza e l’omogeneità del percorso autoriale, resta però molto difficile – differentemente da quanto suggerito in precedenza per Ianus Pravo – affermare, in un contesto così chiaramente anti- o a-dialettico, un’alternativa che si opponga alle logiche dominanti, per quanto manipolate. Il potere resta un problema inaggirabile e anzi, quando si manifesta come potere economico, legato al consumo, manifesta tutto il suo potenziale di sussunzione: il proclama di un uomo medievale, ad esempio, prevede un’estrema, accurata invettiva, prima della sparizione dell’io individuale («cosa c’è ora di così cambiato se prima erano volevano ma oggi come ieri sono l’oggetto di uno slogan») per poi rivelare il fatto che anche suddetto proclama è una «informazione pubblicitaria» (p. 39).
L’alternativa a questa sussunzione totale, ormai data per scontata anche da tanta teoria politica contemporanea, è quella della rinuncia alla poesia, ma di farlo come scelta ancora non completamente eterodiretta, come una sorta di “abiura” villiana, invece di ostinarsi nella rivendicazione di un potenziale oppositivo che – come accade con tutte le merci, e quindi anche quelle dal valore assai esiguo, però mai anti-economico, come i libri di poesia – può essere facilmente sussunto. A questo, più che le operazioni ludiche intorno alla retorica della poesia civile che si trovano verso la fine del libro (pp. 52-53), vale la destrutturazione del manuale prescrittivo in poetica: eserciziari: «ho scritto pure questo / mi ero ripromesso di non farlo / mi avevano consigliato di non farlo / e non farlo era la cosa giusta» (p. 19).
È una soluzione anche più convincente di quella risposta in forma di poesia a un questionario richiedente una propria poetica personale che inizia con l’imperativo «scrivi tutte le parole possibili» e finisce con la loro cancellazione: «dopo solo dopo solo davvero dopo / cancellale ancora e ancora anche dopo» (p. 25). L’esaurimento di tutte le possibilità sul tavolo resta infatti un esito sempre possibile, nelle poetiche combinatorie e plurilinguistiche di Ianus Pravo e Alessandro Ghignoli, in un processo di avvicinamento rischioso, ma a tratti inevitabile, nella sussunzione generale, al nichilismo postmoderno della parificazione orizzontale e svilente di tutte le alternative possibili. Entrambi gli autori riescono a salvarsi a un passo dal baratro – pure indicandolo, e indicando, indirettamente, quanti vi siano caduti – dicendo tutto e insieme facendo un “verso di puro niente”.
Anche l’ispanofonia, in fondo, deve pur rendere omaggio alla tradizione del trobar clus.

"Questa postfazione è in realtà un saggio: un'ottima prova"
(scarica il PDF della Postfazione)
Basse frequenze per uno scacco al verbo: voce del verbo del silenzio protratto
di Maria Grazia Insinga
“Il cervo giudicato” è una caravaggesca opera al nero che tende a qual- cosa di incorruttibile, alla morte dell’io e del nome del padre e consuma la parola a nigredo del tempo (p. 50), dove “nigredo” non è che il primo passo – putrefazione e decomposizione – verso la creazione del ventre d’oro. A risanare la corruzione dell’io, troviamo una scrittura caratteriz- zata da crudo realismo, suoni aspri e, soprattutto, da un asse ideale che predilige la variazione diafasica come canale primo di comunicazione. Ne risulta un palinsesto di registri, di codici e sottocodici che arricchiscono le varianti situazionali del poema. Il lettore modello di questa scrittura
onnicomprensiva e onnipotente, comprensiva pure dell’antimondo e, quindi, anche del niente, della fragilità, dell’essere e del non-essere – è il lettore non-modello, è qualsiasi lettore purché disposto al mostruoso e alla meraviglia, allo stupore e allo stupro, disposto alla visione di una Vergine vertigine, argine allusivo e matrice dell’inferno. Le lingue spe- ciali di scarsa comprensibilità contaminano una materia comune e bassa per la formazione di significati altissimi, ma accessibili a tutti. L’Autore rende accessibile finanche il personale modo della coscienza di perce- pire qualcosa per via diretta, attraverso un novissimo trobar clus capace di compitare la luce a vantaggio del lettore: Luce e scandire ultimo del / ritmo del bianco, / lo scandire / del bianco / il pausarius nella luce (p. 40). Si immagini Ianus Pravo, dunque, come un pausarius che con una mazza sorveglia i rematori e batte il tempo ad alta voce per scandire il ritmo di immersione dei remi nell’acqua e accostarsi alla luce, al potere del korbàn (p. 40), l’antico sacrificio ebraico.
Come il poeta provenzale Arnaut Daniel, Pravo è il maestro del trobar clus; come Guglielmo d’Aquitania, è il trovatore bifronte. Nell’ultimo componimento (p. 54), il poeta ripete un verso del conte di Poitiers: de dreit nien. Il sintagma in antico occitano non ha rimandi filosofici o me- tafisici e sta a indicare la locuzione “un bel niente”: Farai un vers de dreit nien (Scriverò un verso di puro niente). De dreit nien è, qui, la negazione sia di orrore sia di bellezza: e apre nel primo verso con Dies Irae de dreit nien; e chiude nell’ultimo con Ira Rosae, de dreit nien. E le parole iniziali della sequenza liturgica di Jacopone da Todi, Stabat Mater, col tema giovanneo della Madre dolorosa, danno la chiave di quel nulla, forse, nella condivi- sione: offrir la mano / del nome / (la dimora del nome è una mano). Da un lato il nulla che permea l’io, dall’altro la condivisione dell’ultimo noi, noi che moriamo à la clarté des cieux, dell’ultimo cielo, come nel primo testo del libro (pp. 13-17): così, nasce la poesia, tempo primo, unità minima sufficiente di comprensione, linguaggio ineffabile, ineffabile nome, legge. E la legge di Pravo sopravanza la nostra e la rifonda: Sopra di me il cielo stellato, dentro me / cielo stellato e sangue fanno argento e legge // nessuno sa, e io ancor meno, il nome che il padre ha scritto / nel mio corpo di tedio (p. 45). Il pensiero kantiano subisce un rovesciamento di senso: nessuna leg- ge è dentro quest’uomo, un uomo-tutto-cielo dove nessun padre ha scritto nessun nome. Qualche tempo fa, Ianus disse: «E se qualcuno pronuncia il mio nome, non è cosa che mi riguardi». Una rivelazione percorre l’opera del poeta che si è dato, quindi, un nome con le sue mani, un nome con- cepito da un melvilliano matrimonio d’acqua e meditazione: pravé ianuaria (p. 33) che potrebbe essere il riflesso della nuova legge o del nuovo cielo; del nome stesso di Ianus Pravo, nato in gennaio; il dio bifronte latino unito a un aggettivo che indica “storto, deforme”, rictus (pp. 34, 38, 47) in opposizione a “retto” e, di conseguenza, “malvagio, perverso”. Quel “pravé” – Ceco? Esperanto? – sembra corrispondere, però, all’avverbio “appena, giustamente, a ragione”. Un linguaggio, quello di Ianus, che ri- scrive la legge, ne fa cielo: una inedita prospettiva del male del mondo, o meglio, di ciò che il mondo considera male e mostrando l’osceno ha occul- tato l’osceno (p. 46, ma anche pp. 15, 36). C’è il XXXIV canto dell’Inferno e c’è Mandel’štam – il poeta bifronte dell’ode d’ardesia – con la parola- incarnazione in questo percorso, senza dubbio, angelico; c’è la moderna superstizione del salario contro la mietitura giovannea (Giovanni 4,36) e la trasmutazione per cui il male non è che la bellezza luciferina ferita e da quella fenditura entra (– p. 51: pane-pundra e vetro, e fenditura; – p. 13: Der Trübung durch Helles tratto da “Zürich, Zum Storchen” per Nelly Sachs, di Paul Celan dove, appunto, il torbido viene dal chiaro). E la ferita è sempre corpo che si apre a una lingua, a una genesi. La genesi del libro è proprio una ferita luminosa nel cielo: il poemetto “La clarté” (p. 13). Lo stesso Pravo chiarisce al riguardo nella rivista “NiedernGasse”:
«[…] Sette anni prima avevo conosciuto Avghí, che in greco vuol dire “alba”. Ero a bordo del Kámiros, in viaggio da Rodi al Pireo. Vestivo la maglia gialla e nera dell’Aek, la squadra degli esiliati di Smirne. Era la squadra di Avghí. Passai indenne attraverso la sua malattia, Avghí morì di AIDS. E io non c’ero. Non so quale corrente segreta mise in contatto il mio ricordo di Avghí con la lettura di una bellissima pagina di Denis Diderot, nella sua Lettera sui sordomuti, in cui il filosofo francese parla dei versi 645-647 del Canto XVII dell’Iliade. Diderot polemizza con le traduzioni di Longino, Boileau e La Motte delle parole di Aiace: “Gran Dio, caccia la notte che ci copre gli occhi,
/ e lotta contro di noi alla luce dei cieli” (Boileau), “Gran Dio, ridacci la luce e lotta contro di noi” (La Motte). Per Diderot era un errore mettere in bocca ad Aiace parole di sfida a Zeus: nei versi dell’Iliade solo c’è un eroe disposto a morire, se è la volontà di Zeus, a cui Aiace implora null’altro che la grazia di morire combattendo. “Grand Dieu, chassez la nuit qui nous couvre les yeux, / Et que nous périssions à la clarté des cieux”, traduce Diderot: O padre Zeus, alza la notte dai nostri occhi, e che possiamo morire alla luce del cielo.
La notte mi ha sempre passato un salario, con cui ho pagato il prezzo dell’al- ba. Quaesivit caelo lucem, ingemuitque reperta (Virgilio, Eneide, IV, v. 692). Cercò nel cielo la luce e gemette per averla incontrata. Quando Aiace si darà la morte, un fiore rosso sorgerà dalla terra, e nei suoi petali porterà scritta la sillaba Ai, le iniziali del suo nome, un nome ridotto a un gemito (Pausania I, 35, 4)».
La percezione del corpo di Aiace è nell’Autore dispercezione e disappari- zione del corpo. Il poeta non immagina il corpo, lo disimmagina, poiché il corpo immaginato non è il corpo. Ciò che la poesia di Pravo nomina non è ciò che la poesia prima di Pravo nominava. L’uomo è un’immagine, la parola lo è, ma la parola del poeta è smisurata a tal punto che egli stes- so arranca come in un luogo senza misura e sconosciuto a sé stesso dove le cose fino ad allora nominate, fino ad allora immaginate si scoprono falsi miti di sé e si dispongono al silenzio. Ed è qui, nel verbo del silenzio protratto (p. 33), che può nascere davvero la parola, lo scacco al verbo. Il linguaggio di Ianus non è una questione puramente linguistica, così come dovrebbe essere il linguaggio; è privo di artifici, nudo e, quindi, blasfemo. Mentre Dio si dà alle sue creature come Parola fondatrice di relazione, Pravo, si dà al lettore nell’ossimoro della separatezza dai commerci del mondo. Un intero, che fonda la sua integrità nella separatezza, è quanto di più lacerante il poeta possa sperimentare. A precedere la Creazione, è l’atto di separare: la carne dalla carne – le ferite non risplendono (p. 14) è tratto dal Prologo del “Don Chisciotte”, «Se non risplendono le mie ferite agli occhi di chi le osserva, acquistano però pregio dalla cognizione che ognuno ha della loro origine»; le acque dalle acque (Genesi 1,6) – divide et coagula per l’alchimia; l’aria dall’aria – il volo che nel cielo separa / in due gole l’azzurro (p. 32). Che il due, / un numero, / sia uno, specchio / a uno specchio (p. 19), scrive Pravo; e Panero risponderebbe che essere due è tutto (“Dioscuros”, 1982). È qui la nigredo alchemica la cui immagine è il Calvario e richiama il verso Je suis ta viande nue oh (p. 13). Il riferimento è probabilmente all’opera di Don Antonio di Guevara, La tua carne nuda nel Calvario (1545) che espone le sette parole di Cristo scorporato sulla Croce; oppure, incorporato nell’Alleanza, al Secondo libro di Samuele (5,1): Vennero allora tutte le tribù d’Israele da Davide in Ebron e gli dissero:
«Ecco noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne». Un intero minato continuamente dalla censura religiosa, politica, dei costumi, della corru- zione nemica della parola autentica; e dalla cesura tra il poeta e il mondo. Un intero in cui la separatezza si dà per nudità e la nudità per separatezza. Si può essere nudi solo lontani dal mondo; qualsiasi contiguità col mondo è un’infezione per il linguaggio, impurità, impossibilità di poesia. Ianus vive la lacerazione, accetta la separatezza, ma chiede la misericordia dei cieli ultimi e della loro ultima luce: quaesivit caelo certum (p. 39). Solo così, la vita compirà il suo mandato, prendersi cura della morte, propria e di coloro che amiamo et que nous périssions / à la clarté (p. 33). Accettare la separatezza non esclude l’attaccamento istintivo alla luce, anche se la ferita luminosa è pur sempre una ferita. Da un lato, Dio e la purezza del non essere e, dunque, l’impossibilità dell’intero; dallo stesso lato, l’uomo che nel suo conato supremo abbandona i cadaveri al monatto (forse dal greco, μόνος, unico, solo, formato da uno solo) unica interezza possibile, fogna, azzurro mortifero: il Dio slabbra sulla schiava ogni purezza / del non essere, la materia / della sua immagine // homo conatus abbandona il cadavere / ai monatti o alla fogna, all’azzurro dell’addio (p. 19). Diventare uno è stupore, stupro.
Ianus è il sopravvissuto condannato a ripetere “E io non c’ero” nel mo- mento in cui l’alba termina, nel momento in cui Avghí muore. Non potersi prendere cura della morte dell’altro, ci rende sopravvissuti alla ricerca di un’ultima alba, di un ultimo cielo di luce, di un ultimo “rehem/utero” che poi non è altro che “rachamim/misericordia”. Un bambino senza occhi – Non c’è vedente che assomigli in empietà a un cieco (p. 24) – che ripensa la percezione e il pensiero mentre procede a tentoni e ha bisogno di toccare con le mani la realtà per percepirla. Solo la luminosità di una ferita può consegnare agli occhi ancora la visione, la veggenza. Ma le ferite non ri- splendono (p. 14), dice con Miguel de Cervantes. Qui nasce la visione del lettore che ha visione di qualcosa di cui ha nostalgia e, al tempo stesso, non ha mai conosciuto e conosce solo grazie alla poesia. Scrive Pravo: chi è cieco, aide¯s, è un io che muore / assente come ciò che non muore (p.
32) dove aide¯s è Ade, il dio dei morti e, al tempo stesso, αιδης, non visto, invisibile. A Cahuachi (Perù) – il cui nome significa “luogo dove vivono i vedenti” – la civiltà Nazca (I-VI secolo) realizzerà le ceramiche citate qualche verso prima, una ceramica nazca / una donna che dà alla luce una testa mozzata che fa pensare alla fossa della “grande offerta” ma anche al “luogo del teschio” per eccellenza, il Golgota.
Dimentico di sé, deprivato del racconto fondante dell’essere, deprivato, cioè, del suo io, senz’arma che dia carne all’imperium (p. 27) – che è anche il titolo di un libro del 2011 scritto da Panero e Pravo – il poeta ritrova la sua dis-umanità, una divinità che toglie carne all’imperium. Nella fine dei tempi, così facendo, Ianus edifica un poema tra eternità e tempo, e sancisce: da un lato, l’insufficienza dell’eternità poiché nulla di sovran- naturale è nell’assoluto; dall’altro, l’abolizione del tempo stesso per la via di una visione, anzi di una previsione che è in nuce al valore mistico e carnale di questa poetica impossibile, generata dopo lungo digiuno per togliere carne all’io, appunto. L’effetto contemplativo è raggiunto tramite il soggiacere della sensibilità per così dire “uditiva” alle basse frequenze come quelle di cui si avvale, ad esempio, il pachiderma che, grazie agli infrasuoni, sente i compagni prima di vederli. Si tratta di una percezione fisica delle vibrazioni che è quasi una preveggenza. Un rumore rosso che è simile a un tuono, a una passeggiata aleatoria tra le parole sotto una ca- scata di suoni, un’esile pioggia battente: Perla rubata all’ano di Yehoudit, la schiava, / senz’arma che dia carne all’imperium, / un’accentuazione delle basse frequenze / il dolore esile della pioggia che è fitta, / un rumore rosso (p. 27). Il campo di udibilità di questa scrittura non pare assoggettato al meccanismo di selezione culturale: Ianus ode ancora l’avvicinarsi della preda, il fremito delle fronde, il respiro dell’altro. Il timbro della voce umana e il prisma deformante del linguaggio sono la risultante estrema- mente originale di ciò che il poeta ha udito: una voce, quindi, inumana. Il pensiero pravo-shakespeariano – Amleto sul corallo del padre (p. 50)
è assoluto, origina, dunque, dal puro niente come la voce di Ariel e coagula sul corallo del padre nella “Tempesta”: «Tuo padre è là, nel fondo del mare, / sono già perle quelli che furono i suoi occhi / e le sue labbra ormai fatte corallo. / Niente di lui è destinato a svanire / ma a subire un mutamento dal mare / in qualche cosa di nuovo e strano». La trasmutazione alchemica è compiuta al massimo grado della tempesta o dal punto più elevato del castello di Elsinore, per fare risuonare il mondo ai confini del mondo e della servitù del dire e, aperti gli occhi vasti (p. 18), far risuonare ancora il mondo al minimo grado di frequenza.
Il lettore sprofonderà verso l’alto, anzi l’altissimo, della parola rissosa di Pravo, di un linguaggio che rappresenta l’intero, un tutto, una babele e, dunque, una balbuzie, la balbuzie di spazio in un flusso di tempo (p. 41): un coacervo di citazioni quasi mai esplicitate – ciceroniano il verso Pro aris et focis le dita ardenti (p. 13); quadaus en son us (p. 45) è tratto da “Alto e basso tra le prime foglie” di Arnaut Daniel che canta, nel suo trobar clus, ciascuno secondo la sua specie; nel tempestoso Egeo in grembo a Teti (p. 16) descrive la nascita della dea la Vénus des Médicis et la Vénus des médecins ed è tratto dalle “Stanze cominciate per la giostra del magnifico Giuliano di Piero de’ Medici” del Poliziano; un albero senza radici, Sozan Kyonin, foglie d’acqua foglie / gialle, / più in là l’azzurro, non una sola macchia nella luce, Tsugen (p. 13) è tratto da “Un albero senza radici (poesia sulla morte)” del maestro zen Sozan–Kyonin; Ah caminante, ah confusión de párpados (p. 13) è tratto dal “Libro del frío” del poeta spagnolo Antonio Gamoneda; Dich nur / neigt zu mir hin, / was du geworfen (p. 14) è tratto da “Das Schwere” di Paul Celan; womb / in english is a rhyme to tomb (p.
14) è tratto da “The double man” di W. H. Auden, dove grembo è luogo di sepoltura, espropriazione umana e disincarnazione; when mercy sea- sons justice (pp. 25, 48) è tratto dal “Mercante di Venezia” di Shakespeare; Non sa il labbro, scoria, il tremore di carne /che fa la notte oscura, oscura? Oscura la notte? (p. 25) da Juan de la Cruz –; una megalopoli, un siste- ma-mondo dove troviamo città, quartieri, ponti in un flusso babelico di nomi – Srebrenica, Rodi, Pireo, Monastiráki, Praga, Zizkov, Sabra, Sha- tila, Londra, Mostar, Auschwitz, Micene, Elsinore… – eppure, Non alba né città dove io vado (p. 50) che riecheggia le parole di Simone Weil in “Venezia salva” –; un flusso di linguaggi che di lingua in lingua, di ventre in ventre attraversano il libro – sanscrito, latino, greco, inglese, francese, spagnolo, tedesco… e sul ventre immacolato, l’azzurro mortifero del lin- guaggio è seme –; un maniluvio di riferimenti biblici per cui il massimo grado di blasfemia coincide col massimo grado di sacralità – (p. 49) ogni famiglia ha un libro che è meglio non leggere / ad alta voce, sentenzia Pravo partendo dagli inventari dell’origine di un Dio che indica ad Abramo la Moriah per il sacrificio di Isacco (Genesi 22, 1-18); Il fumo per il Dio dalle aperte nari (p. 13) si riferisce al Dio longanime, lento all’ira o, come legge Gilbertus Genebrardus, Longus naribus che trattiene per lungo tempo il fiato e aspetta, differisce di molto il castigo poiché molto misericordioso (in Placido Padiglia, “David penitente; lezzioni sopra il cinquantesimo salmo di David”, Zannetti, 1610); solus non / sum (p. 25) tratto dal Van- gelo (Giovanni 8, 16); il tremore del verbo in diversi punti del libro (pp. 25, 26, 38, 40 e 46) è, forse, lo stesso tremore di San Paolo nella Seconda Lettera ai Corinzi –; fino a giungere ai versi (alcuni già presi in esame) che testimoniano il forte legame di Ianus Pravo con Leopoldo María Panero, non un dialogo, ma un intero – il titolo “Il cervo giudicato” riprende quello di un libro di Panero del 2013, “Il cervo applaudito”; e poi, l’esergo tratto da Himno a Satán; e anche, aun cuando el musgo es certeza (p. 49) verso di Panero tratto dalla poesia “A Claudio Rodríguez”.
Siamo di fronte a un’opera in cui il doppio scappamento fa cilecca per assenza di gravità: lo smorzatore non ricade sulla corda, i feltri si gon- fiano, i martelletti non riescono a “scappare” dalle corde e la vibrazione non si blocca e impone l’ascolto di ogni singola parola, del suo risuona- re, poiché lo strumento non è pronto a una ulteriore percussione, pena un palinsesto troppo doloroso di significanti. Il piede destro sul mare, il sinistro sulla terra e per l’angelo Ianus non vi sarà più altro tempo che la poesia. Il dolore che perde di sé memoria è il dolore che fa più male. La rimozione è il modo migliore per rivivere il male all’infinito. A meno che, alchemicamente, e due volte in questo libro (pp. 27, 46), in stercore invenitur aurum nostrum, il ventre orinato risolva nel mostrare, invece che nel negare e rinnegare, tutto il dolore di una dualità, di un rispecchia- mento impossibile in una umanità narcisa. Il rispecchiamento non è in fondo il tentativo di conservare tale e quale il mondo? non è, in fondo, il fallimento nella mutua comprensibilità, e l’impossibilità di alcuna opera conoscitiva svolta dalla poesia, dall’arte, dal linguaggio. Il poeta non mira all’autoconservazione, non cerca alcun applauso, non dice con il labbro azzurro di Hegel (p. 18) “Mi auguro che la mia esposizione vi abbia sod- disfatto”, né, come Prospero, dichiara or else my project fails, / Which was to please; ma è pur sempre un essere umano e chiede, problematizzando il rituale del riconoscimento – in lotta contro sé stesso, contro l’io, contro il narcisismo, contro l’essere – una lingua sufficientemente comune, una minima comune possibilità di luce, di unità, di comprensione, un cielo condiviso. Nel rifiuto immondo, in fondo, come scrive Giuseppe Vallardi nel “Trionfo e Danza della Morte dipinta a Clusone” (1859) «Quando i vermi avevano terminato il loro ufficio, usavansi raccogliere dalle sepolture gli avanzi dei corpi disfatti, e sovrapporre con simmetrico studio i cranii e le ossa nelle cappelle vicine alle chiese ed ai cimiterj, affinché fosser soggetto di meditazione ai viventi». I vermi (vedi p. 20) terminano il loro ufficio, ma al contempo rappresentano ciò che è ancora vitale e, dunque, il trionfo sulla morte. Questo vitalismo macabro fa sì che la memoria del dolore non provochi più il male: in stercore invenitur.
È significativa la ricorrenza della parola “ventre”, nominata ben quindi- ci volte, porta e chiave di questo poema vitale e cellula germinale della parola. Il frutto dell’aquila è maturato sul ventre, / bianco come la ferita e il tempo / azzurro come la mano / la mano azzurra che conduce al sonno / all’inverno ardente che riunisce le perfezioni del calice e / della latrina (p. 16). L’animale selvatico è portatore di un messaggio iniziatico scritto sul ventre bianco dalla mano azzurra che conduce al sonno primo nell’iden- tità perfetta di calice e latrina, alto e basso: e l’alto, con la sua perfezione, somiglia alla morte; e il basso, con il suo sterco, somiglia alla vita. La poesia, in questa perfetta identità, è il ventre, la rinascita, è annegare nel- la propria sorgente, il regno della madre. Una bellica variazione, quella sul tema dell’orina (pp. 13, 19, 23, 28, 33, 45, 53) che riporta ad Amelia Rosselli: la mia fresca urina spargo / tuoi piedi e il sole danza! danza! dan- za! – fuori / la finestra mai vorrà / chiudersi per chi non ha il ventre piatto. Versi, quelli di Pravo, che possono essere intesi come un laisser pisser, uno sprezzo sublime per chi disprezza la carne. In fondo, l’imperatore Vespasiano tassò il liquido perché ritenuto prezioso. Qui, il poeta, per
esempio, lo pone accanto alle lacrime: Sono un vecchio che lacrima / orina sulle mani per scaldarle (p. 13). Facile intravedere tra i versi il Cupido di Lorenzo Lotto o teorie di fanciulli urinanti come in un baccanale di putti michelangioleschi. Ianus è il poeta innocente come un puer minge¯ns e sovversivo come un Manneken-Pis. Innocenza o scandalo, sono punti di vista: un fatto privato è reso scandaloso nell’atto di porgerlo in versi al lettore? Partendo dal presupposto che ogni parola in più sul cervo si tra- durrà in una parola poetica in meno, partendo dal presupposto che non riusciremo a catturarlo perché il cervo è inafferrabile, ingiudicabile la sua bellezza, sulla pagina c’è un buco, direbbe Leopoldo María Panero, da dove la realtà cade / come acqua morta (“Himno a Satán”) e il lettore aiutato dalla luz del cigarro, comunque, ci cade dentro.
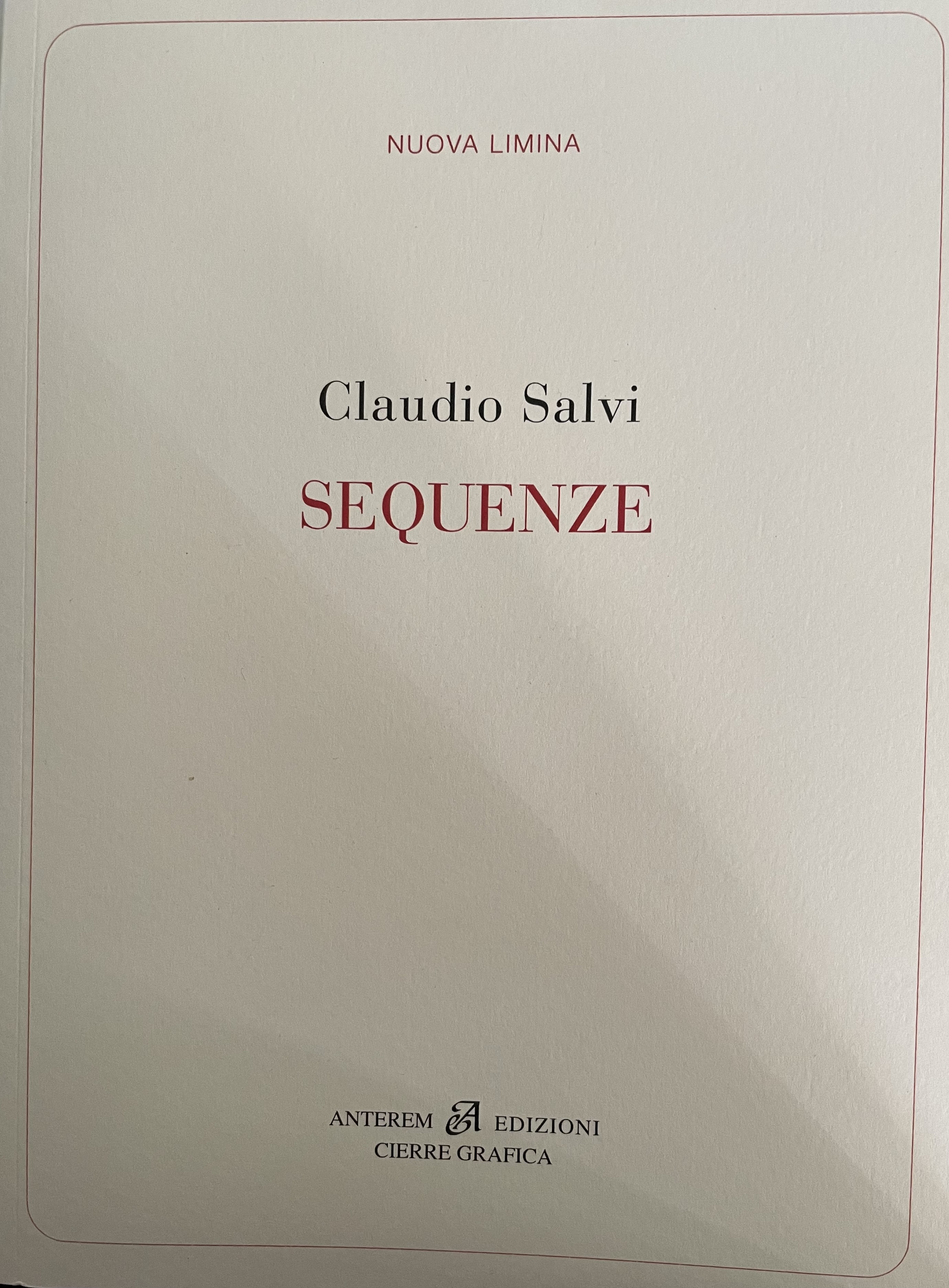

Per ordinare il volume è sufficiente scrivere a: redazione@anteremedizioni.it


Per ordinare il volume è sufficiente scrivere a: redazione@anteremedizioni.it
.jpg)
L’ultimo nato nella collana Nuova Limina è “Dinosauri Psicopompi” di Paola Silvia Dolci, un libro che comprende testi lineari e calligrammi. Qui una pagina iniziale:
Mi sveglio sempre prima
della fine dei sogni.
Staccata,
come se venissi ritagliata
con le forbici dalla carta.

Per info e prenotazioni: redazione@anteremedizioni.it
È l’ultimo libro pubblicato, a novembre 2021, da Anterem Edizioni. Lo presentiamo, oltre che con la nota in quarta di copertina di Laura Caccia, con le
recensioni di Mario Famularo, Isabella Bignozzi e Antonio Devicienti.
Per ordinare il volume scrivere a redazione@anteremedizioni.it

Felici di aver pubblicato questo libro che varca i generi, articolato e complesso, di Sofia Demetrula Rosati. Condividiamo una sua scrittura asemantica, l'ultimo testo della raccolta, l'indice.




Dopo la chiusura di “Anterem”, l’eredità di quasi mezzo secolo si è trasferita interamente al Premio Lorenzo Montano, che ne continuerà il cammino di conoscenza e l’esperienza cartacea.
E lo farà pubblicando, nell’omonima editrice, non solo la raccolta inedita vincitrice del premio, ma anche altre opere finaliste che la giuria riterrà di dare alle stampe, al di là dell’intrinseco valore di tutte.
I primi due libri appena editi – “Liturgia dell’acqua” di Daìta Martinez e “Herbarium Magicum” di Bianca Battilocchi, entrambi finalisti all’edizione 2020 del “Montano” nella storica sezione “Raccolta inedita” – sono esempio di questa nuovissima via.



Tutto ha una logica, dal momento che rivista e premio hanno convissuto felicemente per 35 anni. Per ordinarli, scrivere a premio.montano@anteremedizioni.it
Confermiamo che gli abbonati attivi ad “Anterem”, fino alla scadenza della sottoscrizione, riceveranno tutto quello che sarà pubblicato dalla rinnovata editrice; per gli ex “abbonati con libri” ci sarà un prolungamento biennale. Ringraziamo con affetto chi ci ha sempre sostenuto.