


Carte nel Vento
periodico on-line
del Premio Lorenzo Montano
a cura della redazione di "Anterem"
Diamo vita a quello che non è stato.
Un ormai abituale appuntamento come il Forum Anterem, vibrante perché solitamente vissuto “insieme”, in questo periodo trasmetterà la stessa passione grazie alla tecnologia.
Ascolteremo i poeti dalle loro case, dal loro giardino, come se fossimo in Biblioteca Civica a Verona.
La viva voce dei poeti rompe il silenzio di questo tempo sofferto.
Sono gli autori finalisti per “Una poesia inedita” al “Montano” 2019. Da remoto proviene anche il brano originale composto da Francesco Bellomi per la poesia vincitrice di Roberta Sireno.
La novità introdotta lo scorso anno, e che si ripete con identica modalità nell’edizione in corso, è stata la creazione di una Giuria critica per determinare il testo da premiare. Per istituire questa giuria, che si affianca a quella storica composta dalla redazione di “Anterem”, abbiamo invitato finalisti e vincitori della precedente edizione del “Montano”. La stessa cosa, con personalità quindi differenti, sta accadendo quest’anno:
www.anteremedizioni.it/premio_lorenzo_montano_xxxiv_(...)
Com’è prassi per la giuria storica, abbiamo chiesto anche ai nuovi giurati di scrivere su alcune delle poesie valutate, scegliendo liberamente. È il motivo per cui è stata denominata “Giuria critica”.
Tutto il lavoro collettivo è racchiuso in questo nuovo numero di “Carte nel vento”, che si apre con un omaggio allo scrittore belga Marcel Moreau, figura dirompente della letteratura francofona del ‘900, praticamente inedito in Italia e di recente scomparso.
Buon ascolto, buona lettura.
In copertina: Fotogramma di Giorgiomaria Cornelio e Lucamatteo Rossi
Ranieri Teti
Da Moreau. Quintes, L'Ivre Livre, Sacré de la femme, Discours contre les entraves. Éditions Denoël, p. 419
Traduzione e premessa: Cristiana Panella

Cantore e soggetto, per sua stessa definizione, dell'Escritauro (Escritaure), creatura ibrida Verbo e Bestiario, Marcel Moreau riporta il monstrum al suo senso originario di prodigio come ammonimento, messaggero del divino. In una lingua intrinsecamente 'ossimora': astrale e intestinale, numinosa e sanguinolenta, edotta e carnascialesca, Moreau erige l'amore carnale a banchetto sacro. In perpetuo bilico tra la combustione dell'istante e l'imminenza della separazione, si celebra l'anelito all'Assoluto che attraverso il lamento veggente rimpiange il presente osservandolo dal già futuro.
Estratto da: “L'anima dei bolidi” in “L'Ebbro Libro” (1)
[…] Neanche tu mi segui più. Neanche te che amo, mi segui. Sei più lontano di me, ancora dietro ciò che mi soverchia. Più nessuno mi segue, riesce ad afferrare al volo gli assi folgoranti, e mi ritrovo solo con le mie rapidità bionde che mi spaccano il corpo da te solcato. Anche i miei omaggi alla tua bellezza ti attraversano così rapidamente che ti sfuggono al momento della carezza. E la carezza ha un bell'attardarsi, compiacersi alle labbra, abbeverarsi alla feccia, le galassie che mi ispiri, loro, viaggiano a distanze tali avanti a noi da sembrarti opache. Eppure i miei omaggi ti hanno presa, portata via, esposta a soli di parole; ti hanno piantata dentro, trascinata sopra, inchiodata a loro, oppure hanno girato con violenza attorno alla tua carne, abbeverandosi a cosce a gola, a sessi liquidi e vasche succose. Non saprai mai a che punto lo sciabordio di ogni goccia di te sulla mano fece danzare duro e folle la mia mente (2). Ma i vortici se ne sono andati, e noi ci ritroviamo corpo lento addosso a corpo ancora più lento...
Questo non è che un esempio; tuttavia quale altro esempio può raccontare della velocità dei linguaggi non indottrinabili? Arruolamento impossibile, schiavitù in arretramento, né patria né partito, sostegno rifiutato, perpetue partenze, arrivi annullati. Ma dolori attivati, sconforto che rimesta, eccome rimesta... [...].
Marcel Moreau (Bossu 1933-Bobigny 2020) è uno scrittore belga francofono. Proveniente da una famiglia operaia, abbandona gli studi adolescente, poco dopo la morte del padre, e inizia a lavorare in una rubinetteria. Assistente contabile per il giornale Le Peuple, a Bruxelles, sarà correttore di bozze per Le Soir, attività che continuerà a Parigi, dove si trasferisce nel 1968. Nel 1963 pubblica il suo primo romanzo, Quintes, a cui faranno seguito più di 60 opere, per lo più in prosa poetica, tra cui Sacre de la femme (1977), L'Ivre Livre (1973) e Discours contre les entraves (1979), riproposte insieme dalle Edizioni Denoël nel 2005. Orgambide (1980) inaugura la fase più travagliata e prolifica della vita di Moreau, caratterizzata da una profonda crisi esistenziale in cui lo scrittore renderà omaggio, in testi che definisce degli "adoratoires", alla sublimazione della donna; un'apoteosi della carne e dell'amore che continua con Bal dans la tête (1995), l'ultimo romanzo. L'elemento della carnalità, che unisce l'amore per la donna e la scrittura, di cui Moreau farà una militanza intellettuale, sfocia maturo in Corpus scripti (2002); esso si rifletterà nell'opera degli anni 2000, tra cui Adoration de Nona (2004), Une philosophie à coups de reins (2008), Un cratère à cordes (2016), e con la ripubblicazione di À dos de Dieu (2018).
(1) Una seconda valenza, certamente voluta da Moreau, è "L'ebbro si racconta".
(2) La traduttrice ha scelto di lasciare "dur" et "fol" al maschile per restituire l'uso dell'aggettivo come avverbio del francese e mantenerne l'effetto icastico.
Perché quando Berkana ornata di rami
Si innalza sino ai margini del cielo
Emana la tensione delle tue viscere
Dichiara un nuovo inizio:
Una mutazione del sangue per accoglierti
Come il Dio che porterà in dono
La testa spezzata di Fenrir.
Allora rinasceremo l’uno nell’altro
Ci scambieremo la pelle
Per essere il seme fecondo della madre terra.
Nota: Berkana è la Runa del femminile, simboleggia la Betulla. Fenrir è il lupo, figlio di Loki, che nel Ragnarok delle saghe norrene verrà ucciso dal dio Vidarr.
Silvia Comoglio per Andrea Breda Minello
Due dimensioni convivono nel testo di Andrea Breda Minello, quella mitico/divina e quella umana. Berkana, la Runa del femminile e Fenrir, il lupo delle saghe norrene, ucciso dal Dio Vidarr abitano i nostri spazi, sono presenze con cui misurarsi, figure che finiscono con il sovrapporsi alla nostra essenza. Ed è proprio da questo sovrapporsi che nasce un innesto, una correlazione tra l’umano e il mito che ci disvela il ciclo della vita racchiuso in inizio/mutazione/fine/rinascita. Ciclo, questo, che richiama a sua volta un altro mito, il mito dell’eterno ritorno.
In un testo dalla struttura compatta e dalla luce asciutta, l’umano e il mito, in un gioco continuo di rimandi, si incontrano e scambiano pelle per poter essere, come scrive Andrea Breda Minello, “il seme fecondo della madre terra” . Una fecondità che nel testo di Breda Minello si traduce, da un lato, in rinascita e in stretto legame tra il mito e l’umano e, dall’altro, in forte correlazione tra scrittura lirica e epico-mitologica.
Patrizia Dughero per Andrea Breda Minello
Con un colpo fendente tra terra e nebbia questa poesia incede, incalza, una quartina e due terzine, a ribaltare il mondo, destando al contempo nel lettore una certa fantasticheria sul sonetto, come un dolce ricordo, per la quartina d’attacco che sembra portare avanti una narrazione previa, qui tesa a circoscrivere il necessario mutamento, un nuovo inizio.
Poesia carica di visioni, per la sua atmosfera, un gelo rotto soltanto dai rami bianchi e luminosi di betulla, per l’“attesa” quartina d’inizio che si scarica sul suo ultimo verso, Dichiara un nuovo inizio:, per il passo epico e gli incipit di ogni verso, in maiuscolo, desueta maniera, e per quella dichiarazione: all’inizio occorrerà un cambiamento viscerale oltre che un’azione.
Poesia assertiva che attinge dunque al sangue e agli elementi viscerali stabilendo un’equilibrata tensione per l’inevitabile, “non possiamo più attendere”, sembra essere l’incitamento del poeta che ricorre alla primordiale lotta tra buio e luce, che ristabilisca il brodo affinché la parola continui in bios e nell’unione. Non possiamo più aspettare ma non possiamo arrenderci e allora il poeta “si fa carico”, e il suo carico è “ogni disperazione”, così “prende spazio” all’assoluto. Se via d’uscita non c’è occorre declamarlo (mi pare importante sottolineare che per il Premio Montano, sezione Poesia inedita, è richiesto un componimento “che costituisca per l’autore un momento privilegiato della sua ricerca, un testo che proprio nell’unicità trovi la sua ragione”); occorre guardare la bestia spezzata, la testa del lupo sacrificale con cui scambiare la pelle, per far rinascere una nuova umanità e perché la terra venga rigenerata. Versi che conducono a stupore assoluto, ma non si ammantano di silenzio, piuttosto di orme pesanti tra nebbie fonde tagliate dall’alitare di chi non desiste, pur senza fuoco a scaldare e nessuna fiammella che possa alimentare lo scambio necessario, soltanto un click che il volto epico possa introdurre nel nostro DNA.
Poesia epica antilirica, retta da un’apertura che contiene una domanda, sia causale che finale su un determinato accadimento, sembra quasi farsi beffa del canone e della scansione metrica, oscillante com’è tra versi alessandrini, fino al limite dell’endecasillabo sdrucciolo, intervallati in maniera atipica da settenari e novenari: inducono a pensare che anche la rima avrebbe avuto una giusta collocazione al fine di ristabilire il passo marziale evocato. Ma nessuna rima appare, mentre noncurante il poeta inneggia saldamente a un gesto eroico che ristabilisca vera giustizia fuori dall’umano, con una luce lunare riflessa nel pallore della bianca betulla, frondosa e poetica runa offerta. Noi lettori a raccoglierla, quasi indifesi, almeno coloro che non sono addestrati a una buona osservazione degli elementi naturali, veri protagonisti di questo componimento. Rischiando pure di essere risucchiati da un’epica che non ci appartiene (interessante, affascinante lavoro di contaminazione) quasi un manga europeo o un must da graphic novel, risollevati poeticamente dall’ottimo equilibrio di questo testo che dalla sua brevità trae forza e potenza, mentre i versi lanciati ondeggiano, e continueranno a farlo, tra grigie volute norrene, aprendosi al vento per spargere semi che, composti e segreti, getteranno basi sicure ad altri componimenti.
Andrea Breda Minello (1978) è nato a Treviso, dove vive e lavora come docente. È poeta, traduttore e drammaturgo. Ha esordito in X quaderno di poesia contemporanea e ha poi pubblicato Del dramma, le figure (Zona, 2015) e ora Yellow (Oèdipus, 2018). Come traduttore: Julien Burri, Se solamente (Kolibris edizioni, 2010), Pierre Reverdy, Sabbie mobili (in “Testo a fronte”, 2015), Anna de Noailles, Poesie d’amore (Arcipelago Itaca, 2019). Suoi testi sono usciti su “Poesia”, “Nuovi Argomenti”, “Versodove”, “l’Immaginazione”. Collabora con “Testo a fronte” e “l’avantionline”. Sta ultimando il suo primo romanzo.
Pneumeno
edificio nella notte, fiotti d’uomo
(terra di gonfiore)
sulla direttrice del nuovo viso
(effetto sagittale)
Talete al timone del lobato
a braccia separate
le vite mai sognate
a un ritmo più lento, nauti oltre, a sostegno
(in acque cordate)
disàrmati, qualcosa del consiglio, la qualità del suono netto
(a giaciglio delle torbe)
respiro di erranza
gli dèi degli avanzi
vanga di mucosità
spegni le vie, sbarra le rotte, nel piano, del suono, l'esercito è rotto
Silvia Comoglio per Giuseppe Calandriello
Su acqua e respiro si fonda il testo di Giuseppe Calandriello costruito con un sapiente uso della parola e con forti e vivide immagini. L’uomo, nel testo di Calandriello, si sveste della sua solida essenza e si fa fiotto, onda che imprime al suo viso una nuova identità, che lo trasforma non momentaneamente ma in modo perenne in un nauta che si trova in cordata con altri nauti, una cordata fatta di acqua, ossia di qualcosa che è inconsistente, che sfugge. E in questa cordata, ci chiediamo, che non ha la resistenza della fune ma l’inconsistenza dell’acqua, come possono, se possono, sostenersi e salvarsi gli uomini diventati nauti? E neppure, si direbbe, rassicura la presenza di Talete al timone, quel Talete che sosteneva che il principio, l’arché, di tutte le cose è appunto l’acqua e che è dall’acqua, forza attiva e vivificatrice, che si trae nutrimento.
Rimane così all’uomo il respiro ma è un “respiro di erranza”, perché quando cerca di diventare suono, e da qui poi si presume parola, si infrange e l’esercito dei nauti si scopre rotto, e quindi ancora una volta senza salvezza. “spegni le vie, scrive Giuseppe Calandriello, sbarra le rotte, nel piano, del suono, l’esercito è rotto”.
Ranieri Teti per Giuseppe Calandriello
L’incipit del testo è cinematografico, con il passaggio da un’inquadratura aperta e generale, da un esterno simbolico che si protrae fino al primo piano di un volto: tutto mediato, tra parentesi, da una considerazione dell’autore e da una sorta di appunto sceneggiato per la regia. Nei quattro versi iniziali Giuseppe Calandriello produce e crea un accavallarsi spaesante di immagini che offre una chiara indicazione di lettura: “Pneumeno” chiede di abbandonarsi al suo flusso, richiede di condividere e di abitare l’idea del suo autore. Questa si precisa in maniera definitiva subito dopo, quando nel testo interviene il “lobato”, un aggettivo adoperato come se fosse un sostantivo, per dirci che in poesia tutto può succedere all’improvviso e niente è mai scontato. E “nauti” lo conferma. La fusione dello stile con il senso offre uno degli elementi distintivi di una poesia che non si appiattisce sulla realtà ma la trasforma creando una parte di mondo prima inesistente. Le percezioni del poeta predispongono frammentazioni del sentire, avvenendo simultanee come respiri in corsa, e in questa modalità assecondando, nella messa in pagina, un andamento interiore. Lo testimoniano i versi ora sincopati ora lunghi, e franti se lunghi, come se fossero pulsioni irregolari, sintomi di uno spezzare il ritmo per un dire ulteriore. Come se fossero fuse insieme tecnica e visione, forma e idea, sapendo che non c’è idea che non sia riconducibile all’esperienza di una cosa generata nel pensiero: gli ultimi versi, così spiazzanti e fatalmente nitidi, concludono l’unione di pneuma e immaginazione.
Giuseppe Calandriello nasce a Pietrasanta nel 1979. Dopo gli studi artistici si laurea in Cinema, musica e teatro presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa. È membro del gruppo [dia•foria, con il quale ha pubblicato opere di Balestrini, Ballerini, Blotto, Burchiello, Carravetta, Curi, Mansour, Péret, Toti, Villa e altri. Nel 2017 cura, con Daniele Poletti, la seconda edizione di "Obsoleto" di Vincenzo Agnetti con testi di G. Agnetti, C. Bello Minciacchi, B. Corà e C. Costa. Sue opere sono pubblicate nelle antologie "Tuttologia e Contro Zam", Cinquemarzo; "Nuova Tèchne", Quodlibet; "Scrivere all’infinito", Museo della Carale Accattino; "Offerta Speciale", Carla Bertola editore; "Athe(X)ehtA", Edizioni GDFAEOA. Ha partecipato a contenitori d'artista come "BAU" e "Antologia Ad Hoc". La sua ricerca poetica e artistica verte su tematiche come la casualità, il determinismo, il rapporto tra l'impossibile e l'improbabile, le energie cosmiche e il potere del linguaggio segnico.
Giorgiomaria Cornelio, “Palinsesto”, audiolettura-cartolina;
note di Silvia Comoglio, Mariangela Guatteri (con immagine asemantica), Daniela Pericone, Lia Rossi

Silvia Comoglio per Giorgiomaria Cornelio
Con parole soppesate e di limpida densità Giorgiomaria Cornelio concentra la sua attenzione su due elementi che in poesia sono cardine/essenza: il nome e la scrittura. Dall’oggetto, dalla “cartula” di cui parla Cornelio, si astrae il nome, quel nome in cui tutto in potenza è contenuto e che ci rimanda, tra l’altro, al Prologo del Vangelo di Giovanni, In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio. Richiamo avvalorato dal desiderio di baciare nell’orazione la cartula che si è fatta nome, “baciarla nell’orazione”, ossia proprio in un momento privilegiato dell’incontro dell’uomo con Dio. Ma quel nome, che tutto contiene e che è presso Dio, pronunciato e mediato dall’uomo muta e perde i suoi connotati, la saliva lo corrode, e nella saliva diviene mancante, incompleto. E questa mancanza, incompletezza, si trasmette alla scrittura, allo scrivere, che, ci si rende conto, non è evento che dà risposte ma evento che le risposte le allontana a favore di un cercare continuo, meglio, di uno scrivere e riscrivere continuo. Del resto, un palinsesto è proprio questo, un manoscritto da cui si raschia ciò che è stato scritto per scrivere un nuovo testo.
Palinsesto, oserei dire, una dichiarazione di poetica, acuta e ponderata.
Mariangela Guatteri per Giorgiomaria Cornelio (con immagine asemantica)
Rebus
Il titolo di questo testo poetico è l’intero processo di stratificazione e rimaneggiamento occorso al segno (scritto tanto quanto dipinto) attraverso un'azione perentoria di raschiatura che rinnova la superficie che lo ospitava.
Per economia di supporti – come pergamene, muri intonacati, tele, tavole lignee, carte – o per necessità di trasformazione, si organizza il segno su una superficie usata che viene resa vergine o quasi: il supporto non viene raschiato e lavato, e ciò che accoglie si trova parzialmente neutralizzato da un'ulteriore scrittura, da segni che cancellano, da velature cromatiche, da tagli che escludono.
Se questo processo abrasivo e sostitutivo che definiamo “palinsesto” è assimilabile all'intendimento dell'atto della scrittura – «Così s'intende la scrittura: un | lento stornare la necessità | della risposta», come termina il testo di Cornelio –, dovremmo comunque fare i conti con gli strumenti e i processi (anche chimici e radianti) di risuscitazione di ciò che appare estinto, che «è venuto a mancare». Nome, che viene nascosto, che manca, che muore. Si rimane in una sospensione del pensiero di fronte a questo testo, testimone del suo stesso processo, già riassunto nel titolo ma annunciato poi – senza parole – alla fine e da un'immagine iconica: un dettaglio. Così riporta la didascalia dalla quale si può dedurre cosa esclude il riquadro, e perciò cosa è stato annunciato. Si vede infatti che manca una parte della figura; si sa che manca l'agente dell'Annunciazione. In modo paradossale e analogico e lontano da ogni tautologia, è annunciata l'assenza stessa dell'annuncio.
In ogni caso la scrittura ha agito e il Verbo ha forse già attecchito dentro la quasi Vergine senza la testa.
Mi viene naturale chiamare questa piccola opera una "lirica concettuale" che ha la forma di un asciutto "iconotesto" e dove le chiavi d'entrata sono esposte, installate all'ingresso e all'uscita; cosicché «a via diritta» e scartando ogni volta «Qualcosa insinua».
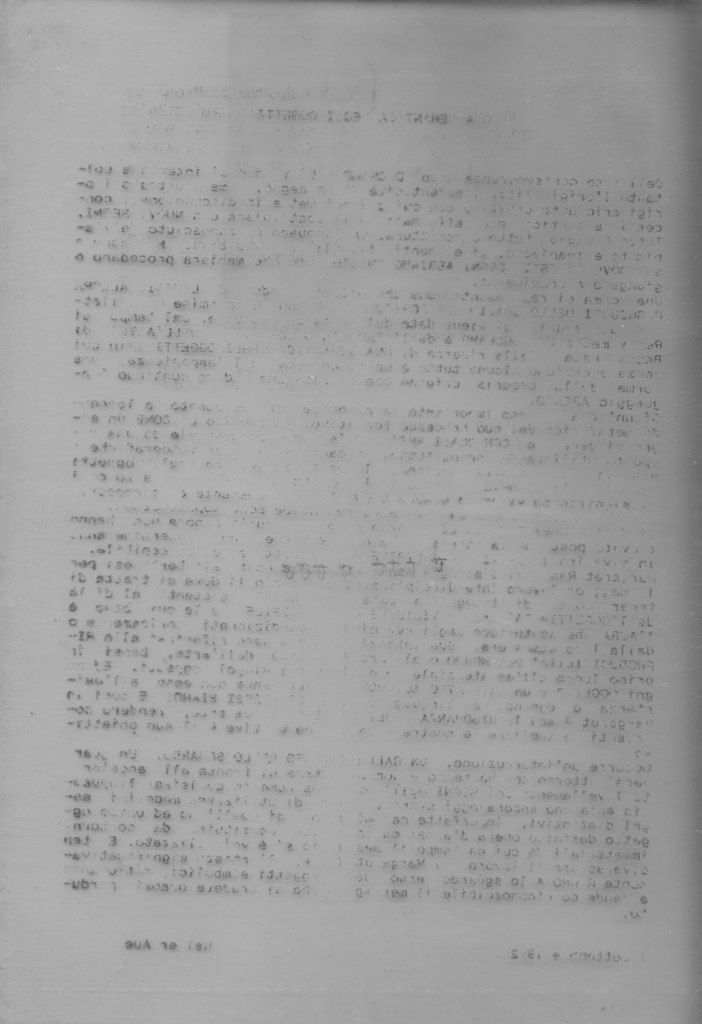
Daniela Pericone per Giorgiomaria Cornelio
La scrittura è sovente ri-scrittura, tanto si ravvisa nell’intrinseca significanza del termine palinsesto (dal greco παλίμψηστος, «raschiato di nuovo»). La poesia Palinsesto di Giorgiomaria Cornelio insorge come un’ostensione di verbo su una pergamena, legata a un affresco del Beato Angelico, a una particolare angolatura dell’Annunciazione della cella 3 di San Marco. È nel contempo architettura autonoma, edificazione di forma nel «sortilegio dell’ombra», nominazione insistita come un’eco che si perpetua tra le pareti di una stanza (o di una cella). L’ignoto si manifesta nel moto («insinua»), se ne coglie la direzione («a via diritta»), intelligibile tuttavia discontinuo se esorbita a volte nel verso la misura consueta tra le parole. La «cartula», ora abrasa ora incisa, conserva tutte le sue tracce, i sedimenti non più visibili, gli affioramenti nella parola presente (o mancante). Eppure a chinarsi in ascolto si sottrae «la necessità / della risposta».
Lia Rossi per Giorgiomaria Cornelio
Respira l’aria della postilla, Palinsesto di Giorgiomaria Cornelio, tra righe, tra spazi, via via cautamente fa sorgere sentimento, introduce in seno il senso, fa fare incantesimo, fa operare poesia: un sortilegium, una malia.
Bacio-baciare è recitare discorso e preghiera, fare compiere libri di orazioni.
E si sta in orazione a rileggere Palinsesto, preghiera significativa autenticamente nella forma a postilla, preziosa cartula.
Non manca di solennità, né di vita della lentezza questa scrittura che volge in diversificati versi e distoglie in tante sensate soluzioni, in pesi pensati e sottilmente filati come fili di lana, scomponendo le falde, battendole e torcendole. Filatura e filanda la scrittura; filatrice-poeta, femmina o maschio che sia, con saliva bagnandosi i polpastrelli, allunga torcendo la materia grezza dal fiocco al filo.
La certezza di esistere che avrei/ se fossi tu a pesarmi, poesia, scrive Josè Saramago nelle Poesie possibili. Sempre Saramago: E quando non si placa la protesta/del sangue soffocato nelle arterie? (…) E quando siamo stanchi di domande, e risposta non c’è, neanche urlando? G. Cornelio ha consapevolezza degli orli della voragine e li trasforma in impalcatura petrografica (sia secca, sia rude / come pietre calcinate), netta attraverso una coscienza linguistica nella densità di quel che era indicibile fino ad ora.
Ora è una pergamena raschiata, sottostante è un’altra scrittura, vergata nello stesso senso o in senso trasversale al primo testo: segnale già iniziale di suggestione della molteplicità insinuata di verso e di significato.
La chiave è il palinsesto, la porta è la cartula, l’interno è la scrittura.
E nel lago del cor, immagine fulminante di Dante, rimane il bacio al segno della gioia-gioiello-poesia.
Giorgiomaria Cornelio (14 gennaio 1997) ha fondato insieme a Lucamatteo Rossi l'atlante Navegasión, inaugurato con il film Ogni roveto un dio che arde durante la 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. È co-curatore del progetto di ricerca cinematografica La Camera Ardente, e redattore di Nazione Indiana. Suoi interventi sono apparsi su Le parole e le cose, Doppiozero, Il tascabile e Il Manifesto. Nel 2019 ha vinto il Premio Opera Prima (Anterem) con la raccolta La Promessa Focaia. Studia al Trinity College di Dublino.
vivo la tregua del desiderare
lo spazio senza fine in qualsiasi
direzione
disturbi ma di rado per
irrobustire il vuoto
ed è sempre maggiore
ad ogni picco quel
distacco
non v’è disperazione
né gioia né amarezza
l’asprezza dell’esistere
in un cardiogramma
piatto
orienta solo il bene
dove riesco ad abitare
qualcosa da ricevere
e tutto da
lasciare
rimango per il male che svanendo
potrei dare
la mia è la pace
dei morti
Giorgio Bonacini per Mario Famularo
I versi di Mario Famularo offrono al lettore attento – oltre a una parola non programmatica, ma di essenziale precisione evocativa – uno sguardo di movimento dove l’occhio, e non solo il pensiero, trova il percorso di una vasta ma precisa significazione. Perché la poesia è scrittura e voce che attiva la metamorfosi e l’attrazione di tutti i sensi. E’ così allora che si può sintetizzare, senza sminuire, un percorso di senso sostanziale attraverso il tragitto di alcune sue parole (direzione, vuoto, distacco, piatto, lasciare, dare morti), che per noi, per il nostro singolare sentire, mostrano il puntum del testo. Sono le parole che chiudono ognuna delle sette brevi strofe, che danno forma sostanziale a quel pensiero di desiderio d’abbandono (o meglio di “tregua” per usare la parola dell’autore) con cui inizia la poesia, e che è come un velo che copre il testo, ma lascia trasparire altro, e ne fa il suo fulcro distintivo esistenziale. La direzione è l’andamento del senso, vissuto nell’apparente spegnimento delle passioni, che segna il vuoto dove l’io si allontana ogni volta che si prova a innalzare gli occhi verso il reale. E in quel distacco apparentemente sembra racchiudersi ogni emozione, verso un sentimento piatto; che se veramente fosse così, spegnerebbe anche la poesia, e invece porta il poeta a riconoscere, pur nel poco bene che si riceve, il tanto da lasciare. Dunque vale rimanere qui, per evitare il troppo male che si potrebbe dare, continuando a vivere (e a scrivere) con la propria pace, che è la stessa dei morti.
Allì Caracciolo per Mario Famularo
Testo lirico costruito su un linguaggio apparentemente semplice, in effetti risultato di essenzialità, di quella precisa definizione cioè che ha la parola esperienziale, quando nel profondo esprime il significato, esperito appunto, della cosa.
Il tono è puro dolore, privo di ogni enfasi. La voce è solitudine senza dichiarazione, lontana da qualunque retorica.
Giuseppina Rando per Mario Famularo
Con vivo la tregua del desiderare Mario Famularo, attraverso immagini delicate ma intense, apre spiragli sul mondo interiore di ciascuno di noi, quasi sempre gremito di sogni e desideri mai realizzati.
Il poeta, però, ha deciso di non più sognare, né desiderare, ha firmato con se stesso una tregua,
la tregua del desiderare che egli vive e si configura nei versi, come un privilegio, un dono.
Più che una tregua o blocco di bramosie, si intravede come distensione dello spirito, stato di tranquillità, vissuta in uno spazio senza fine dove pure si colgono speciali sensazioni di distacco non evocanti angoscia o sconforto, ma accettazione radicale della sofferenza tanto da modificare la realtà degli avvenimenti che da negativi si mutano in positivi:
… l’asprezza dell’esistere / in un cardiogramma / piatto/ orienta solo il bene…
E’ una luce folgorante a svelare la verità più profonda che prima restava nascosta, quella di poter …ricevere / e tutto da lasciare…la mia è la pace / dei morti.
Un testo introspettivo incastonato nello spazio/tempo percepiti nella disarmonia costitutiva della condizione umana la quale, sperimentando se stessa, la trascende nella ricerca di significati più ampi e totalizzanti.
Mario Famularo (Napoli, 1983) esercita la professione di avvocato a Trieste. Ha realizzato il portale dedicato alla poesia e alla critica letteraria Kerberos Bookstore. Suoi testi sono apparsi su antologie e riviste letterarie, tra cui “Atelier”, “Carteggi Letterari”, “Argo”, “Inverso”, “Menti Sommerse” e tradotti in lingua spagnola dal Centro Cultural Tina Modotti. Collabora al sito Laboratori Poesia con interventi critici sulla poesia contemporanea e una rubrica di analisi dei testi. Ha curato per lo stesso sito una rubrica su prosodia, metrica ed eufonia. La sua prima raccolta, “L’incoscienza del letargo”, è stata pubblicata dalla Oèdipus, mentre la successiva è in corso di pubblicazione per la Giuliano Ladolfi Editore.
L’energia del sonno
Io vivere vorrei addormentato
dentro il dolce rumore della vita
Sandro Penna
Adagiàti
ossa e sensi
infine torneremo
nel Grande Sonno
Se gli alberi dormono da quando sono nati
gli animali vivono nel torpore
e ci guardano dal loro chiaroscuro
simile al nostro dormiveglia.
Da sempre il mare dorme
cullandosi limpido o torbido
né gli urti di tempeste e scogli
potranno mai risvegliarlo.
La strana oscillazione di onda e nave
che ripete la culla umana
è legge creaturale del cosmo
del suo modo di respirare.
I gesti insonori
vorrebbero soffiare via il rumore
I’insistente brusìo delle parole e non increspare
la sintesi del sonno e del silenzio.
Che ci facciamo qui
noi così svegli e stretti
con le pietre chiuse sul petto?
Se non torniamo presto a dormire
moriremo di noia e asfissia
senza l’aria del sonno.
Quel magnifico sonno
che attraversò la storia le storie
le figure le poesie le musiche
che continuano a riposare nel cervello.
Come nacquero le immagini
dall’inizio del mondo fino a qui:
lampi di sonno che squarciarono
la luce accecante e cieca
di una terra troppo sveglia.
Come nacquero sole e luna
quelle prime forme in alto scintillanti
ancora spoglie di simboli
emersi da dove?
Come nacque la notte
prima molto prima del giorno
che conosceva la forza più profonda
l’immisurabile durata di ogni possibile?
Si passa via senza un saluto.
Noi non siamo dove siamo.
Come quando le palpebre inclinate
chiudono il mondo in basso
e si guarda incerti solo l’esito della pioggia
i chicchi di grandine e di neve.
Non chiamiamola luce
o luce della luce
questo chiarore trattenuto dalle ciglia
dei neonati
dei gatti
o dei lupi invernali.
Volontà non c’è
nel dormiveglia
di chiamare a sé l’energia.
L’energia non è che questo respiro
dell’aria raggiante
intorno a noi.
Tra la terra e le nuvole
l’atmosfera fa socchiudere gli occhi
si insinua nelle fessure
tutto sospende
e i corpi vaporosi
cadono dentro il peso della terra.
È ’dalle fessure
che i nostri profili folli e atterriti
vedono futuro e realtà
spiando le scene misteriose della storia.
Forse sono gli dèi
a iniettarci nel sangue
un po’ di significato
quella fusione simultanea
con l’estraneità.
A volte due corpi insieme
credono di sfiorare
i limiti dell’assoluto.
Confusi in un vertice acuto
mimano l’attimo incostante
dell’ eternità.
Non svegliatemi.
Brulicano pensieri senza specchio nel cervello
rosicchiano la pelle vecchia dei sogni.
Se mi sveglio
vorrò mettere ordine al disordine
separando sogno e veglia
fondo e cima.
Non svegliatemi.
Per chi insegue tracce su mappe non scritte
il presente non è mai presente
mai nulla è di fronte
e fugge sempre dietro a qualcosa
che continua a fuggire.
Noi si viene
dal grande sonno del grembo materno e marino
poi passiamo il tempo a svegliarci
dimenticando i luoghi sacri
la cima di potenti montagne
il fondo di potenti deserti
perché l’energia del sonno
passa tocca unisce e va.
Gli eremiti
le figure bizantine
le figure graffiate sulle rupi
le figure senza figura
le figure di Antonello e Piero
tutti i suoni naturali
continuano qui a testimoniare
quell’energia.
Perché piange forte chi nasce
nello strazio di questa luce crudele
che lo strappa al suo sonno?
E noi ostinati
a volerci sempre svegliare
camminare e svegliarci
svegliarci e camminare
solo per allontanarci.
Mi inginocchio
ai piedi del Grande Sonno
mai diviso o interrotto
dove so di entrare se scrivo
di uscire se smetto
e perdermi e impazzire.
Se scrivo
è come chiudere gli occhi
tornare all’animale che sono
albero
nuvola
sasso
tornare all’atomo casuale che sono
che ha nell’aria il suo piccolo eden.
Il Sonno
è la prima cellula di tutte le cose
il resto
è opera teatrale del tempo
del suo gioco prospettico
che ci conduce ad aprire gli occhi
lentamente
lentamente
scivolando
nell’assoluto sonno dell’inizio.
Allì Caracciolo per Lucetta Frisa
Il testo si fonda su un’idea originale, complessa di sensi e fondamentalmente ‘semplice’, una sorta di rovesciamento profondo che attinge all’anima segreta delle cose. La vita umana è un insistente tentato risveglio dal “Sonno”, che è concentrazione assoluta nell’Essere, per gettarsi nella esagitata dimensione della differenza, o della caotica commistione, ignorando la potenza creativa dell’energia di quel “Sonno” così simile al Vuoto.
Mara Cini per Lucetta Frisa
L’energia del sonno è un’articolata “rappresentazione” che allude alla condizione naturale di ossa e semi, alla condizione antropologica e culturale di nostre antiche figure graffiate sulle rupi, e risale indietro fino all’assoluto sonno dell’inizio, a un’abiogenesi ancora dormiente.
Tutto questo, ad un io poeta, si rivela, principalmente, nel proprio fare: so di entrare se scrivo / di uscire se smetto.
Lucetta Frisa, attrice, poeta, traduttrice, nasce e vive a Genova. Tra le sue opere poetiche: Modellandosi voce (Corpo 10, 1991); La follia dei morti (Campanotto, 1993); Notte alta (Book editore, 1997), L’altra (Manni, 2001); Siamo appena figure (G.E.D., 2003), Disarmare la tristezza (Dialogolibri, 2003); Se fossimo immortali (Joker, 2006); Ritorno alla spiaggia (La Vita felice, 2008); L’emozione dell’aria (CFR, 2012); Sonetti dolenti e balordi (ibidem, 2013). Narrativa: Fiore 2103 (SEL; 1977); Sulle tracce dei cardellini (Joker, 2009); La torre della luna nera (Puntoacapo, 2012). Ha collaborato con i suoi racconti per ragazzi al quotidiano “Avvenire”. È presente in varie riviste (Nuova prosa, Poesia, La mosca di Milano, L’immaginazione, La clessidra), antologie (Il pensiero dominante, a cura di F.Loi, e Altra marea, a cura di A. Tonelli) e in siti web (La dimora del tempo sospeso, Viadellebelledonne, La poesia e lo spirito, Carte sensibili, Doppiozero). Traduce dal francese Pierre-Jean Jouve, James Sacré, Sylvie Durbec e dall’inglese J. Clare, E. dall’inglese J. Clare, E. Dickinson, G.M. Hopkins, J. Keats. In volume: Henri Michaux (Sulla via dei segni), Bernard Noël (Artaud e Paule e L’ombra del doppio) e Alain Borne (Poeta al suo tavolo). Collabora a vari blog letterari tra cui “La dimora del tempo sospeso”, dove sono apparse nuove traduzioni di 30 poesie di C. Baudelaire. Pubblica nel 2018 la plaquette dedicata a N. de Staël, Tutto deve accadere dentro di me (Via del vento, 2018)
Con Marco Ercolani cura i “Libri dell’Arca” per le edizioni Joker e insieme a lui pubblica: L’atelier e altri racconti (Pirella, 1987); Nodi del cuore (Greco & Greco, 2000); Anime strane (Greco & Greco, 2006) (Âmes inquiètes, tr. fr. di Sylvie Durbec, Éditions des états civils, 2011); Sento le voci (Greco & Greco, 2009); (J’entends les voix, ibidem, 2011); Il muro dove volano gli uccelli (L’Arcolaio, 2014); Diario doppio (Robin, 2017) e Furto d’anima (Greco & Greco, 2018). Con lo stesso Ercolani cura la rivista online “La foce e la sorgente”.
Vince nel 2005 il Premio Lerici-Pea per l’inedito e nel 2011 il Premio Astrolabio per Ritorno alla spiaggia e l’opera complessiva. Suoi testi sono tradotti in antologie, riviste e libri collettivi. Nel 2016 raccoglie, per Puntoacapo, un’antologia della sua opera poetica: Nell’intimo del mondo. Poesie 1970-2015 (finalista Premio Camaiore 2017).
Sito web: www.lucettafrisa.it
Carne viva
⃰
Carne viva
l’inestinguibile sete
nel trapassare infinito
dal nulla al nulla
verso/voce
dell’originario
La luce è l’ombra dell’Ombra,
lingua dell’inaudito
estasi dell’assenza
infanzia del logos
⃰
Vicino è ora
l’irraggiungibile
sapere è non dire
o dire quel niente
che è un tutto
ci tiene in bilico l
a parola
e non salva
solo un gesto
purissimo, il più leggero
sarà forse la traccia,
una svista, lo scarto,
o il logico caos
del caso
⃰
l’azzurro slabbrato
nel primo battito
dell’estate
esserenuvole nuvole
e lontananza
assoluta mancanza
nel presente remoto
di un futuro anteriore
saremo quali eravamo
prima di precipitare
in un nome
Adelio Fusé per Tiziana Gabrielli
Tre poesie d'impronta filosofica (con echi presocratici) comprese in un unico itinerario esistenziale, che è insieme biografia della parola e della vita. Si va da... a..., dalla luce all'Ombra (la maiuscola è nel testo, e non per caso), "dal nulla al nulla", seguendo un tracciato non lineare ma circolare. D'altra parte è circolare la concezione del tempo che qui traspare: siamo già lontani come una mancanza "nel presente remoto / di un futuro anteriore" e infine "saremo quali eravamo / prima di precipitare / in un nome".
E la parola? "ci tiene in bilico / la parola / e non salva". Rispetto all'esistenza, la parola appare in posizione privilegiata: mentre la parola trae il proprio senso dicendo l'esistenza, l'esistenza non riceve un senso dalla parola. Il senso dell'esistenza sta nel riconoscere che il 'governo' delle cose spetta a "il logico caos / del caso". Di più non possiamo pretendere.
La parola non aggiunge (non porta qualcosa in più all'esistenza) ma attesta e certifica una condizione: "Vicino è ora l'irraggiungibile / sapere è non dire / o dire quel niente / che è un tutto".
La "Carne viva", allora, è lì, nel caos/caso, nella sequenza imperscrutabile degli avvenimenti a cui siamo consegnati.
Romano Morelli per Tiziana Gabrielli
La poesia di Tiziana Gabrielli è la descrizione dolorosamente lucida di uno stato esistenziale, il momento dello svelamento dell’essere al mondo: “assoluta mancanza / nel presente remoto / di un futuro anteriore.”
I versi, densi e nitidi, evocano i mobili contorni inafferrabili del grande equivoco in cui siamo smarriti, “il logico caos / del caso”, ristabiliscono verità e misure dell’essere umani e ci annunciano un destino, forse un auspicio: tornare ad essere “quali eravamo / prima di precipitare / in un nome”.
Tuttavia il testo pulsa come una ferita aperta, è “carne viva” e la sete è inestinguibile; è la voce dell’attesa inquieta di un compimento. Ed ora che sappiamo che “la luce è l’ombra dell’Ombra”, che “sapere è non dire” e che la parola non salva, “vicino è ora / l’irraggiungibile”.
Mario Novarini per Tiziana Gabrielli
Dire l’indicibile, la parola che esprime il mistero dell’esistere, ma guarda anche al prima, al dopo e all’oltre, è, non meno di un’inestinguibile sete, esigenza primaria della carne viva. Un paradosso, un adynaton: il logos è il solo mezzo a nostra disposizione per esprimere ciò che lo trascende. Così non possiamo definire la luce se non come negazione del suo opposto. Così l’irraggiungibile (pur sentito vicino) sapere è ineffabile, o è dire quel niente / che è un tutto. E nel provare a dirne anche solo un barlume la sequenzialità univoca della sintassi deve superarsi facendo coesistere la dimensione paradigmatica e quella sintagmatica (l’irraggiungibile / sapere fa da soggetto, contemporaneamente, a vicino è ora… e a … non dire / o dire quel niente / che è un tutto) e annullando quasi completamente la punteggiatura.
Ci tiene in bilico / la parola / e non salva: forse solo attraverso una svista del soggetto senziente è possibile cogliere, in modo inavvertito, un frammento del senso nascosto nel logico caos / del caso, dove il mistero del tempo sfugge all’indagine razionale che, per provare a interpretarlo e a descriverlo, deve stravolgerne le categorie grammaticali e ontologiche.
E alla fine, ripercorso l’iter dal nulla al nulla iniziato nel momento in cui siamo precipitati temporaneamente in un nome, irripetibile individuale declinazione di un caso della grammatica dell’essere, ci accorgiamo di un’altra traccia, non meno misteriosa, apparsa nella filigrana della trama che la nostra vita ha intessuto.
Giuseppina Rando per Tiziana Gabrielli
“Carne viva“ di Tiziana Gabrielli, emerge come immagine riflessa di quel l’inestinguibile sete
che assilla l’essere umano e lo rende consapevole del nulla da cui proviene e a cui è destinato (dal nulla al nulla).
La Poeta ri-vive la lucida disperazione esistenziale che concepisce la vita come tragico esilio, impenetrabile mistero (lingua dell’inaudito/ estasi dell’assenza), condanna alla solitudine, all’incomunicabilità (sapere è non dire / o dire quel niente).
L’essere umano (carne viva) s’aggira come una fosse una larva, rassegnato a vivere nel logico caos / del caso.
E’ la poetica del non-essere che tiene in bilico / la parola / e non salva, emblematica dell’intellettuale moderno di fronte agli enigmi della natura e all’irrazionalità della Storia.
Sembrerebbe che la Gabrielli si interroghi sul senso della ricerca poetica, forse, nel tentativo di confrontarla con la vita e con ciò che, in apparenza, sta fuori dei suoi confini.
L’immagine dell’ esserenuvole nuvole accende per un attimo un barlume di fugace serenità, assorbito subito dopo dalla dominante intonazione dell’assoluta mancanza e della perenne angosciante realtà.
Tiziana Gabrielli (1969) vive tra Roma e Chieti. Ha conseguito nel 1996 una laurea in Filosofia (cum laude) all’Università degli studi di Chieti, e, nel 2004, un Dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera e la Humboldt-Universität di Berlino. Si è perfezionata presso la Scuola Normale Superiore di Pisa in Filosofia classica tedesca, e in Bioetica, presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma. Attualmente i suoi studi sono orientati all’approfondimento dei rapporti tra filosofia, arte e letteratura. Giornalista pubblicista dal 2007, è autrice per la tv, la radio e il cinema ed esperta in marketing e comunicazione digitale. Come poeta, le sue liriche – talune tradotte in spagnolo e in greco moderno - hanno ottenuto importanti riconoscimenti.
Nel 2014 ha pubblicato l’opera L’ora senza nome, Cierre Grafica, Verona 2014 (Premio “Opera Prima” 2013), e la silloge Il silenzio della luce, Giulio Perrone Editore, Roma 2015 (Finalista del Premio di poesia Walter Mauro 2014). Alcune sue liriche sono state scelte per essere pubblicate nell’Enciclopedia di Poesia Contemporanea 2015, edita dalla Fondazione Mario Luzi Editore.
Non ancora corpi
della bestia amavi quel suo attendere tra le righe, sfuggire alla morsa del testo
quella forma che si aggira non è corpo e non è volto, è soffio e tensione di vita
nascondersi tra le sembianze dell’esserci e lacerare coi denti quella carne viva
pulsa per pochi istanti, sparsa nella grafite ai piedi del foglio, ferma nel verso
prima che il nome recida il cordone di una parola ferita, attesa di un divenire
tra filamenti e nervature, il segno impedisce di scorgere il filo appeso alle fibre
cosa muta, carezza e tremore dove il respiro è scrittura dell'essere incanto
corpo di argilla impastato con la saliva del tempo e lo sguardo fisso nell’aria,
soffio di musica nella mano, dove pensiero e vita scorrono via, e si penetrano
grido soffocato e silenzio dell’astinenza, sabbia trasparente svela il disegno
parola chiara ti svesti insicura in quel corpo non tuo, dipingi il volto ferito
chiuso tra le pieghe sanguinanti del mistero che lega il tempo all’eternità
alla pietra serena, al suo freddo esistere senza labbra e senza parole, essere
muto sguardo che avvolge e protegge, ti guida nella grotta dell’urlo iniziale
che spunta tra le nuvole e si affaccia sulla scena, sole femmina, opera rotonda
pancia di cielo, nel fango di quell'essere ancora informe, mani aperte bianche
sulla pietra scolpita, scavata nel nulla, di quello che fuori non ha ancora nome
antica misura di un essere informe, essere solo pensato, essenza di un sé salvato,
anima nuda sofferta che sale, procede lenta e piegata, arretra e cade, sollevata
prende corpo, si fa volto e impronta di un procedere senza lamenti, ferma nel cielo
luna maschio, schiena della notte, urla parole prima che sul sogno cali il sipario
dire favola femmina, dire ascoltare rotondo maschio, assecondare il corso
allentare le parole e attendere che tornino bianche, velami di vita nell'aria,
strisciare, dire strisciare con le pance e ruotare con i fianchi sui sassi piatti
espellere uova parola, albume femmina imbianca l'acqua, dire cicatrizza
imbuto maschio non permette di entrare, occlude il desiderio con il dito,
tralasciare si appiccica al senso corrente, ferma il suo movimento, avvolge
pulsare, per un solo attimo hai tenuto il pensiero libero dal non essere nato
si ritrae, non esce nel fuori, si lascia toccare non presa dal dire
chiamata si affloscia sollecitata a salire nel momento senza tempo
si raggomitola nell'esteso dell'innominabile luogo, si erge sospesa
finita nell'orizzontale apre di nuovo al possibile guardare, ripresa
sollecitata a salire si riempie di niente, espelle l'indicazione verso
non pronuncia il nome avvolge il senso nel ritirarsi dentro, piegata
avverte di essere sul punto di scorrere via, uscire dal testo inviolata
di nuovo in cammino, il passo è quello di sempre insicuro e sospeso
speranza e calore ancora di quel soffio, certo di un pulsare animale
parola tam-tam, parola urlo, cosa recisa sanguinante di puro senso
nascondersi dove il dire dorme tra le pietre, dove il nome è fuggito
velata nudità di un sogno, di un divenire carne, di un tramutarsi solo
sfuggire alla voce che invoca, nascondersi dove il verso è fuoco vivo
vegliare la morte e stendersi tra le parole tremanti, non ancora corpi.
Laura Caccia per Massimo Rizza
Ha la forza del risalire la corrente il dire poetico di Massimo Rizza. Immerso tra gli anfratti di un impasto primordiale in cui le parole non sono ancora voci,“non ancora corpi”. Dove, tra mistero e desiderio, è un tendere inesausto e insieme un ritrarsi, l’affacciarsi in una forma e subito spogliarsene. Un incessante passaggio tra fisicità e parola, corporeità e scrittura. Verso una nudità del dire che attende di essere portata alla luce e nello stesso tempo esige di rimanere occulta, nutrita da una tensione che insieme musica e lacera.
Quasi una contesa tra forze in opposizione: da un lato, il finito prevaricante del testo, dall’altro, “un pulsare animale /parola tam-tam, parola urlo” che sfugge e resiste. Dove il pulsare è soffio, tensione vitale infuocata e desiderante. Qualcosa di più, però, del solo portare in superficie il contrasto tra incorporeità e sembianze, essere informe e forme costituite. Qualcosa che piuttosto richiede di immergersi completamente nell’informe, colmo di sangue e di fango, saturo di assenza di nome e di senso, assumendo il contrasto come costitutivo dell’esserci e dello scrivere.
Qualcosa che esige di trattenerne il respiro, in un pensiero senza nascita, in una parola senza nome, e, nello stesso tempo, di renderlo possibile per sé, nella propria corporeità così come nella scrittura. Tra parole insieme incorporee e desideranti, residui dell’ardere muto, in attesa “dell’urlo iniziale”. In un processo, vitale e poetico, che tenta, tra gli anfratti dell’esistere e del dire, anche onirici e inconsci, di risalire fino al prima della parola, nel gorgo muto e infuocato, misterioso e lacerante che ne precorre il parto. Ancora prima di quella precedenza temporale che O. Mandel'stam attribuiva al sussurro rispetto alle labbra. Qui ancora prima. Prima della corporeità e del dire. Un prima radicale: un pre-dire “senza labbra e senza parole”.
Adelio Fusé per Massimo Rizza
Chi non ha ancora un corpo è, anzitutto, la parola prima di essere scritta. Eppure, quando acquisisce un corpo, lei, la parola, manifesta disagio ("parola chiara ti svesti insicura in quel corpo non tuo"); muovendo poi verso il senso delle cose, lei, che "si riempie di niente", si sottrae (la parola "avvolge il senso nel ritirarsi dentro").
A non avere un corpo è anche l'autore quando non scrive e attende "un pulsare animale / parola tam tam", la parola che si propaga e viene condivisa (sottintendendo il lettore, figura qui taciuta ma certo presente). La mano che scrive e la parola che pulsa sono un unico corpo. O, meglio, sono la ricerca di un corpo mai trovato come definitivo.
La parola è la protagonista di una storia inevitabilmente sempre in corso. Si acquatta, si manifesta, non si lascia imbrigliare ("della bestia amavi quel suo attendere fra le righe"). E siccome l'autore non è un predatore ma qualcuno che vuole capire, dopo averla attesa e provvisoriamente incontrata, sa di perderla fino al prossimo appuntamento.
La scelta del verso lungo con una inclinazione alla prosa (benché il testo sia in tutto e per tutto un testo poetico) si traduce in un andamento ipnotico costruito con perizia, di tempo moderato (tempo, qui, in senso musicale), che mescola i due versanti della realtà e del sogno. Del resto la parola, nel suo dire fuggevole, appartiene all'una e all'altro.
Massimo Rizza è nato a Sesto San Giovanni e vive a Segrate (Mi). E’ laureato in pedagogia e ha operato nel campo dell’istruzione in qualità di dirigente scolastico. E’ condirettore della rivista letteraria Il Segnale. Ha pubblicato la raccolta poetica Il veliero capovolto, Ed. Anterem (2016).
Nel 2017 ha vinto il Premio Letterario Interferenze, Bologna in lettere, per la sezione poesie inedite.
Suoi testi narrativi sono pubblicati in antologie e on line sul sito della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Testi di poesia, critica e saggistica sono apparsi su riviste letterarie italiane, tra le quali: “Anterem”, “Capoverso”, “Erba D'Arno”, “Il Segnale”, “l’immaginazione”, “Pagine”, “Scibbolet”.
Il peso delle parole
riappare (eccolo) il peso delle parole
ostinato e greve confuso con
la grammatura della carta
per astratte materie e indivisibili misure
verso distinte e confinanti unità
si riavvolge il labirinto dei pensieri degli elementi
assoluti così imperfettamente congrui i solchi
le indelebili macchie fra le righe e gli spazi
poi la coerenza da non dimenticare mai
lo stile cercato nei cassetti e dentro la polvere dei libri
la fatica della ricognizione tutto ha un inizio
nulla si conclude qualcosa rimarrà o
magari no forse soltanto un peso inutile
un debordante avanzo di vuoto
e la scialba consapevolezza che il
tempo sposta le nuvole e
inchioda i sentimenti
alle pareti per ogni anima perduta
Rosa Pierno per Enea Roversi
C’è un elemento in comune fra parole, peso, misure, spazi, tempo ed è il pensiero. Come si debba riconoscerlo è la questione centrale nella poesia di Enea Roversi “Il peso delle parole”. Innanzitutto, lo si fa tramite l’intercessione di oggetti concreti: la carta con la sua grammatura, il labirinto, le macchie, i cassetti, la polvere: nulla si conosce se non tramite esperienza. Il testo poetico descrive un armamentario - e si direbbe quello tipico dello scrittore, inchiodato alla sua scrivania - che serve metaforicamente alla trasmutazione degli oggetti quotidiani nelle metafore che funzionano da trampolino per la creazione dei concetti astratti. Non troppo nascosta è la questione del pensiero in poesia, come isolarlo, come individuarlo; se esso sia propriamente il pensiero preciso che ogni lettore attinge ineluttabilmente, oppure se esso sia appena una possibilità interpretativa, un barlume, perché se così fosse, si tratterebbe di un senso impreciso e aleatorio, eppure altrettanto ineludibile. Eccola, in chiusa, l’evidenza che risalta come un diamante innestato nella fanghiglia di ogni inizio di scrittura poetica, che ha sempre in sé la possibilità di uno scacco: la consapevolezza che il sentimento, intriso di senso, schiuda ogni volta a qualcosa che, pur nato tra solchi e macchie, illumini il cielo della pagina.
Lia Rossi per Enea Roversi
Perché pesare le parole, perché non lasciarle alate, perché pensarle insite in grammature di carte?
Parchè la parola è anche carta assorbente, include silenziosamente solchi, macchie, righe, spazi, polvere dei libri. Attira a sé lo stile della ricognizione, la fatica, la consapevolezza delle nuvole che si spostano e i sentimenti inchiodati alla fermezza dei muri.
Le parole sono abiti, e senza cuciture, come la veste di Cristo, sono sacre fasciature del reale che accade ed è accaduto: un‘unica materia di tessuti intrecciati, un patchwork impensato e sotterraneo, una colla potente.
E’ il modo di cucire del poeta rhapsòdos: cuce il canto.
La parola, già metafora per eccellenza, termine che porta fuori dal confine, pervade pensieri e lingue, organizza, inventa una cosmogonia, all’interno di un tempo eterno. Il tempo entra nella parola di Enea Roversi anche all’improvviso in modo più discorsivo: Poi la certezza di non dimenticare mai …
Nulla si conclude qualcosa rimarrà o magari no. Come briciole di conversazione, quasi un poème-conversation di Guillaume Apollinaire, quasi un Lundì, rue Christine: la parola si iscrive, per far parte della commedia della scrittura, di questa necessità ne siamo convinti, insieme a Roland Barthes.
Riappare (eccolo) il peso delle parole: ecco l’iscrizione, per fortuna.
Enea Roversi vive a Bologna, dove è nato nel 1960.
Ha ottenuto riconoscimenti e segnalazioni in vari concorsi nazionali di poesia ed è stato pubblicato su riviste, antologie e siti web.
Tra le pubblicazioni: la raccolta Eclissi di luna (Poesie 1981-1986), uscita in versione e-book nella collana Nuovi Echi per la casa editrice La Scuola di Pitagora e la silloge Asfissia, pubblicata nel volume Contatti edito da Edizioni Smasher.
Più volte segnalato o menzionato al “Premio Nazionale di Poesia Lorenzo Montano” organizzato dalla rivista Anterem, ha partecipato ad alcune edizioni della Biennale di Poesia di Verona e ad altre rassegne letterarie.
Fa parte della redazione della rivista online Versante Ripido e figura nello staff organizzativo del Festival Letterario Bologna in Lettere.
Cura il sito web www.enearoversi.it, interamente dedicato alla propria attività letteraria e pittorica e il blog Tragico Alverman – Scrittura e altro.
trasmette luce differente, acqua
buia di montagna, occhio
fossile nel tatto che riprende
nella vocale che articola e cede
all'impatto della visione, largo
campo di foglie e poi
solo vento
Laura Caccia per Roberta Sireno
Un germoglio del caduco il testo poetico di Roberta Sireno. Pronto a schiudersi all’interno di una stagione oscura, dentro un calco residuo da cui irradia mistero. Un germoglio della visione, della parola, dell’oltre. Denso della ricchezza occulta e manifesta che un intero contiene, racchiuso nella forma compatta e insieme aperta del testo, e, nello stesso tempo, colmo della precarietà che il molteplice declina nelle sue forme fugaci.
Quasi un affresco dai rapidi tratti e dalla pluralità di strati: dove, da una profondità remota, sbocciano immagini pronte facilmente a dissiparsi. Il colore sensoriale è quello immediatamente percepibile: una varietà di impressioni visive, tattili, uditive che si dilatano e si richiamano tra i versi. Al di sotto, in chiaroscuro, la trama oppositiva che governa il pensiero dell’intero, tra gli ossimori che trattengono, uniti, oscurità e chiarezza, fissità e movimento. E, ancora, tra le sfumature, la presenza rarefatta dell’oltranza: all’inizio, introdotta da una luce altra; al termine, lasciata emergere dal vuoto che il vento trascina in primo piano.
Un affresco alla fine sottratto al visibile, non però alla parola. Sulla compattezza visiva del testo, supportata dall’unica strofa che lo compone, la dinamica delle sonorità interne, amplificata dalla vocale risonante in posizione centrale, prende il sopravvento. Sottesa nell’oscuro, ma potente nel suo emergere, la presenza della voce tra gli elementi naturali e sensoriali riesce a portare il testo altrove. A dipingere lo sbocciare di una visione che cancella. Sotto forma di ossimori, i sostantivi e i loro attributi. In battere e in levare, in sottrarre e in dilatare, le forme verbali. Così una parola altra prende voce, “trasmette luce differente”.
Adelio Fusé per Roberta Sireno
Una sola strofa di sicuro effetto, fonicamente omogenea, misteriosa e onirica, che accosta immagini di segno opposto ("luce differente", "acqua / buia"). Ciò che qui si descrive è un'esperienza sensoriale onnivora: il vedere ("occhio fossile nel tatto", attore e testimone in sintonia con il tempo smisurato delle ere geologiche) si unisce al tatto (dunque la fisicità) e sbocca nella necessità del dire ("vocale che articola").
La rapida concentrazione delle immagini, simile a quello di un sogno, infine prende respiro e si allenta ("largo / campo di foglie"), ampliando la prospettiva: il "solo vento", isolato e conclusivo, disperde la visione; oppure, meglio, la sospinge altrove. Perché la visione – sembra ricordarci Sireno – è dinamica, mai ancorata a uno stesso punto del paesaggio (reale o immaginario che sia), e in movimento continuo.
Irene Santori per Roberta Sireno
Considero la poesia di Roberta Sireno meritevole di vincere, per avervi incontrato, oltre alla misura e originalità di talune immagini, riscontrabile anche in altri finalisti, una ricerca di unità compositiva del testo, giocata su serrati rimandi interni.
Tatto e udito, in una spirale sinestetica, sembrano afferire alle proprietà dell’occhio e dare alla vista la facoltà di toccare e articolare suoni, anzi la vocale, parola connotatissima questa, che porta in sé l’origine oscura del linguaggio, prima dell’avvento delle consonanti. Perciò l’occhio si fa tramite di una luce differente, altra, ossimoricamente buia, come acqua di montagna, forse carsica, ovvero del profondo. Ma il buio dice molto di più. Questo potenziamento sensoriale viene infatti pietrificato, quasi accecato, nella fossilizzazione dell’organo di senso, occhio fossile: l’espansione dei campi percettivi è dunque contestualmente abolita fino alla perdita della stessa facoltà visiva dell’occhio. Recuperata poi, ma in chiave deponente, in un arrendersi alla visione, soccombendo ad essa.
Quel cede, inanellato a riprende, entrambi a fine verso, non è dunque nel campo semantico del cedere ovvero del dare, come alienazione di un sicuro possesso, ma ancora nella modalità passivante della resa: non siamo nello schema del prendere e del dare, ma del prendere e perdere.
Accumulo e perdita: ancora una volta, come fosse una coazione a ripetere dell’autrice, si riaffaccia il nodo - tematico e portante dell’intero componimento - dell’espropriazione, della sottrazione e spoliazione: nel campo visivo come nel campo semantico, e come, infine, nel campo di foglie… Immagine, quest’ultima, quasi olfattiva e di raccordo e sintesi di tutte le disseminazioni del testo. Essa ci dice di accumuli di foglie cadute da alberi che si vanno spogliando. Appena un colpo di vento poi e si spoglia anche il campo.
Roberta Sireno (Modena, 1987) autrice di Fabbriche di vetro (Raffaelli, 2011) e senza governo (Raffaelli,
2016). Riceve il primo premio al Certamen (Centro di Poesia Contemporanea di Bologna, 2009) e al concorso di poesia Dentro che fuori piove (Università di Bologna, 2013). Suoi scritti sono su «Poetarum Silva», «blanc de ta nuque», «Golden blog», «La macchina sognante». Principali rassegne: RicercaBO (Bologna, 2012), Teatro Valdoca (Cesena, 2013-2017), Cabudanne de sos poetas (Seneghe, 2014), Magnifico Teatrino Errante (Bologna, 2016-2018). È curatrice insieme ad Anna Franceschini della rassegna Una come lei. Incontri e pratiche di poesia (2018-2019, Centro delle Donne di Bologna). Nel 2018 è prima classificata al premio nazionale Anna Osti di Costa di Rovigo nella sezione poesia edita.
Diego Terzano, “Parapiglia”, videolettura;
doppia versione (per il “Montano” e la variante uscita su “Anterem” 99), note di Flavio Ermini e dell’Autore
Flavio Ermini per Diego Terzano, Essenziali riflessioni su “Parapiglia”
Tra volo e gravità
Solo la ninfa Mnemosyne – in quanto figlia di Urano (il cielo) e Gea (la terra) – potrebbe ancora dar luogo all’ascolto della coscienza originaria. Ma da tempo ormai Mnemosyne si sottrae al suo ruolo, ponendo così in evidenza l’ingiustizia dell’oblio al quale l’ha condannata l’essere umano.
“Parapiglia” è l’accorato volgersi alla ninfa per chiederle di tornare tra noi, portando con sé il suo linguaggio, fatto di gesti, di espressioni corporee, di occhi, di sguardi, di effusioni affettive; un linguaggio-dei-corpi a tutti comprensibile, in quanto dialogo, colloquio “tra volo e gravità”.
“Parapiglia” è l’incessante volgersi a Mnemosine affinché ci aiuti ancora una volta nella ricerca di una parola che, ripetendo l’origine, si costituisca come rinnovato principio di una relazione autentica con il mondo.
La nostra storicità, osserva Diego Terzano, non è di per sé una condanna; al contrario può consentirci di esercitare la nostra libertà, facendoci soggetti della storia stessa.
Il nostro esserci, d’altro canto, non è solo una chiusura in ciò che già è; al contrario può costituire anche un’apertura rivolta a ciò che può essere; un’apertura affidata a labbra che hanno finalmente ricominciato a parlare.
Ma queste possibilità possono realizzarsi solo a una condizione, e Terzano prova a indicarcela: diventare partecipi di un processo linguistico e gestuale in cui produrre continui ricominciamenti, in virtù della consapevolezza che il passato – con il suo peso – ha su di noi. Un passato al quale ci sarà ancora consentito accedere unicamente grazie alla memoria della quale unica custode è la ninfa Mnemosyne.
Parapiglia (Versione di aprile 2019)
Si spande di tra occhio e cielo un fumo
su cui corre una polvere stellare:
di là vite, oltremare,
punteggiano già tutta la pianura
del pensiero. L’imago tua e il profumo
di vaniglia, la rabbia liminare
che raccoglie un tonare
più nero, si rastremano in arsura, e
tra volo e gravità l’inarcatura,
antica, del tuo gesto ormai governa,
nella cieca caverna
del tormento, lo spazio e il tempo puro
del fiore: nato, e da sé morituro.
Il fuoco per l’abisso che riarde
funesto si fa sole; ancora mosso
dal tuo terrore rosso
mi richiudo negli atti, i tuoi, di petra.
Prolissa, la tua posa, nelle tarde
sere mi scuote e iracondo, commosso
è il tuo cuore colosso –
dei miei moti ti scopri geomètra.
Ma ora che, lenta, la bruma s’arretra
rivolta già ti desto, ed esitante,
a blandire un istante
senza modo. È un divino, eterno azzardo:
l’oblio, forse, godi nello sguardo.
Eppure attendo, come te silente,
che si riapra l’immobile stato –
un tocco delicato
della sottile mano, chiara linfa,
l’immane abbraccio dell’in sé latente
del mondo: come segno inabitato
l’evento è incastonato
tra i nostri corpi e il tuo volto di ninfa.
Come il fuoco la pietra (paraninfa
di nozze, e spettri, tra condanna e strazio)
risorgerà topazio
nel bruno dei tuoi occhi, giù nel mare
fresco. L’assillo vi lasci annegare.
E se poi l’aria, candida, che schianta
i nostri giorni avvolti nello speco
notturno, amore cieco,
ammaliasse di vera luce il corso
che s’invade del niente – già rifranta
da sempre dentro sé la vasta eco
di un remoto, più bieco
terrore (quello del senso, trascorso)...
Allora certo, nel folle decorso
– tra luci nuove – dell’inerte cuore,
guarderemmo all’amore
il primo, che si cela già nel bianco
del vento. L’alba ammanta il cielo stanco:
su queste lande, fuori del deserto
aspro – incastro d’eterne viltà,
fuor di necessità
che si versò nel ventre della terra,
due fonti attingono a uno sguardo aperto.
Tersa goccia di luna, è vanità
l’immensa oscenità
della misura: ecco un nume, ci afferra...
E ancora la tua mano: ora serra
l’unità del pensiero – l’aporia:
già questa melodia
è ombra, ma l’imago della sorte
buona rammenti. Recede la morte.
Parapiglia (Versione di ottobre 2019, da “Anterem” 99)


Diego Terzano, Intorno al parapiglia
Prove urgenti di sublimazione, proiettate verticalmente nel tempo – proprie e altrui; la resa di qualcosa in immagini, che rispetto alle attese di qualcuno permangono o rimarranno mute; e la tentazione di tenerle private, a un primo livello: salvo poi provare – tentare ancora – delle personae, che di quel plesso di esigenze si facciano mediatrici (o ermeneuti); e al massimo della dispersione concettuale, una dittatura della forma, distesa orizzontalmente? E ancora, forse, la ricerca di una comunicabilità in primis fallita, e via via rinegoziata: c’è, effettivamente, qualcosa da dire a qualcuno?
Fallisce, a dirla tutta, lo stesso tentativo – questo – di testimoniare il campo di energie di cui scrivendo ci si fa sfogo. Con ciò intendendo la comunicabilità e il fallimento comunicativo moduli scalari e coimplicati: reversibili; così come reversibili, a posteriori, si presentano la dimenticanza e la reminiscenza di ogni tentativo di dire, all’atto della rimodulazione testuale. Continuando a procedere per associazioni, e assunto che per chi scrive non si risolve ancora la dialettica tra possibilità e determinazione di una variante concettuale-formale, la divaricazione fra due cristallizzazioni testuali resta naturalmente l’isolamento di due momenti di uno scalare processo di indecisione, di delineazione del plesso tematico via via ingannato, a cui per sfinimento ci si arrende una volta attestata una possibilità minima di dialogo.
Diego Terzano (1993) ha compiuto studi letterari e filosofici a Genova ed è dottorando in Studi italianistici all’Università di Pisa. Si interessa al rapporto tra antico e contemporaneo e tra pensiero e poesia. Al centro del suo lavoro si colloca, in particolare, l’opera di Carlo Michelstaedter.







Giorgiomaria Cornelio (14 Gennaio 1997) e Lucamatteo Rossi (3 Dicembre 1996) hanno fondato l’atlante Navegasión, inaugurato nel 2016 con il film “Ogni roveto un dio che arde” durante la 52esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Loro opere sono state presentate in festival e spazi espositivi internazionali, come i Rencontres Internationales Paris/Berlin, il Marienbad Film Festival, l’Asolo Film Festival e il Richmond Center for Visual Arts (Western Michigan University). Tra le altre collaborazioni si segnalano la performance ”Playtime”e la mostra “Young at heart, older on the skin ”, entrambe curate da Franko B. Nel 2019 hanno tenuto un Openshop alla Dublin Science Gallery, e hanno inaugurato la loro ricerca teatrale con il primo studio di “Elagabalus”. Attualmente studiano al Trinity College di Dublino.
Giorgiomaria Cornelio cura infine il catalogo online di ricerca cinematografica “La camera ardente”, ed è anche scrittore: suoi interventi sono apparsi su “Doppiozero” “Le parole e le cose”, “Il Manifesto”, “Il Tascabile” e “Nazione Indiana”, di cui è anche redattore. Ha vinto il Premio Opera Prima (Anterem) con la raccolta La Promessa Focaia, ed è stato finalista al premio Montano e al premio Bologna in Lettere.