Rivista
Anterem è una rivista di ricerca letteraria
Fondata nel 1976 da Flavio Ermini e Silvano Martini, “Anterem” è tra i periodici che più profondamente hanno indagato il rapporto tra parola poetica e pensiero. A questo scopo ha istituito una particolare interazione tra poesia e saggistica, suscitando riflessioni e dibattiti, e incidendo profondamente sulla storia della letteratura che si è formata tra il ventesimo e il ventunesimo secolo.
Tra le pagine di “Anterem” vengono riprese le domande fondamentali che urgono nel pensiero aurorale, approfondendole, muovendo da angolazioni sempre diverse, fino a rendere viva l’antica eredità che si trova in noi. Questo cammino del pensiero è – in quanto poesia – pensiero del cammino: luogo comune per tutti coloro che si sono allontanati dai singoli generi letterari per assumere una funzione, per così dire, di “rete”.
Il nome “Anterem” nasce porgendo attenzione al valore originario della parola, chiamata a essere il luogo di raccordo tra sensibilità e percezione. Questa espressione fa cenno all’«= 0» hölderliniano (Il significato delle tragedie e Mnemosyne) che – evocando l’«uguale a zero» di Sofocle (Edipo re) – richiama quel «procedimento dello spirito poetico» che impone all’essere e all’esistere di presentarsi privi di separazione, indivisi, e tuttavia reciprocamente distinti.
Altri riferimenti si trovano nelle «archai» che Nietzsche colloca nel «sottosuolo della storia» (Umano, troppo umano) e che Deleuze e Guattari affidano a quella parola rizomatica (Rizoma) a cui è dedicata la prima serie della rivista (1976-78).
Ma l’opera su cui esplicitamente fa presa il nome “Anterem” è la Scienza nuova di Vico, dove leggiamo: «Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso, ed è propietà de’ fanciulli di prendere cose inanimate tra mani e, trastullandosi, favellarvi come se fussero, quelle, persone vive. Questa degnità filologico-filosofica ne appruova che gli uomini del mondo fanciullo, per natura, furono sublimi poeti». Sarà lo stesso Vico a citare a questo proposito una riflessione di Spinoza: «La fantasia tanto è più robusta quanto è più debole il raziocinio».
“Anterem” è giunta a costituire nel corso di oltre quarant’anni uno dei più illustri cataloghi di quella letteratura che fa i conti con il pensiero delle origini; una letteratura scettica nei confronti dell’oggi, di ogni oggi, dello stesso concetto di oggi.
Indipendente dalle scuole, dalle mode e dal conformismo dei circuiti editoriali, fin dai primi numeri la rivista ha esercitato un forte fascino su poeti e pensatori che coltivano un’idea di letteratura incamminata in una direzione quasi del tutto ignota.
Viene infatti messo a tema ogni volta un domandare aperto all’ulteriorità, rispetto a ciò che ci sta davanti come già dato.
“Anterem” è una di quelle riviste che segnano una discontinuità profonda con i paradigmi e i programmi del proprio tempo. Con questa consapevolezza, intorno alla rivista si è formata una comunità di poeti e pensatori che ha deciso di privilegiare quelle riflessioni che faticosamente – attraverso difficoltà continue e mai completamente superate – producono opere letterarie. Tale comunità fa della ricerca un principio estetico che emerge da una trasformazione e non dal calcolo. Una trasformazione che nell’era della tecnica sembra possibile unicamente nel dire.
“Anterem” accoglie l’istanza di un pensiero non più metafisico e quindi nuovamente e radicalmente iniziale, in grado dunque d’immaginare come il mortale può tornare a essere. Gli autori convocati sanno che è vana la ricerca di un senso centrale e di princìpi fondanti che non sia l’enigma dell’erranza, vera cifra dell’esperienza umana.
Attraverso testi poetici provenienti da ogni parte del mondo – pubblicati in lingua originale e con traduzione a fronte – “Anterem” si è assunta il compito di veicolare la varietà e la complessità di un mondo in continua trasformazione, codificabile solo con nuovi alfabeti, da coniugare in un mosaico irregolare e vitale.
La ricerca alla quale guarda “Anterem” fa i conti con l’eterogeneità e la frammentarietà del mondo, volgendosi verso un aperto non integrabile, ossia verso forze che non si lasciano più unificare e ordinare da un soggetto legislatore in un centro unitario.
Né cattedrale né prigione della poesia, la grande casa di “Anterem” continua a costituirsi come luogo verbale affacciato sul mare dell’altrove e dell’inconosciuto. È in questo processo che viene favorito il movimento precategoriale e autonomo della parola ante-rem, in un incessante nomadismo.
Ai filosofi, ai poeti, ai prosatori, ai saggisti ai traduttori, agli abbonati e al Consiglio editoriale di Opera prima
Comunicazione ai filosofi, ai poeti, ai prosatori, ai saggisti e ai traduttori di Anterem, agli abbonati alla rivista e al Consiglio editoriale di Opera prima.
In merito al comunicato sulla chiusura di “Anterem” e della sospensione di “Opera prima”, essendo ancora in corso abbonamenti e collaborazioni, desideriamo aggiungere alcuni chiarimenti.
Prima di tutto esprimiamo gratitudine ai filosofi, ai poeti, ai prosatori, ai saggisti e ai traduttori di “Anterem”, che hanno contribuito in modo determinante ad arricchire l’intenso e costante dialogo tra pensiero e poesia che ha caratterizzato e reso speciale la rivista. Questo dialogo potrà continuare, se pur in forme diverse, nel periodico on line “Carte nel vento”.
Allo stesso modo ringraziamo gli abbonati per l’importante sostegno dato negli anni ad “Anterem” e alle relative iniziative.
Gli abbonati in corso, oltre al numero 100, in luogo della rivista e fino alla scadenza, riceveranno tutti i libri di prossima pubblicazione. Gli ‘abbonati con libri’ godranno di un prolungamento biennale dell’invio dei volumi.
Siamo inoltre grati, pur non avendone gestito l’iniziativa, al Consiglio editoriale di “Opera prima”, per il prezioso, indispensabile supporto.
Vogliamo significare quanto siano stati importanti e apprezzati i contributi di tutti, insieme alla collaborazione che ci auguriamo possa continuare, nella condivisione di intenti e prospettive.
La redazione
Comunicazione rivista Anterem
Con grande dispiacere e con un sentimento di forte passione, gratitudine e rispetto per la sua storia, comunichiamo che, dopo l’uscita del numero 100, la rivista “Anterem”, fondata e guidata per 45 anni da Flavio Ermini con idee, visione e coraggio, interrompe la pubblicazione.
La decisione del nostro direttore è stata sofferta e ponderata. Ha scritto alla redazione: “Devo dirvi con rammarico che questo numero cento sarà l'ultimo. La rivista Anterem con questo numero, al massimo dello splendore, cessa le sue pubblicazioni. Rimane a voi il compito di proseguire la restante attività da ora in poi, e se lo vorrete”.
Con lo stesso rammarico, dobbiamo comunicare che è di conseguenza sospeso, già dall’edizione 2019/2020, il Premio Opera prima, ideato con Ida Travi e da lui interamente gestito per vent’anni.
Possiamo annunciare che il patrimonio di esperienza e conoscenza che “Anterem” rappresenta non andrà perduto: sarà interamente riversato, in accordo con Flavio, nell’attività della nuova casa editrice, che proseguirà con rinnovati progetti per le diverse, storiche, collane.
È stato inoltre potenziato il Premio Lorenzo Montano e tutto quello che gli gravita intorno, a partire da Carte nel vento, grazie al già comunicato ingresso in giuria di Silvia Comoglio, Stefano Guglielmin, Maria Grazia Insinga. Come da prassi consolidata, sono ex vincitori, nonché “Autori di Anterem”.
Questi tre poeti e critici si sono aggiunti a Giorgio Bonacini, Laura Caccia, Mara Cini, Ranieri Teti.
Flavio Ermini rimarrà presidente onorario dell’Associazione di promozione sociale Anterem, da cui tutto origina.
Nel cambiamento restano la continuità di intenti e l’idea di ricerca condivisa nella grande comunità cui “Anterem” ha dato vita.
La redazione
Autori di Anterem
Autori di Anterem
Christoph Wilhelm Aigner, Alain, Anne-Marie Albiach,Pierre Alferi, Rafael Argullol, Ingeborg Bachmann, Nanni Balestrini, Roland Barthes, Georges Bataille, Henry Bauchau, Thomas Bernhard, Maurice Blanchot, Yves Bonnefoy, Eugenio Borgna, Joë Bousquet, Iosif Brodskij, Edoardo Cacciatore, Nanni Cagnone, Alberto Cappi, Camillo Capolongo, Paul Celan, Iain Chambers, René Char, Velimir Chlebniov, E.M. Cioran, Danielle Collobert, Osvaldo Coluccino, Maria Corti, Corrado Costa, Fausto Curi, Marina Cvetaeva, Franz Josef Czernin, Milo De Angelis, Jacques Derrida, Louis-René des Forêts, Eugenio De Signoribus, Robert Desnos, Emily Dickinson, Gabriella Drudi, André du Bouchet, Franc Ducros, Jacques Dupin, Félix Duque,Paul Eluard, Antoine Emaz, Antoine Emaz, Andrea Emo, Claude Esteban, Gio Ferri, Benjamin Fondane, Antonis Fostieris, Michel Foucault, Katarina Frostenson, Pascal Gabellone, Umberto Galimberti, Aldo Giorgio Gargani, Rubina Giorgi, Alfredo Giuliani, Remy de Gourmont, Giuliano Gramigna, Dominique Grandmont, Cesare Greppi, Félix Guattari, Hubert Haddad, Vladimír Holan, Friedrich Hölderlin, Iolanda Insana, Philippe Jaccottet,’Abd al-Rahmân Jâmî, Vladimir Jankélévitch, Nuno Jùdice, Sarah Kirsch, Alfred Kolleritsch, Ursula Krechel, Philippe Lacoue-Labarthe, Roger Laporte, Cristine Lavant, Giacomo Leopardi, José Lezama Lima, Gabriela Llansol, Giancarlo Majorino, Henri Maldiney, Stéphane Mallarmé, Giuliano Manacorda, Osip Mandel’sˇtam, Friederike Mayröcker, Gian Giacomo Menon, Henri Michaux, Pierre Michon, Lorenzo Montano, Inge Müller, Roger Munier,Magdalo Mussio, Giampiero Neri, Giulia Niccolai, Paul Nizan, Bernard Noël, Oan Kyu, Cosimo Ortesta, Pierre Oster, Walter Friedrich Otto, Giuseppe Patella, Camillo Pennati, Mario Perniola, Alejandra Pizarnik, Antonio Pizzuto, Marcelin Pleynet, Antonio Porta, Catherine Pozzi, Pascal Quignard, Michele Ranchetti, Lou Reed, Luigi Reitani, Franco Rella, Pierre Reverdy, Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, Jacqueline Risset, Maurice Roche, Amelia Rosselli, Antonio Rossi, Jacques Roubaud, Gustave Roud, Pier Aldo Rovatti, Cesare Ruffato, Lucio Saffaro, Tiziano Salari, Roberto Sanesi, Edoardo Sanguineti, Cécile Sauvage, Giacinto Scelsi, Toti Scialoja, Rioko Sekiguchi, Angelus Silesius,Bernard Simeone, Adriano Spatola, Vasyl' Stus, Giorgio Taborelli, Arsenij Tarkovskij, Ferdinando Tartaglia, Jean Thibaudeau, Fëdor Tjutčev, Charles Tomlinson, Georg Trakl, Ida Travi, Birgitta Trotzig, Giuseppe Ungaretti, José Angel Valente, Paul Valéry, Bernard Vargaftig, Gianni Vattimo, Patrizia Vicinelli, Vincenzo Vitiello, Christa Wolf, Paul Wühr, Yang Lian, Yu Jan, Gino Zaccaria, Andrea Zanzotto, Elémire Zolla.
Collaborano alla Sesta Serie della Rivista
Stefano Agosti, Antonella Anedda, Claudia Azzola, Luigi Ballerini, Lorenzo Barani, Jean-Christophe Bailly, Sara Barni, Maria Angela Bedini, Mathieu Bénézet, Roberto Bissani, Ginevra Bompiani, Domenico Brancale, Nicole Brossard, François Bruzzo, Gio Batta Bucciol, Gabriella Caramore, Alfonso Cariolato, Mauro Caselli, Enrico Castelli Gattinara, Ivana Cenci, Anna Chiarloni, Sandro Ciurlia, Silvana Colonna, Adalberto Coltelluccio, Bruno Conte, Elena Corsino, Gianluca Cuozzo, Umberto Curi, Lyndon Davies, Carla de Bellis, Alessandro De Francesco, Roberto Diodato, Bianca Maria d’Ippolito, Massimo Donà, Michael Donhauser, Paolo Donini, Marco Dotti, Giovanni Duminuco, Chiara Elefante, Marco Ercolani, Ottavio Fatica, Federico Ferrari, Gio Ferri, Jean Flaminien, Massimiliano Finazzer Flory, Alberto Folin, Giorgio Franck, Lucetta Frisa, Madeleina Gagnon, Jacqies Garelli, Romano Gasparotti, Carlo Gentili, Alessandro Ghignoli, Gianluca Giachery, Enrico Giannetto, Giulio Giorello, Sergio Givone, Jean-Marie Gleize, Ronel Gonzalez Sanchez, Daniele Gorret, Evelyne Grossman, Giovanni Guanti, Stefano Guglielmin, Federico Guerri, Clemens-Carl Härle, Riccardo Held, Christian Hubin, Gilberto Isella, Marie-Thérèse Kerschbaumer, Giancarlo Lacchin, Marica Larocchi, Silvia Lavina, Federico Leoni, Nicola Licciardello, Carla Locatelli, Eugenio Lio, Gilberto Lonardi, Max Loreau, Carmen Lorenzetti, Gabriel Magaña Merlo, Dario Maggi, Claudio Magris, Mauro Maldonato, Daniela Marcheschi, Adriano Marchetti, Aldo Masullo, Susanna Mati, Camilla Miglio, Cesare Milanese, Andrea e Robert Moorhead, Giampiero Moretti, Bruno Moroncini, Hugo Mujica, Jean-Luc Nancy, Giulia Napoleone, Adele Netti, Federico Nicolao, Riccarda Novello, Claude Ollier, Margherita Orsino, Maria Pia Pagani, Feliciano Paoli, Amnna Chiara Peduzzi, Daniele Maria Pegorari, Giuseppe Pellegrino, Carlo Penco, Luigi Pestalozza, Antonio Pietropaoli, Antonio Prete, Rosella Prezzo, Fabio Pusterla, Andrea Raos, Caterina Resta, Franco Riccio, Alfredo Riponi, Jean Robaey, Cecilia Rofena, Sofia Demetrula Rosati, Alessio Rosoldi, Antonio Rossi, Claude Royet-Journoud, Enrica Salvaneschi, Andreas Sanesi, Lucio Saviani, Andrea Schellino, Fabio Scotto, Lucio Sessa, Carlo Sini, Nelio Sonego, Aldo Tagliaferri, Andrea Tagliapietra, Davide Tarizzo, Carlo Tatasciore, France Théoret, Francesco Tomatis, Aldo Trione, Edith Urban, Amelia Valtolina, Sandro Varagnolo, Federica Venier, Federico Vercellone
Editoriali 1995 - 2019
Sono qui raccolti gli editoriali - tutti a firma di Flavio Ermini - che hanno introdotto i vari numeri di "Anterem" nel corso degli ultimi anni. I titoli corrispondono alle questioni di volta in volta tematizzate sul periodico. L'ordine segue la cronologia della loro pubblicazione. Agli appassionati segnaliamo un volume che raccoglie gli editoriali che si estendono dal n. 51 del 1995 al n. 71 del 2005: è curato da Marco Ercolani ed è edito da Joker (2006). Il suo titolo è "Antiterra".
n. 51, = 0
«Anterem» dicembre 1995
… dal momento che il segno, in se stesso privo di significato, viene posto = 0, anche l’originario, ovvero il fondo nascosto di ogni cosa, può allora farsi presente.
Hölderlin
A ogni atto deliberativo, la parola offusca il paesaggio colonizzato per fare luce su quello che va fondando. Continua conferma nel testo dell’immanenza di un sapere del testo, la parola muove i suoi passi in zone liminari, in prossimità dello zero; dove si fa visibile l’oltranza, il luogo di caduta e di strapiombamento in cui la poesia può mostrarsi.
È propriamente una crepa quell’ambito a cui è rivolto il suo sguardo, quel mediante che la parola apre e chiude con un battito di ciglia.
La sua vitalità risiede in un nucleo estremamente mobile, principio dell’origine perduta o dell’assenza di origine. La sua natura profonda è intransitiva. I suoi risultati sono sempre il consolidamento di un’atopia. Per cui la relazione è differenza. La durezza, vibrazione. L’opacità, trasparenza.
Lo zero si configura come effetto di una cancellazione che lo precede. Stringendo con essa alleanza, la parola testimonia l’essenza della prima pronuncia: l’hybris che nel suo svanire splende. Mimesi del caos originario.
La parola destinata ad accogliere in sé, istituendole, alterità e identità non conosce sospensioni, serenità, riposo.
Seme e terra atta alla germinazione, in sé custodisce l’ombra che sta alle sue radici, impedendo alla costruzione poetica di configurarsi come una battaglia di suoni o di rifluire nell’amorfismo del dizionario.
Avida e madre, percorre le aule in cui l’intendere e il sentire non sono separati, e il vedere è anche vedersi. Aule di una Wildniss incessantemente esposta a una minaccia; erosa e al limite della sommersione. Sempre inscritta in una sitazione di emergenza. Straziata coscienza aurorale in cui la luce non sconfigge le tenebre, ma ne prosegue il cammino.
Flavio Ermini
n. 52, Uguale a zero
«Anterem» giugno 1996
Un segno noi siamo, privo di significato,
siamo senza dolore e abbiamo quasi
perduta la lingua nell’estraneo.
Hölderlin
Ah generazione dei mortali
uguale a zero
valuto la vostra vita.
Sofocle
Parole liminari, situate là dove visibile e invisibile si sfiorano, dove luogo e non luogo sono tangenti. Immagini atopiche, irriducibili a paesaggi e cose che già hanno un nome. Parole e immagini che non si esauriscono in prossimità dell’inscrutabile.
La poesia sta in quel muoversi per piccoli barbagli luminosi, nell’innervarsi sempre diverso di forme in cui resta aperta la ferita del sentire originario ed è avvertibile il soffio della prima pronuncia.
Il limite è propriamente un velo. E l’altrove non è ciò che il velo lascia illusoriamente intravedere, bensì il non detto che si manifesta sul suo rovescio; dove muovono al dialogo sequenze verbali generatrici di un senso non preesistente. Qui il non riconosciuto può incontrare la sua forma.
In questo luogo liminare, valutato uguale a zero, il linguaggio fonda la sua struttura inaugurale di separazione; e apre al poeta la facoltà di occupare una posizione parlante, che, esponendosi alla possibilità di una risposta, impone l’ascolto.
Indica Nietzsche: «Guarda questa porta carraia… Due sentieri convengono qui: nessuno li ha mai percorsi fino alla fine».
La scrittura è definita dall’azione simultanea di due movimenti di verso opposto. Entrambi rivolti all’alterità e abitati dai segni di un collasso verificatosi nell’ordine. Entrambi situati su margini da sempre soggetti a profonda instabilità e per questo lasciati in ombra dalla direzione teleologica della storia.
È precisamente questa mancanza di fondamento che produce il manifestarsi di un senso mai pienamente presente, ma che si dà come differimento continuo, traccia.
Flavio Ermini
n. 53, Ante Rem
«Anterem» dicembre1996
Dico: un fiore! e, tratto dall’oblio dove la mia voce ne confina una certa forma, come qualcosa di alieno ai calici consueti, musicalmente s’innalza, idea incarnata e soave, l’assente da tutti i mazzi.
Mallarmé
Quando nel discorso una lacerazione si apre, comunemente viene presto colmata con un’ideologia o rimossa da un delirio. Ma per un istante il poeta qualcosa ha pur scorto in quel varco schiuso sul disegno esauriente. Qualcosa ha pur colto tra la genesi e il compimento della forma. Da quel tumulto una rivelazione gli è stata largita.
Quando su quello squarcio luce e buio convergono in doppia luce, la materia oscura e primordiale che si forma è la parola. Una parola destinata a recuperare, nella costituzione di un senso che eccede la nominazione, la sua inaugurale possibilità di essere e dire. In essa gli opposti più non si escludono ma si richiamano. È la nostra ombra, con la quale siamo chiamati a coincidere. Ha il volto stesso dell’abisso ed è l’accesso al silenzio che tanto raramente viene consentito. Un silenzio destinato all’ascolto e alle voci, proprio come il deserto è destinato al movimento.
Già scena di un tragico destino, l’oscurità non cela più al suo interno il Minotauro, né, verso il cielo, l’uscita.
Dove si trovava soltanto il discorso insensato della pazzia o il rammarico per l’impensabilità della nozione teologica, è ancora possibile seguire l’inaugurale multiversum della parola promessa alla sapienza, ai valori delle cose a cui la poesia dà origine; in un conoscere ostinato e impietoso.
Condannato a non poter cantare altro che il furore dell’inconosciuto, il poeta oscilla tra i frammenti incessantemente dispiegati dal caos generativo, costruendo un transito possibile tra loro; ma senza cancellarne le differenze e cogliendone l’emergenza negli spessori profondi.
Dovrebbe essere ormai perspicuo: al poeta interessano quelle voci del limite che nella complementarità o nell’esclusione documentano le caratteristiche di terreni accidentati, irriducibili a ogni abitudine cognitiva ed esistenziale. Proprio in questi punti d’intersezione e mescolanza, in queste zone di confine, prima del bordo opaco delle cose, si concepiscono le forme.
Va promossa la scoperta di questo regno intermedio, con il quale il poeta intreccia il proprio sguardo e la propria voce; in un gesto che prevede un moto di sradicamento prima di quello di un avvento. È la sporgenza dell’essere sul pensiero che intende contenerlo.
La parola poetica è la mano che si appoggia su un oggetto e che non appartiene più totalmente al corpo da cui proviene. Si mostra nell’atto dell’allontanamento per manifestare un nuovo senso.
Flavio Ermini
n. 54, L’Aperto
«Anterem» giugno 1997
Dans la stupeur de l’air où s’ouvrent mes allèes …
Char
O quale e quanto in quella viva stella
pur vinse, quale e quanto si sospinse
oltre le soglie della sua stessa luce;
al di là del silenzio quale e quanto t’induce.
Zanzotto
Conviene decidersi una volta per tutte a vedere quello che si sta guardando. L’Aperto, connesso alla pronuncia della parola originaria, ante rem, come intenderlo nel pensiero e nelle poetiche della contemporaneità?
I poeti dicono ciò che eccede la pura designazione delle cose, chiamando in causa differenza e relazione, No e Sì. Annunciano il rivelarsi del senso là dove la protezione manca e nulla è trattenuto nella qualità e nel calcolo.
Un andare verso che Dante riprende, spingendo il suo Ulisse incontro all’abissale violenza del caos, dietro al sole, in un transito consentito da una parola non più collegata a un senso preesistente.
Non c’è fine al visibile e non è detto che quanto resta da vedere si celi necessariamente nell’invisibile.
Oggi il processo estetico non tende a un mitico altrove, posto al di là delle sue incisioni – le colonne d’Ercole – e le sue iscrizioni: hic sunt leones. Al contrario, avviene proprio praticando il limite quale non luogo dove si muovono le figure della precarietà, prima che vengano nascoste nella lontananza o perdute nella fissazione micrologica dell’adiacenza.
Attraversare la contemporaneità significa oltrepassare i limiti che ne costituiscono la frontiera interna. E accettare che qui, in prossimità del lontano, il riconosciuto possa incontrare la sua forma; chiamando in causa figure di un pensiero che riconosce al suo interno una duplicità costitutiva.
L’aperto si annuncia grazie a un tra, nella forma del congedo da un senso. Grazie a una siepe è visto, può essere pensato. E dischiude alla parola il precipizio della Wildniss, la massima vertigine dell’indifferenziato; spalancando sul significante quel passato ancestrale dell’antesenso, che dischiude la via da un ordine all’altro. Dove l’altro è il tutt’altro, irrelato e non sublimato; l’uno e l’altro insieme, in un evento che accade e ancora non ha nome.
Con l’apertura a un ospite inatteso, un nuovo senso viene fondato. Chiama in causa cielo e terra, con la mobilità dei loro orizzonti. Libero dall’origine e dalla fine, mette a tacere il detto e i suoi impianti categoriali. E ci pone direttamente a confronto con l’affermarsi di forme essenzialmente instabili e di aree sottratte alla chiarezza rassicurante della coscienza.
Cogliere la persistenza dell’Aperto nel pensiero contemporaneo, in quanto pensiero della sua crisi, significa accogliere le interrogazioni che la parola poetica non cessa di promuovere, impedendo al senso di cristallizzarsi.
La parola che chiama e aduna non è mai ciò che si pensa, ma ciò in cui e da cui si pensa. In questo permanere che è anche un andare verso, essa diviene ciò che è.
Flavio Ermini
n. 55, Metaxy
«Anterem» dicembre 1997
Parla anche tu
parla per ultimo,
dì la tua parola.
Parla –
ma non dividere il No dal Sì.
Dà alla tua parola anche il senso:
dalle l’ombra.
Celan
Ogni nuova enunciazione poetica impone di risalire al momento della decisione storica che ha provocato una cesura tra il No e il Sì; di mettere in tema quel punto inesteso in cui voce e silenzio si coappartenevano; di portare a parola quanto è stato costretto a tacere.
Il problema sembra essere questo: come può enunciarsi un linguaggio quando rifiuta di articolare il suo pensiero nella rete grammaticale della sola ragione? e come può imporre – dal silenzio – il suo gesto vocale?
Ci troviamo di fronte a domande radicali sulla questione del limite, sulla possibilità di pensarne entrambi i lati, sulla vocazione del dire a travalicarne i margini.
Ogni nuova enunciazione poetica si compie secondo regole che sospendono i contratti lessicali, sintattici, semantici precedenti. Ma indica nello stesso tempo che il taciuto non è l’altro dal discorso, ma l’altro del discorso. È ciò che mai ha cessato di circolare in esso e, fin dall’inizio, lo ha travagliato dal suo interno.
Impossibile quel sogno della ragione di potersi svincolare una volta per tutte da ciò che altera l’ordine del dire, dal dissimile che lo minaccia.
Dall’antro di Delfi all’Agorà: i messaggi suggeriti dalle foglie sparse dall’oracolo si disperdono, sostituiti dalle parole ordinate delle categorie. Ma la poesia non tralascia per il definito e il determinato, l’indefinito e l’indeterminato. Tiene sempre un rapporto vivo con il silenzio.
Correlativa alla mobilità del proprio orizzonte, sa di trovarsi lontana dalla conoscenza piena e di essersi incamminata lungo il sentiero proibito: «hinaus / in Unland und Unzeit», il non-paese e il non-tempo nominati da Celan.
Come tracciare una scrittura che intacchi ogni volta la linea di demarcazione tra il No e il Sì, e che ne alteri profondamente la presunta compattezza? Come produrre tagli e innesti nel corpo del testo, fino ad aprirlo all’altro che, sotterraneamente, racchiude in sé?
Ogni nuova enunciazione poetica lo documenta: va favorito un dire che in un doppio gesto separi e al tempo stesso unisca interno ed esterno, quel rimanere sulla soglia, in cui l’ascolto dell’essere si determina nella sua alterità. Va coltivato un pensiero che, sordo alle sirene del ritorno e della meta, disegni i margini della nostra epoca, tra quanto è stato pensato e quanto è rimasto inespresso.
Proprio verso questo impensato si muove il poeta, quale spettatore interessato, collocandosi sul limite stesso. E da questo mobilissimo tra, sempre sul punto di ridelinearsi, da «questa siepe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude», ne forza dall’interno il margine, ne rileva le fratture, ne mostra i varchi.
La scrittura, quale inscindibile coappartenenza di radice ed erranza, non si può trascendere. E qui sta l’impresa più rischiosa: va infranto il limite, e pure conservato. Poiché non ci si installa in un altrove della parola e del suo pensiero, che sia ancora parola e pensiero.
Non c’è metodo. Forse solo quel trattenersi tra le vie di una scrittura che costringe il senso a tracciarsi, senza la certezza che un risultato possa offrirsi, può consentire al poeta di spingersi fino all’unità arcaica in cui l’essere e il non-essere, sapere e non-sapere, Epistéme e Doxa convivono. Qui le cose sono e non sono in quanto divengono. Indicano che l’origine non è soltanto passato e che la scrittura accade disfacendosi.
Nominando il tra senza luogo che giace tra uno e molti, senza essere né l’uno né gli altri, e pure in qualche modo essendoli tutti, ogni nuova enunciazione poetica è estranea a una facile partizione di genere. Tra quanto era originariamente unito e indistinto mette in opera un avvicinamento che non è semplice riconciliazione. Propone un’esperienza cruciale del limite che porta all’incontro dell’Altro, in quel punto d’incontro dell’inizio e della fine, in cui prende forma la nozione di principio nella sua assoluta atemporalità.
Flavio Ermini
n. 56, L'Altro
«Anterem» giugno 1998
La poesia tende a un Altro, ha bisogno di questo Altro, ha bisogno di qualcuno a fronte. Lo cerca, riconosce di appartenergli.
Ogni cosa, ogni essere è per la poesia, che verso l’Altro si volge, una forma di questo Altro.
Celan
La poesia porta a parola il taciuto, superando la cesura tra Sì e No, ripristinando l’inaugurale coappartenenza tra voce e silenzio.
Sapendo di nascere sulla separazione, la poesia si pone sul luogo della nascita delle parole, sulla frontiera del prius, del prima di ciò che non ha prima, nominando il fiore che non esiste in alcun bouquet.
Ma permanere in colloquio a tu per tu con l’originario non è privo di conseguenze. Significa concepire il pensiero come passo che segna l’essere-in-cammino, il verso. Significa fare i conti con l’Altro, il sin qui taciuto, ovvero con l’antiparola, la lingua muta delle cose, le cui forme celate apostrofano qualcuno: colui che è in grado di strutturare un dire ricadente su se stesso, non rivolto a nessuno, interiore.
Un elemento alieno e perturbante si affaccia dall’altra parte della lingua a minacciare l’integrità del poema, si introduce sul suo cammino, gli impone di continuare a essere interrogazione, a parlare dell’Altro senza ridurlo al medesimo, in un dire «altrimenti».
Celan ci parla di un soggetto poetico che agisce «sotto l’angolo d’incidenza della propria esistenza» e pone interrogativi all’ora presente: alla propria e a quella del mondo. Un interrogare che riguarda una singolarità originaria, antecedente alla distinzione tra universale e individuale. E consente che abbia voce ciò che all’Altro è più proprio: il suo tempo. Risultato di un intreccio di forze, pensieri, idee, problemi, progetti diversi e spesso tra loro in conflitto. E di cui oggi lo spazio metropolitano, nella definizione di passaggi e limiti tra parola e antiparola, è un emblema.
Perché e come l’Altro? Perché e come accade che ci si interroghi su di esso? L’Altro: è uno dei problemi tra i tanti o ha un posto preminente?
C’è un lavoro tutto da fare, solo parzialmente e settorialmente affrontato nel Novecento: va tentata una fissione capace di portare alle estreme conseguenze la poetica di Mallarmé, un passo oltre l’arte, un passo oltre la storia. Compiendo un ulteriore atto di libertà dopo le peripezie delle avanguardie.
Tante opere lo hanno indicato: vanno adunati su entrambi i lati del Metaxy´ il silenzio da cui la voce era stata separata e la voce a cui era stato sottratto il silenzio. Questa esperienza è designata dallo spazio dell’interrogazione, dove a interrogare non è il poeta, ma l’Altro che lo ha sorpreso nel dialogo dell’interrogazione in atto su di sé e con sé.
È così che accade: il poeta è chiamato a incidere il respiro nella parola scritta, a seguire il respiro in cui la sua parola nasce e nascendo non è più sua, come egli non è più io, ma l’Altro. L’Altro: quell’io nascosto nell’io che la coscienza nasconde, perché gli nega l’ombra necessaria a dire il vero. L’Altro: quell’eccesso infinito delverbo che rompe i legami della ragione e minaccia il suo esercizio di potere.
Il poeta non può che avanzare nella parola perduta-ritrovata dal giro di respiro che la spezza.
La questione, dunque, non si pone più esclusivamente tra silenzio e voce, ma tra il No e il suo Altro, tra il Sì e il suo Altro. È questa la pratica di scrittura a cui il poeta pensa quando dice che va aperto il testo all’ombra che lo attraversa.
Flavio Ermini
n. 57, Epoché
«Anterem» dicembre 1998
Dice lo straniero nel deserto: «Ogni cosa al mondo mi è nuova». E la nascita del suo canto non gli era meno straniera.
Saint-John Perse
Quella strada non preceduta da alcuna verità che le prescriva la sua esattezza – è la strada del deserto.
Derrida
L’Epoché. Vero e proprio esercizio del silenzio, questa figura del limite conduce dall’ascolto all’ascolto pensante, dove pensare non è più avere e richiede una sospensione, o forse l’annientamento, di ogni abitualità di senso. Tanto da condurre a un vedere che non è più virtù della vista e a un costruire in cui le cose si danno nella loro complessità. Un modo che vuole essere un leggero circondare – come salvaguardare, come custodire –, non un possedere o un rinchiudere nel concetto. Un esercizio che lascia coincidere l’oggetto della ricerca con il cercare, in libere sequenze, senza traguardi successivi, con le sorprese e le quasi ovvietà di ogni esperienza di pensiero le cui peripezie non sono l’accidente, ma la caratteristica principale.
Nel suo guardare che è essere guardata, la parola poetica incontra se stessa nelle sembianze di uno straniero. Si prepara alla produzione di senso. La questione è: come può trasformarsi nell’Altro che è, conservando le reciproche ragioni costitutive?
La domanda si fa ancora più radicale con l’emergenza di ciò che all’Altro è più proprio: il suo tempo, di cui lo spazio metropolitano, nella definizione di passaggi e limiti tra discorso e antidiscorso, è un emblema.
Le strade che portano all’incontro con l’Altro costituiscono il luogo esemplare dell’intreccio tra la parola poetica – impegnata a fondo nel confronto col fantasma delle proprie origini – e la realtà della propria trasformazione.
Il movimento dell’alterità verso la parola, quando è provocato dall’Epoché, domanda un discorso altro da se stesso, dove la parola precipita e si addensa in nuove interrogazioni; e si riabitua all’ombra, il cui senso diviene la scienza stessa della ricerca poetica.
È qui in gioco la questione radicale che il linguaggio incessantemente pone nel suo passo verso il dire inaugurale.
La parola poetica non parla che del silenzio del mondo; quel silenzio che custodisce l’elemento tettonico a cui l’edificio linguistico e le torri dell’uomo possono solo alludere... Chiede di accogliere come autentico ciò che è instabile; di allentare il troppo, aprire interstizi, creare zone di nulla e di vuoto, fino all’erosione di ogni fondamento… Impone una dislocazione del pensiero rispetto alle sue pretese, consentendo così al gesto vocale e al fenomeno metropolitano di manifestarsi nella loro evidenza, di darsi senza essere traditi. Favorendo la crescita di un’esperienza che sia solo esilio e non anche rimpianto o nominazione di una perdita.
Grazie alla parola poetica, lo spazio metropolitano diviene l’immagine del pensiero contemporaneo e della sua mancanza di ogni fondamento trascendente.
Delimitato da molti margini, mai omogeneo, mai perfettamente chiudibile, in questo spazio ciò che parla non è l’abitare, ma la sua crisi, seguita dall’incapacità di distinguere tra il vuoto e la sua apparenza. Qui l’immagine del mondo non è più data dall’esperienza del mondo, ma dall’appartenersi reciproco e originario del costruire e dell’abitare. Qui nemmeno il tempo conosce altra segnalazione se non quella offerta dalla successione dei passaggi dalla luce del giorno alle tenebre.
Il proliferare di immagini vuote, di superficializzazioni e appiattimento funzionale maschera e rescinde la natura; tronca la possibilità di riconoscere il destino e individuare il luogo, per diventare pura spazialità inerte: deserto progressivo e inarrestabile.
L’Epoché ci conduce a riconoscere nel deserto il senso ultimo del fenomeno metropolitano e della sua alterità.
Nell’orizzonte di un pensiero che riconosce il deserto come spazio che gli è proprio e forma del destino, la parola poetica sta in una dimensione cruciale e interstiziale. In un movimento vicino allo zero, rinuncia ad appigli e certezze, per guadagnare la superficie svuotante e annichilente della perdita di ogni differenza e divisione.
Alla forma del deserto corrisponde uno svanimento della sostanzialità delle cose, un infittirsi della caduta, un venir meno... che per la poesia è un terreno inesauribile e fecondo, un suolo enigmatico dove la parola può avventurarsi con passi ricercanti.
Flavio Ermini
n. 58, Eterotopie
«Anterem» giugno 1999
... un moto molteplice, incerto, confuso, irregolare, disordinato, un ondeggiamento vago ... la varietà, l’incertezza, il non vedere tutto, il potersi perciò spaziare con l’immaginazione riguardo a ciò che non si vede.
Leopardi
… irregolarità, avvicendamenti. Precipitazioni, intermittenze, collisioni di cose ed eventi, punti di silenzio abissali; rotaie …
Musil
L’eterotopia ha il potere di giustapporre, in un unico luogo reale, diversi spazi, diversi luoghi che sono tra loro incompatibili.
Foucault
... un linguaggio senza discorso, una parola senza frase, senza sintassi, né parti, né grammatica, una lingua di pura effusione, al di là del grido, ma al di qua della fenditura che articola e al tempo disarticola l’unità immediata del senso, nella quale l’essere del soggetto non si distingue né dal suo atto né dai suoi attributi.
Derrida
Dopo il Novecento. Dopo la sospensione del senso e in assenza di significazione, come parlare? Come prendere la parola per dire il dopo del silenzio e ciò che era prima del dopo in cui siamo?
Decisiva è forse l’alleanza tra poetare e pensare, tra parola poetica e parola filosofica. Nella complessa relazione che si istituisce, ognuno dei due termini è sospinto al limite del proprio senso, in zone per le quali non esistono ancora nomi adeguati. Esattamente là dove nella contemporaneità si schiude lo spazio del silenzio.
Parlare di quest’ora senza nome significa sfidare la lingua a divenire la lingua del dopo. A pronunciare il silenzio come tale. Consentendo alle parole di farsi puro significante del disastro del senso. E di crearsi un varco dentro il nucleo del più profondo ammutolire: non il senso che dia senso al niente, ma il significante che significhi il niente come tale.
È la lingua del poema: dell’adesso, dell’incessante rotazione meccanica che caratterizza il presente.
Descrivendo lo sviluppo crescente dei dispositivi automatici, già Musil poteva parlare del nostro tempo come di una civiltà nella quale esistono esperienze senza colui che le vive, ed esistono parole senza che ne sia stata elaborata l’emozione. È come se a nostra disposizione fosse rimasto l’uso della parola, ma ne avessimo perduto al tempo stesso l’altra metà, la sua sensazione interna.
Eppure sono ancora lì le categorie di percezione dell’essere ed è lì, dall’altra parte della lingua, che va cercato il nostro destino. Con essa dobbiamo fare i conti, per capire il vuoto del nostro tempo, dove lo stesso io è un momentaneo mosaico di pulsioni, stati d’animo, sentimenti discontinui; un’aggregazione continuamente scomposta.
Un «ondeggiamento vago», un tra che, nella forma del congedo da un senso, consente di portare a parola e pensare l’alterità, ciò che non si dà direttamente a vedere. Così lo spazio metropolitano chiama alla responsabilità del pensiero. Percepito e raggiunto mediante la lingua, dalla lingua ricava forma e verità.
La parte centrale del poema non può essere, quindi, che una cosmogonia, il farsi del mondo; così come l’eterotopia rende visibile qualcosa tra le cose presenti: fa apparire le opposte rive, riunisce la terra intorno a sé, concilia terra e cielo.
Ma abitare il rapporto tra dire poetico e alterità è consentito solo da un ulteriore passo, che conduca a «stare» in entrambi i movimenti, salvaguardando quello conoscitivo dalla parola verso l’Altro e quello etico dall’alterità verso la parola.
Va radicalizzata l’esperienza di questo modo particolare di “abitare”, in un moto che ha come effetto il trascorrere da un vedere abituale a un altro modo di vedere. Uno scarto che non equivale a una variazione, a una deviazione di percorso, ma che esige un altro inizio.
Si attua così la possibilità per la parola di liberare la zona non effabile in cui interrogarsi come «enigma». Tale esperienza comporta il passaggio più pericoloso: attraversare l’estremo ammutolire, il vuoto a cui la lingua ancora non ha dato parola, e di fronte al quale è essa stessa ammutolita.
L’atto della scrittura sarà allora il poema dell’erranza del senso.
Cogliere e vivere come essenziale il nascondimento – l’erranza che non perviene a una localizzazione che la determini e la definisca – non ci mette in ascolto di un’altra voce, ma ci dispone a un altro ascolto delle stesse voci, delle stesse parole.
In questa Verwindung ciò che finalmente si perde è la possibilità che il senso della parola venga rinviato a un regime di senso.
n. 59, Endiadi
«Anterem» dicembre 1999
Non intendono come da sé discordando con sé concordi.
Eraclito
Due, sì, sono in due.
Sembra perfettamente naturale ora –
Plath
E credi tu che uno ..., sano di mente o pazzo che sia, abbia
il coraggio di dire sul serio a se stesso, con l’intenzione
di persuadersene, che necessariamente ... il due è uno?
Teeteto
Endiadi, hén diá dyóin, uno per mezzo di due: non una generica ambiguità, ma l’«endiadi», la vera e propria irriducibile compresenza del due-in-uno.
S’impone, con questa figura della duplicità, la controversa questione sul senso che nel testo si articola quando nella parola viene ripristinata l’inaugurale coappartenenza tra voce e silenzio, mantenendo ferma la differenza che il mondo, costituendosi in categorie, sopprime. Ciò che gli uomini non intendono, ci dice Eraclito, è il coincidere degli opposti. Per loro ciò che diverge non può nel medesimo tempo convergere. In realtà, la parola poetica concorda con se stessa proprio mentre da se stessa discorda. E ce lo dimostra conducendoci proprio dove i contrari sono complementari e gli opposti si richiamano. Dove l’uno contiene in sé anche il suo contrario ed è un’endiadi.
Portarsi all’origine di questa lacerazione significa esattamente cogliere la coscienza umana al suo sorgere, il formarsi dell’essere come custode della differenza. Fino a riconoscere l’Altro da sé e mantenerlo nella sua alterità, ottenendo dall’opposizione un accordo.
Ma com’è pensabile l’armonia dei differenti? e, insieme, il doppio sguardo che implica il loro confinare?
Oggi la poesia è assenso all’essere attraversato dal silenzio. E proprio di quel silenzio – in cammino verso il senso – costituisce una rivelazione.
La sua avventura si svolge tra gli estremi di un pendolo, la cui aporeticità è data dal richiamo dell’uno all’altro, suo volto speculare, confine di un dualismo costitutivo e massima distanza. Per questo implica un rispondere e un corrispondere: chi ascolta è chiamato.
La ricerca che incrocia l’arco vario e mutevole di tanti saperi, riunendo ciò che pare essenziale alla questione letteraria, indica nell’alleanza tra parola poetica e parola cognitiva una strada percorribile per la nostra esperienza di pensiero.
Ma ulteriori e decisivi spostamenti vanno compiuti. Utili per introdurci in una tonalità poetica complessa e rischiosa. In una pratica della scrittura di cui non è agevole immaginare i contorni e gli esiti. In rapporto all’Altro, ma soprattutto rispetto al silenzio da cui l’Altro proviene.
Il doppio sguardo a cui ci induce l’originaria e ineliminabile duplicità della parola impone uno scrivere altrimenti che della parola sconvolga i margini, alteri i limiti e mostri le irrisolte contraddizioni. Uno scrivere che si volga alla produzione di segni di nascondimento, dove la parola produca i termini del silenzio da cui trae origine.
Il cammino di pensiero che cerca di esporsi da se stesso sull’orlo dell’enigmaticità, e di corrispondere all’evento della risposta come evento sempre originario, è ancora lungo. Ma cominciamo intanto a prendere distanza da una fisica del puro sentire e del mero pensare. Nella consapevolezza che non vada confusa la kantiana «assenza di finalità» della letteratura con l’assenza di «responsabilità». Responsabilità che va cercata nell’altrimenti di una scrittura che non proceda pietrificando le cose nei concetti e nelle idee. E che si faccia carico di un compito non più solo estetico, ma anche etico. Che concepisca la «duplicità» – quell’inaugurale convertibilità di presenza e assenza, essere e nulla, bene e male, che è la libertà – senza la sopraffazione di un potere. Ed elabori un pensiero che oltre il potere sia pensabile, e sia rivolto alla verità dell’uomo, del suo essere al mondo, del mondo stesso.
Flavio Ermini
n. 60, Nomothetes
«Anterem» giugno 2000
Nel linguaggio non cerchiamo nulla, piuttosto costruiamo qualcosa.
Wittgenstein
La scrittura è inseparabile dal divenire: scrivendo si diventa nutrice, si diventa animale o vegetale, si diventa molecola.
Deleuze
Ognuno dei passi che il poeta arrischia porta al vivo e originario soggiornare presso le cose, a cogliere la tonalità fondamentale della loro voce, a nominarla.
Con ognuno di quei passi il poeta prende congedo dalle grammatiche dell’ascolto conosciute e accede alla lingua che crea, alla sapienza antica dei Nomothetes, i quali, dando i nomi a luoghi e cose, diedero vita al mutevole e vario orizzonte del mondo.
I nomi sono la decisione intransitiva, l’iniziativa inaugurale che stringe insieme i tratti più disparati degli eventi. E il poeta, come il legislatore dell’età più antica della lingua, con i nomi rende accessibile lo spettacolo a cui senza consapevolezza partecipiamo. Moderno nomoteta, si espone al principio della necessità che lo ha fatto pensare. Per effetto di un gesto interiore testimonia che il problema dell’origine della parola è una questione capitale: concerne la provenienza della sua essenza.
Prima dell’espressione c’è il nulla. Solo la parola proverà che vi si doveva trovare qualcosa piuttosto che niente. Scrivere è un’attesa e insieme un approssimarsi verso l’aperto, in cui la presenza è costretta a muoversi sul terreno dell’assenza, a lasciarsi disvelare dal suo stesso sottrarsi. Ma poi cercare un verso vuol dire, sì, scoprire o riscoprire un accento nuovo nel gioco smisurato della letteratura, ma significa soprattutto «pensare».
Ma c’è qualcosa da aggiungere e riguarda il vero: un termine primitivo che indica propriamente il riconoscimento di un pensiero nell’incontro con la sua necessità.
Il poeta esperisce il vero nel momento in cui scopre che quanto dice e fa corrisponde alla necessità di dirlo e farlo, producendo nel pensiero un’effettiva modificazione.
Nel convertire in parola ciò che normalmente resta rinchiuso nella vita separata da ogni conoscenza, il poeta indica che non esiste solo una ragione immanente al discorso e fondata sulla non-contraddizione. Segnala un altro sistema di pensiero, preesistente al senso comune e al moto intenzionante della comunicazione; un pensiero fondato su un sentire dove i contrari sono complementari e gli opposti si richiamano, e su un gesto vocale dov’è custodita la differenza che il mondo, costituendosi in categorie, sopprime.
C’è in Platone piena consapevolezza di questo passaggio in una esplicita dichiarazione: «Sembra che finora ciascuno ci abbia narrato una specie di favola, quasi fossimo bimbi».
Quella “specie di favola” consentiva tuttavia di far dire alla parola più di quel che essa intendesse dire, aprendo la strada al possibile, a ciò che poteva esistere. Le faceva dire «quel dir-più che è l’esatta verità del dire» (Nancy).
Di nuovo, oggi, la parola poetica tende a istituire una strana parentela «tra ciò che per lungo tempo fu temuto come grido e ciò che per lungo tempo fu atteso come canto» (Foucault). Fa segno a un codice non preesistente. Con maggiore esattezza: fa segno all’unità pre-riflessiva, pre-concettuale che si espone al mondo prima del pensiero cosciente e razionale.
In questo senso la parola enuncia un principio poetico a noi anteriore, manifestandoci che la condizione della nostra capacità di parlare non sta nell’esigenza di comunicare, ma nell’ascolto dell’appello che il linguaggio ci rivolge. In altro senso, è come se il testo poetico dicesse: «Andate a vedere voi stessi, se non volete credermi», esattamente come leggiamo in conclusione del sesto canto di Maldoror, a dimostrazione che la poesia è e poi anche non è “una specie di favola”».
La parola ci chiama e ci interroga dal silenzio che essa stessa incarna e che alla fine costituisce il destino nel quale scopriamo di essere coinvolti.
In un passaggio che attraversa e travalica il vissuto e il vivibile, fa nascere in noi una terza persona che ci spoglia del potere di dire Io e ci induce ad affrontare un volto sconosciuto.
La parola poetica, scrive Gargani, «sorprende noi stessi e ci insegna qual è il nostro pensiero». È dunque in qualche modo l’atto di coraggio e di rischio che ci consente di accedere al vero, che è al tempo stesso il piacere del pensare e l’emozione della libertà.
Flavio Ermini
n. 61, Poros e Penìa
«Anterem» dicembre 2000
dove i corpi si mischiano, dove
si articolano e si parlano
imparano a parlare
toccandosi con le due mani
Faye
La mano porge e riceve, e non soltanto le cose, porge anche se stessa e se stessa riceve nell’altra mano.
Heidegger
È come un gioco con qualcosa che si sottrae, e un gioco assolutamente senza progetto né piano, non con ciò che può diventare nostro e identificarsi con noi, ma con qualcosa d’altro, sempre altro, sempre inaccessibile, sempre a venire. La carezza è l’attesa di questo avvenire puro, senza contenuto.
Levinas
Eros
In principio l’essere umano era l’uno e l’altro. «Noi fummo interi» dice Platone «e il desiderio dell’antica unità così come la sua ricerca ha per nome Eros».
Come ci viene presentato da Diotima nel Convito, quale daimon nato dall’unione tra Penía e Poros, Eros è mancanza, bisogno, insufficienza e nel medesimo tempo via, passo per accedere a ciò che non si possiede. È forza perpetuamente insoddisfatta e inquieta che occupa «il posto intermedio tra l’uno e l’altro estremo».
Corpo
Frontiera fisica che tiene fuori di sé l’altro, il corpo si configura come limite di pensabilità di tutti i sensi. È nella sintonia dell’incontro erotico che s’instaura un rapporto in cui il corpo si trasforma in transito dall’uno all’altro. In questo esodo è pensabile anche il movimento che porta verso l’altra parte di noi stessi, alla terra incognita (l’inexplicablemallarmeano) da cui un giorno ci siamo emancipati. Accade quando i corpi «si parlano» e la parola, destinandosi a un altro, impara la disciplina dell’ascolto.
Promesso a una forma, Eros è custodito «dove i corpi si mischiano», nella zona di confine tra il pensiero razionale che l’essere umano ha nel tempo articolato e la follia che in esso non ha mai cessato di tracciarsi. È il mediante che dalla scena porta all’impensato del linguaggio, dove la parola non è ancora asserzione, ma coappartenenza di presenza e assenza. Dove, precisa Umberto Galimberti, «i termini subiscono quello s-terminio che offre lo spettacolo dell’o-sceno». Pulsioni e desideri, sconvolgendo come significanti incontrollati le ordinate gerarchie dei significati, liberano ulteriorità di senso.
Parola
Non si dà parola se non liberando l’originaria follia. E ogni nuova parola è l’allarme percettivo del contenuto preverbale; fa segno dall’interno del dicibile all’unità preriflessiva e preconcettuale che ha preceduto il pensiero cosciente e razionale.
Se non fossimo stati scoperti dall’ombra che agiva in noi, quale parola senza soggetto parlante, non avremmo mai potuto inventare nulla. Come scrive Wallace Stevens: «La poesia deve resistere alla ragione con successo quasi completo».
Alla parola senza linguaggio si può accedere dunque non con le parole ordinate dell’Io, ma con il collasso dell’Io, infrangendo il divieto che esso pone all’irrompere incontrollato dell’Eros.
È l’incontro degli opposti insieme alla lacerazione che lo precede a venire in primo piano: una duplicità senza opposizione, che pur legando non sopprime i differenti e li lascia essere in pace. Come se l’accadimento avesse in serbo un pensiero che, là dove tutto manca, è ancora un ricordo o già un’attesa. È proprio nell’immagine di questa piega – propriamente una carezza – che il tra dell’Eros va pensato.
Carezza
Nella carezza, l’intenzione affidata alla mano – che «porge anche se stessa» – offre il dono di sé e sfugge a ogni controllo. Ogni carezza, quella spaziatura tra il desiderio e il compimento, diventa un enigma sia per chi la dà sia per chi la riceve. Il senso che abita la mano è sempre compromesso dal senso che scaturisce dal corpo dell’altro. Quel corpo che non si ha mai la sensazione di possedere anche quando lo si avvinghia.
È del vuoto che ci si innamora e non del pieno. Per questo il linguaggio dei poeti, che hanno sempre a che fare con l’inizialità del dire, sembra rubato al linguaggio degli amanti. Per questo la parola, come l’Eros, mette in gioco l’esposizione all’altro, l’esposizione a qualcosa che intende sottrarsi alle prospettive del senso finale.
Via di trasformazione e passaggio a un nuovo percorso interiore, Eros conduce a un sapere accessibile a chiunque non pretenda di dominare il pensiero, ma intenda lasciarlo avvenire e pensare. Indica precisamente l’impossibilità di un calcolo e di una padronanza.
Eros e parola
Nell’iscrizione della lingua poetica al tempo che precede la lingua, si fa più stretta la rispondenza tra il dire del poeta e la natura di Eros. Consentendo l’irriducibile compresenza del due-in-uno, Eros e parola rivelano l’essere umano nel suo statuto di intrinseca e originaria duplicità, nella sua impossibilità di essere soltanto uno.
E così, per la sua capacità di pensare e dire se stessa come altro, la parola poetica ci interpella da una profonda relazione tra i sensi e la lingua, tra il movimento del corpo e il verso, tra il brusio mentale e l’ordine visibile sulla carta.
Il suo senso non è accessibile se non con un pensiero confusivo, capace di mettere assieme gli opposti, tanto da corrispondere al silenzio quando si destina al nome: momento di esperienza , etico, prima che conoscitivo.
L’inexplicable che Poros e Penía dispiegano è già la nostra instabile e provvisoria dimora. Dietro di sé non ha il verbum divino, ma l’ingenssylva dello stato demonico arcaico. Lo ricorda Gabriella Drudi: «Noi non siamo soli al mondo – e gli animali che ci portiamo dentro possono sempre divorarci o leccarci la mano».
Flavio Ermini
n. 62, Grados
«Anterem» giugno 2001
Dài loro annunzio duplice:
di te e di te,
dei due piatti della bilancia,
del buio, che chiede di entrare,
del buio, che consente di entrare.
Celan
Un passo ancora: per guadagnare quel terreno originario del pensiero che consenta un più radicale domandare. Al fine di accedere a una poetica prima della poetica, prima cioè del suo irrigidirsi nelle forme tipiche delle sistemazioni dottrinarie. Dunque una poetica finalmente in armonia con il luogo del soggiornare che le è proprio: la radura aperta al dire essenziale che accade nella poesia.
Grados: in quanto «passo» e insieme propria «misura», questa figura molto particolare della duplicità mostra come la poesia pensi e si pensi. Come il pensiero che parla dalla poesia non abbia dimenticato di essere originariamente poesia e torni così a sospendere con essa ogni frontalità. E come vi sia nel pensiero, secondo Derrida, «un far accadere ciò che ancora non è: l’irrompere di un evento che interrompe uno scambio. È questo pensiero che è all’opera nell’arte». Ed è in virtù di questo pensiero che il testo può proporsi come conoscenza senza mediazioni del mutevole orizzonte del mondo al suo rivelarsi, oltre che come esperienza del linguaggio e del suo respiro.
Un «passo»: ma verso cosa? Verso il respiro dell’essere. Nella direzione di un’esposizione e un ascolto che conducano a produrre il senso di evento, in opposizione al senso disponibile.
E in quale «misura»? Secondo il progetto di pensare il divenire puro, il movimento assoluto, sciolto da ogni quiete.
Ecco ciò che il poema impone all’essere umano: il coraggio etico ed estetico insieme di offrire al pensiero quel gesto inaugurale che s’inscrive nel presente della creazione e conduce dal caos al senso. In un dire che richiede un esilio e un cogliere che è un attenuarsi della luce: restare sulla terra senza sprofondarvisi, alzare gli occhi al cielo senza lasciarsi abbagliare. Tanto da consentire a Zanzotto di annunciare: «La poesia allora avvenga come avvengono, prima di una colpa o di un merito, le nascite».
Andiamo verso qualcuno o verso qualcosa. Prendendo congedo dal nostro io. L’essere umano cerca con costanza la separazione dalla sua unità. Per destinarsi a un Altro e prestargli ascolto. Per tenerlo con sé o respingerlo. Senza questo movimento intenzionale tutto sembra cristallizzare.
Eppure lo stato di solitudine che ci domina appare invalicabile; è un limite che non riusciamo a lasciarci alle spalle: specchio della nostra finitezza e insieme varco abissale su cui affacciarsi.
L’estinzione della solitudine può avvenire solo con l’estinzione dell’essere. «Lascia solo la notte parlare avanti agli occhi» statuisce Celan.
Se il risultato ultimo è l’attenuarsi della luce fino all’esilio dal mondo, scrivere significa darsi all’oggetto per eccellenza: il nulla. E il poeta è tanto più vicino alla realizzazione del senso dell’esistenza, considerata come apparizione e sparizione nel tempo, quanto più riesce a dare conto della profonda inquietudine che accompagna questa certezza: l’uomo, in qualsiasi direzione si muova, non è che il modellatore del suo nulla finale.
Cifre si uniscono a cifre, fino a formare la somma delle nostre esperienze. Ma il risultato conclusivo è uguale a zero. O comunque qualcosa che niente avrà in comune con ciò che siamo vivendo.
Il nulla ci appartiene nel senso in cui diciamo, per esempio: la vita mi appartiene. Asserzione che consente di aggiungere: questa appartenenza del mio essere a me stesso è tutta la coscienza che ho di me.
«Ogni risultato, ogni passo avanti nella conoscenza è il prodotto del coraggio, della durezza con se stessi» scrive Nietzsche. Aggiunge Wittgenstein: «Chi non vuole discendere in se stesso perché è troppo doloroso, costui rimane naturalmente alla superficie nello scrivere».
L’opera poetica deve innalzarsi per realizzare il proprio «= 0». E impone al poeta di restare fedele a un paradosso: compiere una conquista entro un interminabile cadere.
Noi siamo sempre in una posizione di dialogo e spingiamo i nostri passi in sfere molto lontane, anche in quelle che ci possono impaurire. «Io sono le mie scelte» annuncia Sartre.
Flavio Ermini
n. 63, La poesia pensa
«Anterem» dicembre 2001
Le poème – cette hésitation prolongée entre le son et le sens.
Valéry
La ricerca letteraria si muove tra conoscenza intuitiva e conoscenza concettuale, in un movimento che infrange la differenza dei codici; torna a sospendere la frontalità tra poesia e pensiero; provoca a pensare altrimenti.
La ricerca letteraria – intesa come atto conoscitivo senza possesso – impone al poeta di esporsi alla necessità che lo ha fatto pensare; di affidarsi a nomi declinati come elementi naturali, anteriori alle distinzioni fra soggettivo e oggettivo; di aprirsi un varco verso ciò che resta di impensato.
Filosofi e scienziati percepiscono che il linguaggio tradizionale è incapace di raggiungere certi fenomeni della vita, non visibili e dunque inaccessibili in modo diretto (e a cui dunque partecipiamo senza consapevolezza): sono realtà che, non nominate, si sottraggono, si trascinano via, per rispecchiarsi nel silenzio, con il quale il linguaggio della poesia si trova invece in stretta comunicazione.
Ci domandiamo: è ancora praticabile un respiro poetico che viva unito alla filosofia e alla scienza in virtù della necessità e, come chiede Zambrano, «in un’unità tanto intima e autentica da risultare invisibile»? È ancora configurabile un nesso tanto preciso tra sentire, parola e pensiero da cogliere in tutta la sua forza la lacerazione tra l’uomo e il mondo?
La possibile definizione di essere pensante è questa: un essere che non si lascia pensare da un altro essere o da una macchina. E la poesia? La possibile definizione di una poesia pensante è questa: una poesia che non si lascia pensare da un’altra istanza.
Chi lo può negare? Il pensiero della poesia non è più il pensiero della filosofia, dell’estetica, della critica letteraria, ma un pensiero che parte dall’opera stessa. Non solo. Il pensiero che parla dalla poesia è un pensiero che non può aver dimenticato di essere originariamente poesia.
Va rimessa in circolazione l’idea di una poesia che si costituisca nei confronti delle cose come esposizione e ascolto senza mediazioni. E questo perché la parola non abbandoni totalmente l’inquietudine dell’enigma per la quiete della ragione.
Per la parola poetica non si tratta di afferrare le cose, come vorrebbe la ragione, ma di incontrarle. Nominando la cosa, la poesia le assegna il suo destino così come lo assegna a se stessa.
Poesia non è la messa in scena di una realtà preesistente, esterna all’invenzione linguistica. Poesia è nuovo evento.
Per questo il poeta da una parte custodisce il valore della parola, lasciando intatto il suo legame con il silenzio. E dall’altra favorisce le transizioni fra codici differenti (scientifico, politico, religioso, etico, musicale, filosofico...) allo scopo di stabilire una nuova relazione con la passione della verità.
A questo proposito, la poesia va dunque pensata non come un rapporto sulle sensazioni, ma come l’organizzatrice diretta delle stesse. Come insegna Guy Debord, «si tratta di produrre noi stessi».
E allora non si può che essere d’accordo con Benn quando scrive: «Se da una composizione in versi estraete ciò che è legato allo stato d’animo, quello che resta, ecco, questo è forse una poesia».
Con tutto questo, non si tratta di assegnare un ruolo eminente e primario alla figura del poeta. Solo di stabilirne la specificità.
Su ciò che ancora non si sa, come su ciò che non è più logico, l’uomo suole imprimere una forma e un nuovo linguaggio, per dominarlo. Pretende di gettare una luce completa sulla sua esistenza e sulla realtà. In questo modo vede bene ciò che ha, ma non ciò che è.
Ma il linguaggio non è solo una rigida struttura logicizzante, padroneggiata dagli utenti. Contro questo linguaggio la parola poetica è insorta allo scopo di non annullare una parte consistente dell’essere al mondo.
Il nostro punto di vista su ciò che esiste non è indipendente dal modo in cui ne veniamo a conoscenza. Cioè non prescinde dalla nominazione. Dunque non è indipendente dalla parola poetica.
A questo punto non risulta più azzardata l’ipotesi sostenuta da Wittgenstein: «La filosofia si dovrebbe comporre poeticamente».
Flavio Ermini
n. 64, Antipensiero
«Anterem» giugno 2002
Ora entriamo nella penetrazione,
nel rovescio pungente
di ciò che infinitamente si divide
…
nel rovescio della pupilla,
nell’estremità terminale della materia
o nel suo unico inizio.
Valente
Il volto accettabile dell’uomo comincia dove il suo volto pubblico va in polvere. Da questa progressione scaturisce uno sguardo nuovo, costretto a misurare da capo distanze, prospettive, spazi.
Martini
Il pensiero che chiama dalla poesia è il pensiero che nasce nell’opera stessa. In quanto originariamente poesia, inizia sempre nei dintorni di un senso che non ha l’equivalente. In quanto atto senza delimitazioni, impone itinerari sempre nuovi di conoscenza. E induce a uno sguardo che non è più rivolto alla poesia, ma che muove dal suo interno.
Ma quale sguardo? in quale soffio di pensiero? verso quale esperienza?
Torna a farsi avanti con forza l’imperativo di Hanna Arendt: «Denken ohne Geländer», pensare senza balaustre. E aprirsi all’antipensiero: non a ciò che si oppone al pensiero, ma al suo volto in ombra.
Pensare senza balaustre significa approssimarsi a quel negativo ante rem che rifiuta di articolarsi nella sintassi della ragione. Significa favorirne il sorgere stesso.
Ce ne parla Günter Eich: «Quando la finestra viene aperta / e penetra l’orrore della terra – / il bambino con due teste, / mentre una dorme, l’altra grida, / grida contro il mondo / e riempie di spavento». Da questo versus, la poesia muove per la ricostruzione del senso, per la messa in opera della verità: intesa come qualità per cui una procedura conoscitiva ha successo. Come? Assecondando il movimento dell’origine, sorvegliandone la gestazione e il travaglio, ripetendolo. Pensando come il primo uomo ha fatto, scrivendo come se non si fosse mai scritto.
In questa cura della verità – sia dell’essere, sia dell’ente, secondo leggi di necessità interiori –, crediamo che sia possibile accedere agli elementi costitutivi dell’antipensiero.
Portarci in prossimità di questo versus significa esattamente cogliere la coscienza umana al suo sorgere; partecipare al formarsi dell’essere quale custode della differenza.
In tale logica senza conciliazione si articola l’aristotelico «movimento destabilizzatore» che l’antipensiero dall’interno della parola poetica non cessa di praticare.
In tale logica si pone Ingeborg Bachmann quando osserva: «Quello che è possibile è solo il mutamento».
La parola poetica conduce verso ciò che temiamo di più; nella direzione opposta alla vita che conosciamo. E da qui lancia una capitale avvertenza: va assaltato il pensiero, per portare a termine un’opera.
Farlo, significa rompere la fitta tela concettuale tessuta dalla ragione; spezzare la rigida forma vuota dell’io conscio; aprire una breccia nella barriera della consapevolezza razionale, da cui mani falsamente pietose tendono a censurare disagio, sofferenza e malessere; riconoscere come propria ogni ipotesi di lavoro programmaticamente rivolta contro lo spirito del tempo.
Niente ci riguarda più da vicino della parola poetica. Ci parla dei nostri margini scuri: i bordi incerti, decentrati e ambigui che esistono ai limiti del tempo, lasciati in ombra dalla luce sterilmente rettilinea del progresso.
La parola del poeta è l’esposizione della libertà del senso e del senso della verità. E mostra come il senso sia in gioco ogni volta: a ogni gesto, in ogni senso.
«”Origine” significa» ricorda Jean-Luc Nancy «non qualcosa da cui proviene il mondo, ma la venuta, ogni volta una, di una presenza al mondo». Non ci parla di nient’altro l’origine, se non di questa infinita singolarità del senso, e dunque dell’accesso alla verità.
Le donne lo sanno: per generare, il loro corpo deve lacerarsi. Così il dicente deve sapersi dividere per potersi affacciare alla vera soglia dell’essere. E lì esporsi all’ombra che ci abita. Lasciare che essa, quale parola senza soggetto parlante, ci scopra.
I poeti testimoniano il loro trapassare quel limite su cui l’uomo ha tracciato i bordi dell’essere. Nel farlo, muovono a espressione l’oscuro e il nascosto. E pongono cura che questa traduzione non sostituisca l’indifferenziato delle origini, ma lo porti attraverso sé al visibile.
Nel mettere al sicuro tale lacerazione, indicano la necessità dell’antipensiero, l’esigenza di una dislocazione – che è esodo delle parole – oltre ogni senso conosciuto.
A questa insituabile dislocazione fa cenno Gottfried Benn quando, citando George, provocatoriamente scrive: «Nella poesia – come in ogni attività artistica – chiunque sia ancora preso dalla smania di voler “dire” qualche cosa, “operare” qualche cosa, non è neppure degno di accedere al vestibolo dell’arte».
Flavio Ermini
n. 65, Il perturbante
«Anterem» dicembre 2002
Quando la finestra viene aperta
e penetra l’orrore della terra –
Il bambino con due teste
– mentre una dorme, l’altra grida –
grida contro il mondo.
Günter Eich
... da dietro il vetro è in rapporto immediato con il nostro corpo, noi viviamo e subiamo il suo significato, nello stesso tempo s’impone, annulla la distanza ed entra in noi.
Jean-Paul Sartre
Aprirsi all’antipensiero significa portarsi in prossimità di quel negativo anterem che rifiuta di articolarsi nella sintassi della ragione. Significa esporsi all’ombra che ci abita e lasciare che essa, quale parola senza soggetto parlante, ci scopra.
La questione è: come accedere all’antipensiero? A tale proposito, va messa in questione la pensabilità di un’esperienza estetica fondata su una più ampia autonomia del sensibile rispetto all’intelligibile. E realizzata in una lingua sconosciuta, non ancora sottomessa al controllo della coscienza: la lingua dei poeti.
Va forse ripetuto il gesto che Baumgarten aveva compiuto nel Settecento: disseppellire il significato dell’estetica come Aisthesis, scienza del sensibile: «Aesthetica est scientia cognitionis sensitivae».
Una maniera di conoscere non concettuale e che consenta ai sensi di fare a modo loro implica almeno due presupposti. Convenire che il mondo non è una docile provincia delle nostre idee. Accettare che l’esistenza non sia qualcosa di spiegabile esclusivamente nei limiti del tempo e dello spazio.
Scrive Sartre: «Non bisogna vedere nell’emozione un disordine passeggero dello spirito, che verrebbe a turbare dal di fuori la vita psichica ... L’emozione è un modo di esistenza della coscienza, una delle maniere in cui essa comprende (nel senso heideggeriano di verstehen) il suo essere-nel-mondo».
Ecco perché va forse prestata maggiore attenzione a quanto ci dicono i poeti, alle tonalità emotive che mettono in campo per la comprensione della nostra esistenza autentica, cioè quell’esistenza che non si abbandona al mondo e alle sue vicende, ma cerca di aprirsi all’esperienza originaria di sé, al proprio fondo illeggibile.
Non è un compito facile. Impone di convenire con Leopardi che il male è già nell’ordine, in quanto «l’essere è in contraddizione con sé medesimo». E implica il riconoscere la mancanza di fondamenti delle nostre credenze, quando queste ci impediscono di cogliere la lingua muta che si spalanca in noi.
Pensare il sentire. Aderire al pensiero nel suo stato nascente. Ecco il compito a cui sono chiamati i poeti. Ecco l’itinerario che nelle loro opere compie la parola poetica: dall’ombra al vaglio della coscienza. Ogni attenta lettura consentirà di avvertire nelle pieghe dei versi quelle cesure che interrompono proprio l’accesso alla coscienza, cancellano lo spazio e sbriciolano il tempo. Rendendo possibile la coesistenza di ascesa e declino, crescita e sparizione, ombra e luce: «È esodo anche il ritorno: è la luce del giorno anche il nascondimento della notte», registra Bigongiari.
In questo viaggio che conduce lontano dall’esperienza comunemente intesa, la scrittura abbraccia alternativamente il proprio senso e la tenebra che la circonda; quella stessa tenebra che corrode i bordi dell’opera, fino ad alterarne la presunta compattezza. Produce tagli, innesti nel suo corpo giungendo a renderla irriconoscibile e aprirla al silenzio che, sotterraneamente, racchiude in sé. Registra Eich: «Il bambino con due teste / – mentre una dorme, l’altra grida».
È la luce del giorno che rivela nel nascondimento della notte ciò che temiamo di più: il nostro cuore di tenebra, quel perturbante che, attraverso itinerari paradossali e contradditori, ci restituisce alle nostre antinomie: a noi stessi.
In quel sondaggio dell’inesplorato, in quella noncuranza dei significati e della vita, in quell’entrare nel proibito c’è la disposizione ad accogliere come autentico ciò che è instabile e la volontà di porre nuovi interrogativi all’ora presente.
La lingua deve frantumarsi per esprimere nel buio delle cesure ciò che si sottrae all’espressione. Ma l’oscurità è sempre stata scambiata per caduta irreparabile. L’uscita stessa dall’Olimpo imponeva lo smarrimento nella selva. Eppure già in Ippocrate troviamo in proposito un nuovo modo di vedere. Soprattutto là dove osserva che allontanarsi dal divino equivale allontanarsi dall’ignoranza ed esporsi alla conoscenza.
Va detto con chiarezza che solo lì, in quel cuore di tenebra, è possibile incontrare l’ingenssylva dello stato demonico dell’esistenza umana. Non tensione verso l’alto, ma discesa: dentro la pietra scavata, nel corpo a corpo con la polvere.
Nell’impensato il poeta cerca di cogliere quella furiosa molteplicità di nuclei su cui l’occhio comunemente scivola abbagliato e non sa dove posarsi. Si attua qui la possibilità per l’uomo di liberare la sua zona d’ombra in cui interrogarsi come enigma.
Per giungere nel luogo in cui tutte le direzioni sono possibili è necessario scendere nelle profondità oscure dove la parola è ancora mancante di senso e ogni cosa ha in sé il proprio opposto.
Conrad ne è consapevole quando – lasciando la parola all’ombra – registra il grido di orrore di quell’essere che non è se non nel perturbante in cui si manifesta.
Flavio Ermini
n. 66, Segni del perturbante
«Anterem» giugno 2003
Mi addosso alla sua ombra
raccolgo il suo silenzio tra le mani.
Jaccottet
Ogni processo approfondito di conoscenza non porta che alla scansione di strati sempre più profondi e abissali d’incomprensibilità.
Nei suoi sforzi cognitivi, l’uomo segue un itinerario paradossale e contraddittorio nel corso del quale l’attività della mente si manifesta nel sentire e nel pensare contro, giungendo a volgere ogni emozione e concetto nel loro contrario, fino alla sperimentazione dell’indifferenziato. I segni del perturbante ne sono una testimonianza.
Nel suo rimettersi all’oscurità come a una forma più profonda del sapere, il pensiero entra in un processo di lacerazione e dissoluzione che lo porta a identificarsi con la natura; o meglio: con l’ombra stessa della morte che la natura distende sulla vita.
«Questa montagna ha il suo doppio nel mio cuore» scrive Jaccottet. «Mi addosso alla sua ombra / raccolgo il suo silenzio tra le mani.»
Questa è la nostra esistenza. Noi viviamo una vita in cui il silenzio e l’ombra divengono la scienza stessa di un pensiero che si pone in fondamentale rapporto con ciò che si rifiuta a ogni inchiesta e si sottrae a ogni risposta.
Non lo ignora Bernhard quando annota: «Noi domandiamo, ma non riceviamo alcuna risposta. Noi continuiamo a domandare. Tutta la vita consiste di domande e noi esistiamo soltanto per il fatto che precisamente domandiamo, ma non riceviamo una risposta ... ognuno è un incubo abbandonato a se stesso».
L’uomo non viene al mondo per rispecchiarlo col suo linguaggio e con i suoi sistemi simbolici. Sarà anche vero che questi gli consentono di resistere alla pressione altrimenti insostenibile dell’esistere. Ma va detto con chiarezza che difficilmente con essi potrà accedere alla propria essenza.
Il dato di fatto della nostra vita non è l’esistenza che vediamo e descriviamo, ma l’impossibilità di vederla così come essa è e di descriverla secondo logica.
L’esercizio del pensiero nel sentire e nel pensare contro è l’arte di far emergere quanto una concezione cristallizzata e gerarchica del sapere ci impedisce ormai di cogliere.
Il centro geometrico che l’uomo si è costruito come abitazione per proteggersi dal mondo a cui è stato consegnato, va trasformandosi in un presente fatto d’ingombri, sbarrato: esito di una forma mentale fondata esclusivamente sulla ragione.
Secondo Wittgenstein va presa coscienza che la nostra cosiddetta comprensione è soltanto una forma di cecità rispetto alla nostra incomprensione: «La difficoltà è riconoscere l’infondatezza della nostra credenza». Quell’infondatezza è l’unica condizione che ci fa essere.
Solo chi ha confidenza con la parola poetica tenta di spingersi oltre lo spazio fisiopsichico che lo trattiene e di farsi ricettore di segni «indicativi di una cosa oscura», come avevano per primi formulato gli Stoici.
Eppure non c’è grazia, ma solo dolore e sgomento nel congedarsi dalle cose ridotte a merce e nello spingersi fuori dalla luce, verso la propria notte, camminare dentro se stessi parola dopo parola, segno dopo segno discendere verso ciò che sembra rivelare qualcosa alla sensibilità.
Questa esposizione investe tutto l’essere da noi sperimentato. E per parlarne la lingua si priva di ogni ornamento. Solo così potrà dire ciò che è essenziale: l’assenso al silenzio e alla voce che nel silenzio è custodita. Perché, come in Hölderlin secondo Heidegger, «questo dire non è l’espressione del pensiero, ma è il pensiero stesso, il suo cammino e il suo canto».
Chi si affida ai livelli inconcepibili del sentire e del pensare non ci consegna alcuna certezza. Ma ci stimola all’interrogazione ininterrotta e ci ricorda che la radice dell’angoscia non è inscrivibile solo all’esistenza come possibilità, ma anche al grido che avvertiamo dentro di noi e che usa la nostra mente come semplice cassa di risonanza, per chiamarci.
Il cammino verso la profondità dell’essere, e dunque del suo fondamento, si compie in un continuo digradarsi della luce verso l’oscurità della materia.
Nel suo volgersi a ciò che esclude ogni rapporto, si espone ai segni del perturbante e, in uno scompiglio di limiti e conoscenze, costituisce un banco di prova per la scrittura.
Flavio Ermini
n. 67, Lo straniero
«Anterem» dicembre 2003
Io sono ancora aurora e già il tramonto
dice su me che il giorno è per finire
non sono ancora nato e già morire
io devo al tempo che à invertito il conto.
Ferdinando Tartaglia
Quando si posa lo sguardo su una forma, questa viene messa a soqquadro. La scena subisce le conseguenze di un’immissione non annunciata. La porta si chiude su interni molto addomesticati per aprirsi su uno sguardo abitato da domande. Per via di questa esperienza, la responsabilità verso la forma giunge a coincidere con la responsabilità verso l’Altro da sé, propriamente uno straniero.
Prima che lo straniero giungesse fino a noi la realtà era considerata un rapporto fra dati concreti. L’occhio che la penetrava poteva solo riconoscere delle connessioni. Si conformava al dato. E lo restituiva come emozione, senza mai disimpegnarsi da una situazione imitativa. Le corde vibravano sempre sulla cassa armonica di uno strumento precostituito.
Solo con Rimbaud il postulato di Descartes diventa: «Io penso, perciò io non sono io». Ed ecco che dall’oscuro della consapevolezza divisa si affaccia l’Altro.
Posare lo sguardo su una forma per relazionarla alla propria interiorità è condizione irrinunciabile all’umana creazione. Il problema assillante dell’adeguamento a qualcos’altro viene così a modificarsi nel problema dell’adeguamento dell’Altro a noi stessi. Fino alla metamorfosi di sé nell’Altro che dal sé si affaccia come pulsione non programmata, discontinua, nascente.
L’incontro tra l’estraneo e il proprio mette il linguaggio in una situazione di emergenza e lo espone a un’altra lingua. Prima di quell’esposizione non c’è che una febbre vana. Solo la parola proverà che vi si doveva trovare qualcosa piuttosto che niente: è la parola pronunciata da Celan, per dire il dopo; la parola per dire l’ora senza sorelle, senza padre né madre, senza nome.
Tale parola si fa rivelatrice di una natura segreta. Dove si scava un alveo nuovo. Quello di una concretezza improntata alla massima libertà. In quanto trova in se stessa le regole da rispettare.
Posare lo sguardo su una forma significa forzarne gli argini posti all’irrompere dell’ignoto: quell’eccesso che rompe i legami della ragione e minaccia il suo esercizio di potere.
Ci muoviamo lungo gli argini oltre i quali la materia, nome dopo nome, riprende ad animarsi e si destina all’atto di interrogare la vita. Qui, l’ideazione della poesia è l’ideazione del mondo, un’affermazione umana di esistenza. Il paesaggio in essa dispiegato è già la nostra dimora.
Ma non è uno spazio di sapere. Semmai è uno spazio di esperienza, etico, prima che conoscitivo.
Noi siamo il prodotto di questo scatenamento di tempi irregolari, in un disegno che costringe la poesia a tracciarsi, in tutta la sua estensione: «O città io t’ho scritta nel palmo della mia mano» (Is., 49, 16).
La poesia è inadempiente rispetto alla realtà convenzionale. Non c’è scopo né corso in essa, se non, forse, nel nomadismo che prende forma tra identità e alterità, prima di ogni assegnabilità di un senso.
Identità e alterità. Facile è l’aut-aut. Ossia, facile è scompartire. Ma difficoltoso è unificare.
L’«e», di cui parla il poeta, è l’accettazione di quelle esperienze che donano alla realtà una consistenza priva di mascherature. E la rendono dunque vivibile.
L’evento che ci desitua e ci fa atopici rispetto a ogni piano imitativo è questo appartenersi reciproco e originario del sé e dell’Altro.
La poesia non è accessibile se non con un pensiero con-fusivo, capace di mettere assieme gli opposti.
Ecco perché il poeta non deve solo creare, ma anche ridestare le esperienze che radicheranno la sua parola nelle altre coscienze.
L’«e» di cui parla il poeta è l’esperienza di un vuoto indefinito. La vita, lo vediamo bene, procede su un filo teso sopra una crepa sottile.
Poiché non sappiamo nemmeno in cosa consistano i due capi del filo, dobbiamo ammettere, come sottolinea Tartaglia, che il primo nodo forse non è da nessuna parte. E ci aggrappiamo a un secondo nodo, considerato convenzionalmente come primo.
È il disegno delle ipotesi. Ma il mondo respira su ipotesi. E l’ipotesi è, insieme, libertà e pericolo. E separazione da calcoli coperti da garanzie.
Nel volgersi verso lo straniero, il poeta assume non il proprio, ma il «suo» sguardo come punto di erranza: uno sguardo che cessa di essere fisico, si libera del principio di non contraddizione e si misura con il «tempo che à invertito il conto».
In questo avventurarsi oltre le leggi del pensiero, verso l’inizio, il poeta non rinuncia alla propria lingua e introduce nel nostro paesaggio un concetto di realtà che non ha riscontro, se non nella nozione dell’Antiterra.
In questo rovesciamento dello sguardo, si compie il passaggio attraverso l’ombra della scrittura. Ed è come se il mattino fosse l’altro nome della notte. Ne è consapevole Marie Luise Kaschnitz quando scrive: «Solo all’ / alba / solo allora // scorgi i suoi / begli / occhi / tristi».
Flavio Ermini
n. 68, Pensare l’Antiterra
«Anterem» giugno 2004
Quanti negano che la terra sia posta al centro dell’universo, affermano che ruota intorno al centro; e neppure soltanto la terra, ma anche un’altra terra, contrapposta alla nostra, cui danno il nome di “antiterra” ...
Aristotele
Si trova l’uomo a vivere nel mondo,
Proteso in alto, e così è del tempo,
Che nel mutare è pur vero nel profondo,
La durata giunge con il cambiamento;
Perfezione così è unita a questa vita,
E il tendere dell’uomo a lei si adegua.
Scardanelli
Un segno siamo, senza spiegazione
siamo senza dolore e quasi abbiamo
perso la lingua in terra straniera.
Hölderlin
Lo spazio assoluto si nega alla misura e all’appropriazione. Per essere nominabile, deve diventare uno spazio relativo, assumere una sua delimitazione.
La definibilità conferisce allo spazio una dimensione geometrica e una filosofica. La misura dello spazio diventa in tal modo equivalente alla misura delle ragioni umane che spingono l’uomo ad adottare quello stesso spazio come un proprio luogo.
Ecco in cosa consiste il nostro compito: dare limiti e rendere questi limiti pieni del respiro che ci serve. E farli sorvegliare da occhi che vedano al di là di ciò che c’è da vedere: dentro di noi. Perché, come indica Wittgenstein, per tracciare al pensiero – e dunque allo spazio – un limite, è necessario pensarne entrambi i lati. La definibilità impone di pensare anche quel che pensare non si può.
Uno spazio fatto scendere dalle altezze di una riflessione incontaminata – staccato da quelle altezze e rimesso sulla terra, ma «dietro il paesaggio», come indica Zanzotto – diventa un territorio dov’è possibile vivere: l’habitat proprio dell’uomo.
E diventa nominabile: l’Antiterra
Accedere all’Antiterra presuppone la consapevolezza che tutto quello di cui abbiamo bisogno è alle radici dell’essere, e attende di essere ritrovato.
Significa aprirsi a due possibilità: o svolgere un’azione nella parte più profonda del nostro essere, aprire un varco nel suo cuore, indagare la sua ombra; oppure assecondare dell’essere le naturali propensioni, ascoltarne i suggerimenti, portare a completezza le efflorazioni che lo caratterizzano.
Nel primo caso l’intervento è drastico: una Verwindung – un rimettersi dalla malattia, una convalescenza – decreta la perpetua rottura che avviene nell’identico e nell’immobilizzato.
Segni e parole entrano con la violenza di un marchio; impongono la loro pronuncia; chiedono ospitalità.
È l’ingresso risoluto nell’Antiterra: una faticosa discesa lungo sentieri a spirale, attraverso l’oscura notte dell’anima – una specie di caligine psichica, estenuante e ambigua –, fino a uno spazio vuoto destinato alla trasformazione: una nuova nascita, in verità. Per cui la parola viene per sovrapporsi, per cancellare e sostituire. È il passo in avanti senza riserve; che comporta un prezzo da pagare, sempre lo stesso: diventare la nostra ombra.
Rifiutarsi di pagare questo prezzo comporta la perdita della consapevolezza di ciò che siamo.
Nel secondo caso, l’intervento consiste nell’ascolto della lingua muta delle cose. Richiede disposizione al sentire, accoglimento e accoglienza; e riconoscimento. Fino alla riconoscenza di appartenere al mistero di un’alterità che sfugge a qualsiasi presa e possesso, come indica Hölderlin.
Il rapporto con l’alterità ci assegna a noi stessi e al nostro limite, nomina il nostro habitat, ci definisce.
L’Antiterra mette in evidenza entrambe le posizioni e il comune elemento costitutivo: il dolore dell’esistere.
L’accentuazione data all’esperienza ambientale – soprattutto a livello di quotidianità, consuetudine, esperienza diretta – ci consente di vedere, al di là delle apparenze, l’intima verità delle cose: una perdita che non prevede salvezza. Una perdita rappresentata da piani inclinati sui quali ogni significato si trasforma in caduta verso la più radicale frammentazione del senso.
Scrive Leopardi: «E così quello che veduto nella realtà delle cose, accora e uccide l’anima, veduto nell’imitazione o in qualunque altro modo nelle opere di genio, apre il cuore e ravviva».
Ma l’opera «ravviva» non per il potere illusorio che esercita sulle cose. E non per inganno «apre il cuore». Al contrario per il suo sapersi fare «verissima imago» della realtà; ossia per il suo riuscire a mostrarci, come precisa Donà, con più forza e verità di ogni altra forma espressiva, la medesima insensatezza che rende insopportabile l’esistenza. Per il suo far sì che quel vuoto venga ricondotto alle sue reali possibilità conoscitive, alla conoscenza.
Non si incontra mai l’Antiterra se non nella parola poetica.
Flavio Ermini
n. 69, L’Antiterra
«Anterem» dicembre 2004
Non è solo uno, Dio, vero? Sopra ce n’è un altro di
Dio?
– Come si scrive nel luogo nuovo?
Cvetaeva
Il luogo del molteplice
Viviamo in una realtà dominata dai segni di un collasso verificatosi nell’ordine. Ogni senso che la presidiava è sprofondato nell’oscurità. Qui va cercato, in un faticoso inabissarsi del pensiero.
Non ha più corso l’idea di compiutezza ed è caduta la fiducia in un tempo che avanza rinnovandosi. Dove prima si affermava un assoluto armonico si apre l’Antiterra, nella sua evidenza di polvere sparsa. Ne è consapevole Hölderlin quando scrive che la divina unitezza è andata perduta e precisa: «Siamo in disaccordo con la natura e quello che un tempo era uno appare ormai come opposizione».
L’Antiterra è il luogo del molteplice. Nei suoi interstizi l’essere finito non può più comportarsi come se possedesse le certezze di un dio, né può determinarsi scordando che il tempo lo costruisce e decostruisce insieme.
Il tempo è l’estensore di una somma che conduce all’azzeramento. Ed è limitato lo spazio che finge di assegnarci tra il qui della vita e il laggiù della morte. Ecco perché ogni espansione del pensiero nella storia e nello spazio non è mai tale da farci superare la nostra finitezza e liberarci dall’infelicità. Quale unico successo resterà l’ascolto terreno della parola che si china verso il vuoto per accoglierlo: laggiù sono le voci che ci chiamano e ci rivelano che non siamo più soli com’era accaduto nella salita.
Le voci che prendono corpo nell’Antiterra sono l’altro del discorso e del pensiero (propriamente, l’antidiscorso e l’antipensiero), e danno corpo al testo che coglie nella fine le estreme possibilità dell’inizio, anche quelle rimaste impensate, e abbraccia alternativamente il proprio senso e il vuoto che lo circonda. Quel vuoto che corrode i bordi della scrittura, fino ad alterarne la compattezza, e produce tagli e innesti nella parola fino ad aprirla al silenzio della propria origine. Quel senso che dice di sé a condizione di un preliminare congedo dai sensi preesistenti, fino a consegnare il testo a una dimensione straniera. Sono espliciti a questo proposito i versi di Mandel’stam: «Mi piego alle umili radici / e guarda come divento insieme cieco e forte…».
L’idea della morte
In passato, l’Antiterra era stata interpretata come perdita di quella capacità espressiva che l’antichità aveva inaugurato e il rinascimento, riproposto.
L’Antiterra era stata scambiata per degradazione, caduta irreparabile: vero e proprio smarrimento nella selva dopo la cacciata dall’Eden.
In realtà, da quando la trascendenza ha perso la sua forza vincolante ed è ammutolita, l’uomo abbandonato a se stesso reclama, al cospetto del nulla, la sua libertà. In questo divergere da un fondamento metafisico s’inaugura il gesto filosofico della modernità, che non smette di interrogarsi sul senso del vuoto lasciato da questa perdita.
La falsa elevatezza che ci sta alle spalle lascia il posto al protendersi dell’uomo verso il principio del proprio essere finito: l’incompiuto. L’infinito, così com’è concepito dall’uomo, precisa Leopardi, è «un parto della nostra immaginazione».
Ma l’incompiuto non va confuso con l’approssimativo o, peggio, con l’incuria. È al contrario la risposta a un bisogno insopprimibile: togliere brillantezza alle luminarie della rappresentazione e portare nell’immobilismo la vacillazione.
La vita è nella morte che l’attende. E la morte è il termine dal quale il paesaggio esistenziale prende luce, consentendo un nuovo gesto e una nuova passione per la conoscenza.
L’idea della morte si è insediata nell’operatività artistica. La pianura s’imbatte nella spinta sismica. Il paesaggio viene attraversato da fenditure. Il termine ultimo non si trova soltanto a conclusione della nostra vita: si è insediato nei nostri pensieri. È commisto alla materia tutta. Diventa un elemento costitutivo dell’Antiterra, dove lampeggiano, allo stesso tempo, la vita e il suo declino.
Lo stesso io è diventato un momentaneo mosaico di pulsioni, stati d’animo, sentimenti discontinui: un’aggregazione continuamente scomposta.
La poesia deve rispecchiare il termine ultimo, emanarlo, diffonderlo intorno.
L’incompiuto è questa necessità di cui ogni cosa è proprietaria. È precisamente quell’impensato che nei vuoti della scrittura, nelle sue cesure, nelle sue cancellazioni, non ha mai cessato di scriversi.
L’incompiuto diventa così testimonianza di apertura e il concluso, di limitazione. Il primo si attiene al vero e tenta di aprire il testo all’impensato che lo attraversa. L’altro, alle garanzie di un muro. Si attua qui – in questa sospensione, indipendente da ogni sapere preliminare – la possibilità per il soggetto di congedarsi dai dispositivi formali del linguaggio e di liberare la sua zona d’ombra in cui interrogarsi come enigma.
Il destino di nulla dell’uomo
Come avrebbe potuto il cosmo, che al dire di Eraclito «non è stato creato né da dio né dall’uomo», restare mondo a disposizione dell’uomo? Nell’universo fisico della moderna cosmologia l’uomo non può più sentirsi a casa propria. E la lingua della poesia, così come il gesto artistico, può solo dire questa lontananza e nominare la sopravvenuta frattura.
Ne è consapevole Michelangelo quando entra nell’incompiuto e ne fa un alloggiamento decisivo, spegnendovi l’avorio delle sue strutture plastiche. Dalla medesima consapevolezza sarà guidato il Greco quando deformerà verticalmente le figure e le strapperà al vincolo dei riferimenti naturali.
Tra incompiuto e deformato si svolge il rito della sconsacrazione. In questo passaggio va colta l’apertura di uno spazio sempre nuovo per il pensiero: una modalità con cui l’essere e il niente ancora si danno.
«Tutto è nulla» annuncia Leopardi. A partire da questo sapere l’uomo fa «esperienza originaria» di sé e dell’altro. Seguendone le tracce fino agli estremi confini del territorio metropolitano, dove gli spazi sono creati dal disordine, dall’irregolarità, dall’anomalia, dall’instabilità dei corpi: sono senza forma e misura, e in essi è costante la presenza di una nuova figura individuale, non tesa a riunire ciò che è separato, ma figura concreta che vuole il massimo di libertà negativa e materiale. La sua libertà non è più circoscritta da limiti dettati dalla natura o da un contratto sociale. Dai suoi percorsi illegali nascono spazi vuoti di significati simbolici, terre incolte e indefinite.
In questa moderna Wildniss la scissione e l’irregolarità sfidano l’armonia e l’ordine. E il poeta non può che andare verso, più che trovare dimora. Con la coscienza di dire da un luogo di separazione e lontananza: dal sacro, dal classico, dall’istituzione letteraria e politica.
Nella metropoli vige una parola tendenzialmente portata a quei minimi di senso prossimi alla cancellazione, unici depositari di autenticità per un soggetto che niente può trascendere. È l’Antiterra degli addii mortali. Qui nasce la poesia che pensa il destino di nulla dell’uomo.
Flavio Ermini
n. 70, Nozione di ospitalità, n. 70
«Anterem» giugno 2005
L’essere umano come poeta, come pensatore,
come Dio, come amore, come potenza.
Nietzsche
Tutto ciò che esiste nel mondo rivelato ospita al suo interno una forza che lo destina alla fine. Niente, se non l’illusione, può impedirci di prendere atto che l’annullamento è il solo possibile esito dell’esistenza.
La voce del limite ultimo scuote il reale e rivela l’angoscia al fondo di ogni cammino.
È un grido di morte quello che gli esseri umani – atterriti – odono dal primo giorno della loro consapevolezza. Quello stesso grido sarà il certificato di nascita della comunità umana. E spingerà uomini e donne al risentimento, se non all’odio, nei confronti della natura.
Dal punto di vista dell’essere umano, infatti, la natura è mostruosa, perché, creando la vita e l’amor proprio di ogni vivente, ha reso la morte e il dolore centrali nell’esistenza di ciascuno.
L’approssimazione al nulla
Da limite a limite, il percorso di formazione può essere seguito attraverso uno sguardo che veda il pensiero rinunciare alle ali degli angeli per cogliere lo stretto rapporto tra essere umano e nulla, e dolorosamente annegare.
La poesia reca in sé questo sguardo e ne mantiene l’angolazione verso dopo verso.
La vita è questione di spazio e non di tempo. Invecchiare è avanzare nel buio, conoscere la notte a fondo prima di cadere. Invecchiare non è lo smarrimento nella selva oscura, né una prova divina; ma la brusca e irrevocabile interruzione del nostro passaggio sulla Terra.
Nella nostra dolorosa approssimazione al nulla, il limite ultimo è ogni limite e la direzione è quella che va dalla notte al buio. La ripetizione è ripetizione ogni volta rinnovata di un percorso verso la fine.
Solo nel presente c’è una tregua. Sul presente riusciamo a tenerci in bilico. Nell’oltre non c’è scudo. Oltre c’è la paura. C’è il futuro, se «futuro» può essere definito questo processo distruttivo in cui è evidente, insieme all’abbandono del pensiero, il riposo delle emozioni, vera e propria esperienza simbolica della morte.
La penultima pagina dello Zibaldone
Che la morte sia inevitabile e che con la sofferenza ci costituisca è un’evidenza prima; non ha bisogno di dimostrazione. Eppure noi insistiamo a inscrivere morte e sofferenza come voci in passivo di una tabella statistica. E tendiamo ad attribuire significati palesemente falsi al nostro dolore. E rifiutiamo di credere che l’immortalità sia un’illusione che la luce del vero dissolve.
Accettare che le cose spariscano significa accettare la nostra caduta; e prendere atto che il buio avanza su noi, escludendoci dal futuro.
Ne era ben consapevole Leopardi se nella penultima pagina dello Zibaldone (4525) scriveva: «Due verità che gli uomini generalmente non crederanno mai: l’una di non saper nulla, l’altra di non esser nulla. Aggiungi la terza, che ha molta dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a sperare dopo la morte».
Il diritto alla verità
È attraverso l’hairetikós (propriamente: colui che sceglie) che nella trama illusoria della nostra storia irrompe talvolta un frammento di verità. Quando accade, acquista evidenza l’insensatezza dell’esistere e la nostra stessa storia crolla nell’insignificanza.
Ricusare l’illusione come categoria significa pensare nella direzione della fine. E la fine reclama la conferma del nulla che l’uomo è.
Sarà Leopardi a liberarci per sempre dalle illusioni e dunque da un destino deciso da altri. Pronunciando la penultima parola – il nulla – ci condurrà a farci carico della verità.
«Il nihilismo è alla porta» soggiungerà Nietzsche, annunciando l’avvento del «più inquietante degli ospiti».
L’angoscia mortale
Noi siamo eterni solo nella nostra fugace apparizione su questa Terra, nello sfiorire graduale della speranza, nel dischiudersi precipitoso della caducità.
La nostra unica salvezza risiede nella coscienza di operare nello spazio limitato che si forma tra due cadute, nella comune fragilità.
Ne sa qualcosa il poeta che fa del nulla non uno schermo di fronte a cui distogliere gli occhi, ma piuttosto il centro stesso della vita. Tanto che la sua creazione poetica si rivela come l’appropriazione di un qualcosa che non può essere posseduto interamente e una volta per tutte.
Ecco perché la poesia rende tangibile l’instabilità perpetuamente mitigata della nostra condizione. E riesce a riconoscere nel nulla il principio che converte l’essere umano nella libertà. In tale processo, la poesia disancora l’essere dal principio di ragione e lo espone non solo al poter essere altrimenti ma al poter non essere.
Esattamente come le nostre idee, siamo eterni solo nella nostra angoscia mortale. Un’angoscia che sfida l’atmosfera trasognata degli inganni e delle illusioni. E impedisce di rifiutare il proprio destino.
Flavio Ermini
n. 71, L'ospite
«Anterem» dicembre 2005
Eppure dalla china dell’orizzonte ultimo del monte il viaggiatore
non porta a valle un pugno di terra, a tutti indicibile,
ma una parola conquistata […]
Noi forse siamo qui per dire: casa,
ponte, fontana, porta, brocca, albero da frutto, finestra,
al più: colonna, torre… Ma per dire, capisci,
per dire così, come nell’essenza le cose stesse
mai hanno inteso d’essere.
Rilke
L’ospite e le cose
Mettersi su ogni strada offerta dal mondo significa accogliere tutto del mondo. Significa non scartare alcuna possibilità e riconoscere l’oscillazione di senso propria dei fenomeni di cui viene fatta esperienza.
Quando osserviamo un fenomeno, noi possiamo con pazienza enumerarne i molteplici aspetti e sentirli interdipendenti. Ci è concesso, entro un certo perimetro di sicurezza, di attribuire a esso un carattere che lo preservi dall’incomprensibilità e dall’insidia del nulla. Entro questo limite, possiamo godere di una sufficiente tranquillità.
Dice Socrate: «Le cose hanno ciascuna un suono, una figura, e molte anche un colore». Ebbene, quel suono, quella figura e quel colore sembrano rappresentare proprio la trasparente prossimità a noi delle cose, nello spazio e nel tempo del loro apparire.
Eppure quando cerchiamo di gettare ponti tra fenomeno e fenomeno, tra fenomeno e cosa, tra cosa e cosa, vediamo accumularsi sulle nostre operazioni dubbi che ci sconfortano e questioni che minacciano la validità dei procedimenti adottati. Se sono accettabili i singoli termini e qualcuno dei risultati conseguiti, ci appare errata o quanto meno manchevole la conclusione.
«Noi forse siamo qui per dire», scrive Rilke, «… per dire così, come nell’essenza le cose stesse / mai hanno inteso d’essere». La parola poetica porta avanti questo compito con estrema precisione. Il suo è uno sguardo appassionato sulle cose e sulla loro luce oscura. È un approssimarsi alla loro figura, al fine di percepirne anche il più lieve movimento, tra suoni e colori. È una ricognizione per tendere un agguato alla loro lingua.
Ma non c’è simmetria nel rapporto tra parola e cosa. Quest’ultima, infatti, tende a occultarsi alla parola che chiede di coglierne l’essenza. Nel suo celarsi, la cosa sottopone i fenomeni che la manifestano a metamorfosi rapidissime, di cui la parola non può afferrare che gli effetti più evidenti. Proprio per questo tenace negarsi, i nostri margini di libertà nel dire diventano ridottissimi e mostrano quanto sia illusorio il nostro crederci vicini al cuore delle cose, di cui alfine dobbiamo imparare a vedere anche l’ostilità.
Il carattere di ogni procedura cognitiva – che abbia per oggetto, oltre che la parola «conquistata», l’ospite che la pronuncia e le cose – conduce al tema dominante: il desiderio di decifrare il mondo con sufficiente chiarezza pur nella precarietà degli equilibri su cui contare.
L’ospite e l’opera
Creare un’opera significa disporsi a un’attesa, dopo essersi incamminati su ogni strada offerta dal mondo.
Nell’opera, a un’accensione interna corrisponde un’accensione esterna di pari intensità. L’opera parla senza interpreti con la stessa voce del luogo segreto che deve portare alla luce. È la bolla d’aria che da un fondale buio va a esplodere in superficie: una pellicola sensibilizzata da immagini contrastanti: una membrana ricevente che non può arginare né selezionare gli stimoli che la investono.
Scrive a tale proposito Musil: «Il pensiero non è qualcosa che osservi ciò che è accaduto interiormente, ma è questo stesso accadere interiore. Noi non ci mettiamo a pensare su qualcosa; al contrario, qualcosa è emergente in noi pensanti. Il pensiero non consiste nel fatto che vediamo chiaramente ciò che si è sviluppato in noi, ma nel fatto che uno sviluppo interno si estende fino a questa zona chiara».
Nel mondo, la presenza è costretta a muoversi sul terreno dell’assenza, a lasciarsi disvelare dal suo stesso sottrarsi. Questo andare verso è anche un permanere… un continuo offrirsi all’aperto che Heidegger chiama Inständigkeit, insistenza…
Creare un’opera significa dunque dare continuità a questa procedura creativa; perfezionarla; sospingerla in zone ancora più spettacolari e spericolate; negarle qualunque possibilità di assestamento; affondare le mani nel serbatoio di un magma profondo in perenne mutazione.
Ecco perché il poeta aderisce a quel pensiero che è un rispondere a quanto si annuncia prima che l’indagine conoscitiva inizi la sua azione di discernimento. E fa sua una concezione instabile della forma, estranea a ogni sorta di controllo sulle emozioni.
Ecco perché l’opera diventa il prodotto di un’esposizione e, insieme, di un ascolto nei confronti del mondo.
Il poeta conosce il distacco dalla conoscenza piena, sa di essersi incamminato verso quel mondo che dà ospitalità a tutte le strategie di percezione dell’essere. O forse sta inventandone di nuove. E torna a lasciarsi sopraffare dalla lingua muta delle cose, a subire la minaccia del silenzio, mettendo in conto manualità elementari, imperfezioni tecniche, automatismi.
Il problema dell’unità di espressione, come fedeltà a se stessi e come riconoscibilità, viene emarginato.
Il poeta si avventura su quel suolo originario dal quale nascono sequenze di suoni affini, grumi disordinati di sillabe, balbettii, afasie. E domanda a sua volta: cosa significa pensare quando il pensare si rivela come qualcosa di molto diverso dal possedere?
L’opera che non passa attraverso il controllo assume il carattere d’involontaria bellezza e impone una diversa logica del rapporto tra parola e senso. Accetta che qualcosa sia Inständigkeit, ma anche Haíresis. E si dà alle cose, e consente che abbia voce quanto alle cose è più proprio: il loro tempo: il presente.
La pluralità espressiva promuove una situazione precaria ma esaltante: creare un’opera affrancata da ogni schiavitù a un ordine manifesto del sentire. Al monolitismo di una sigla il poeta cerca di sostituire la frantumazione dello sguardo.
Flavio Ermini
n. 72, Hairesis
«Anterem» giugno 2006
E sotto il cielo fugace del purgatorio
Noi dimentichiamo spesso che –
La custodia celeste e gioiosa
È la casa terrena che si distende.
Mandel’stam
1.
Un’abbagliata elevatezza ci sta alle spalle e lascia il posto al protendersi dell’uomo verso il fondamento del proprio essere finito: l’incompiuto. Questa eresia – propriamente hairesis, scelta – si è insediata nella parola poetica.
La parola si forma in un ricercare insistente all’interno di molte esperienze. Ma è negata l’eventualità di un dissolvimento in qualcuna di esse. Anzi, ogni posizione raggiunta stimola verso altre; e tutte, invece di elargire risposte, finiscono con l’acuire la tensione della ricerca stessa.
Nel suo ascolto terreno, la parola abbraccia il proprio senso e, insieme, il vuoto che la circonda: si china verso il limite per accoglierlo. In questo divergere da un assoluto armonico, s’inaugurano l’atto poetico e il gesto filosofico della modernità, che pure non smettono di interrogarsi sulla sensazione di vuoto lasciato da quella perdita.
La parola poetica esige la deliberazione e può essere esercitata esclusivamente su ciò che dipende da noi. In questo senso è connessa alla passione per la verità e fa sì che l’uomo sia il principio dei propri atti, come impone Aristotele.
Lì dove appare, la parola accoglie il bagliore che le esperienze hanno saputo esprimere. E lo trattiene, congiuntamente a quel buio che preme per salire, fino al tracciarsi della frase e al compiersi dell’opera. Sicché, come il gesto della mano che si leva “imita” il moto verso l’alto di ciò che è leggero, così il formarsi della frase e l’orizzontale sostare dell’opera “imitano” rispettivamente l’esserci e la stasi delle cose. In un corrispondere che mai è identificazione, né raggiungimento, né tanto meno compenetrazione.
L’affermazione del pensiero sta nel suo rimettersi all’oscurità della materia come a una forma più profonda di sapere e quale banco di prova per la scrittura.
2.
L’opera si costituisce come luogo di parola per la lingua muta delle cose. Accedere all’opera nel suo ricercante tracciarsi svela la vanità di una visione che pretenda di produrre o annientare le cose e mette in guardia dall’uso di parole che abbiano la presunzione di coincidere con la loro insistenza. La parola stessa è a un tempo tutt’uno con la cosa che indica, ma anche ulteriore e dissimile da essa. Per la parola, la cosa non è mai a fuoco nel punto giusto, tanto che il risultato poetico pone sempre un problema di assenza.
Insomma quel che accade nella formulazione di una frase è un continuo allontanarsi di quel confine che dovrebbe unire l’essenza delle cose all’opera. Eppure proprio questa estraneità consente all’opera di vivere una vita propria, indipendente dalle circostanze e dalle tonalità emotive in cui si è formata. Giungendo a manifestarsi in una sua pratica di cosa… Una pratica in cui il confronto con l’impensato diventerà assillante e ineludibile, e consentirà l’annunciarsi del non-detto e l’inaugurazione di quel colloquio originario che precede ogni dialogo tra gli uomini.
Accedere all’opera nel suo farsi presuppone la consapevolezza che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è alle radici dell’essere e attende di venire riconosciuto; e impone di volgere il dire in tutt’altro verso rispetto a quello del discorso, dove la parola semplicemente designa questa o quella cosa, come d’abitudine, e non ha più bellezza. Questa inversione del cammino ci porterà a un’esperienza estetica fondata su una più ampia autonomia del sensibile rispetto all’intelleggibile, e realizzata scegliendo una lingua sconosciuta, non ancora sottomessa al controllo della coscienza: la lingua dei poeti.
3.
Scrive Jünger: «Le cose non si modificano agli occhi di chi è sopra di esse e le osserva, ma mettono in mostra un altro lato della loro realtà». Sale dalle cose il respiro che posa realtà sulla parola e in essa si unisce all’acqua nascosta di un desiderio: trovare il golfo e attingere sicurezze inattaccabili, a difesa non soltanto dell’unicità personale, ma anche di quello stato prelogico ed emozionale che Vico chiama «sapienza poetica» e colloca ante rem.
Scrivere – quale atto di coraggio e di rischio – non rappresenta un abbandono della vita, ma un addentrarsi nel folto dell’esistenza, una disposizione ad aprirci verso noi stessi e ad ascoltarci, trovando nuove parole a cui consegnarci.
Scrivere significa conoscere. E conoscere vuol dire, con Novalis, «sprofondare lo sguardo nell’anima del vasto mondo». Questo movimento va trasformato in uno scorrere di vita, dove l’opera si disponga a dire qualcosa di noi dicendo se stessa. Ecco la cosa che l’opera trae a sé. (Ecco l’opera che la cosa chiama a sé.)
Va prestato ascolto ai poeti che rischiano una dimensione dell’estetica non più intesa come culto di un codice stilistico o rito della forma, ma quale espressione di una svolta cognitiva ed etica insieme, una svolta di portata complessiva del pensiero: uno strumento di comunicazione del materiale preverbale e di un’emozione che ancora non si sa di provare.
Flavio Ermini
n. 73, L'esperienza della percezione
«Anterem» dicembre 2006
Gli uomini sono ossessionati dall’opinione che hanno delle cose, più che dalle cose stesse.
Epitteto
Tra le molteplici dimensioni in cui siamo gettati, e a cui non ci possiamo sottrarre, c’è quella dell’essere destinati a fare esperienza.
Ciascuno di noi è gettato nel tempo ed è condannato a crescere. Il che vuol dire riconoscere che siamo solo un punto tra i tanti, una particella impersonale in un universo sterminato.
Il soggetto non appare più come identità, ma come limite mobile. Si estingue come principio costitutivo del sapere per scoprirsi correlativo ai confini che esplora e alle scelte che compie.
L’esperienza della percezione: ne danno conto i poeti a cui si apre questo numero di “Anterem”. Accompagna i loro testi un nucleo di riflessioni che modula lo stesso tema dal punto di vista filosofico: sotto il profilo del tempo, della parola e della memoria. Ne sono autori Carlo Sini e i collaboratori della cattedra di filosofia teoretica della Statale di Milano.
Le cose sono nel raggio dell’attenzione. Ma, come ci dicono i poeti e i filosofi, non se ne coglie mai con esattezza l’essenza.
L’uomo conosce soltanto segni vuoti, non le cose in se stesse. Per conoscerle sono necessari all’uomo una mediazione (il linguaggio), delle leggi (quelle della ragione), l’osservazione (attraverso i sensi). Va da sé che l’uomo può conoscere solo la propria ombra (data dal linguaggio, dalle leggi, dai sensi) che lui stesso frappone tra sé e le cose. E con la parola può esprimere solo la propria opinione.
La parola non si aggiunge alla parola per dare estensione allo spazio delle cose, ma per modificare la situazione che si era venuta a creare tra le parole precedenti. Ci segnala che qualcosa si aggiunge a quanto già sappiamo.
Parola dopo parola, la mutazione del punto di vista linguistico introduce una mutazione del punto di vista psichico, infrangendone la fissità.
Queste incessanti variazioni ci fanno capire che l’io narrante va subendo una crescita.
La successione verbale non genera architetture, né dona alle cose luce maggiore. L’io narrante ne è consapevole: non mira al possesso scalare dell’oggetto: lo dà semplicemente come irraggiungibile. In un certo senso, egli è un interprete del principio di variabilità.
Il tempo dell’aggancio alle cose diviene un gioco interminabile di avvicinamenti e allontanamenti. E di scoperte minime, che, pur raggruppate, forniscono una somma solo parziale di dati. O una somma totale insensata; essendo l’ingrandimento di un solo addendo: quello più evidente per l’occhio che si muove sul mondo.
Il risultato ultimo, ammesso che ci possa essere, è sempre eleatorio. E quando circoscriviamo quello che ci sembra essere prossimo al vero, avvertiamo ancor più che il nostro calcolo richiede una revisione, che quasi sempre richiede il congedo dall’abituale modo di vivere e pensare.
Eppure, quando l’io narrante arriva a mettere a rischio i fondamenti del proprio sapere, a sfasciarne la logica, a distruggerne i più ovvi punti di riferimento; riesce a mettersi in contatto per un momento con l’essenza delle cose. Ma attenzione, non la cosa, dunque, ma l’essere di questa nel modo in cui di volta in volta si dà. Per cui, non di ridondanza dobbiamo parlare, ma forse di balzi percettivi.
La poesia, quindi, non acceca l’intelletto per consolare il cuore…
«La vera via» scrive Kafka «passa per una corda che non è tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo. Sembra destinata a far inciampare più che a essere percorsa».
Ma è la via più aderente alle cose. E l’io narrante non si stanca di ricercarla.
In direzione di un nuovo “qui” e di nuovo “adesso”, lo spazio indagato torna a esplodere interamente allo scattare di ogni istante. Fa intuire un altrove che non si sa mai dove sia.
Chi guarda, comprende che è fragile, smarrito: sul punto di essere soltanto nell’atto di scrivere. Chi scrive mostra la sua terra insicura, il suo cuore incerto.
L’opera poetica si costituisce propriamente come un disegno del pensiero. È formata da parole la cui successione evidenzia che il cielo circoscrive solo se stesso e che sulla terra la desolazione è compiuta. Ma in pari tempo delimita un habitat in cui, sia pure con disagio, è possibile vivere.
Come può accadere?
Un costante diniego letterario – il divieto di esistere, se non come linguaggio – trattiene questi lembi di vita fantomatica in un mondo di frammenti e di cose disperse. Qui l’io narrante avanza con tanta ignoranza. Ma solo qui può cadere la sua scelta, anche rischiando che la sua azione resti illeggibile.
Ogni sforzo di comprensione totale non può emergere che da questo sfondo abissale, dal caos, quale apertura, spalancamento, disponibilità per tutti i sensi; nell’estremo tentativo di attingere un’ulteriorità di senso nel fluttuare dell’indeterminato. Ne è ben cosciente Spinoza quando scrive: «La perfezione delle cose deve essere valutata soltanto in base alla loro natura e potenza; le cose non sono più o meno perfette perché dilettano o offendono i sensi degli uomini, o perché favoriscono la natura umana o la avversano».
Dentro la costante dell’inaffidabilità in cui si trova ad agire, l’io narrante cerca un’ossatura. Se non c’è, la inventa, in quel fondo di mistero che è la cosa; soprattutto perché vuole andare oltre gli oggetti imitati, oltre la loro fattezza esteriore, il loro fenomenico darsi secondo questa o quella modalità.
Nel forte ramo dell’esistenza, egli mette un incavo dove collocare o nascondere il tempo della nostra esperienza; consapevole che la scelta non è più tra verità e menzogna, ma tra parola che si spaccia per realtà e parola che si dà come tale, l’unica che sulle cose gli procuri una piccola garanzia di ancoraggio.
Ma noi fuggiamo senza posa da una cosa all’altra soltanto per farcene un’opinione e ci distruggiamo da soli. Non facciamo che scappare, fino a quando cessiamo di vivere.
Questo concetto è di tale importanza che (tratto da: Épictète, Enchiridion, X. Traduction de Montaigne, livre II, chap. XIV) lo troviamo tra “Les sentences peintes dans la ‘librairie’ de Montaigne”: «Les hommes sont tourmentés par l’opinion qu’ils ont des choses, non par les choses mêmes».
Flavio Ermini
n. 74, Anacrusi
“Anterem” giugno 2007
L’anacrusi, presso i greci, è senz’altro un semplice preludio, per esempio quello della lira. Ma in alcuni esempi del diciannovesimo secolo si complica…
L’anacrusi. Non una parola, appena un mormorio, appena un fremito, meno del silenzio, meno dell’abisso del vuoto; la pienezza del vuoto, qualcosa che non si può far tacere, che occupa la totalità dello spazio, l’ininterrotto, l’incessante, un fremito e già un mormorio, non un mormorio ma una parola, e non una parola qualsiasi, ma una parola chiara, giusta, alla mia portata.
Blanchot
La parola poetica trattiene due movimenti. Uno è discendente, e propone il passaggio dalla presenza all’allontanamento. L’altro è ascendente, e impone l’apparizione.
Fra questi due opposti, dove niente aderisce al canone della fissità, il poeta coglie il momento ontico primordiale.
Il poeta regredisce al nucleo profondo della convulsione materica e investe il momento antepredicativo delle archai, dove la temporalità acquisisce la sua potenza originaria.
L’onda creativa che ci porta all’essere è preceduta da quella oscura della cancellazione. Vuoti e spegnimento sono destinati a capovolgersi in energie e forme, che a loro volta si fanno produttrici di altre assenze.
Il legame tra silenzio e parola è inscindibile e ci fa apprendere quanto sia breve il volo terreno.
Siamo osservatori e costruttori di uno spettacolo che, inciso su una mappa albale, ci fa misurare tutto il valore della nostra fugacità.
La parola e il silenzio, così come il segno e il vuoto, sono strettamente connessi nell’anacrusi. L’incontro fra due elementi che ordinariamente si trovano distinti sottolinea come tra la percezione e la sua traduzione in parola e segno non vi sia mai sicura concordanza.
I segni formano una sorta di parasele intorno al vuoto. Quel vuoto indica anche lo spazio liberato, il tempo che attende una nuova pronuncia, il luogo dove il futuro potrà insediarsi con altre leggi: quasi un desiderio di ridurre a respiro terrestre ogni trascendenza.
Un varco si apre dentro il nucleo del più profondo ammutolire e si manifesta come genesi di pensiero e avventura di parole che ci parlano di ritorno, riapparizione, nascita.
La parola fa da unione fra i diversi modi di essere delle cose, che la nostra emozione va stringendo nelle sue reti. Tali presenze, appena chiamate a entrare in un tenue grado di vita, cercano l’ansa dove tramutarsi nella migliore trascrizione di se stesse.
Il vuoto. Questo concetto è al centro dell’operatività dell’artista, il quale con l’anacrusi si trova di fronte al rischio del primo volo, al vuoto da attraversare per congiungersi alla leggerezza di una forma.
Il silenzio. Il persistere del silenzio e il transitare nella parola si compenetrano intimamente in un possente movimento endogeno.
La parola è l’ascendere di una forza vitale da inesplorabili profondità. Il grido che la segue è il segno dell’apparizione e della consistenza: il ripetersi dell’evento della nominazione.
Questo controtempo che va materiandosi attesta l’importanza del pensiero capace di non smarrirsi davanti all’enigma di un cammino da un luogo seminale a un luogo di piena manifestazione.
L’essere creaturale è qui rappresentato nel suo stadio compiuto: quello del suo entrare nell’ombra per rendersi riconoscibile.
Nelle scritture raccolte in questo numero di “Anterem” la parola è colta nell’attimo in cui l’involucro protettivo si spezza. Il silenzio involgente cede e ci restituisce a un movimento inarrestabile che torna a narrare la vicenda della nascita.
Una creatura entra nelle maglie di un destino e comincia a conoscere la strada che la porterà a tracciare l’arco della sua scalata verso la compiutezza e poi verso il declino.
In queste scritture si fa cenno al viaggio verso le oscurità ctonie, verso tutto ciò che si colloca dopo il limite della temporalità. Si va allora dalla definizione dell’essere al suo seme iniziale. Dai gradini del tempo all’atemporalità.
La figura intravista nel movimento dell’anacrusi diventa il simbolo di ogni presenza terrestre. Incarna l’idea di silenzio diventando voce, nome, bisogno, piacere, dolore.
Astrazione e materialità trovano così un raccordo indissolubile. L’una non esclude l’altra; anzi l’una è dall’altra chiamata entro quella vivente unità che nega il principio di non contraddizione.
In ognuna di queste scritture c’è un tratto in cui la pronuncia e il pensiero si compenetrano. Qui lo sguardo deve posarsi: nel fuggevole spazio posto fra l’incrinarsi del rivestimento e quella sottile pelle che preme per liberarsi: fra il tempo del mondo e il tempo soggettivo.
L’atto di preludere – su cui fa presa, nella durezza del silenzio e del vuoto, il vocabolo “anacrusi” – è l’esperienza inaugurale sulla quale convergono i testi proposti da “Anterem”.
Nell’intervallo fra un prima occultato e un dopo appena visibile sta il loro senso.
Flavio Ermini
n. 75, Dire
Al di là della parola riluce il silenzio.
Rosenzweig
1. Ogni parola, se sappiamo ascoltarla, chiama dall'essere silenzioso delle cose. Intorno al mistero del silenzio - e al sussurro che dal silenzio si leva a ogni inizio del tempo - tesse la sua frase e procede verso il dire.
1.2. La frase è terra di frontiera tra le cose e l'uomo. In questo "tra" la parola non contiene più solo la parola, ma anche il silenzio, e le cose permangono nella loro originaria vitalità.
1.3. Il dire è luogo della coincidenza tra silenzio del possibile e sussurro, ma è anche luogo della metamorfosi, che si aggiunge alla creazione del mondo per sostanziare la vita.
1.3.1. Essere chiamati alla parola significa dover dire per poter essere.
1.3.2. Ecco perché la via alla parola non conduce semplicemente da un luogo a un altro, da un senso all'altro, ma ci porta ad appartenerle.
2. Già convocato alla flessione del vocabolo "anacrusi" sul n. 74 di "Anterem", Blanchot aggiunge qualche riga a proposito del "dire": «Quella parola monotona, distanziata senza distanza, che afferma al di sotto di ogni affermazione, impossibile da negare, troppo debole per essere taciuta, troppo docile per essere padroneggiata, che non dice qualcosa ma soltanto parla, parla senza vita ».
2.1. La parola di cui torna a parlarci Blanchot non arretra di un passo dinanzi al sensibile e nello sperimentarlo è suscettibile di autenticità. Questa parola sfida la lingua a nominare il silenzio della vita, istituendo quel colloquio originario in virtù del quale ascoltare e dire trovano la loro unità.
2.1.1. Il pensiero, finalmente, è la stessa cosa del sangue che bagna il cuore. Nella parola che lo forma c'è il mistero della consonanza col mondo, non figura ma essenza delle cose. Una parola "delebile", sottratta alla coscienza per mettere in essere le cose, così come annuncia la pagina rilkiana: «Terra, non è questo ciò che vuoi, / invisibile risorgere in noi?».
3. Il dire richiede di farsi ciechi per le cose della terra e di affidarsi a una vista superiore (epopteía, "guardare al di sopra"): per testimoniare così dove finisce il silenzio e comincia il sussurro; dove, alla minaccia del pericolo, sopraggiunge il grido.
3.1. In questi orizzonti del dire alcune forme appena accennate si sollevano e galleggiano. Altre forme relittuali svaniscono. Sono presenze che gravitano brevemente intorno al proprio centro, per poi essere cancellate da forze esterne, come accade nell'ultimo Celan, nel suo frammentare, rinumerare, fare a pezzi la lingua, balbettando, brancolando a tastoni.
3.1.1. Nel dire, sulla pagina viene ripetutamente consumata una apparizione-dissolvenza di quel «sussurro» che, come annota Mandel'stam «nacque forse già prima delle labbra» e che nulla sa di quello che lo precede e lo segue, pur testimoniando, come precisa Blanchot, «il trattenersi delle cose nel loro stato latente».
3.2. I nuclei alfabetici del dire, in sé compiuti, incomunicabili fra loro e non configurabili in un discorso, mostrano che viviamo per frammenti espressivi. Le frasi che pronunciamo non si allargano in periodi e il periodare, quando si verifica, non ha la capacità di dare impulso a un discorso totalizzante.
4. Nel dire accade il ritrarsi e il salvaguardarsi dell'essere; il suo manifestarsi, nel suo sorgere come nel suo svanire.
4.1. Il dire fonda un abitare in cui si danno convegno le parole colte nell'atto di assentire alle cose e non a una rappresentazione tranquillizzante delle stesse.
4.1.2. È grazie a questo universo che la parola è parola. Una parola prima del pensiero, alla quale il nome "parola" forse non conviene più. "Sussurro", magari, che si esprime nella forma elementare del respiro e dunque della vita.
4.1.3. Proprio quel respiro che si sottrae per sua natura alle parole ha voce nella poesia.
4.2. Il dire sorge da quello spazio vuoto che la poesia è andata a occupare con il suo respiro, compiendo l'isolamento inaudito della parola e assegnando a essa, per la sua intransitività, la chiave della propria decifrazione.
4.2.1. La parola vive di vita propria. È per essa che qualcosa giunge a stare di fronte. Il dire è sempre, in primo luogo, ascolto della parola che a noi si rivolge per essere accolta.
5. Noi abbiamo il compito di restituire la parola a quanto è stato costretto a tacere, per un ascolto fedele di ciò che chiede di essere tratto dal silenzio, ovvero la parte non significabile che abita l'ombra di ognuno. Proprio come si chiede Bonnefoy: «C'è qui, sull'orlo di chi siamo, un impensato da capire? ».
5.1. Questa parte oscura del dire è la nostra fonte. «Al di là della parola riluce il silenzio» annota Resenzweig. E aggiunge: «Dio stesso sta lì, redento dalla sua stessa parola. Tace».
5.2. La traduzione del silenzio non si può stabilizzare in alcuna forma: il movimento della scrittura conduce la frase ogni volta a strutturarsi e a disgregarsi. In quel culmine si colloca per un momento la poesia.
Flavio Ermini
n. 76, Dire la vita
... l'incessante apertura dell'apparire ...
Gabellone
Nella poesia interminabilmente viene alla vista il non-veduto della vita. Per altro verso: la parola poetica è esposta a un "fuori" invisibile, e quel "fuori" mette l'opera alla prova del mondo. Ma come accade?
Sul n. 75 di "Anterem", dedicato al Dire, Pascal Gabellone scrive: «La possibilità della poesia poggia sulla certezza sensibile che il mondo, prima di essere semplicemente "ciò che è apparso", la cosa nel suo riposo, il visibile dato come tale, sia l'incessante apertura dell'apparire che, nell'apparso, resta sepolto, invisibile, eppure reale; meglio, il reale stesso».
Vediamo benissimo i limiti della poesia quando è priva di un richiamo alla presenza, ovvero fine a se stessa e separata dal pensiero. Per questo crediamo, con Max Loreau, che si debba «cercare una scrittura che non sia affatto un fine in sé = che non sia per l'esattezza "letteraria" o "estetica"».
Tale decisione richiede di meditare ulteriormente sull'essenza della parola poetica e sul suo destino.
Il cercare persiste nel domandare, e lo fa proprio perché si trova in fondamentale rapporto con ciò che nella vita si rifiuta a ogni inchiesta e si sottrae alla risposta, in una finitudine senza fine. È quanto fa "Anterem", questa rivista che in ogni numero si costituisce come opera che torce lo sguardo sempre verso un nuovo inizio, là dove ogni volta - con una domanda - tutto comincia.
Leggiamo cosa dice Heidegger: «Il nostro scopo è il cercare stesso. Che cos'altro è il cercare se non il più persistente essere-vicino a qualcosa che si nasconde, qualcosa a partire dalla quale proviene ogni bisogno e si accende ogni esultanza? Il cercare stesso è lo scopo e, nel contempo, il ritrovamento».
Ecco perché il dire del poeta è un pre-dire che reca l'annuncio di ciò che viene nel suo carattere di evento che è sempre a venire.
In questo senso siamo autorizzati a parlare qui di ricerca della verità: trovare nomi nuovi per ridefinire il permanere della parola nell'orizzonte della domanda, facendo emergere le prospettive che essa dischiude; lasciando risuonare l'inespresso, custodendolo e serbandolo come inviolabile segreto, irriducibile alla rappresentazione.
«Il problema» scrive Schelling «non è se e come esista realmente fuori di noi quell'insieme di fenomeni e di cause e di effetti che chiamiamo vita della natura, ma come esso divenga reale per noi, come quel sistema e quell'insieme di fenomeni abbiano trovato la via per giungere al nostro spirito ...»
Si tratta insomma di capire come la poesia possa ancora salvare il gesto della prossimità all'animale, al silenzio, al fiorire della physis, e nella nominazione renderlo intelligibile.
Intanto va detto: che ci sia poesia testimonia che c'è desiderio di relazione con ciò che è a venire.
Stando dalla parte di ciò che si offre come ignoto - dalla parte dell'ombra - la poesia testimonia che la vita non coincide con ciò che è.
Nemmeno l'origine è più vista soltanto come fondamento, ma anche come ritrarsi, come rimosso. Da qui la persuasione dell'essere agiti e dominati da un Altro che è fuori di noi.
Il discorso - ciò che appare ben definito e formato - è il muro che comunemente si erige contro i pericoli che nascondono il thauma dell'origine e l'Altro che, in costante metamorfosi, lo abita.
È questo particolare pensiero arrischiante che prende forma di poesia. Il poeta, annota Keats, guarda nella nebbia e «lascia imperturbato che la bellezza passi come un rivo sotto la sua soglia».
L'opera si manifesta con un movimento ascensionale di insurrezione che, lasciandosi alle spalle il discorso diurno, punta a una regione notturna, verso un rischio ulteriore.
Dire il non-veduto della vita dopo che la lingua si è liberata dalla sua funzione rappresentativa, significa dire la "nebbia": allearsi con la parola accanita che vuol parlare con la pietra.
Sorgere è quell'erompere dall'inapparente per il quale la physis appare, diviene manifesta, senza tuttavia che il celato da cui proviene possa mai compiutamente mostrarsi.
L'esercizio della nominazione, in questo particolare processo di svelamento, richiede che ci si interni nel profondo del cogito: nella parola che l'ha pensato.
Solo così il lavoro poetico - questa attività sottostante al pensiero esplicito - potrà riflettere l'Altro da sé. Quell'Altro da sé che è il suo più proprio se stesso.
Ecco perché l'opera non è affatto un luogo sicuro, saldo, fidato, ma è tale da contenere in sé l'estremo pericolo: il non che si lega alla parola: il suo opposto, che la salva.
Di queste originarie "forme di vita" siamo chiamati a fare esperienza in questo numero di "Anterem", in cui centrale è un'aporia: come giungere a conoscere e comprendere ciò che nella sua essenza appare ogni volta in modo diverso?
Flavio Ermini
n. 77, Forme di vita
Wittgenstein
Nella poesia viene alla pronuncia la physis nel suo fiorire: quella “natura” che si nasconde fuori dalla storia, ma prima e a suo fondamento: nel tempo originario.
Questa dislocazione produce nella parola una rottura, un cambiare rotta, in un vero e proprio manifestarsi del luogo che ci è proprio e che ci rende propri.
È un cammino verso la vita e si lascia indietro ogni consuetudine e certezza; conduce verso l’ignoto e l’estraneo; consente d’immaginare un altro luogo: un fuori che impone di obbedire al proprio respiro.
Qui, ciascuno non è più se stesso e insieme il suo negativo, ma se stesso soltanto quale negativo di sé: la natura stessa.
Il dentro e il fuori della vita non possono essere separati: agiscono nella parola, sono la parola stessa, dove il fuori è travagliato dal dentro e il dentro è fessurato, aperto al fuori.
Al poeta accade come a Ewald Tragy che «aspetta ancora mezz’ora, ma la vita non arriva. Allora si alza lui e decide di andarle incontro». Per questo si dice che il poeta abita quel luogo atopico, quel “tra” che dissesta e conduce in un altrove: nella vita in cui già da sempre siamo.
Osserva Celan: «La poesia non s’impone più, si espone», tanto che il proprio
viene compreso a partire dall’estraneo, e l’estraneo – ciò che incessantemente apre all’apparire – può essere percepito e raggiunto mediante la parola: dalla parola ricava forma e verità.
La poesia «si espone» al sentire prelinguistico, quel sentire che ci manca e ci spinge al dire per ritrovarci. In questo processo le parole sfuggono al dominio del concettuale e delle categorie; interrompono l’infinito intrattenimento della lingua; si pongono in relazione con il forire della physis.
Annuncia Hölderlin: «Sovente allora chi interrogò il suo cuore / dice di quella vita che genera parola». Dire la vita, dunque, è scoprire in sé l’alterità e il suo interminabile affiorare.
Ma come portare a parola la materia nuda e silenziosa che si agita al fondo della
nostra vita?
Va corretta la convenzione che considera il poeta come produttore e detentore del dire. È ormai chiaro che la responsabilità della parola si fa presente solo sulla soglia di qualcosa che può essere atteso, e unicamente quando su questo “tra” non viene esercitata dall’autore alcuna forma di dominio, d’imposizione.
Prima di domandare, noi siamo dalla vita domandati e ad essa dobbiamo corrispondere, perché sulla nostra risposta si fonderà la nostra essenza.
L’esperienza poetica del pensiero non sta nel contemplare, nel vedere, nel conoscere, ma nell’esposizione all’ascolto. Qui, solo in apparenza c’è in gioco esclusivamente la poesia.
Arrischiandosi nel mondo prelinguistico, il corpo scrivente accosta la vita a qualcosa di principiale: la notte dei tempi che continuamente viene, dopo ogni giorno, con la notte.
«Una belva preesistente all’uomo preesiste sotto lo status quo ante ontologico» ci avverte Quignard. Sotto lo stato presente dell’ordine vi è un tempo indefinito e indeclinabile di vita. È il perduto che solo nelle parole si rianima.
Un fuori dal tempo dà tempo a una forma di vita originaria.
La parola poetica fa segno all’oscuro che precede la nascita e che accompagna in ogni momento la vita. Ci induce al gesto di disvelare; possiede una misura di dire le cose che le preserva, le lascia essere nel loro essere e dicendole crea in sé un analogo di ciò che le cose sono.
In questo processo accade sostanzialmente un ritorno della parola a se stessa quale cosa. Non segno, ma luogo di un apparire: una fonte, un prima che – sempre oltre – incessantemente viene alla vista dalle profondità ctonie della terra.
La poesia conferma che non c’è mai stata una qualche mattina nella nostra sera.
Nemmeno ciò che è originario appartiene alla luce. Solo l’illusione, denuncia Nietzsche, «fa credere che al principio di tutte le cose si trovi il più perfetto e il più essenziale».
Il dire poetico porta ogni volta il pensiero a quell’inizialità del dire dove la lingua vive ancora la drammaticità di un conflitto che la contrappone a se stessa.
Ed è ravvisabile nelle “forme di vita” che trovano spazio sul n. 77 di “Anterem”,
in questi segni contrastati che, nel loro sembrare campo di battaglia, si costituiscono come un oscuro e insopprimibile tratto costitutivo della vita, un modo d’intendere che trasforma.
Flavio Ermini
n. 78, Apostrophé
Vincenzo Vitiello
Torniamo a parlare del principio e del suo interminabile apparire. Parliamo di qualcosa che, con una domanda, ogni volta comincia e, con l’ultima domanda, prepara il nuovo inizio. Là tra le due soglie è la physis: che impone di sterrare e dissestare la nostra vita, scoprire l’originaria lingua che è al suo fondo.
La ricchezza dell’essere non coincide con il mondo manifesto: risiede nel non-veduto di quel mondo, nella parola che da ultimo noi siamo.
Quella parola segnala in primo luogo l’apertura verso ciò che non ha nome.
Ecco il carattere ortivo del dire la vita.
Nella domanda prima – in quel chiamare principiale – risuona la parola che può dispiegarsi nell’opera poetica.
È la scena aurorale della scrittura.
Quella scena in cui la parola “è” nel suo movimento verso la cosa.
Quell’aurora per cui s’impone la fuoriuscita dell’ente da un fondo di occultamento.
Quella scrittura che si manifesta in un processo mai concluso di uscita dal Lethe.
Si tratta di tornare alla parola che ha consentito all’uomo di fare esperienza dell’ente nella sua interezza; del “tutto” che il dire ripete in ogni istante, incessantemente, e che conferisce alla lingua una sostanza entelechiale che la emancipa da ogni successivo uso strumentale e derivato.
Di tale parola va custodito con cura particolare il senso, nella consapevolezza che solo arrischiandosi nel dire autentico all’uomo è consentito di cogliere qualcosa della propria essenza.
Questo passo – la cui misura si è conservata nel vocabolo grados – porta dal visibile al non-veduto della vita ed è riconoscibile nella figura dell’apostrophé, il cui nome significa propriamente “deviazione”, “sviamento”. Deviazione dalla lingua «del mondo»; sviamento verso il tu dell’antidiscorso.
A tale proposito, come non ricordare, con Celan, che la poesia è «forse soltanto uno sviamento che porta da te a te»?
In questo “sviamento” l’io si allontana da sé, si autoestranea, si destina a un altro, lo fa essere tu a se stesso – altro dall’io – e lo lascia essere nella sua estraneità.
L’altro è il punto di arrivo del movimento intenzionale che caratterizza la ricerca della parola poetica, l’unica in grado di condurci all’insorgenza dell’antipensiero, ovvero alla convergenza del sapere con il da-pensare.
Tale «sviamento» nasce dal desiderio di dare respiro al respiro della parola; scaturisce dalla necessità di far risuonare il silenzio originario, quel silenzio da cui ognuno di noi proviene e nel quale ciascuno, ascoltandolo, torna a dimorare.
Il tu della parola ha un compito capitale: spingersi fino al limite del dire oltre il quale ha luogo la contesa originaria che nomina l’iniziale differenziarsi del tutto. Chiama dal silenzio. E ci invita a testimoniare un limite: toccare i bordi dell’essere.
Il senso di quanto il tu sta per dire ancora non c’è in nessun luogo. Cercarlo impone davvero di metterci in viaggio verso noi stessi e di tradurre in pienezza di assenso l’appello dell’ombra celata nel taciuto della vita.
L’apostrophéè una figura che sta alla base di tale relazione e proprio per questo – per la sua fondatezza – presiede alla possibilità che la poesia si faccia presente.
Nell’apostrophé la parola torna alla sua incontrollata libertà originaria.
In tale processo la parola non è ancora asserzione ma un coappartenersi di presenza e assenza, nel fiorire della presenza stessa.
Ce lo conferma Celan quando a proposito della poesia di Mandel’stam scrive: «La poesia è linguaggio di un singolo diventato figura: possiede capacità di resistenza, permanenza, vigilanza, presenza».
L’esperienza poetica del pensiero coincide dunque con il moto nascente della lingua. Ecco perché la parola che stiamo ascoltando è vicinissima a ciò che siamo. Ecco perché scopriamo che non c’è sostanziale diversità tra quella parola e il silenzio che assedia i bordi dell’essere.
Quella parola è la salvaguardia di ciò che la vita non dice. Grazie a essa è possibile andare a riprendere il tu che irrimediabilmente sembra falciato da ciò che è apparso.
Il tu definisce l’io, altrimenti indicibile, e giunge al mondo come il giorno sopraggiunge alla notte, solo in quanto da essa negato.
D’altro canto, l’io è sottoposto allo sguardo di colui che, richiamandolo a sé, lo situa e – proprio come sguardo – lo costituisce.
L’ascolto del tu è la condizione per dire la vita.
n. 79, Tu
E guardai gli altri
E non bastava ancora
Inge Müller*
1.
La scrittura poetica chiama in causa a ogni parola la pluralità delle parole di cui è composta. A ogni battito temporale, nella parola viene convocata l'intera sfera mondana.
La scrittura poetica abita un mareale presente, dove le forme emergono e svaniscono, lasciando minime tracce; e dove ciascuna forma è intimamente collegata alle altre, in un destino globale di composizione dell'essere.
Queste forme di vita tendono a farci riconoscere la struttura metamorfica dei fenomeni anziché quella consolidata.
Le contraddizioni che avvertiamo sono conseguenti alla nostra incapacità di dare significazione e senso ai dati in atto.
Il tempo della scrittura poetica trova corrispondenza nell'«infinito eccesso del verbo», nella più grande disparità dei suoi lacerti, come se il peso della materia verbale si risolvesse totalmente nell'imponderabilità di un'energia universale.
2.
Al centro della scrittura poetica c'è il concetto di spazio. Uno spazio che si manifesta come genesi di mondi: venuta incessante di forme e presenze che, pur sottomesse alla caduta, ci parlano di ritorno e rinascita.
Nella scrittura poetica è inestricabile il legame che viene a crearsi tra spazio e tempo. Da questo legame apprendiamo quanto breve sia il volo terreno e quanta energia esso riesca ad esprimere.
Siamo osservatori e insieme costruttori di uno spettacolo che affonda in plaghe remote e ci fa misurare il valore della nostra fugacità.
Le pagine di letteratura che "Anterem" presenta in questo numero indicano come il persistere e il transitare si compenetrino intimamente, in un possente movimento endogeno. Porgono l'immagine dell'ascendere di una forza vitale da inesplorabili profondità.
Nel loro affiorare e offrirsi alla lettura, per poi capovolgersi ogni volta nella forza oscura della cancellazione, sta il rinnovarsi continuo del senso.
Questo spazio che va materiandosi in parola testimonia la suprema importanza del pensiero capace di non smarrirsi davanti all'enigma.
3.
Il tempo e lo spazio della scrittura poetica sono abitati dall'io, sempre preso nel cerchio di una riflessione il cui oggetto è rappresentato dalla sua identità.
Il tu è colui che lo incontra: si oppone e si integra a un tempo con l'io, ma sempre secondo una strategia sovversiva: dischiudere attraverso la parola le vie dell'ascolto e della metamorfosi stessa di sé.
Il tu è qualcosa di più di un destinatario: è il congegno che fa saltare l'ordine istituito dal noi e dal processo dialogico che lo presiede, innescando un movimento di rivoluzione.
L'incontro con il tu è l'atto che, inaugurando un'apertura verso l'inconosciuto, rompe con la tradizionale propagazione dei saperi e il suo circolo dialettico.
Il tu viene alla parola mantenendo la propria alterità. Ma non un'alterità neutrale o parallela. Il tu viene alla parola come un'antimateria che perturba radicalmente l'ordine e la creazione. Scrive il suo essere chiamato a dire e parla il suo tornare alla parola ortiva.
Aprendosi un varco attraverso il tempo e lo spazio, la figura del tu si lega con l'esperienza di un movimento verso ciò che continua ad accadere.
Il tu si fa presente quando la parola appare come congedo verso ciò che si nomina, quando ogni discorso è chiamato a sciogliersi della violenza del grido e il pensiero abbandona anche l'interiorità della coscienza e diventa pensiero del limite.
Non trasmette alcun messaggio, non ha nulla da comunicare. Semplicemente appare.
Nel tu, l'io si riflette e si ripete, moltiplicato. «Tu hai inteso una lingua di stranieri» annota con precisione Hölderlin.
4.
Il tu, come pensarlo? Occorre uno spazio ulteriore: una soglia dove suono e silenzio - ovvero chi pronuncia e il mondo che viene pronunciato - sembrano obbedire a identiche valenze. Qui uno spirito unificante congiunge l'uomo alla natura.
Il tu non ha un corpo, ma condivide con i corpi un tratto essenziale: la nudità. Per questo dice qualcosa che ci riguarda intimamente, qualcosa che ci tocca in modo essenziale. Si lascerà conoscere solo a patto che nel pensare siamo disposti a essere trasformati dall'incontro con la parola, per disporci ad accogliere un altro pensiero, un sentire che si misuri con l'esperienza poetica.
Nel tu ogni cosa scorre, oscilla, incombe. In questo incontro non è possibile pianificare ciò che viene, né riordinare ciò che è stato. Non resta che aggrapparsi con tutta la vigilanza possibile a quel punto in cui si sta e che si chiama esistenza.
5.
La parola poetica nasce nella natura interrogante dell'esistenza, di cui il tu è testimone. È una sorta di allocuzione infinita che segue le tracce dell'assente: uno spazio interrogante che si delinea sempre più come un luogo in cui l'io si proietta fuori di sé e nella lingua riesce a portare a compimento ciò che muta del sapere.
La frase poetica rompe l'isolamento dell'io. Lo invita alla prossimità con il tu e con l'enigmatica opacità che lo circonda, dovuta alla sua lontananza temporale e spaziale.
Nel testo risuona così il movimento dal detto al dire, fino al dire altrimenti, che si curva irreversibilmente in un dire all'altro, in un portare e porre la domanda, nello scuotere il minaccioso dogmatisno del logos paterno con l'antipensiero.
Il tu è chiamato a dire questo nuovo sapere, che implica un sovvertimento dei sensi: recuperare sulla terra i tesori che erano dispersi nei cieli.
6.
Sempre precaria, la scrittura poetica è minacciata, esposta. Riconosce il tu senza sottrargli la sua singolarità.
Il carattere del possesso impossibile del tu e della bellezza di tale impossibilità si fa presente nell'abitare dell'uomo. Un abitare di cui la poesia è misura, ma è misura esorbitante.
In questa dimensione, che si fa riconoscere nell'oscillazione fra presenza e assenza, riconosciamo il precipizio dell'assenza di fondamento.
Scrive Nietzsche: «Non è il nostro un eterno precipitare? E all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non abita su di noi lo spazio vuoto?»
Tutte le dimore che possiamo edificare nel tempo sono provvisorie. Il tu segna ogni volta le loro mobili frontiere. Ci allontana da noi stessi e dalla nostra storia, per avvicinarci sempre più al principio: un incontro sempre rinviato, sempre annullato, cancellato, ma mai dimenticato.
Sopportare la durezza e la solitudine dei luoghi che s'incontrano è la condizione di questo turbinoso avvicinamento, nel corso del quale il tu combatte la sua estrema battaglia, come avamposto perduto e sentinella del nulla. Sarà proprio questa accettazione del nulla che permetterà alla scrittura poetica di sperimentare ancora una volta la molteplicità dell'io e la frammentazione della sua lingua.
Le meditazioni sul tu che abita la scrittura poetica ci indicano che dopo l'attraversamento dell'estraneità - attraverso un'interiorizzazione che trapassa nella più radicale esteriorità - è possibile delineare quanto ci è proprio.
Flavio Ermini
n. 80, L'esperienza poetica del pensiero
consistenza propria. Assumono quella che noi
intendiamo conferire loro. L’esperienza poetica
è andare verso qualcosa e, nello stesso tempo,
costruire quella cosa stessa.
Silvano Martini
Il numero 80 di “Anterem” inaugura una nuova serie della rivista, la sesta, con la quale ci proponiamo di enunciare e approfondire alcune questioni relative al- l’esperienza poetica del pensiero.
È un numero problematico. Mette in pagina una pratica conoscitiva che, senza indulgere all’illusione di potersi costituire in sistema, si declina in molte articola- zioni. Entra subito nel merito della tematica e chiede al lettore un ascolto partico- lare: un ascolto “attivo” che gli consenta di attendere quel che può essere davvero detto dal pensiero, quando questo si mette all’altezza di una parola proveniente da un altro luogo.
Questo numero documenta quanto mobile sia la disposizione interrogativa alla quale ci affidiamo e mostra il preciso configurarsi di una tensione riflessiva che trae la propria linfa da elementi propri della poesia.
In ciò si rivela decisivo l’intervento di poeti e pensatori che, accogliendo nel pen- siero qualcosa di impensato, aiutano a comprendere e a salvaguardare la parola nella sua purezza e nelle sue tonalità emotive.
«Siamo marinai che devono riparare la loro nave in mare aperto» annota Otto Neurath, annunciando il fallibilismo di ogni riflessione filosofica e scientifica che tenda a proporsi come enunciato protocollare.
Il che non significa coltivare l’incertezza e l’indecisione, ma prepararsi ad assume- re la finitudine del pensiero e delle sue parole più appropriate come guida.
In questo senso abbiamo deciso di scommettere su alcune poetiche e su un pensiero che, orientando verso la frontiera di una lingua incognita, sono in marcia verso di essa, pur nella consapevolezza di non poterla mai compiutamente attraversare.
L’uomo non può sapere tutto ciò che dice ed è esposto, se vuole saperlo, alla pos- sibilità dell’errore.
Il dire prevarica sul detto e dà luogo a un pensiero incamminato verso quanto si sottrae, così come richiede la poesia che non può permanere in nessun senso, né stabilirsi in alcuna interpretazione. Un pensiero che – schiudendo le porte della coscienza ai dubbi e alle interrogazioni – nulla lascia intatto di quanto di accomo- dante si perpetua nel pensare.
Non c’è un fondamento al quale aggrapparsi. Formulare una domanda sul lin- guaggio non significa cercare per essa una risposta adeguata, ma esplorare lo spa- zio stesso dell’interrogazione. E non potrebbe essere altrimenti se ogni domanda sul linguaggio presuppone il suo parlare già dal linguaggio. Ed è lì che si tratta di operare ogni volta un rivolgimento, nella cui incompiutezza c’è qualcosa di silen- zioso che viene a interrogarci.
I saggi qui raccolti si affidano a un pensiero che vuole restare in cammino. L’intento che li anima è di raggiungere alcuni luoghi in cui l’esperienza del pensiero si rac- corda con la poesia; prestando la massima attenzione all’intersecarsi in un punto, senza tuttavia perdere di vista il tracciato dei fili che lavora alla sua formazione.
Abbiamo abdicato dalla centralità del metodo e seguiamo le tracce che portano alla natura metamorfica del linguaggio.
La scelta di questa via obliqua ci pare forse la più idonea a seguire il cammino di un pensiero che non ama essere ordinato in una struttura categoriale.
Il nostro ricercare intende corrispondere all’estremo rigore del dire pensante. Ecco la questione sulla quale rimane situato e imperniato il nostro pensiero.
Nell’ordire l’intricata rete dei testi poetici, narrativi e teorici che formano questo numero, abbiamo inteso privilegiare la precisione nell’aderenza al tema, indi- viduando ogni volta le difficoltà, misurandole; di volta in volta sforzandoci di trovare una risposta o accogliendo come dato ineludibile l’incompiutezza.
I passaggi tra i vari testi non risultano univocamente determinati. Ogni contribu- to di indagine e di riflessione muove da attese create dagli altri lavori che trovano spazio nel numero e conducono non verso una teoria critica conclusa, ma verso un’interminabile interrogazione.
Bisogna intendere bene cosa sia l’esperienza poetica del pensiero. Queste pagine cominciano a mostrare in quali radici affonda e in che cosa consiste la sua radicale differenza e irriducibilità rispetto ad altre forme di conoscenza, più specificamente filosofiche e scientifiche.
Il colloquio tra il pensiero e la parola poetica – quando il pensiero si mette al- l’altezza di una parola proveniente da un altro luogo – è un momento struttura- le, decisivo del pensare che accade nel linguaggio. Nel rapporto che si istituisce, ognuno dei due termini viene sospinto al limite del proprio senso, per offrirsi a una produzione di senso principiale.
Flavio Ermini
n. 81, Poetiche del pensiero
... ma quello che c’è non è ancora abbastanza,
e allora si scrive per farlo esistere
Aldo Giorgio Gargani.
L’esperienza poetica del pensiero coincide con il moto nascente della lingua. Nella consonanza che si crea, il pensiero ha il compito capitale di spingersi fino al limite del dire, oltre il quale ha luogo la contesa che dà principio al differenziarsi del tutto.Su quel limite, dove il silenzio assedia i bordi dell’essere, la nominazione è affidata a una parola che s’impone come risultato di un problematico processo di riappropriazione.
L’origine, infatti, è accessibile soltanto a posteriori, a seguito di un movimento che compete al pensiero solo perché, prima di tutto, appartiene all’esistenza ontologicamente intesa: nella forma di una dilacerazione sempre annunciata. Non c’è ritorno che non debba passare attraverso il dolore di un esodo senza fine.
Grazie all’esperienza poetica del pensiero, il progetto della razionalità umana si scopre gettato nel dominio del prelogico.
Lo stagliarsi l’uno di fronte all’altro, l’uno per l’altro, del poetare e del pensare richiede di fare ritorno a quello stato di pura indeterminazione in cui l’essere umano viene a trovarsi prima che qualcosa provochi un’impressione sui suoi sensi.
Va abbandonato quanto ci è familiare, al fine di attraversare per intero l’estraneo e aprirci così a una parola proveniente da un altro luogo: l’uguale a zero hölderliniano.
L’estraneo diventa dunque la zona essenziale e decisiva per l’accesso alle tenebre.
Questo numero di “Anterem” annuncia che l’estraneo richiede di non pensare più ciò che prima già era stato pensato. Lo fa attraverso un richiamarsi reciproco di poetiche del pensiero che impongono uno sporgersi dal proprio limite, e indicano verso la lontananza dell’altro.
Le tenebre si lasciano comprendere a partire dalla verità resa manifesta nei passaggi che dalla luce portano al buio.
Il pensiero che digrada nella tenebra è annunciato da Nelly Sachs: «Luminosità rientra nel verso scuro / sventola col vessillo ragione / nel grigio mi tocca cercare / trovare è altrove». Ma spetta a Nietzsche, attraverso la voce di Zarathustra, registrarlo: «È notte: ora parlano a voce più alta tutte le fonti sorgive». Conclude Freud: «Sembra confinato nella vita notturna ciò che un tempo dominava in pieno giorno».
Va narrata questa storia di tenebre che è prima della storia stessa.
Fare esperienza del pensiero poeticamente significa sperimentare un linguaggio che trasforma la vita e la compie nella sua disposizione alla scrittura.
Poesia e pensiero hanno origine da un terreno comune: la struttura umbratile dell’esistenza umana che si progetta come ricerca di senso. Il territorio sul quale agiscono è senza effettiva giurisdizione, è privo di reali gerarchie e destituito da princìpi-guida.
Tra pensiero e poesia il colloquio torna a essere urgente e necessario, così come resta indispensabile convocare la facoltà dell’immaginare: non si pensa se non immaginando.
Ricorda Leonardo: «È costume scrivere di cose mai esistite, e questa libertà è assennata e coerente con il vero». È attraverso questo processo che il poetare raggiunge un livello riflessivo che lo intreccia al pensare.
Pensiero e poesia si specchiano senza fine, una volta e ancora un’altra, interminabilmente contro l’una volta per tutte del “sempre” iniziale. La loro coincidenza profonda va sottratta a ogni tracciato lineare e rassicurante, per consegnarla al formularsi sempre nuovo della parola che nomina.
Dopo la deviazione platonica del concetto di verità e ancor più dopo la radicalizzazione di questa deviazione a opera della scienza moderna, l’uomo non può riscattarsi dal suo errare se non si congeda da quel modo di pensare che tende a risolvere l’incomprensibile in intelletto e rappresentazione.
La nostra ricerca indica che nel farsi della scrittura è essenziale un pensiero costitutivamente disposto all’erramento e allo scacco; quindi davvero un pensiero che non sbaglia mai.
È una conoscenza impropria quella dell’arte poetica... Una conoscenza non influenzata da apparati categoriali. Un’esperienza estetica fondata su una comprensione sensoriale: vero e proprio paradigma di un processo conoscitivo che, rimandando alla facoltà dell’immaginazione, giunge a restituire all’uomo parti del suo sé.
Comprendiamo davvero la vita se non abbiamo fatto esperienza dell’incalcolabile – senza soggetto e senza oggetto – che si disloca nella lingua poetica e ci riporta all’originario àpeiron della scuola ionica? L’impegno della lingua poetica è attestato dal patto che nella parola viene deciso tra essere umano come persona e uno come essere. Un patto continuamente violato, se Rousseau può ancora affermare: «L’uomo è nato libero, e dovunque è in catene».
L’esperienza poetica del pensiero implica la responsabilità del pensiero stesso di agire risolutamente – con insistenti tentativi di orientamento – sulle tracce di una rivoluzione.
Flavio Ermini
n. 82, Pathos del dire ulteriore
Ci sono occhi spalancati in fondo agli occhi chiusi.
Bonnefoy
Il modo eminente in cui accade l’autenticità è il modo in cui l’essere umano vede configurarsi nella parola il mistero della propria consonanza col mondo.
È un dire ulteriore: un appello alle cose che, ponendosi al di sopra e al di sotto della ragione e delle sue categorizzazioni, sono.
Tale appello consente di accedere pienamente alla sensibilità e avviene in un progredire che è già un tornare; in un compiere un passo che ci conduce là dove già ci si trova, per divenire ciò che si è.
Il dire ulteriore comporta conseguenze di portata molto vasta, tanto da mettere in connessione i due opposti stati del sentire e del pensare.
L’incontro del pensiero con l’ulteriorità della parola attribuisce alla riflessione la sua forza critica nei confronti dei caratteri alienanti dell’esistenza e impone di compiere fino in fondo lo sforzo di pensare oltre il tempo calcolatorio dell’economia. L’idea di una via estetica alla liberazione – così come la propugna Marcuse – può ancora indicare un cammino realisticamente percorribile.
Che cosa consente alla sensibilità di farsi cifra della vita stessa e di rispondere alla domanda dell’estetica sull’etica? Ciò accade quando il mondo si annuncia facendo cenno al pathos del dire ulteriore: lasciando spazio all’esistenza in tutte le sue molteplici schegge di senso. Lo sa bene Hölderlin quando scrive: «[...] e chi più si ama / vive vicino, esausto su / monti separatissimi».
La parola ha tutto da domandare, e il proprio permanere nell’orizzonte della domanda testimonia la sua etica, la sua volontà di introdurci nello spazio dei problemi che chiedono di essere portati alla luce; testimonia l’infrangersi di un’abitudine, l’abbandonare una dimora abituale.
Il rapporto dell’essere umano con la parola svela più di quanto le correnti visioni filosofiche siano disposte a riconoscere.
Ci avverte Bonnefoy: «Ci sono occhi spalancati in fondo agli occhi chiusi», invitandoci così a dire la verità della condizione mortale: la nostra solitudine. La creatura umana è sola sulla terra. È prigioniera in un paretaio che non è l’ombra di un perduto eden, ma il confine, mobile e sempre ridefinibile, tra caducità e caduta.
La parola poetica è la salvaguardia di ciò che la vita non dice. È una parola “delebile”, sottratta alla coscienza per mettere in essere le cose, così come annuncia la pagina rilkiana: «Terra, non è questo ciò che vuoi, / invisibile risorgere in noi?».
Esattamente come l’esistenza umana, l’esperienza poetica del pensiero non è riducibile a ciò che di fatto attualmente è, ma si protende verso ciò che può essere, ovvero il proprio inevitabile da-farsi. Suscita l’opera e l’operare. Chiamando al fare, induce l’essere umano a partecipare di sé.
A partire da questo inizio ritrovato, possono aver luogo una nuova scrittura e un pensare che rifiutino di rispecchiarsi in un sistema già dato delle cose.
L’esperienza poetica del pensiero produce nel pensiero stesso una profonda e inimmaginabile trasformazione che attraverso il sentire lo porta “prima” del pensiero, in rapporto diretto con le cose.
Il pensiero ha se stesso come origine. È un inizio assoluto. La storia può rendere conto solo del suo sviluppo. Non a caso con la scrittura giunge all’opera qualcosa di impensato: quell’articolarsi dello spazio e del tempo nell’avvenimento della parola. È un gesto che produce degli eventi di scrittura tali da risultare più potenti della filosofia e delle poetiche. È un procedere quasi a tentoni nell’ancora impensato, per compiere il quale è forse necessario un difficile balzo tra il non-più e il non-ancora.
Il dire ulteriore è un fare, prima che una teoria. C’è nel dire ulteriore un far accadere ciò che ancora non è: l’opera.
L’opera è una deriva della scrittura, che vive solo nel suo farsi. È un’esperienza che sopraggiunge per un turbamento e un coinvolgimento profondi dell’essere umano. È la modalità di un sentire radicalmente alternativo all’apatia del pensiero tipica dell’età della tecnica.
È incessante il richiamo alla responsabilità che impone la parola poetica. Assegnando l’essere umano all’ascolto, lo sottrae alla cura ordinata di un sapere disciplinato – rassicurato da un metodo, rafforzato da uno statuto, da un canone – e lo consegna al suo limite, al mistero di appartenere a quanto è assolutamente estraneo e irriducibile al sé.
L’oscurità e la positiva inclinazione al pathos sono state abbandonate perché risultavano scomode. L’essere umano ha preferito risolvere l’incomprensibile in rappresentazione e intelletto, anziché misurarsi con le frontiere del proprio destino notturno, dove la frase poetica – essendo qualcosa di strutturato ma non prevedibile – è ciò che consente l’accesso all’indeterminato, Il pensiero che nasce dalla poesia non procede su alcuna base solida, sicura, bensì su un terreno cosparso da crepe e lacune; ecco perché è all’origine di un sapere ovunque attraversato da profondità oscure.
Parlare dell’esperienza poetica del pensiero è come parlare della nascita di uno sguardo, del primo formularsi di una parola sul bordo di un dire ulteriore.
Flavio Ermini
n. 83, Di un altro dire
L’armonia nascosta è superiore alla manifesta.
Eraclito
Il dire poetico è la casa ospitale in cui nominazione e indicibile possono sostare, in un tenersi insieme dei differenti: nel loro contraddirsi e nel loro opporsi. Il dire poetico è il frammezzo che porta il non-nominabile a nominarsi come originaria contra-dizione.
L’essenza della parola – ovvero ciò che impone alla parola di essere una vera parola – va pensata a partire dalla sua capacità di mostrare nel dire il fenomeno per quello che è, in assenza di pregiudizi.
E se la sostanza del fenomeno è l’indicibilità? Ebbene, la funzione svelante della parola sarà proprio di aver cura dell’indicibile, di custodirlo insieme all’oscurità (l’orphne, così prossima al nome Orfeo).
L’inconoscibile è incessantemente in atto e il dire poetico non smette di segnalarci che è impossibile sottrarci al tempo delle tenebre e dei conflitti.
Il compito del dire poetico è di parlarci della forma umbratile che, risalendo da uno sfondo pre-umano, ci abita e ci trasforma.
Dire: per tornare in possesso della propria ombra.
L’evento del linguaggio – nel dare vita con il nome a un’ombra tra le ombre – rende possibile l’apparire di ciò che non si potrebbe né si dovrebbe mai vedere: l’originaria, fisiologica inabitabilità del mondo. A iniziare da questo evento si può cominciare a riflettere veramente, così come accade davanti alle pitture nere di Goya, sul destino cupo dell’umanità.
Lo sa bene Mary Shelley quando dà parola alla nostra parte in ombra, consentendole di rivolgere un appello al suo ottuso creatore: «Oh, Frankenstein, non essere giusto con tutti per calpestare me soltanto! Me, a cui tu devi non solo giustizia, ma anche bontà e affetto! Non lo dimenticare, io sono la tua creatura: dovrei essere il tuo Adamo, e sono invece l’angelo caduto al quale di proposito tu neghi ogni felicità, sebbene io non abbia colpa».
Lavorando al buio, chi scrive cerca la chiarezza. Lo fa dando parola all’oscurità che lo circonda, ovvero al profondo senza fondo della luce: il fuori come dentro assoluto. Non la notte del tempo cronologico, ma un’altra notte che nessuna aurora può rischiarare. A quest’altra notte non può corrispondere nessun altro mattino. Proprio come la terra verso la quale ci dirigiamo, che altro non è che questa terra che abitiamo, dove da sempre già siamo: una terra che è proprio qui, pur essendo altrove.
Quest’altra notte senza un mattino, sopra quest’altra terra senza una nuova terra, è ciò che rimane indisvelato, ed è proprio ciò che nella parola viene custodito.
Solo un dire che non nasconde il proprio non-detto, ma incessantemente lo riprende, può pretendere di farsi prossimo all’inaccessibile, e forse diventare l’inaccessibile stesso.
Per avvicinarsi alla sostanza ultima del mondo, il dire poetico deve andare al di là del mondo, deve rendersi insensato, fuor-viarsi, dissestare il principio di non contraddizione.
Iniziamo e terminiamo il nostro percorso terreno nella tenebra più fitta, che nessuna luce potrà rischiarare. Grazie al dire possiamo accogliere in noi l’ombra e farne esperienza, così come l’io impara a conoscersi facendo esperienza dell’altro.
Ecco perché non si può cominciare a scrivere se non dal fondo dell’opaco, dal rovescio del discorso: propriamente dall’antidiscorso.
Il vivente umano e il semplicemente-vivente sono compresenti nello stesso essere.
Nel dire, il primo si fa trascinare indietro – come accade a Samsa – dalla metà in ombra di se stesso. Sarà nel corso di questo processo che dalla dimensione sotterranea potrà emergere la parola obliqua dell’errore e dell’imperfezione, la sola che può nominare quel luogo inospitale. Dal sottosuolo da cui l’essere umano parla, una parola mostrante prende la parola e fa sì che l’essere, con il ùsuo dire, si faccia presente, si dischiuda.
Per il vivente umano può non essere sufficiente disporre della parola. Può sentire il dovere di averne anche cura, di abitarla, dispiegando così compiutamente il proprio vivere.
Sono tante le illusioni presso le quali cerchiamo riparo per giustificare la nostra ignavia, la nostra viltà, la nostra paura: dalle ragioni della tecnica alle leggi di mercato, dalla democrazia alla religione. Le illusioni tengono in scacco l’essere umano. Fuoriuscirne significa fare i conti con il sottosuolo, dove chi lo abita – come drammaticamente registra Dostoevskij – soffre di ogni privazione. Per l’uomo del sottosuolo il dire consiste nella fedeltà al già-tramontato, alla propria origine oscura; consiste nel guardare alla sparizione del senso, trattenendo per sé il compito di nominare l’insensatezza.
Flavio Ermini
n. 84, La contiguità alle cose
Mancher auf der Wanderschaft
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden Trakl
La conoscenza vera è conoscenza dell’essere. Ce lo conferma Parmenide: «È infat ti la stessa cosa il pensiero e l’essere».
La conoscenza vera segue il cammino del pensiero, allontanandosi dalla conoscen za sensibile, ovvero dall’apparenza testimoniata dai sensi.
L’apparenza pretende che la via di accesso alla verità sia fondata sul nascere, sul pe rire, sul mutare delle cose, cioè sull’insieme del loro essere e del loro non essere. È ingannevole l’esperienza sensibile così com’è apparente il mondo del divenire. La contiguità alle cose non può avere che il fine di rivelarle nella loro apparenza. Attesta Parmenide: «Anche questo imparerai: come stiano verosimilmente le cose apparenti, per chi le esamini in tutto e per tutto».
Così fa la parola poetica quando segue la via del pensiero.
Il senso della poesia, come quello dell’esistenza, sta nel suo prendere posizione per l’essere, prima di volgersi a qualsiasi altra destinazione. Solo così potrà coincidere con il pensiero e interrogarsi sull’enigmatico sentiero della conoscenza.
Nella poesia viene messo in scena un modo di guardare che consente di cogliere il punto in cui esattezza e verità coincidono: «vedi, io salgo, vedi, io cado / sono un altro, non un altro» registra Celan.
Va seguito con attenzione il disegno del pensiero che tende a quei limiti della parola che sfiorano l’iniziale differenziarsi del tutto. In verità, luce e notte sono una cosa sola, ci ricorda Parmenide.
Quando il disegno del pensiero giunge a concepire il principio indifferenziato, significa che non è lontano dall’aperto in cui si affermerà l’opera.
Va ben interpretato il disegno del pensiero che si assume il difficile compito d’in scrivere lo spazio e il tempo nella parola poetica; ne va aiutata la comprensione. Va seguito il disegno del pensiero, nelle sue delicate funzioni di accennare dall’aperto all’inconosciuto, serbandolo nella sua inesplicabilità, e di recare nel tempo l’annuncio di ciò che viene: senza pre-dirlo, salvaguardandone l’avvento. Il disegno del pensiero traccia un’azione che nessun significato può definire. Cur vandosi su ciò che si sottrae, indica l’emergere dell’essere.
Sono profonde le corrosioni che il chiuso orizzonte dell’apparenza ha prodotto su di noi: tacciono tutte le parole, l’azzurrità è spopolata, il deserto si estende ovunque.
Non deve esserci esitazione nel prendere le distanze dalle opinioni, rappresentate da quello che crediamo di sapere, e nel mettere alla prova i nostri convincimenti. Sotto quel cielo vuoto, a malapena rischiarato da un’unica stella, «svaniscono, 5 precipitano / gli uomini dolorosi / ciecamente dall’una / all’altra delle ore, / come acqua gettata / di scoglio in scoglio / negli anni giù nell’ignoto». Non potrebbe essere più preciso Hölderlin. Gli esseri umani «svaniscono» in quel reale che si trova al limite della vita, dove l’avvento del deserto tutto fa apparire marginale e irrilevante. Camminiamo. Irretiti nella trama dell’illusione (l’illusione del potere e del successo; del piacere a ogni costo), andiamo verso il «giardino dell’infelicità» leopardiano, dove il cantico delle creature è rovesciato.
Un’ombra è l’emblema del corpo che appare e scompare; un’ombra costretta a muoversi nell’orizzonte di due riflessi opachi. L’umbratilità è così radicale da far pensare che anche la vita sia un’apparenza: la messa a fuoco dell’ombra, quale struttura portante dell’esperienza umana.
Percorriamo una strada ma non andiamo da nessuna parte. Siamo intrappolati nel la rete delle apparenze, nella rete dei nostri sensi e delle cose che ci circondano. Questa rete – propriamente un paretaio – non è che una diversa nozione dell’om bra originaria: una forma omogenea e indifferente all’uomo.
Il colloquio pensante con l’essere è una possibile risposta alla forza con cui venia mo chiamati dal reale a riconoscerci come esseri che si pongono delle domande. Tale colloquio propone l’essere in una possibile forma; senza tuttavia tematiz zarlo; cercando di non tradirlo. Propone un possibile senso, anche se il senso si rivelerà pura insensatezza.
Quando un pittore come Franz Marc dipinge cavalli azzurri, rappresenta nell’ani male una qualità che non c’è in natura e che non può essere percepita. Questa “qualità” è l’essenza del cavallo.
Insomma, Marc non dipinge singoli cavalli, i cavalli che noi vediamo circolare nel paesaggio, bensì l’essenza dell’animale, quella che comunemente non si vede, abbagliati come siamo dalle apparenze.
Per cogliere delle cose l’essenza nascosta e profonda, dobbiamo fare un passo nel nudo disvelamento del vero; oltre la superficialità dell’intuizione sensibile, oltre le connotazioni sensoriali.
Pensiamo, a tale proposito, all’oscuro migrare di Trakl: «Alcuni, durante il pelle grinaggio, / giungono alla porta per oscuri sentieri». Solo chi segue la via del pen siero corrisponde all’appello dell’essere. Eppure «per molti la tavola è pronta». Ma allora, se la porta è aperta, se il pane è pronto, perché non entrare e non seder si a tavola? Perché non prendere posizione per l’emergenza del dire?
Flavio Ermini
n. 98, Perché la poesia?
Siamo nati quando la parola poetica era già apparsa. Labbra a noi sconosciute l’avevano pronunciata, strappandola dal caos pretemporale per affidarla al logos. Siamo nati perché la parola poetica ha una natura dialogica. Siamo nati in seguito alle domande radicali che la parola poetica, quale sorgivo colloquio, ci ha rivolto. Siamo nati con la notte preumana del mondo, gettati in terra d’esilio, prigionieri della nostra finitezza, nella precarietà e nella casualità.
Flavio Ermini
n. 97, Per oscuri sentieri
No, la parola d’ordine per gente come noi è:
avanti verso la tua essenza!
Trakl
Gli esseri umani si sono smarriti perché si sono abbandonati alle apparenze, consentendo così al molteplice d’imporsi come una vera e propria potenza nell’attribuzione dei nomi. In tal modo, il linguaggio ha iniziato a dire «è» riferendosi alla molteplicità, quando invece avrebbe dovuto assegnare l’essere esclusivamente all’Uno originario.
Il superamento delle apparenze richiede una lingua “accogliente”. Una lingua venuta a dire agli esseri umani che la verità si annida in una zona incerta, indecisa: nella loro essenza; ovvero oltre il sensibile: nel suo lato oscuro, in ombra. Nel suo altrove. Questa lingua cade fuori dai sensi e si costituisce quale terreno per il permanere di tutte le cose nell’interezza.
Il destino essenziale dell’uomo è determinato da questa sua possibilità di aprirsi al mistero dell’essere, la cui alterità va riconosciuta come propria interiorità. Come? Si tratta di convertire l’aperto nella scommessa di passi ulteriori. Per esempio, dire il margine da cui ogni apparenza incessantemente sorge e in cui torna a permanere. Ovvero il frammezzo che ci fa essere, al di là dell’orizzonte di senso che ci fa semplicemente vivere.
La parola poetica ha il compito di riportare a unità ciò che fin dal principio è stato diviso: una funzione rifondativa che impone di rifuggire dalla paralizzante convenzionalità del segno informativo. Una funzione rivoluzionaria: esattamente come accade in “Anterem”, nel flusso eracliteo delle sue pagine, dove i dispositivi linguistici non sono atti a nominare le cose, ma la loro essenza.
Il dire poetico ci fa prossimi alle dimensioni di apertura che consentono di accedere all’essere, al fine di tornare a dargli unità e parola. Conferma Heidegger: «Nella parola si rivela l’essere di quanto è nominato. La parola, infatti, nominando l’essenziale, recide l’essenza dalla non-essenza. Questo oltrepassamento è la conseguenza e il segno di un dire che comincia in modo più iniziale». Questo oltrepassamento fa sì che l’essere sia essere: qualcosa che gli impedisce di affondare nel falso movimento dell’apparenza.
Nella scrittura del poeta parla la parola che assume su di sé la funzione di pensare le cose in quanto «consistono di essere» come precisa Anassimandro. Quell’essere che si trova sempre a fondamento: presente sia nel delimitato sia nell’indefinito. Tanto che risulta necessario uno sguardo più avvolgente e ravvicinato per nominarlo.
È la scrittura in primo luogo a parlare, mai l’essere umano, il quale ha un unico compito: quello di corrisponderle a partire da quell’intreccio di linguisticità e mortalità che costituisce la caratterizzazione storica dell’esistente.
Perché esaurire e irrigidire in una definizione le sfumature insite nell’accadere della vita? È evidente la corruzione del linguaggio che progressivamente s’irrigidisce e non sa più cogliere i nessi strutturali che stringono insieme le umbrae interiori e le umbrae esteriori.
Attribuendo ai nomi significati rigidi e immutabili, l’uomo ha fatto sì che essi risultassero del tutto estranei alle vicissitudini della physis. Il mondo non è se non nello specchio dell’antidiscorso. È qui, nell’aperto linguistico; cioè altrove, dove risplende nella misura in cui essenzialmente accade.
La parola poetica non può essere usata per portare qualche sollievo sull’arido cammino del pensiero. Se la parola comunica qualcosa al di fuori di se stessa corre il rischio dello scacco. Il suo dire poggia sulla propria verità: una funzione rifondativa e rivoluzionaria che conduce oltre le voci effimere dell’estetica e dei generi letterari.
Osserva Trakl: «È bene guardarsi dalla bellezza perfetta, definita; ci si risparmia solo una vista ingannevole. No, la parola d’ordine per gente come noi è: avanti verso la tua essenza!». Per «gente come noi» è necessario seguire gli oscuri sentieri dell’interiorità, anche se i suoi abissi sono colmi di angoscia e di sofferenza; anche se nei suoi crepacci vige il nucleo del più profondo ammutolire.
È necessario incamminarci verso tale principio. Giungendo ad affidarci al pensiero dell’ingens sylva del nostro stato arcaico, tra fenomeni che ci trascinano in un vortice d’indeterminazione, in un incontro fra stranieri che non parlano la stessa lingua. Qui ogni atto creativo di poesia ci parla di questo passaggio: il passaggio dalla «non-essenza» all’«essenza».
La nostra stessa vita va considerata come un carattere strutturalmente connesso all’evento dell’essere. È necessario prenderne atto per imparare a pensare di più e a parlare con maggiore proprietà. Ma quanta fatica richiede la ricerca di una parola che sia in grado di dare parola all’essere! E quanta fatica richiede l’acconsentire a un pensare che ci consegni al segreto di quella parola che parla da un’altra lingua.
Flavio Ermini
n. 96, Oltre le apparenze
Straniera giunse a noi la parola
che forma i mortali.
Hölderlin
La poesia viene dalle profondità misteriose del mondo e del tempo, portando con sé alla luce quanto laggiù è sospeso e indefinito. E lo fa negandosi a una modernità che tutto dissimula. Ecco perché quando nella scrittura non persiste – come fondamento – il moto originario del pensiero, scompare dalle parole l’essenziale.
«La poesia non conosce progressi lineari» registra Ingeborg Bachmann. «Se ci si limita a manipolare la lingua per darle una patina di modernità, ben presto la parola poetica si vendica e mette a nudo le intenzioni dei suoi manipolatori».
Nel testo poetico, la posta in gioco non è il possibile del progresso, bensì l’aspro orientarsi oltre le apparenze: verso l’inizio. Quell’inizio che coincide con il punto aurorale di strappo dal silenzio alla parola.
La paura del silenzio – come della pagina bianca, come del deserto – altro non è se non il timore ancestrale e reverenziale nei confronti dell’origine.
Insomma, la poesia è lo spazio d’interrogazione sul nostro apparire; è il tempo di una contesa ingaggiata con l’orizzonte albale. Compiere un’opera poetica significa soccombere sotto il peso della devozione assoluta a un principio che non conosce compimento. Decidersi per l’opera significa consegnarsi all’ossessione di una lingua capace di aprire squarci nelle oscurità della vita.
Viviamo in un’epoca in cui la fede nel progresso sta diventando la religione dei popoli. Lo splendore superficiale delle merci si va via via sostituendo alla parola poetica; le voci effimere del mercato e della città coprono il canto. Tutt’altro è auspicabile. Va coltivata l’idea di una materia originaria destinata alla persistenza. Quella materia, per intenderci, denominata arché da Talete, apeiron da Anassimandro, physis da Eraclito. E sottratta alla tormentosa damnatio del Werther goethiano che ci vuole «chiusi nella nostra povertà, nella nostra limitatezza».
Nel suo darsi, la poesia richiede lo sconvolgimento del finito. Impone di incamminarci verso ciò che non è ancora formato; verso lo spazio puramente aperto che preme dalle profondità dell’altrove. Solo nell’aperto – propriamente nell’apertura dell’apparire – c’è il seme della nostra completezza, qualcosa che è là dov’è internalizzato l’esterno ed esternalizzato l’interno: in una geografia instabile, liminare.
Sulle rovine dell’io («Io è un altro» ci ricorda Rimbaud) prende posto un accadere che più non distingue tra altezza e profondità. Cos’è accaduto? È accaduto al poeta proprio quanto auspicava Novalis: «Dopo non molto tempo osservò collegamenti, incontri, coincidenze. E presto non vide più nulla isolatamente». Ogni discesa nell’interiorità, precisa ancora Novalis, è anche «ascesa, viaggio al cielo – sguardo volto al davvero esteriore».
È chiara la necessità di tornare a unire tutto ciò che è separato dalla superstizione della tecnica, che tutto divide. Torniamo a ripetere ciò che, secondo la ragione, non si può ripetere: l’inizio. E come se non affidandoci a una lingua separata, a una lingua della pietra e della porosità? È ciò che prova a fare Celan: dire il mutismo, rendere il niente al linguaggio, prestare parola all’ammutolire, alle tenebre di quanto non-detto del discorso: all’antidiscorso.
Il davvero esteriore ci precede, precede la parola; è lì prima della poesia. Ecco perché ripetere l’inizio, oltre ogni ragione. Il davvero esteriore è un’ulteriorità che attende l’uomo. Ma non gli giunge addosso dall’azzurrità. Bensì proviene da lui stesso. Il davvero esteriore proviene dall’uomo e avvia l’uomo verso la propria essenza: l’insistente protrarsi – cioè il pro-trarsi fuori dal nascondimento – del sorgere stesso di ogni “essere” per dire. È come se il linguaggio affermasse: «Non rappresento più, sono».
Impone Hölderlin: «Ti devi porre con libera scelta in opposizione armonica con una sfera esterna, così come sei per natura in armonica opposizione con te stesso, ma lo sei in modo inconoscibile finché resti in te stesso».
Conferma Levinas: «È come se, nell’andare verso l’altro, io potessi ricongiungermi con me stesso e impiantarmi in una terra, ormai natale», una sorta di “terra promessa” intravista attraverso lo spaesamento. Insomma è come se fosse in atto un dire che va incontro all’altro prima ancora di ascoltare una sua chiamata. È un dire progettante: quel dire che, nel preparare il dicibile, simultaneamente mette al mondo l’indicibile in quanto tale. È un dire che si mette al servizio di una lingua per l’altra, nell’altra: una lingua poetica sempre in costruzione: unica e allo stesso tempo duale.
Dobbiamo affidarci al dire che sta al di là di ogni detto, ovvero dove regna il silenzio da cui ogni parola proviene e a cui ritorna a ogni sua insorta estensione. Dobbiamo avere l’audacia di far sì che il movimento tra le due lingue sia reciproco: un andare-e-venire dall’una all’altra, mai a senso unico. Perché? Perché cambiar-luogo della verità dell’essere – da una lingua all’altra, da una parola all’altra – consente di ricollocare ogni volta il pensiero, precisamente come richiede il cammino stesso della poesia, privo com’è di «progressi lineari».
Flavio Ermini
n. 95, L'altrove poetico
Fiorire e inaridire sono a noi ugualmente noti.
Rilke
Il dire del poeta ci parla di un altrove dov’è in opera una prospettiva rovesciata rispetto al mondo sensibile.
Il poeta non nomina le cose esperibili. Il suo canto dà forma all’assenza di ciò che ancora non è apparso. E, opponendosi alla pretesa dell’indicibile di restare non-detto, ci incalza senza tregua, per dare conto della totalità della vita. Quel canto proviene dall’antiterra: da una sorgente dispersa che riaffiora da un cielo inconosciuto.
Grazie a questo dire, ciò che eccede il mondo sensibile si esprime nelle proprietà di ogni singola parola, conferendo fondatezza e legittimità a quanto può apparire soltanto empirico e casuale.
In se stessa – ovvero altrove – la parola poetica ospita l’essenza delle cose. Ciò si evidenzia quando il dire non è pura nominazione bensì rimanda anche a qualcosa di esterno alle cose stesse, oltre le apparenze. I nomi della poesia sono sperimen- tabili nell’attimo ininterpretativo in cui si schiude l’aperto. Portano a significato l’altro del significato. Ci dicono di assecondare l’esodo della parola quando la pa- rola va oltre se stessa, oltre i propri confini. Ci indicano che è necessario penetrare fino alle cause dell’apparire, prendendo atto in tal modo dell’indefinito da cui sorge ogni cosa.
La poesia è produzione consapevole di parole che si sanno disadattate in questo mondo; sempre rivolte a un altrove; sempre in rivolta; sempre alla ricerca di un accordo con la naturalità della terra, accordo che coincide con uno stadio intermedio dell’apparire, tanto da indicare il momento in cui l’immobilità dell’essere s’incrina e sperimenta l’ingiustizia del tempo.
Va favorito nuovamente il matrimonio tra la terra e il cielo. Va favorita la nascita di una parola che dica, insieme, l’originario uno e l’ingannevole molteplice.
In verità il poema è a casa nell’incontro. Nominando poeticamente, infatti, si configura come un colloquio, costantemente scoperto, esposto alla tensione della se- parazione, della divisione. È qualcosa di straordinario, d’inatteso. Conferma Rilke: «Noi non siamo uniti […] / Fiorire e inaridire sono a noi ugualmente noti».
Abbacinati come siamo dalla troppa mobilità, dal troppo movimento e dalla trasformazione perenne, ci allontaniamo in modo costante da ciò che permane; erriamo e facciamo esperienza del dolore, di ciò che «congiunge nello spezzamento che divide e aduna» come Heidegger registra, per aggiungere subito dopo: «Il dolore è la connessura dello strappo. Questa è la soglia». Qui mondo e parola s’inarcano nella parola poetica fino a giungere alla connessione tra visibile e invisibile.
Solo mantenendoci vicini all’origine – dove le cose sono ciò che sono – possiamo nominare l’inizio e in qualche modo dire l’inaccessibile. Ecco il compimento dell’esistenza: un impartecipe lasciar accadere l’essere, nel dare a esso parola. Quell’essere davanti al quale la vita non può venire più misurata né la totalità del mondo adempiuta. Quell’essere che compare quando la vita urta il suo limite e, con il dire, giunge a infrangerlo.
Il dire non è al suo giusto posto nel mondo. Sta in transito. Sta sulla soglia. Si trattiene nel dolore. Sta fra i vivi e i morti, in mezzo al fluire dell’esistenza, nell’interiore validità di quel principio che sembra depositario di ogni forma.
Lo stare è «come essere» annuncia Rilke. È eccedenza di senso che dev’essere salvata: «Questa stava un giorno fra gli uomini, / stava in mezzo al destino che annichilisce, in mezzo / all’oscurità della meta come essere stava e piegava / stelle sopra di sé da cieli sicuri».
La poesia coglie l’essenza della vita, e tende a farsi essa stessa vita. S’identifica con la potenza che rende manifesto ciò che è occulto. Ma non è la risposta definitiva,
«non è la fine, ma l’altro inizio d’innumerevoli possibilità della nostra storia», come conferma Heidegger.
Cosa prepari il secondo inizio ci è ignoto. Ma la poesia – terra di frontiera fra il primo e l’altro inizio – sembra custodire in questo metaxý il mistero dell’essere. Il principio viene assunto come luogo senza luogo dell’intoccabile, come altrove rispetto a ogni investigazione.
Il mistero è dato dall’eccedenza della vita con le sue molteplici manifestazioni, in molti casi tra loro contrastanti. Annota Florenskij che quanto più ci si avvicina al principio, tanto più chiare sono le contraddizioni. Il principio nasce dall’oltre dell’evidenza: ci rivela che la finestra è solo legno e vetro se non viene messa in relazione con la luce solare del primo mattino.
La poesia ci indica com’erano le cose prima che si mostrassero a noi. Il disvelamento dell’essere coincide proprio con la pronuncia della parola poetica, alla ricerca di un impeto albale. La poesia? Sì, perché l’incontro con la fonte originaria non ci permette di parlare con le parole consuete; bensì impone un dire grazie al quale l’essere e l’esistere – ovvero l’altrove e il qui – si possano presentare indivisi, privi di separazione, e tuttavia reciprocamente distinti.
Flavio Ermini
n. 94, Non c'è fine al principio
Non m’interessa pensare al mondo al di qua del mondo.
Nietzsche
La poesia è il luogo che ospita la domanda sull’essere, testimoniando la profondità della physis quale si era rivelata agli albori del pensiero.
Non c’è fine al principio. Nella poesia la natura può ancora parlarci come all’origine parlava. Grazie alla poesia le antiche parole tornano alle nostre labbra. Sono parole strappate al silenzio; vere, quanto è vero lo sgomento dinanzi all’inconoscibile. Vale la pena di assumerci questo compito affinché ciò accada.
Il lavoro poetico ci induce a pensare oltre ciò che appare; oltre le singole cose che dalle tenebre si levano nella chiarità. Ci svela che sonno e veglia, luce e notte sono solo riflessi evanescenti, non testimonianze dell’essere.
In realtà, tutto resta uno, mentre i mortali, ingannandosi, ritengono che vi sia una molteplicità di cose e che tale molteplicità sia soggetta al mutamento del tempo, alla sua numerazione cronologica. In verità, non ci sono né il sorgere né il trapassare, ma solo l’eterno presente dell’essere.
Il lavoro poetico è chiamato a condurre la natura a svelarsi per quella che è, oltre le nostre opinioni. È chiamato ad aprirsi all’annuncio della physis come potenza, quale energia dell’essere; per farla parlare; per indurla a presentarsi sulla scena della storia dell’uomo.
È quanto fa dire a Hölderlin: «Molto si trova, dunque, e il più nella natura».
La poesia impone di accettare l’essere nel modo in cui si dà; e implica un interrogarsi sul venirci incontro della molteplicità, un interrogarci sul come la parola può salvaguardare l’essere dall’apparenza. La parola è poetica – e quindi è vera – allorché fa sì che l’essere sia. È in questo “lasciar essere” che essa ne svela il senso. La parola è dunque presso la cosa quando ne preserva la differenza.
Il lavoro poetico mette in evidenza non solo il venire alla presenza dell’essere, ma anche il suo sottrarsi. Mette in evidenza uno strappare all’occultamento e alla latenza, un portare a manifestarsi, proprio come suggerisce la parola che indica la verità come svelamento: a-létheia. Conferma Schiller: «Nell’abisso dimora la verità», per aggiungere subito dopo: «Nessuna barca o ponte conduce oltre questo orrido abisso, / né l’ancora raggiunge il fondo».
Va pensato più intensamente l’inizio del pensiero: la verità non consiste nella correttezza del giudizio, bensì nella coappartenenza di velamento e svelamento, in quanto verità dell’essere. Ma come potrà l’uomo accedere a questa esperienza se ogni volta che parla la occulta, proprio attraverso ciò che dice?
Lo indica George quando precisa che non si tratta di andare alla ricerca di «meraviglie e sogni» e di trovare poi le parole adatte per descriverli e rappresentarli. Eccolo l’accadere della parola poetica: «Andare verso qualcosa e costruire quella cosa stessa» come impone Silvano Martini riflettendo proprio sul verso di George:
«Nessuna cosa sia dove la parola manca». Proprio grazie a questa esperienza si schiude una traiettoria di domanda, una direzione di ricerca che porta oltre i generi, verso l’interrogazione della natura, una ricerca che fuoriesce in modo esplicito dall’apatia del pensiero, ovvero dal nostro contegno quotidiano verso le cose, dal nostro contegno opinante, quello che ci fa erroneamente pensare la verità come la concordanza di un’opinione dell’essere linguistico con un fatto.
La via del pensiero seguita dalla parola poetica conduce fuori dal regno dell’opinione e dell’apparenza per guidarci verso l’autenticamente essente: la physis.
Il tempo dei grandi sistemi è finito, ma ancora non è giunto il pensiero che porta all’essere a iniziare dalla sua verità.
È un percorso difficile perché la verità non si manifesta secondo valori eterni e immutabili, ma mettendosi in circolo con il lumeggiare di un pericolo che improvvisamente si mostra. È la notte che scende d’un tratto. È il disastro connaturato allo stare al mondo. È la finitudine in cui imparare a vivere. È il nostro compito quando abitiamo poeticamente la terra. Conferma Heidegger: «Noi guardiamo entro il pericolo e scorgiamo il crescere di ciò che salva». Questo è il gesto che affratella pensiero e poesia.
Va accettato l’abisso; non addomesticato per addolcirne l’angoscia. S’investono più energie per ripararsi dal pericolo che per favorirne l’accoglimento.
Riflette Eraclito: «Ascoltando non me, ma il logos...». L’esclusione della soggettività e della manipolazione dell’interprete segna un passaggio fondamentale: dalla nominazione delle cose per come sono vissute da chi le narra alla loro nominazione per come si danno.
Il lavoro poetico consiste in quella “raccolta” originaria dove le cose giacciono nella loro esposizione e, così esposte, si offrono alla presenza. Eckhart parla della necessità «di essere uguali alla verità di cui vogliamo parlare», proprio come scrive Margherita Porete quando impone di essere la physis stessa, di non avere un sapere separato dall’essere, di non guardare all’essere come a cosa diversa da se stessi. Va compiuto fino in fondo il faticoso processo di liberazione dall’estetica che assimila la natura alla ragione e cerca fondamenti scientifici, postulati di verità alla bellezza. Quando si parla di poesia va seguito compiutamente il pensiero che vuole pensare al mondo al di là del mondo.
Flavio Ermini
n. 93, La poesia non è un genere letterario
Ma i viventi commettono
tutti l’errore di troppo forte distinguere.
Rilke
La parola poetica non accade una volta per tutte. Continua a manifestarsi. Giunge dal silenzio e cerca il dire in cui dimorare. Grazie a quella parola, nel dire tornerà a rivelarsi l’iniziale essenza dell’essere umano nella sua pura naturalità.
Il tratto inaugurale della parola poetica dischiude lo spazio inconosciuto che ecce- de il significato, e lo apre a un cammino che sospinge l’esperienza di scrittura oltre se stessa, per seguire le volute e le inarcature di una voce nascosta. Scrive a que- sto proposito Bonnefoy: «La parola è un’attività sottostante al pensiero esplicito. Al suo libero costituirsi va data la priorità rispetto ai fasti dell’opera compiuta».
Senza dispersioni, in questa “attività sottostante” è possibile cogliere quell’idea d’inafferrabilità che si distende nella linea del tempo; tanto da indurci a scrivere senza nominare. Come fa la danza quando danza; come fa il fiore quando fiorisce.
Si avverte come una sfida lo squarcio di un grido nel soffocamento generale. È il grido che il logos ha la funzione di far dimenticare, di mortificare.
Nell’attribuire a ogni cosa un nome, il logos ordina il chaos, ripartisce e categorizza l’essere. A iniziare da un oscuro sapere, accorda l’essere di classificazioni e lo riduce a sé.
I mortali distinguono e separano, aprendo un varco all’ingannevole apparenza della molteplicità. Resta la poesia a far uscire il conoscere umano dalla sfera delle illusioni; a nominare l’essere senza dividerlo.
L’essere umano è esiliato nell’apparire. Solo la poesia può far sì che nell’esilio non si smarrisca. Può farlo portandolo nell’immediatezza assoluta di una contemplazione senza conoscenza.
L’imperativo di Wittgenstein è esplicito: «Dobbiamo dissodare l’intero linguaggio». Ovvero dobbiamo essere consapevoli che il lavoro poetico non si svolge all’interno di un sistema di regole linguistiche, ma nel suo sporgersi là dove niente è più rassicurante: verso l’Aperto nominato da Hölderlin e da Rilke, verso il perturbante, l’imprevisto.
Dobbiamo abbandonarci all’essere. Farne parte di nuovo. Abbandonare le apparenze. Sostare a un passo dall’al di là. Abbandonarci a una vita rispettosa del mistero.
La parola che parla nella poesia non fa segno, non entra come moneta di scambio nel commercio quotidiano; non fa opera di senso. Non è la parola ineffabile che scende dall’azzurrità, ma quella che sale come fumo e fuoco dal vulcano. È una lingua di “laggiù”, ma è l’unica che può dire cosa accade “qui”.
La parola poetica si proferisce correttamente solo quando la si genera a partire dal silenzio, ovvero dal più assoluto distacco dal sé. Solo allora la parola viene generata non da noi stessi, ma dalla nostra essenza, quando si è quella parola. Il resto è pura ripetizione.
La parola non è il medico che corre in aiuto delle verità logorate dall’uso. È il dolore per la mancanza di un linguaggio adeguato a dire l’essere. Quel linguaggio che detiene il segreto del varco attraverso il quale l’animale viene strappato alla sua vita silenziosa e viene destinato alla caduta fuori di sé, nella figura del parlante.
In questa prospettiva si comprende che la poesia non è tanto un “genere” o una “categoria letteraria”, non è un mero ornamento dell’esserci e della sua finitudine, bensì una forma di vita che mette in relazione essere umano e mondo, soggetto e fondamento; una forma di vita che svela una natura probabilmente indefinibile, ma sulla quale non possiamo non riflettere.
La poesia è il modo in cui c’è l’essere umano.
La parola poetica ama le pure forme originarie, registra Schiller. Per farsi simile a esse, si frantuma, si diluisce, canta fuori da ogni norma prosodica, al limite del silenzio.
Questa parola è sconvolgente perché conserva il movimento lacerato dell’inaudito, proprio del mondo in ombra che si estende oltre i limiti della semplice ragione: quel mondo in cui i significati implodono in un angosciante spaesamento interiore e le cose non sono più assicurate a un terreno di certezze e di riferimenti stabilizzati. Non c’è codice di scrittura per tale visione; non c’è alfabeto, manca la grammatica.
Qui c’è il repentino recidersi di un continuum a causa di un limite senza protezione, dietro cui si nascondono le potenze dell’indifferenziato.
La parola poetica è determinata dal pericolo che essa affronta più che dal servizio alla vita. Il carattere della sua figura è del tutto astorico, e come tale annuncia un guardare senza io e un amare senza oggetto; annuncia ciò che crea durata senza misurazione. Delinea l’arcana esistenza che riposa in se stessa nel sottosuolo della storia, al principio della sua esperienza di vita, quando tutto è ancora originario: presenza pura, rivolta a ciò che semplicemente è, allo stato albale; un fruscio dell’anima e dell’apparire, insieme; uno sfiorarsi di un senso contro un altro, per un intrecciarsi prodigioso del grido con l’ammutolire.
Nel tumulto che sfida il principio di non contraddizione, le parole raggiungono il chaos che di quel tumulto è la causa più profonda. Sono parole che hanno in sé i segni di una condizione umana fragile e ferita; grumi di dolore e di opacità.
Sono parole in cui mille varchi si aprono; in cui s’insinuano bagliori inconsueti, allucinazioni atte a sguarnire la frontiera che la ragione solitamente difende dalle notti in subbuglio.
Davanti a questo abisso che si spalanca d’improvviso là dove la vita sembrava proseguire piana, come si può ancora parlare di “genere letterario” per definire la poesia?
Flavio Ermini
n. 92, La natura del lavoro poetico
Straniera giunge a noi la parola che forma gli umani.
Hölderlin
Il lavoro poetico consiste nel volgersi all’essenza delle cose, quella che comune- mente non si vede, abbagliati come siamo dalle apparenze.
La rivoluzione che impone il lavoro poetico muove dall’arduo riconoscimento della parola poetica quale prima lingua, quale sostanza diversa da quella imposta dalla nominazione: sostanza diversa nel senso di natura più originaria, raccordata pienamente con l’essere.
La parola che entra nel processo del lavoro poetico non è frutto di tecnica, ma di rivelazione ontologica. Si fa presente senza necessità teoriche, senza orpelli. Noi osserviamo meravigliati il suo ingresso nell’ambito del pensiero, nel quale essa per natura già è.
Erra chi traspone la lingua muta delle cose nella lingua dell’uomo. Erra chi no- mina.
Gettare un ponte fra le due sponde rende ancora più evidente il crepaccio che le separa, tanta è la differenza tra la lingua umana e la lingua muta delle cose.
Impone Celan: «Tacere con la parola, serbarla nello spazio dell’intervallo». Que- sto è il compito della poesia. Questo è il dovere di una lingua che sta diventando libera.
Ecco perché la parola poetica nega la parola “nominante”. Perché la parola no- minante offusca, vela, copre. Prevale sulle cose. Le strappa dall’essere, le affida all’apparenza. Ecco perché, come registra Eraclito, «il Signore che ha l’oracolo in Delfi non dice e non nasconde, ma accenna». Facendo sì che là, dove s’interrompe l’ordine del linguaggio, parola e indicibile possano sostare, in un tenersi insieme degli opposti, nel pericolo.
Non c’è protezione per noi dove interminabilmente affiora il pericolo. Il pensiero non si placa, il naufragio non termina di compiersi. Nemmeno il familiare è una difesa di fronte al terribile “di là”, che trapassa nella nostra esistenza e ci porta alla consapevolezza della nostra finitudine.
La poesia avviene per lasciar risuonare l’eco della domanda fondamentale sul senso dell’essere e dell’esistere nel contesto angusto del divenire, senza mai tro- vare una risposta definitiva. Ecco perché sembra che il linguaggio, come asserisce Novalis, non esprima altro che «la propria meravigliosa natura», quella natura in grado di rendere leggibile il mondo grazie al proprio perenne fiorire. Nella parola
– sia in quella pronunciata sia in quella che sempre manca – il fuoco aurorale si avverte e perdura.
Solo se la parola vive per sé potrà anche avere la forza di farsi strada e divampare e divampare ancora.
Quale prima lingua, la parola poetica custodisce il mistero dell’origine che verrà. La sua natura è appena decifrabile; ma una cosa è certa: la prima lingua non è l’inizio né il fare una volta per tutte, ma il nuovo principio di innumerevoli pos- sibilità della nostra storia.
La prima lingua non “è”, semplicemente “parla”. Propriamente parla come tra le labbra dei sapienti della Grecia delle origini, i sophoí, i quali non pronunciavano parole proprie ma parole del logos, come svelano Eraclito e Parmenide. Parole di cui nessuno può rivendicare la paternità. E come tali adatte all’apertura dell’im- possibile.
Queste parole proclamano la mancanza di ciò che nominiamo, la mancanza di ciò che non appare. Raggiungono così il centro inverificabile del verificarsi umano. Registra Hölderlin: «Straniera giunge a noi la parola che forma gli umani». È una parola che ci guida nell’esistenza autentica, una parola che prende e scuote, si solleva ed eleva al di sopra dello stato abituale, trasmuta. Parla per superare la limitazione della forma finita e per riportarci a una sfera che, nell’infinitudine delle sue possibilità, trascende quella forma perché è la forma stessa dell’essere.
La natura del lavoro poetico sta nel rimettere in gioco la verità, disincagliarla da ogni dogmatismo, esprimere un pensiero all’altezza del problema.
La nostra gratitudine per la poesia è la gratitudine per chi tanto ci ha atteso e ha conservato integro per noi il luogo della verità di ciò che siamo. Nella poesia si cela una lettura dell’esistente che ci interpella come eredità ineludibile, come radicale domanda sull’essere; tornando ad affrancarci dal mondo sovrasensibile – così come un tempo ci siamo affrancati dal mito, così come un giorno ci affranche- remo dalla tecnica –, giungendo a concepire la verità come rivelazione dell’essere. Siamo parte della verità, ma non siamo la verità. Le nostre barche sono senza governo. L’attenzione al linguaggio sul quale stiamo navigando deve farsi par- ticolarmente vigile. Ma non si tratta di applicare rimedi e strategie formali di contenimento. Non si tratta di gettare frettolosamente un ponte sull’indefinito. Si tratta di accogliere dell’indefinito anche lo svanimento e la consunzione di ogni sostanza e di ogni senso.
Insomma nel lavoro poetico non siamo chiamati a conferire forma all’informe. Ciò che è informe va custodito come tale.
Il problema della parola è preservare il mistero dell’essere, senza pretesa alcuna di determinarne struttura e destino. Ecco dove sbagliava il mito. Ecco dove sbaglia la tecnica che del mito prosegue il lavoro, quando detta l’ordine del mondo, l’ordine della casa che abitiamo, quando toglie l’arbitrarietà dell’accadere e stende un velo sull’antiterra del pensiero.
Il problema della parola è restituire l’essere a ciò che autenticamente gli appartie- ne: la poesia.
n. 91, L'altrove dell'erranza
Lontano dal cammino degli uomini.
Parmenide
Decidere per l’esistenza autentica implica riconoscere che a fondamento della vita umana sta la consapevolezza di essere al mondo.
Accorgersi di vivere, infatti, è già un inoltrarsi nell’esperienza originaria dell’e- sistenza; è una radicale obiezione all’oblio e un assentire all’essere. Testimoniare con la scrittura il senso di questa esperienza è un compito al quale non possiamo sottrarci.
Scrivere diventa in tal modo una comprensione dell’essere.
L’esistenza appare come una dolente via crucis segnata dal divenire e imposta dal- la natura. Sul nostro cammino non incontriamo che apparenze. Sono apparenze che faranno del nostro cammino una via di sofferenza.
Nel dolore si apprende che acconsentire al divenire rappresenta il solo modo di conoscere noi stessi, al fine di ri-conoscerci in quanto mortali che si interrogano sull’uno e sul puro evento del molteplice che dall’uno scaturisce. Ecco la sostanza di quel mondo aurorale che ogni volta nasce a nuovo dall’incontro tra l’essere umano e le apparenze che lo assediano.
Quella sostanza ha una voce. Parla e si rivolge a noi in quanto immersi nel mon- do e ci convoca per ciò che autenticamente siamo e non possiamo non essere. Il richiamo che questa voce fa risuonare – volgendosi all’essere autentico dell’esserci
– è il richiamo alla struttura fondamentale dell’esistenza: essere nel mondo e del mondo: averne cura.
Solamente con la cura delle cose e degli altri il mortale umano progetta in avanti le sue possibilità. Nella cura dell’apparire sta il frutto della ricerca volta all’essere. La cura è l’atto di una ricerca mai conclusa della nostra orientazione nel mondo.
Quella sostanza narra un’esperienza vissuta innumerevoli volte: un processo dell’essere nella sua apertura al divenire. Il decorso dell’esistenza si fonda sull’e- venienza che qualcosa proveniente dalla zona a noi sottratta del mondo accada. Noi siamo chiamati a far sì che proprio questo qualcosa accada, per poi custodirlo in una forma nuova.
In tale processo viene alla luce lo sforzo radicale di elaborare una comprensione dell’esistenza in modo fedele al suo fluire, senza tradirne o occultarne i caratteri specifici. Non solo. Viene alla luce un’esperienza poetica particolare, ogni volta irripetibile, della relazione fra essere umano e mondo, fra soggetto e fondamento. In questa prospettiva si comprende che la poesia non è tanto un “genere” o una
“categoria letteraria” come altre, bensì una forma di vita che mette in relazione l’esistente con l’essere.
Il mondo non è compiuto una volta per tutte nella sua essenza: l’essere umano è chiamato in ogni momento a completarlo.
Vivendo, noi ci mettiamo sulle tracce dell’enigma della nostra esistenza. Siamo gettati nel divenire e tutto sembra dirci che siamo per la morte, ovvero che ogni nostro passo è rivolto verso la morte. Ce lo dice soprattutto quel fare e disfare incessantemente la tela perché non si sa se l’eroe tornerà. Ce lo dicono quei corpi che non smettono di diventare vecchi.
Le cose sorgono e declinano. Come non riconoscere l’infelicità che nasce e muore in cose sempre diverse, incessantemente e ovunque?
Fare i conti con la verità del dolore significa prendere atto di quanto la caducità non smette mai di disvelare: l’orrore e la crudeltà che ci insidiano, la sofferenza che ci assilla.
La coscienza di vivere è dolorosa. Chiama all’appello le insistenti e indelebili ero- sioni degli anni. Eppure questa consapevolezza è la condizione irrinunciabile per potersi accostare alla verità. Bisogna acconsentire al patimento, esserne coscienti, al fine di perfezionare la conoscenza del bene congiunto di bellezza e verità.
Di fronte a una realtà incomprensibile, può sembrare ragionevole chinare il capo e rassegnarsi. E invece lo scopo del nostro esserci è cercare una risposta alla pre- carietà dell’esistere; è la ricerca insopprimibile di un senso che giustifichi il nostro volgerci all’origine; è il porre anche le domande che vanno al di là dell’umana ragione, ma senza affidarsi al mito, alla religione, alla tecnologia, bensì a un in- sistente domandare. Pur nella consapevolezza delle sofferenze e delle lacerazioni che il domandare comporta.
Optare per l’essere significa mettere in crisi il concetto consueto di realtà, intesa come frutto di un sentimentalismo astratto o di un’estrema categorizzazione.
Porsi sulle tracce dell’essere significa abbracciare una ricerca poetica in grado di rimettere in moto la conoscenza completa del reale, nel suo intrecciare indisso- lubilmente e proficuamente piani esistenziali che di solito ci si arrischia solo di accostare: l’essere e l’ingannevole apparire.
Si viene così a delineare il presentimento di un dire in senso proprio: una sorta di altrove dell’errare, «lontano dal cammino degli uomini», come precisa Parme- nide.
Flavio Ermini
n. 90, Le vie dell'errore
Le parti mutano, ma tutto è immutevole.
Anassimandro
In questo numero di “Anterem” poniamo a tema l’esposizione del dire letterario e filosofico alle vie dell’errore.
In estrema sintesi e in rapida successione, anticipiamo qui di seguito i nuclei di pensiero che sommuovono in profondità i testi poetici e le riflessioni saggistiche.
-
L’essere umano si colloca all’incrocio tra un esserci visibile e provvisorio (carat- terizzato dalla varietà molteplice delle apparenze) e un essere invisibile e defini- tivo (quale si configura l’essere). Ecco perché scrivere significa lasciar coincidere i contrari: la verità dell’essere e l’errore dell’apparenza.
-
L’essere, in quanto invisibile, non può manifestarsi che nel proprio occultamen- to. Per cogliere la sua verità, al poeta e al filosofo non resta che trovare un transito nel divenire; sperimentando così le vie dell’errore.
-
Porre la parola in relazione con l’evento del molteplice significa ricordare a noi stessi quanto avevano registrato i più antichi pensatori: che il nostro muoverci senza sosta è apparente.
-
Scrivere è un gesto estraneo alla chiusura nell’intimità; non è un ripiegarsi su di sé; è fare i conti con l’insieme di tutte le cose che vengono al mondo con un destino di morte e aiutarle a compiersi nell’essere.
-
Va da sé che solo interrogando l’esserci – l’errore – si può riflettere su cos’è l’es- sere. Ecco perché si dice che proprio nell’errore è in gioco qualcosa di essenziale per il pensiero.
Volgendosi a tali questioni, il numero 90 di “Anterem” certifica la necessità di una parola che si faccia interprete del rapporto irriducibile che separa e unisce nella loro distinzione essere e divenire. Registra l’urgenza di una poesia che si ponga in ascolto del canto delle sirene per confutarlo; una poesia che annunci l’insicurezza fondamentale della vita, contro la quale non valgono ripari né rifugi. Una poesia che operi una rivoluzione del testo, aprendolo all’abitare originario, ante rem.
Abitare poeticamente la terra, proprio come impone Hölderlin, significa fare di professione l’essere umano e proporsi di allontanare il linguaggio dalle sue facilità e stasis menzognere. Significa corrispondere all’essere e riconoscere che le possibi- lità umane – soprattutto quella di vedere nella vita il luogo di costruzione di un senso – non sono che illusioni: luna e stelle da teatro.
Troppo poco noi sappiamo dell’essere. È comune la tendenza del pensiero a iden- tificare l’essere con il darsi della presenza afferrabile, visibile… Il pensiero occi-
dentale si sviluppa proprio così: identificando l’essere con la presenza. Lo stesso termine platonico di idea lo dice, grazie a quel suo nesso etimologico con la radice id che ha in comune con il verbo vedere. Ciò ha fatto sì che, come può constatare Nietzsche, «il mondo vero alla fine è diventato una favola».
Liberiamoci dunque dalle favole e dalle illusioni. E operiamo in modo che sia l’esistenza stessa a parlare, a dire poeticamente quel medesimo che, manifestatosi nella physis e poi ritiratosi nel nascondimento, è nuovamente capace di storia grazie alla parola poetica.
La comprensione dell’essere assume la forma del colloquio poetico tra essere e mortali, e indica che pensare davvero vuol dire interrogarsi su quella difficile me- scolanza di essere e divenire che contrassegna la doxa e che costituisce l’ambito in cui soggiornano i mortali.
Pensare davvero significa andare alla produttività originaria dell’essere che si di- spiega. Pensare davvero costituisce un patire senza soggetto e senza oggetto; è un volgersi al celarsi stesso dell’essere; è un volgersi all’ombra.
Essere implica non solo donazione, ma anche rifiuto; non solo manifestazione, ma anche occultamento. Lo denuncia la parola a-letheia, formata da alpha nega- tivo. A questo proposito va sottolineato, come fa Heidegger, il fatto singolare che la filosofia delle origini esprime la verità con un termine “negativo”, pensandola come disvelatezza e quindi come qualcosa che va conquistato, strappandolo all’oc- cultamento.
Come non cogliere, a tale proposito, l’importanza del poema di Parmenide, che, dopo la prima parte dedicata alla via verso l’uno originario, vuole rendere conto anche della via dell’errore, cioè quella che conduce all’esilio nel molteplice appa- rire?
Noi siamo nell’apparenza, noi siamo nell’anti-verità, noi siamo nel mutamento. Ma che tipo di velatezza della verità è questo nostro errare?
Confrontarci con le vie dell’errore significa riconquistare un rapporto genuino con il pensiero, quando il pensiero è albale apertura all’essere. Pensare la “prima via”, quella dell’essere uno e immutabile, non esclude l’obbligo di interrogarsi anche sul perenne fluire delle cose, sul divenire, sul non-essere, cui ci inducono i sensi ingannevoli e le opinioni dei molti.
In ultima analisi, il confine con il quale misurarsi è quello che noi poeticamente abitiamo, intrattenendoci sull’ampia soglia tra l’apparenza delle forme e ciò che a ogni momento le contraddice in una continua chiamata all’essere.
«Le parti mutano» asserisce Anassimandro, facendo riferimento al mondo can- giante delle cose e dei suoi limiti temporali e spaziali; «ma tutto è immutevole» precisa, facendo cenno alla totalità dell’essere; consentendo in tal modo ad Anti- maco di Colofone di concludere: «Nulla nasce né muore».
Flavio Ermini
n. 89, A dire il vero
E presto il mormorio si fe’ parole
Carducci
Tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, Hölderlin e Novalis inaugurano una rivoluzione che solo con l’inizio del Novecento, grazie alle avanguardie storiche, inizierà a dare esiti compiuti; una rivoluzione non ancora portata a compimento e nella quale a distanza di decenni sono impegnati i migliori poeti del nostro tempo.
Tale rivoluzione prevede che la parola venga traghettata là dove sono le cose, al fine di nominarne lo spontaneo apparire, sì, ma soprattutto al fine di rivelarne il lato umbratile, inespresso; ovvero: la loro essenza, la loro armonia nascosta, così come la definisce Eraclito, là dove riflette: «L’armonia nascosta è superiore alla manifesta».
Tale moto rivoluzionario ha lo scopo di portare a espressione la lingua muta delle cose, operando affinché nella parola umana trovi posto alfine la lingua non co- municabile della physis: tanto familiare alla perduta origine, quanto prossima al perduto principio del senso; così affine a quello che noi non siamo più…
Questo procedimento sommuove in profondità tutto il lavoro di “Anterem”, rivolto com’è al richiamo di quella ricerca letteraria che impone all’essere e all’esistere di presentarsi privi di separazione, indivisi nel loro comune compito, e tuttavia reciprocamente distinti.
È un cammino che si compie grazie all’incontro esistenziale tra essere umano e mondo sul piano della scrittura.
Lo scopo di “Anterem” è dire poeticamente quell’essere che, manifestatosi nella physis e poi ritiratosi nel nascondimento, è ora nuovamente capace di storia grazie al detto del poeta.
È un detto vicinissimo alla lingua originaria, comune agli umani e alle cose: perfetta trasparenza di nome e cosa, identità di parola ed essenza.
Ecco perché non si può dire che il poeta crei un’opera. Al massimo si può dire che ne è all’origine, che ne è il formatore e che l’opera sia la sua formazione.
Al poeta spetta il compito di cedere la parola alle cose, di ascoltare le parole che vengono pronunciate dalle cose nella nostra lingua, e di condurre l’ascolto a espressione linguistica.
Operando in tal modo, il poeta iscrive l’essere-cosa nella rivelazione. Dalle sue parole comprendiamo quanto sia profonda l’opacità della notte che ancora ci avvolge.
Lontanissima e nascosta in un tempo immemoriale, l’origine attende una nuova nominazione.
Si tratta di risalire il millenario cammino dell’uomo verso il suo punto aurorale, là dov’è una sola lingua. Dov’è inscritta nella durezza della materia quella felicità impossibile che nella modernità si rovescia in rovina.
La parola umana è il luogo dove l’energia del mondo cambia di segno: il luogo dove il corpo si trasforma. Il permanere di questo vincolo fondamentale consente ancora di poter udire nell’ultima parola gli echi della prima, l’unica che le cose possano ancora pronunciare.
È tempo che il mondo si faccia presente nella sua enigmaticità e nel suo splendore: allorquando viene strettamente legato, come scrive Hölderlin, all’«immagine originaria», dov’è ripresa l’ingens sylva nominata da Vico, l’immensa foresta primitiva che sarà fatta rivivere anni dopo da Conrad, il quale introdurrà la heilige Wildniss (la sacra selvatichezza) nella letteratura moderna.
Qui, nella Wildniss, la parola poetica s’inabissa fino alle forme aurorali dell’essere, per rientrare in possesso del senso perduto. Qui – come nel concepimento – sono gli avi più antichi a essere di nuovo presenti: i sapienti cari ad “Anterem”, i nomothetes, i legislatori che per primi nominarono il vasto orizzonte del mondo. Qui, nell’ingens sylva, la scrittura – così vicina alla forza ctonia delle origini, allo strato culturale originario pre-ellenico – è capace di accogliere tutta la spinta dirompente delle archai nell’ambito di un rischiarato ordine della forma.
Qui, «abitare poeticamente la terra» significa letteralmente abitare una terra su cui uomini e cose vivono in un rapporto di confidenza e siedono a mensa insieme; non si meravigliano se davanti a loro siede il loro essere nella sua essenza originaria: quel medesimo essere che alfine Carducci stesso sentirà parlare: «Intesi allora che i cipressi e il sole / Una gentil pietade avean di me, / E presto il mormorio si fe’ parole».
A imporsi, a questo punto, è l’indicibile: l’essere nella sua forma albale. La natura parla alfine attraverso le proprie figure.
Questo cammino è in relazione con l’evento dell’essere, con l’essenza primordiale, comune all’essere-uomo e all’essere-cosa.
Parlare il linguaggio davanti alla natura e nello stesso tempo dare a essa parola, ci dice il poeta, è qualcosa di completamente diverso dall’utilizzare un linguaggio. Il linguaggio poetico è in sé il parlare iniziale, essenziale: è il parlare che il linguaggio parla attraverso il poeta. E che il poeta può destinare alla natura: «E presto il mormorio si fe’ parole».
Questo avviene quando – nel dire il vero – il pensiero corrisponde a ciò verso cui la poesia si è incamminata: l’essenza delle cose.
Flavio Ermini
n. 88, Per crescita di buio
Si potrebbe dire che abbiamo due destini:
uno mobile e senza importanza, che si
compie; e un altro, immobile e importante
che non si conosce mai.
Musil
Da tempo l’essenza della verità ha subito nella sua determinazione un mutamento radicale. Da evento inerente all’essere – di cui esprimere l’alétheia, la “non-latenza” – la verità è diventata un carattere che l’essere assume in rapporto all’intelligenza umana. Tanto che diviene legittimo domandarci: è ancora possibile tornare a esporci all’essere prima di volgersi a qualsiasi altra destinazione? E, come volevano i più antichi pensatori, è ancora possibile considerare il problema dell’essere prioritario rispetto a quello del conoscere?
L’ambizione di “Anterem” è di corrispondere all’essenza della verità – nel suo occultarsi come nel suo manifestarsi – ponendo il testo poetico nelle condizioni di aprire la parola all’essere e di renderla a esso disponibile.
Questo numero della rivista non fa eccezione. Presenta poesie e saggi che non percorrono i consueti cammini del pensiero; non si accontentano di quanto a noi si mostra; vogliono andare oltre l’apparire: verso l’arché, verso l’oscuro fondamento originario di quanto vive e respira nella luce.
L’arché è l’oscurità della notte da cui sorge il sole e in cui il sole si spegne. Diradare la velatezza dell’origine stessa: ecco il senso del nostro cammino.
Il movimento del disvelare – per mostrare ciò che l’essere è in verità – fa del pensare qualcosa come un cogliere e un vedere. Ma nella nostra contemporaneità cosa cogliamo? cosa vediamo? Ecco la domanda che incalza ogni riflessione che abbia a cuore la comprensione dell’essere, soprattutto se si muove in una distinzione tra essere e apparenza.
Viviamo nel tempo dell’affievolirsi della luce. Il vincolo tra terra e cielo è infranto. La parola non scaturisce più dall’altezza di un assoluto per scendere nel grembo di un antro. Non si precisa più come la vitale mescolanza di azzurrità e humus, ma ricade sulla pietra. Oggi la terra non è più la «sala delle feste» nominata da Hölderlin. La terra non è più la patria di un processo in cui arrivano gli dei e trasformano ogni cosa con la loro presenza.
Molteplici mondi si levano verso la luce e altrettante eclissi di luce rientrano nella terra. Ma un’immagine è sempre incombente alle fondamenta di entrambi i movimenti: l’urgere del pericolo per un lutto invincibile. Ed è qui – nel pericolo – che si delinea il darsi della scrittura. Qui, il poeta e il filosofo abitano presso il limite dell’abitabile, dove sono sempre prossimi all’evento dell’essere, ovvero alla dinamica propria del suo duplice manifestarsi: principio e divenire.
Qui la parola, memore del suo stato aurorale, torna a muoversi per iniziativa dei propri tratti. Qui la scrittura torna a decidere dei propri tracciati, ponendosi al servizio unicamente del proprio accadere.
Ecco perché i testi che “Anterem” pubblica su questo numero sono in rapporto con il loro retro-mondo: con l’eclissi, con la rudezza della quale sono stati testimoni. Assistiamo a un movimento che testimonia – tra lampi ed epifanie – una deriva di cielo. Partecipiamo a un venire essenzialmente alla presenza, a un accadimento che ha rotto i patti con la latenza.
L’oscurità da cui nasce il dire può inabissarci a tale profondità da produrre smarrimento. «Si va facendo la frattura fonda» annota Ungaretti. In tale frattura le parole sono le compagne lacerate di un pensiero non ancora formulato, che vive nell’unità spezzata, aperto all’aperto. È un pensiero che non conosce il proprio posto, non trova pace. È spaesato ed estraneo a tutto. Eppure è l’unica esperienza di pensiero che può portare alla svelatezza l’essere nella sua essenza.
Di fronte a questa tenebra che è la vita; di fronte a questa disgregazione che è il mondo sensibile, il poeta tiene gli occhi bene aperti: non si ritrae inorridito davanti al crollo delle illusioni, non si affida a nuovi mascheramenti per occultare il vuoto.
La scrittura segue il processo lungo il quale le forme si dissolvono, fondendosi tra loro; la parola vede la vita culminare nell’abbandonarsi alla caduta, e assiste al trionfante elevarsi della lacerazione su tutto. L’essenza di questo processo è l’intrico in cui s’irretisce l’esistenza: il caos di tutte le possibilità del perire incessante. «Tutto si mischia / senz’ordine e torna / l’originario groviglio» osserva Hölderlin, ricordandoci che la verità è un evento: lo svelarsi stesso dell’essere, in cui l’uomo è coinvolto e messo in questione.
In relazione alla sostanza dell’essere, la parola si mette alla prova; vuole dire il proprio accadere e, con esso, l’accadere di ciò che sempre si ripete: il fuggevole istante che porta a una progressiva caduta.
La parola vuole dire i limiti della condizione umana e la precarietà delle sue edificazioni. Gli dei sono lontani e probabilmente mortali. Esattamente come siamo noi, com’è il mondo, com’è la volta celeste che nel buio comincia e finisce. Quel buio è l’immagine dell’esistenza.
In questa malinconia umbratile e lacerante, dopo il crollo di ogni certezza, il dire poetico si fa carico del problema dell’«immobile e importante» fondo di noi stessi – ovvero dell’essenza dell’essere e del suo evento – dal punto di vista di una finitudine radicale, che si configura come un vero e proprio tramontare verso una notte che appare interminabile.
Flavio Ermini
n. 85, L’irriducibile al sé
Il dire non è soltanto un viaggio dentro noi stessi.
Ciò che a noi interessa lo custodisce l’irriducibile al sé.
Silvano Martini
Trattiamo la letteratura con troppa confidenza. Va accostato con grande cautela il testo, consapevoli che l’attenzione al dire – e al disvelamento che gli è proprio – ci può trasformare. Il testo è ascolto, esperienza, pura possibilità.
Nell’atto del dire, siamo noi a essere parlati. Ed è radicale il controllo che su di noi il testo esercita. Precisa Martin Buber: «Il nostro “essere parlati” è il nostro esserci».
Quel che importa, nell’atto del dire, non è la successione dei passi, non è il metodo, ma è il lasciarsi incontrare per via dal testo. È l’essenziale accadere della parola che va favorito. L’esposizione al dialogo – nella consapevolezza che noi siamo un colloquio – impone una disponibilità ininterrotta.
A questo proposito, avviare un “romantico” processo di discesa in sé – riversandovi le fragili opinioni dell’io – non è più sufficiente. Diventa inevitabile spostare la riflessione sull’essere.
Abbiamo il compito di sottrarre all’io l’indagine poetica del nostro sguardo. Siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di mantenere la parola in cammino, e di consentire in tal modo la piena apertura dell’essere, così com’è: nella sua evidenza, senza alterazioni né mediazioni.
Scrive Jean Rostand: «Dobbiamo stimare invidiabile soltanto chi, essendo riuscito a esentarsi dal proprio io, sa accettare senza ribellione gli allarmi e gli spodestamenti che l’esistenza ci impone».
Mantenere la parola in cammino significa renderla irriducibile al sé. Significa scavare nella propria lingua una lingua straniera e averne cura nel proprio dire.
Molto chiaramente, Aristotele a questo proposito sostiene che la parola – quale logos apophantikos – deve aver cura, innanzitutto, di portare alla luce la struttura aperta e problematica dell’essere, a partire dal suo stesso manifestarsi, per quello che è.
Nella poesia si cela il segreto dell’inizialità. Farne esperienza implica il destinare
l’opera all’irruzione poetica dell’essere, in sintonia con un’esistenza finalmente
disancorata dalla rigida soggettività.
Come non rilevare nel delinearsi di questo orizzonte linguistico – per ciò che il testo lascia da-pensare – una diversa struttura del rapporto poesia-essere? Solo se osservato dagli occhi di un “altro”, oltre l’idea stessa dell’io e delle sue arbitrarie finzioni, il mondo può mostrarsi nella sua essenza.
Con la poesia l’essere umano sta per la prima volta al mondo in quanto essere umano («Pieno di merito, ma poeticamente abita l’uomo su questa terra» ricorda Hölderlin).
C’è un valore di verità fortissimo nell’esperienza poetica. Per questo è ineludibile il costante colloquio con il testo, nel testo: per rintracciare nella sua lingua l’eco di tante antiche domande. Il dialogo tra poesia pensante e pensare poetante appartiene, ci ricorda Heidegger, al «cammino della storia dell’essere», rende visibile la mancanza di Dio, la fine delle illusioni.
La parola deve aiutare i mortali che abitano «poeticamente» il mondo a giungere, prima di chiunque altro, in fondo al caos originario, e così preparare – proprio a partire dal caos originario – il capovolgimento del mondo.
Rammemorare la lingua aurorale, ante rem, significa anticipare quella dell’umanità a-venire, in vista del proprio poter essere.
Il tempo di cui torna a parlarci il poeta è dunque diverso dal tempo “naturale” così come lo avvertono i sensi, ma anche da quello “umano”: a differenza di entrambi, è destinato a non scorrere. La sua estensione geometrica tende allo zero. La sua irriducibilità al sé – esattamente come per l’essere e il dire – è totale.
Lo spazio di ricerca della poesia è pienamente investito dalla crisi linguistica subita dalla soggettività e consiste in un dire cui sia familiare l’incamminamento dello straniero. «Mi contrappongo a me stesso, mi separo da me stesso» registra Hölderlin.
La poesia dice in seno all’esilio, lontano dalla via della ragione.
Qui dà vita a un testo che si regge nel vuoto e custodisce fino alla fine il suo mistero, sfidando logica ed estetica.
Qui l’indeterminazione che verte intorno all’essere diventa l’essere stesso nella sua costituzione.
Flavio Ermini
n. 86, Dire l’essere
Qui non parlo della bellezza, e delle altre “perfezioni”
che gli uomini hanno voluto chiamare perfezioni per
superstizione e ignoranza, ma intendo per perfezione
solo l’essere.
Spinoza
In questo numero di “Anterem” ci troviamo di fronte a un interrogante risalire verso il senso iniziale dell’essere, mediante successivi smantellamenti della soggettività e del suo accumulo di velamenti.
I testi dei poeti e dei pensatori qui convocati manifestano che nel dire si fa presente l’essere dal cui senso siamo determinati. Sottolineano che il nostro compito
consiste nel pensare l’essere nella sua essenza, evitando di sottometterlo al nostro sentire.
Il cammino tracciato mostra come sia possibile restituire alla parola la proprietà di parola pensante-interrogante e impone una questione capitale: è possibile muovere verso l’essere senza tradirlo?
L’esistente incontra e riconosce l’essere nell’attimo risolutivo in cui l’umano e la parola si rapportano in modo autentico, cioè poeticamente. È nella poesia che la parola “essere” si raccorda all’essere in quanto tale.
A questo proposito, va ricordata la grande rivoluzione avvenuta tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, quando il percorso romantico alla volta dell’interiorità diventa un cammino verso l’essere stesso: un passo che impone la dissolvenza del soggetto per giungere a quell’essere cui l’esistente già da sempre appartiene.
Il testo da questo momento non è più qualcosa che esprime o viene espresso, ma è qualcosa che finalmente è soltanto senso. È un processo inaugurato da Hölderlin molti anni prima, quando con la sua poesia si era portato nei pressi dell’originario legame tra esistente ed essere senza interferire con un’atmosfera soggettiva.
Prima di chiunque altro – prima di Nietzsche, prima di Heidegger – Hölderlin riconosce e dispiega “la domanda iniziale dei greci”: la domanda sul Da-Sein, sulla sua apertura all’essere dell’inizio.
Quando il poeta di Mnemosyne prende la parola, la soggettività lirica viene spazzata via: è l’essere a parlare.
Con Hölderlin, il sentire esclusivo dell’autore viene messo fuori gioco ed entra prepotentemente in scena un sentire liberato, che si manifesta come lo spazio dell’esperienza in cui l’essere si mostra.
Da questo momento l’atto letterario autentico è senza autore, non è riconducibile a una soggettività singolare. La sua apertura è universale e la sua concretezza consiste nell’esser-lì puramente come linguaggio.
Il progetto è ambizioso: rimuovere dall’essere in sé le prese temerarie dell’intelletto; allontanare l’essere da ogni illusione possessiva; affidarlo a una sensibilità depurata dalla vanitas e dall’inerzia. Il nostro compito pare proprio che consista nel pensare l’impensabile dell’essere (ovvero l’essere nella sua essenza) senza sottometterlo ad alcuna ipostasi.
Attraverso tale percorso – in assenza di soggetto – si fa strada un principio aurorale sconosciuto all’“interiorità”, rinchiusa com’è nel corpo. Attraverso tale percorso la lingua non designa le cose, bensì esse vi appaiono: la lingua si costituisce come lo spazio in cui le cose si presentano come cose; tanto da costituirsi come esperienza poetica del farsi e del disfarsi dell’intreccio dell’essere.
Per questo possiamo enunciare che nel dire si svela l’essenza stessa dell’essere.
Il dire rifugge da qualunque esito definitorio: lascia emergere l’essere rimettendolo in collegamento con l’origine e lo espone alla sua pura determinabilità.
Quando l’essere sorge, il sensibile è già alle sue spalle. In questo spettacolo dell’essere, l’esistente è chiamato a prendere posto, a esserci: ovvero a stare in una determinata disposizione emotiva, al sentirvisi situato imponendo l’idea che le passioni, le affezioni, la sensibilità siano costitutive dell’uomo, allo stesso titolo della ragione.
Ecco perché il dire può essere invocato per affermare l’unità originaria delle facoltà dell’animo umano. Ecco perché all’avvento di tale unità gli usuali impianti critici sono per tanta parte scalzati. Il fine è volgersi all’essere e, in un silenzioso fare-spazio, accogliere dell’essere l’essenza.
Noi non abbiamo venti, cinquanta, settant’anni. Questo calcolare ci indica solo quel che siamo in apparenza. Noi siamo arcaici, apparteniamo al principio e a questo principio siamo ancora in grado di guardare se solo prendiamo atto che un’opera letteraria non è il prodotto di un individuo “particolarmente dotato”, bensì l’incursione di un’esistenza nello spazio aperto dell’essere.
Per accedervi l’uomo deve privarsi della propria volontà, proprio come lo era in principio, quando non era questo uomo qui o quello là, determinato nel dove e nel quando.
Nella sua struttura, l’esistenza umana è originaria apertura al mondo quale suo orizzonte costitutivo. Non è dunque qualcosa che prima è isolata in sé e poi si aggiunge al mondo. È «l’essere-nel-mondo», come sottolinea Heidegger. L’esserci fin dal principio. Quell’essere che impone ora di opporsi alla cata-strofe: contro la lacerazione dell’esistenza, contro l’allontanamento dell’uomo da se stesso e dalla pienezza originaria, contro la stolta mancanza di rispetto per la natura.
Se uomo e natura si toccano «in pura vita», come sostiene Hölderlin, ecco che l’uomo risplende tra gli elementi. Infatti lo scambio d’essenza con la physis lo rende armonico, tanto che la natura, sottolinea Leopardi, «parla dentro di lui e per la sua bocca».
Non lui parla, dunque, ma è la natura che, de-soggettivizzata, dice se stessa.
Se uomo e natura si toccano, diventano accessibili i confini della terra e si fa pensabile l’antiterra di cui ci parlano i pitagorici, dove l’umbratilità non è più radice di errore; dove irreparabile è soltanto la frattura tra l’ombra e la facoltà fantastica.
Va compiuta fino in fondo l’esperienza poetica che, intonandosi sull’essere e con l’essere, riconosce nell’essere temporalità, vita vivente, invecchiamento e declino, facendosi carico di quel che la filosofia non è più in grado di sopportare. La parola poetica sfugge talvolta allo sviluppo lineare del pensiero. Ecco perché da dentro il discorso sovente riesce a dire quello che il discorso tace.
Insomma, “Anterem” sta lì a indicare che la letteratura non ha altro compito che portare alla luce del pensiero l’essere nella sua essenza: questo essere che il tempo consuma e rovina, ma cui l’eternità sarebbe probabilmente insopportabile, così come lo sono le illusioni che a essa conducono.
Flavio Ermini
n. 87, Nel pericolo del dire
Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch.
Hölderlin
Arduo è cercare l’essenza dell’essere là dove la terra è creduta salda, dove la parola sembra unire essere e verità. È invece possibile che la parola si raccordi pienamente con l’essere proprio là dove s’interrompe l’ordine del linguaggio, quando si apre una crepa nella frase, propriamente: nel pericolo del dire.
Quando la parola spinge a distogliere lo sguardo dalla diritta via, solo allora produce uno smarrimento che fa pensare alla sua originaria condizione poetica. Quando accade, scopriamo vie interrotte, evitate fino a un attimo prima; scopriamo che a ogni interruzione nuovi percorsi invitano al cammino; siamo indotti ad assecondare i tracciati di una logica consequenziale messa continuamente sotto-sopra da sussulti altalenanti. In questo cammino accidentato e incerto – quale si configura in questo numero di “Anterem” – si muovono i nostri passi.
Molteplici sono i sentieri verbali sui quali possiamo avanzare. In ogni caso, scegliere di seguire le dinamiche poetiche della parola significa prendere posizione per il pericolo.
Le vie della scrittura rappresentano una geografia senza carte. Talora basta deviare di poco perché muti il paesaggio e la storia abbia un seguito imprevisto. Altre volte la parola poetica non dà vita nemmeno a quella geografia. Lascia irrappresentate alle sue spalle le terre sconosciute che attraversa. Il suo racconto non esclude che altri possano rifare il suo stesso viaggio come se fossero i primi. La via è ogni volta nuova.
E il punto di arrivo? Affinché la direzione si riveli come la direzione corretta da seguire, non può mettere in conto la salvezza; non deve avere approdo; deve costituire un viaggio interminabile. Se fosse anche solo prevista, la fine del viaggio coinciderebbe con la fine del nostro fare, con la fine della ricerca. Ha ragione Vincenzo Vitiello a definire «umano, troppo umano» il distico di Hölderlin: «Ma dov’è il pericolo, cresce / anche ciò che salva» e a proporne il rovesciamento: «Dov’è ciò che salva, là cresce il pericolo» (cfr. “Anterem” 86).
La via che segue la parola poetica non è la via della conquista, ma, al contrario, la via dell’identità. Il cammino non serve a fornire una conoscenza dei luoghi, ma a dare un nome a chi è in cammino.
Ciò vale anche per la verità. È per renderla pronunciabile che dobbiamo rinunciare a possederla. Ben sapendo che, solo se la verità resterà sempre a-venire, sarà possibile sopportare ciò che di tremendo in essa si cela.
Con la parola tutte le vie si aprono, ma soltanto per richiudersi alle nostre spalle; tutte le vie si confondono, e senza lasciare tracce. Tutte le vie si perdono nell’oblio. Il paesaggio è in perenne sconvolgimento. Niente resta sempre se stesso, né, cambiando, torna poi uguale.
Non possiamo che tracciare una via ulteriore. Scrivere dopo la fine del tempo, per un tempo senza generazione: il tempo che passa senza lasciare niente dietro di sé.
Noi pronunciamo il nostro sì al dire e consentiamo così che il dire abbia luogo. Acconsentendo all’aver luogo del dire, determiniamo che, nell’esperienza della scrittura, si apra a noi l’esperienza abissale dell’essere.
La scrittura è percorsa da una grande ambizione che la rende impervia e come sospesa continuamente sul vuoto del non detto, del già detto, dell’impossibile a dirsi.
Bisogna dimostrarsi all’altezza di ciò che, in un continuo frantumarsi e incessante moltiplicarsi, si nega allo sguardo. Il dire deve accadere per quello che è: vuoto, spaccatura, crepa, lacuna; ma al tempo stesso: contorno, margine, limite, seppure parziale, seppure ogni volta bisognoso di una nuova definizione.
Il punto di partenza non è il dire paradisiaco, ma l’inferno di questo dire, dove l’interrogazione si fa sempre più stringente. È un’interrogazione interminabile, inchiudibile: ci destina a un’erranza senza sosta, a continue deviazioni.
Va preso atto che la parola non è un possesso personale. Va lasciato tempo e spazio alla parola da dire, fino a essere liberi di ascoltarne le domande e, senza alcuna gerarchia, rispondere.
Scrivere, prestando attenzione a qualcosa che non tutti vedono, al prezzo di perdere di vista quello che vedono tutti. Scrivere, facendo cenno all’invisibile: scrivere perché ciò che non si vede e resta nascosto possa essere partecipato, pur lasciandolo nella sua invisibilità.
Questo modo di consentire all’esperienza della scrittura non è possibile senza una discesa nei pozzi dell’anima, che sono i pozzi dove, chini su noi stessi, ci specchiamo. Qui ogni parola lascia che la conoscenza di ciò che si rivela prenda piede in noi. Allora l’invisibile e il vicino si confondono, l’altrove è ovunque, il centro sembra a due passi da noi. L’invisibile resta nascosto nel visibile, sempre a portata di sguardo. È un continuo scendere e salire per la scala, ma senza mai poterne toccare gli estremi: senza raggiungere il cielo, senza mai potersi soffermare a lungo nelle profondità dell’antro.
È tempo di avanzare. Avanzare: dopo aver sperimentato l’esilio assoluto, dopo aver attraversato quanto è straniero alla scrittura. Avanzare: dirigersi alfine verso ciò che del dire è proprio: l’impossibilità del dire, nel pericolo del dire.
Flavio Ermini
Il cammino di conoscenza di "Anterem"
Il nome "Anterem"
di Flavio Ermini
Il nome "Anterem" nasce porgendo attenzione al valore originario della parola, chiamata a essere il luogo di raccordo tra sensibilità e percezione. Questa espressione fa cenno all'«= 0» hölderliniano (Il significato delle tragedie) che a sua volta evoca l'«uguale a zero» di Sofocle (Edipo re).
Altri riferimenti si trovano nelle «archai» che Nietzsche colloca nel «sottosuolo della storia» (Umano, troppo umano) e che Deleuze e Guattari affidano a quella parola rizomatica (Rizoma) a cui è dedicata la prima serie della rivista.
Ma l'opera su cui esplicitamente fa presa il nome "Anterem" è la Scienza nuova di Vico, dove leggiamo: «Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso, ed è propietà de' fanciulli di prendere cose inanimate tra mani e, trastullandosi, favellarvi come se fussero, quelle, persone vive. Questa degnità filologico-filosofica ne appruova che gli uomini del mondo fanciullo, per natura, furono sublimi poeti».
Le sei serie di "Anterem"
Il lavoro di ricerca di "Anterem" ha le sue fondamenta nella grande poesia europea e le cinque serie lungo le quali fin qui si articola il suo cammino di conoscenza corrispondono alle diverse strategie messe in atto nell'ambito di questa tradizione per giungere a nominare la parola nel suo primitivo valore - poetante e insieme pensante -, con le sue inaugurali potenzialità di creazione della cosa, di creazione del mondo.
È una ricerca che ha le sue radici nella Grecia arcaica dei Nomothetes e si inoltra con decisione nell'aperto a cui conducono le strade tracciate da Arnaut (le sestine), Petrarca (Fragmenta), Scève, Ronsard (Sonnets pour Hélèn), Jodelle (i sonetti), Nerval, Jean de Sponde, Hölderlin, Rimbaud (Illuminations), Mallarmé, Rilke, Ungaretti, Char, Celan, Zanzotto.
Prima serie (1976-78)
La prima serie ha per nome La parola rizomatica. Aperti in squarci.
Nasce per una letteratura "senza generale" e all'insegna del comandamento di Kant:
«Sapere aude», osa servirti del tuo intelletto.
Evidente nei primi numeri il riferimento a Rizoma di Deleuze e Guattari, volume pubblicato proprio l'anno della fondazione della rivista: 1976.
Vanno ricordate le parole di Silvano Martini (uno dei fondatori di "Anterem") sul concetto di letteratura rizomatica, perché costituiscono un vero e proprio programma per la prima serie.
«L'albero e il rizoma sono strutture che stanno a indicare due tipi opposti di letteratura. Cos'è un rizoma? Un fusto sotterraneo di piante erbacee perenni, simile a una radice. L'albero, invece, possiede un fusto esterno al terreno, che poggia su radici e si espande in rami. La letteratura arborea è centrica. Quella rizomatica è acentrica. Nella prima tutto si svolge tra vertice e base, in rapporto di chiara concatenazione e di rigida dipendenza. Nell'altra, ogni svolgimento è base e vertice insieme, e tutti gli svolgimenti hanno la medesima importanza. La letteratura rizomatica permette qualcosa di specifico che normalmente non si dà: il collegamento di un punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi della sfera vitale. Questo significa che la circolazione del senso ha una libertà illimitata».
Tali riflessioni - pubblicate sul n. 7 (aprile 1978) della rivista rivelano che è svanita l'idea di un centro unitario che rappresenti un riferimento sicuro per la nostra esperienza.
Seconda serie (1978-83)
Il nome della seconda serie è Forme dell'infrazione. Il suo programma consiste nell'elaborare nuove strutture di pensiero e dare vita a forme espressive adeguate a parlarne. È il periodo "sperimentale" della rivista, durante il quale viene svolto un grande lavoro intorno allo svuotamento della parola (con preciso riferimento a Mallarmé), alla sia frammentazione (tenendo conto del pensiero di Nietzsche), alla sua connessione con la caducità (Kafka).
Viene seguita alla lettera l'indicazione di giungere all'unità preriflessiva, prelogica della parola. A contatto con le nostre ombre interiori.
L'inexplicable dispiegato è già la nostra instabile e provvisoria dimora. Dietro di sé non ha il verbum divino, ma l'ingens sylva dello stato demonico arcaico.
La rivista si dà con questa serie due occhi esterni e uno interno; un piede nel firmamento e uno sottoterra. Inizia a far segno, con Sofocle e Hölderlin, allo zero, quale effetto di una cancellazione che lo precedeLa poesia mette la propria presenza in contatto perenne con il segreto del mondo.
Ecco perché fondamentale diventa oggi il compito al quale sono da sempre chiamati i poeti: guarire le parole, consentendo l'emergere di un dire che ci preesiste: quella «vera narratio» vichiana, dove fantasia e conoscenza sono una cosa sola. Giungendo a codificare nella frase poetica non solo un'espressione artistica, ma anche vere e proprie forme di sopravvivenza.
Terza serie (1983-93)
Le ragioni della poesia. Questo è il nome della terza serie. Qui viene propugnato uno sguardo che muova dalla poesia, dal pensiero nascente.
Qui si parla della responsabilità etica del poeta chiamato a corrispondere al testo.
Qui si afferma che il poeta è colui che parla dal linguaggio e che cerca di condurre il lettore alla convergenza del sapere con l'inconosciuto. Su quel confine spetterà a chi legge individuare la soglia.
Il poeta in fondo ha un solo compito, ma capitale: spingersi fino al limite del dire oltre il quale ha luogo la contesa originaria che nomina l'iniziale differenziarsi del tutto.
La parola del poeta conduce in realtà all'ascolto di se stessi e non della poesia. Ecco perché la parola che stiamo ascoltando è vicinissima a ciò che siamo. Ecco perché scopriamo che non c'è diversità tra quella parola e il silenzio che porta diritto a noi stessi. La poesia, come suggerisce Paul Celan, è «forse soltanto uno sviamento che porta da te a te». Tale riflessione è molto importante. Sarà in questo «sviamento» che il lettore si collocherà. Questo «sviamento» nasce dal desiderio di dare respiro al respiro della parola; scaturisce dalla necessità di far risuonare il silenzio originario, quel silenzio da cui ognuno di noi proviene e nel quale ciascuno, leggendo, torna a dimorare.
Quarta serie (1993-2001)
La quarta serie della rivista è dedicata alle Figure della duplicità.
In queste pagine viene, sì, ribadito che nell'alleanza tra parola poetica e parola cognitiva sta la strada percorribile per l'esperienza di pensiero del poeta; ma si annuncia altresì che ulteriori e decisivi spostamenti vanno compiuti. Utili a introdurci in una tonalità poetica complessa e rischiosa. In una pratica della scrittura di cui non è agevole immaginare i contorni e gli esiti. Uno scrivere che della parola sconvolga i margini, alteri i limiti e mostri le irrisolte contraddizioni. Uno scrivere che si volga alla produzione di segni di nascondimento, dove la parola produca i termini del silenzio da cui trae origine.
Come "Anterem" intenda la duplicità viene messo in rilievo nel numero dedicato all'Endiadi (n. 59, dicembre 1999).
Endiadi, hén diá dyóin, uno per mezzo di due: non una generica ambiguità, ma l'"endiadi", la vera e propria irriducibile compresenza del due-in-uno.
S'impone, con questa figura della duplicità, la controversa questione sul senso che nel testo si articola quando nella parola viene ripristinata l'inaugurale coappartenenza tra voce e silenzio, mantenendo ferma la differenza che il mondo, costituendosi in categorie, sopprime.
Quinta serie (2001-09)
La quinta serie è dedicata agli Elementi della percezione.
Il rapporto fra parola e cosa torna a farsi cruciale. Le cose sono nel raggio dell'attenzione. Ma, come ci dicono i poeti e i filosofi, non se ne coglie mai con esattezza l'essenza.
L'uomo conosce soltanto segni vuoti, non le cose in se stesse. Per conoscerle sono necessari all'uomo una mediazione (il linguaggio), delle leggi (quelle della ragione), l'osservazione (attraverso i sensi). Va da sé che l'uomo può conoscere solo la propria ombra (data dal linguaggio, dalle leggi, dai sensi) che lui stesso frappone tra sé e le cose. E con la parola può esprimere solo la propria opinione.
Il tempo dell'aggancio alle cose diviene un gioco interminabile di avvicinamenti e allontanamenti. E di scoperte minime, che, pur raggruppate, forniscono una somma solo parziale di dati. O una somma totale insensata; essendo l'ingrandimento di un solo addendo: quello più evidente per l'occhio che si muove sul mondo.
Il risultato ultimo, ammesso che ci possa essere, è sempre eleatorio. E quando circoscriviamo quello che ci sembra essere prossimo al vero, avvertiamo ancor più che il nostro calcolo richiede una revisione, che quasi sempre richiede il congedo dall'abituale modo di vivere e pensare.
Sesta serie
Con questa serie - tuttora in atto - della rivista ci proponiamo di enunciare e approfondire alcune questioni relative all'esperienza poetica del pensiero. Bisogna intendere bene cosa sia l'esperienza poetica del pensiero. Già con i primi numeri abbiamo mostrato in quali radici affonda e in che cosa consiste la sua radicale differenza e irriducibilità rispetto ad altre forme di conoscenza, più specificamente filosofiche e scientifiche.
Il colloquio tra il pensiero e la parola poetica - quando il pensiero si mette all'altezza di una parola proveniente da un altro luogo - è un momento strutturale, decisivo del pensare che accade nel linguaggio. Nel rapporto che s'istituisce, ognuno dei due termini viene sospinto al limite del proprio senso, per offrirsi a una produzione di senso principiale.
Indice generale degli Autori
dal n. 1 (maggio 1976) al n. 98 (giugno 2019)
Abril,Henri,92
Accame,Vincenzo,16,20-21,37,38
Accattino,Adriano,63
Accrocca,Elio Filippo,44
Adami,Claudio,55
Adami,Giorgio G.,42
Agosti,Stefano,11-12,52,57
Agostinucci,Giovanni,49
Agrafiotis,Demosthene,58
Ajazzi Mancini,Mario,81
Aigner,Christoph Wilhelm,66
Aino,Marisa G.,11-12
Airaghi,Alida,6
Aita,Paolo,94
Alain,89
Alamaro,Eduardo,7
Albertazzi,Ferdinando,8-9
Albiach,Anne-Marie,91
Aldighieri,Renato,1,2,5,13,16
Alferi,Pierre,61,71,75
Alvino,Gualberto,77
Anceschi,Giovanni,19,45
Andreotti,Angelo,93
Anedda,Antonella,66
Angelini,Lucio,46
Angioletti,Lina,22
Angioni,Marcello,22,26-27,55
Angius,Luca,38
Antic,Ivo,16
Antoccia,Luca,37,41,48
Apolloni,Ignazio,2,10
Arbizzani,Luciana,8-9,11-12,17-18,19,20-21,23-24,26-27,29-30,32-33,36
Arends,Stuart,53
Arendt,Erich,19
Argnani,Davide,8-9,16
Argullol,Rafael,66,75
Auzias,Jean-Marie,17-18
Azzola,Claudia,96,98
Baccelli,Vittorio,8-9,14-15
Bachmann,Ingeborg,72
Bacigalupo,Massimo,64
Badini,Paolo,13,16,8-9,19,20-21,23-24,26-27,28,29-30,31,34,36,39,42,43,46,47,52,55,56,62,65,69
Badiou,Bertrand,75,84
Bailly,Jean-Christophe,62,76
Baiocchi,Alessandra,17-18,26-27,34,38,46
Baldassarri,Rita,29-30,34
Baldissone,Giusi,59
Balducci,Marco,46
Balestrini,Nanni,49,63,67
Ballerini,Luigi,54,62,66
Ballo,Guido,14-15,25,46
Barani,Lorenzo,83
Barbaglia,Giorgio,59
Barbui,Amelia,17-18,22,25,35,38,48
Baretto,Vittorio,17-18
Barni,Sara,67,69,71
Barry,Jan,11-12
Barthes,Roland,70
Basiri, Iman Mansub, 85
Bataille,Georges,68,72
Battilana,Marilla,4,5
Battistoni,Giorgio,3
Bauchau,Henry,73,75,77
Bea,Anselmo,8-9
Beck,Philippe,62
Bedini,Maria Angela,71,79
Bélanger,Marcel,73,79,92
Bellezza,Dario,19
Bellini,Giorgio,1,2,3,4,8-9,10,11-12,14-15,17-18,19,20-21,23-24,26-27,29-30,35,36
Bellocchio,Silvana,3,4,5,6
Belluomini,Francesco,29-30
Beltrametti,Franco,4,8-9,13,22,25,26-27,31,39,54
Bènézet,Mathieu,52,54,56,71
Benfatti,Carlo,3
Bennett,Guy,59
Benvenuti,Giuliana,49,50
Berardini,Sergio Fabio,97
Bergamini,Giacomo,10,16,17-18,19,20-21,23-24,26-27,29-30,32-33,35,36,39,42,43,44,45,49,53,58,62,64,71,80,82,85
Berio,Luciano,63
Bernhard,Thomas,72
Berra Schwendimann,Donata,40
Berta,Mauro,38
Bertola,Carla,7,17-18
Bertoldi,Piero,19
Bertoni,Pier Luigi,17-18,20-21
Bertoni,Roberto,60
Bettarini,Mariella,2,7,46
Biagi,Dario,5,8-9,11-12
Bianconi,Anna Rita,38
Bigliosi,Cinzia,68
Bisconti,Loris,16
Bisinger,Gerald,22,25,35
Bissani,Roberto,83
Blaine,Julien,10
Blanchot,Maurice,56,57
Bodei,Remo,81,92
Boille,Luigi,84
Bolelli,Franco,35,48
Bompiani,Ginevra,48,56,57,66,72
Bonacini,Giorgio,16,38,41,42,43,46,47,51,55,57,59,64,67,71,73,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98
Bonaguro,Fidelio,65,84
Bonazzi,Matteo,73,79,89,95
Bonecchi,Adalberto,14-15
Bonesio,Luisa,58
Bonessio di Terzet,Ettore, 22,40
Bonifazio,Massimo,60
Bonito,Vitaniello,60,62
Bonnefoy,Yves,52,57,60,61,65,66,69,70,77,80,81,82,83,85,86,88,90,92,97
Borghesi, Roberto,87
Borgna,Eugenio,96
Bortoli,Silvia,59,61
Bottoni, Mita, 85
Bousquet, Joë,87
Brancale,Domenico,84,85,86,87,90,94,96
Brandolini d'Adda,Brandolino,5,10,14-15,25,26-27,29-30,31,35,36,39,42,44,45,47,49,54,57,60,64
Brandolini d'Adda,Yasmin,34,56
Brandt,Per Aage,62,84
Bre,Silvia,98
Breschi,Fabrizio,52,54
Brignone,Maurizio,29-30,32-33,34
Brinkmann,Rolf Dieter,58
Briosi,Sandro,55
Brivio,Guido,88
Brodskij,Iosif,69, 79
Brossard,Nicole,69,71,80,89,91
Brugnaro,Ferruccio,5
Bruzzo,François,20-21,34,37,48,50,51,56,58,74,76,79,85,90
Bucciol,Gio Batta,89,91,92,94,98
Bugliani,Roberto,22,34,39
Bulla,Hans Georg,55
Buongirolami,Donatella,52
Busceti,Giusi,34,38,43
Bussotti,Sylvano,63
Caccia,Laura,86,89,90,92,94,96,98
Cacciari,Massimo,74,92,96
Cacciatore,Edoardo,48,52,53
Caccioni,Luca,53,58
Caddeo,Rinaldo,40,43
Cagnone,Nanni,66,74,87,93
Caliceti,Giuseppe,32-33
Calzolari,Ginestra,46
Camera,Francesco,81
Camerani,Maurizio,11-12
Campagner,Pietro,49
Campanile,Paola,40
Campi,Davide,4,14-15,17-18,20-21,23-24,26-27,29-30,32-33,35,36,41,42,44,46,47,49,53,60,66,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89
Candiani,Livia,31
Canducci,Lea,38
Capitanio,Giorgio,32-33
Capolongo,Camillo,90
Cappi,Alberto,5,11-12,16,20-21,25,26-27,29-30,32-33,34,36,37,39,42,43,45,47,49,78
Caprara,Giovanni,64
Cara,Domenico,1,2,3,5,6,7,10,11-12,16,,19,23-24,28,32-33,35,36,39,42,44,45,47,54,65
Caracciolo,Allì,55,62
Caramore,Gabriella,75
Carandente,Alessandro,13
Carano,Antonio,38
Carducci,Lisa,40
Carifi,Roberto,22,25,29-30,39
Cariolato,Alfonso,68,70,71,73,74,77,78,79,84,87,90,92,93,96
Carolo,Antonio,32-33
Carravetta Peter,10,11-12,13,19,25,28,32-33,34,36,41,42
Casadei,Alberto,62
Casella,Stefano Maria,59
Caselli,Mauro,59,64,67,75,88,93
Casey,Michael,11-12
Castaldi,Marosia,44,47,49,53
Castellani,Leonardo,11-12,32-33
Castelli Gattinara,Enrico,94,98
Castro-Leon,Sophia,28
Catri,Franca Maria,38
Cavalera,Nadia,49,51
Cavallero,Barbara,66,75
Cavallo,Franco,13,19,25,37,39,45,57
Cavatorta,Beppe,66
Cecconi,Giorgia,70
Celan,Paul,72,75,81,85,87,95
Cenci,Ivana,74
Ceni,Alessandro,35,40
Cenni,Alessandra,46
Centro sociale Leoncavallo,7
Cepollaro,Biagio,32-33
Cercignani,Fausto,40,42,44,46,47
Ceriani,Marco,69
Chambers,Iain,61
Chandan,Vattacharja,46
Chappuis,Pierre,79
Char,René,65,66,75
Cherchi,Luciano,8-9
Cherubini,Nicoletta,16,22
Chiapperini,Renzo,29-30,34,36,41,42
Chiarini,Gioachino,35
Chiarloni,Anna,59
Chinaglia,Ruggero,41
Chlebnikov,Velimir,77
Cimatti,Pietro,22
Cimini,Patrizia,41
Cini,Mara,16,22,31,38,41,42,44,46,47,53,58,62,66,71,73,75,77,79,81,83,84,86,88,91,93,95,97
Cioran, E.M.,85,86
Ciprelli,Rita,31,46
Ciurlia,Sandro,91
Clarke,Adrian,51
Clément,Martine,51
Cogo,Roberto,62
Colafelice,Giacomo,19
Colonna,Silvana,56,69,70,71,74,77,80
Collobert,Danielle,88
Coltelluccio,Adalberto,89
Coluccino,Osvaldo,49,51,53,56,63,59
Comitato unitario di base dei poligrafici,Verona,1
Condello,Federico,51,54,65
Condini,Nereo E.,22,32-33,38,44
Consiglio di fabbrica Mondadori,1,7
Consiglio di zona CGIL-CSL-UIL di San Bonifacio,4
Conte,Bruno,43,44,48,49,55,85
Conte,Giuseppe,11-12,22
Conte,Vitaldo,22,7
Conti,Carlo Marcello,8-9
Conti,Diana,29-30
Contò,Agostino,4,7,8-9,44,45,47
Corazza,Chiara,85
Corman,Cid,25,32-33
Coronato,Rocco,41
Corsino,Elena,69,72,74,78,79,81,86,93
Corti,Giuliano,41,44
Costa,Corrado,13,14-15,16,34
Courtoisie,Rafael,71
Coviello,Michelangelo,34,53
Cremona,Antonino,8-9
Cresci,Mario,51
Cuozzo,Gianluca,96
Curcetti,Antonio,6,61
Curci Vittorino,17-18
Curi,Fausto,49,54
Curi,Umberto,67
Cvetaeva,Marina,69,78,81,93
Czernin,Franz Josef,88
D'Agostino,Paola,97
D'Ambrosio,Matteo,13
D'Egidio,Biagio,20-21,25
D'Elia,Gianni,37
d'Ippolito,Bianca Maria 61
Dagradi,Sergio,59,61
Dal Fior,Mauro,46
Dal Prà,Giancarlo,8-9
Dällenbach,Lucien,59
Danon,Betty,46
Davies,Lyndon,96,98
De Angelis,Milo,62
De Bellis, Carla,85,94
De Cadaval,Rudy,19
De Francesco,Alessandro,75,76,77,78,79,80,82,84,86
De Luna,Adriano,40
De Medici,Alessandra,26-27,32-33,44
De Oliveira,Vera Lúcia,60,61,64
De Rosa,Bruno,62
De Signoribus,Eugenio,32-33,45,50,53
Dego,Giuliano,35
Deguy, Michel,79
Deidier,Roberto,40
Del Pizzo,Massimo,11-12
Dell'Arte,Antonietta,32-33
Della Casa,Giuliano,46
Della Corte,Carlo,46
Della Ragione,Pasquale,17-18,43,46
Della Torca,Pasquale,17-18
Delogu,Antonio,98
Democrazia proletaria,4
Denini,Francesco,44,46,54
Derrida,Jacques,62,85
des Forêts,Louis-René,70,92
Desnos,Robert,84
Detenuti del carcere di Treviso,2
Detenuti di piazza Castello,6
Di Ambra,Raffaella,19,40,44,63
Di Iorio,Marisa,38,46
Di Lallo,Lino,32-33
Di Lascia,Vincenzo,29-30
Di Lieto,Giannino,11-12
Di Maio,Nicola,2,7
Di Viesti,Pasquale,17-18
Dickinson,Emily,91,95
Diodato,Roberto,65,70,85,90,95
Docimo,Stefano,34,40,41
Donà,Massimo,65,67,70,72,89,93
Donati,Giuliano,38
Donatoni,Franco,63
Donda,Ellis,44,51,54,56,70,95
Donhauser,Michael,89,91,93,98
Donini,Paolo,81,88
Dotti,Marco,75
Doumet,Christian,51,57
Drudi,Gabriella,37,41,43,46,53,56,74
Drummond-Milne,David,16
du Bouchet,André,68,80,84
Ducros,Franc,72,73,75,80,87,89,97
Duminuco, Giovanni,87,92
Dupin,Jacques,86
Duque,Félix,72,79,82,87
Durante,Tommaso,52,81
Ebani,Ardea,19
Ecker,Gottfried,66
Ehrhart,W.D.,11-12
Elefante,Chiara,73,77
Èluard,Paul,98
Emaz,Antoine,65,87
Emo,Andrea,70
Ercolani,Marco,17-18,72,84
Ermini,Flavio,1,2,3,4,5,6,8-9,10,13,14-15,17-18,19,20-21,23-24,26-27,28,29-30,35,36,39,42,43,45,47,51,53,60,64,69,72,74,76,78,80,83,85,87,90,92,93,96,98
Esposito,Marianna,68
Esteban,Claude,93
Eumenidi,4,10
Eustace,Peter,60
Fachinelli,Elvio,7
Falasca,Franco,43,48
Farnararo,Anna Maria,51
Fatica,Ottavio,73,74
Fautrier,Jean,94
Favaro,Roberto,63
Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL,Verona,4
Feintuch,Robert,51
Ferrara,Ranieri Walter,38
Ferrari,Federico,75,76,78,85
Ferraris,Aldo,40,42,44,46,47,50
Ferreri,Franco,5,7,14-15,31,34
Ferri,Gio,1,4,6,19,20-21,23-24,26-27,28,29-30,31,35,36,39,42,43,45,47,50
Ferro,Pier Luigi,35,38,40,43
Fesslová,Vlasta,69
Filippi,Elena,96
Finazzer Flory,Massimiliano,74,76,79
Finzi,Gilberto,7,11-12,14-15,20-21,48
Fiocchi,Angelo,62
Fiorentino,Alfio,4,5,6,10
Flaccus,Peter,89
Flaminien,Jean,59,95
Florit,Rita R.,97
Focchi,Marco,48
Folin,Alberto,60,68,74,76,78,80,83,88,91,92
Fondane,Benjamin,96
Fontana,Giovanni,22,25,26-27,28,29-30,32-33,35,36,41,42,44
Fontanella,Luigi,16,22,25,29-30,35,39
Fores,Luis,31,41
Formaggio,Dino,48
Forveille,Elisabeth,6
Foschi,Adriano,3,7
Fostieris,Antonis,88
Foucault,Michel,58
Fracassa,Ugo,59
Franceschi,Kiki,19
Franck,Giorgio,59,82,87,90,94
Frare,Giancarla,97
Frau,Greta,64
Frene,Giovanna,56,59,73
Frisa,Lucetta,74,93
Frostenson,Katarina,73,78
Furia,Marco,41,42,43,45,47,52,54,57,61,65,69,72,74,76,78,80,83,85,87,89,91,93,95,97
Füssli,Johann Heinrich,72
Füzesséry-Pedroli,Giovanna,22
Gabellone,Pascal,75,77,81,86,89,90
Gabbia,Gabriele,95
Gagliano,Maria Rosaria,61
Gagnaire,Aline,28
Gagno,Roberto,2
Gagnon,Madeleine,74
Galimberti,Umberto,61,68
Galli Giallini,Elena,45
Gallian,Enrico,59,79
Galvão,Donizete,64
Gamberini,Spartaco,7,16
Garavelli,Bianca,31
García Düttmann,Alexander,51,55,58,61
García Montero,Luis,60
Gardini,Luisa,56
Garelli,Jacques,76,79,80
Gargani,Aldo Giorgio,59,60,61,64,74,80
Gasparotti,Romano,83,92
Gastini,Marco,67
Gaudio,V.S.,1,2,4,6,7,10,25,46
Genovese,Andrea,2,17-18,19
Gentili,Carlo,55
Gentilini,Luca,22,25,26-27,28,31,35,36,41,42,44,46,47
Germani,Mauro,44
Gerratana,Mimmo,43
Ghiandoni,Gabriele,41
Ghignoli,Alessandro,60,61,62,64,66,69,70,71,75,78,83,87
Giachery,Gianluca,58,66,96
Giacobino,Margherita,41
Giacomucci,Ubaldo,22,29-30,38,46
Giannetto,Enrico,92,97
Giannitrapani,Angela,26-27
Giorello,Giulio,70
Giorgi,Mario,50
Giorgi,Rubina,48,50,54,58
Giovannetti,Giovanni,37
Girardelli,Gabriele,8-9
Giuliana,Vito,40,42,44,46,51,54,57,61,64
Giusti,Francesco,49,55
Givone,Sergio,76,79
Gleize,Jean-Marie,52,78
Gobbi,Lorenzo,95
Gombos,Marcello,72,77
Gonzalez Sanchez,Ronel,92
Goria,Françoise,41,52
Gorret,Daniele,60,61,71
Gosetti,Valentina,98
Gourmont, Remy de,91
Graffi,Milli,16,22,29-30,35,36,41,42,44,46,47
Gramigna,Giuliano,11-12,13,19,34,37,39,51,55,63
Grandmont,Dominique,98
Grasso,Elio,6,8-9,10,13,14-15,16,19,20-21,23-24,26-27,28,29-30,31,46
Graziani,Mauro,35
Gremizzi,Ilaria,83
Greppi,Cesare,50,54,62
Grillini,Lidia,26-27,32-33
Grossman,Evelyne,85
Grossetti,Ferdinando,37
Gruppo di donne dell'F.L.M.,8-9
Gruppo di donne,7
Gruppo per una psichiatria alternativa di Vercelli,6
Gualtieri,Massimo,4,13,16,22,25,26-27,28,31,35,36,41,42,44,45,47
Guanti,Giovanni,63
Guarracino,Vincenzo,14-15,20-21,25,26-27,29-30,32-33,35,36,40
Guattari,Félix,83
Gubinelli,Paolo,96
Guerresi,Patrizia,14-15
Guerri, Federico,87
Guglielmi,Guido,48,52,55
Guglielmin,Stefano,67
Guglielmino,Giorgio,19,22,36,38,39,42,44,45,47,51,52,53
Guiducci,Roberto,50
Guzzi,Paolo,40
Haddad,Hubert,83
Hanson,Alice M.,37
Hapkemeyer,Andreas,50
Härle,Clemens-Carl,51,54,58,61,63,70,75,78,80,84
Heimbächer Evangelisti,Irmela,64
Held,Riccardo,69
Helder,Herberto,71
Helmes,Scott,17-18
Héraud,Jean-Paul,72
Hilbig,Wolfgang,57,58
Holan,Vladimír,69
Hölderlin,Friedrich,76,81,95
Hollan,Alexandre,70
Hons,Gaspard,32-33
Huber,Christine,80
Hubin,Christian,76,80,96,97
Huchel,Peter,72
Infelise,Giovanni,43
Ingenito,Domenico,71
Insana,Jolanda,35
Invernizzi,Carlo,71
Irigaray,Luce,80
Isella,Gilberto,67
Jaccottet,Philippe,66,88
Jabès,Edmond,79,83
Jâmî,’Abd al-Rahmân,85
Jandl,Ernst,72
Jankélevitch,Vladimir,70
Jesenská,Milena,97
Job,Renato,35,38,44
Júdice,Nuno,89
Juvara,Raffaello,29-30
Kado,Giulia,63,75
Kampmann,Eva,62,84
Keguenne,Jack,14-15
Kemeny,Tomaso,22,37,39
Kerschbaumer,Marie-Thérèse,67
Kim,Eunice,91
Kirsch,Sarah,55,62
Klivar,Miroslav,13
Kolleritsch,Alfred,55,60,67,75
Krechel,Ursula,71
Kurimoto,Akio 23-24
Lacchin,Giancarlo,66
Lacoue-Labarthe,Philippe,63,65,73,77,93
Lamarque,Vivian,31,39
Lamartora,Enzo,98
Lanuzza,Stefano,3,6,7,8-9,11-12,37
Lanciani,Giulia,89
Lanza,Manfredi,17-18
Laporte,Roger,62,67
Larocchi,Alessio,50
Larocchi,Marica,44,46,47,49,51,53,56,59,62,63,65,66,67,68
Lastraioli,Franco,4
Lavaillante,Renée,71
Lavant,Cristine,56,69,72
Lavina,Silvia,81,91,94,97
Lavoratrici del tomaificio Illasi,4
Legnaghi,Piera,26-27
Lentengre Marie-Louise,52
Lentini,Alfonso,38,43,46
Leoni,Federico,73,74,76,79,80
Leoni,Giulio,20-21,25,26-27,28,32-33,35,42
Leopardi,Gicaomo,81
Lerose,Cosimo,32-33,37,46,50,54
Leucadi,Giancarlo,49
Lezama Lima,José,64,66,71
Li Genbao,16
Li Ying,16
Licciardello,Nicola,64,66
Lima,Robert,22
Lio,Eugenio,89,95
Lischi,Patrizia,72
Llansol,Maria Gabriela,97
Locatelli,Carla,40,45,50,55,62,68,92,98
Lolini,Attilio,3,8-9,13,16
Lonardi,Gilberto,78
Longville,Tim,25,31
Lora-Totino,Arrigo,10,52
Loreau,Max,75
Lorenzetti,Carmen,92
Lucchini Bononi,Giuliana,41
Lucrezi,Eugenio,40
Lunetta,Mario,25,37,38
Lynch,Brian,60
Lytle,John,11-12
Maderna,Bruno,63
Madrussan,Elena,98
Maffesoli,Michel,41
Magaña Merlo, Gabriel,87,93
Maggi,Dario,63,65,70
Magrelli,Valerio,31
Magrini,Marco,6
Magris,Claudio,48
Maj,Barnaba,85
Majellaro,Dino,11-12
Majellaro,Nino,3,5,7,8-9,13,34,39,45
Majer,Giovanni,70
Majorino,Giancarlo,19
Maldiney,Henri,74
Maldonato,Mauro,67,85
Malfaiera,Anna,48,51,55
Mallarmé,Stéphane,57
Manacorda,Giorgio,14-15
Manacorda,Giuliano,37,40
Manca,Gabriele,63
Mandel'stam,Osip,72,74,75,81
Mandolari,Maria Teresa,55
Manescalchi,Franco,25
Manieri,Flavio,41
Mansour,Joyce,97
Manzoni,Franco,34
Manzoni,Gian Ruggero,43
Marcheschi,Daniela,60,62,66,73
Marchetti,Adriano,62,65,66,67,70,75,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
Marchetti,Mirco,55
Marchianò,Grazia,49,56
Marquez Cristo,Gonzalo,81
Mari,Alberto,41,43
Mármol,José,62
Marotta,Francesco,46,51,60
Martinengo,Alberto,98
Martini,Silvano,2,4,5,6,7,8-9,10,11-12,14-15,16,17-18,19,20-21,23-24,26-27,28,29-30,34,36,41,42,44,47,52,71,83,95
Masson,Jean Claude,22,25,26-27,28,29-30
Mastrocola,Paola,22,38
Masullo,Aldo,59,65,84
Mati,Susanna,72,76,78,93
Maugeri,Angelo,7,31,38
Maulpoix,Jean-Michel,65
Mayröcker,Friederike,67,69,71,73,94
Mazzonis,Cesare,61
Mc Clelland,Suzanne,54
Memmo,Francesco Paolo,6,7
Menetti,Nanni,25,39
Mennuti,Rosaria,85
Menon,Gian Giacomo,89,95
Meo,Baldo,38
Merlini Fabio,98
Mesa,Giuliano,53
Mestrovic,Stelvio,38
Métail,Michèle,98
Mezzasalma,Carmelo,25
Miccini,Eugenio,4,13,10,16,37,44
Michaux,Henri,65,93,94
Michon,Pierre,61
Mignani,Rolando,46
Miglio,Camilla,72,75
Mikic,Minya,90
Milanese,Cesare,37,84
Millet-Gérard,Dominique,68
Mogni,Franco,14-15,71
Moio,Giorgio,44
Mollica,Annalisa,17-18
Monticelli,Raphael,79
Montanari,Mario,11-12,14-15,16,17-18,19,20-21
Moorhead,Andrea,29-30,32-33,41
Moorhead,Robert,25,43
Morandi,Franca,71
Morello,Riccardo,62
Morello,Umberto,98
Moretti,Giampiero,59,68,72,75,76,81,86,89,94,95
Mori,Ikuo,14-15
Mori,Massimo,37,45
Moroncini,Bruno,55,59,61,67,77,93
Moroni,Mario,11-12,22,38,40,42,46,43
Morrison,Madison,26-27,35,36,40,42,44,46,47,57,60,65,71,73,77,79,81,82,84,86,88,92
Morseletto,Piera,31
Mozzambani,Alessandro,25
Mujica,Hugo,75,87
Muliere,Carmine Mario,82
Müller,Inge,64
Munier,Roger,94
Muñoz Rojas,José Antonio 64
Muñoz,Miguel,13,25,31,34,36,40,44,45,47,50
Mussio,Magdalo,55,56,57,74,86
Mutini,Claudio,35
Muzzioli,Francesco,37,45,48
Nancy,Jean-Luc,60,62,66,68,79,87,94
Napoleone,Giulia,61,68,77,88,98
Navales,Ana María,64
Nemesiache,3
Neri,Antonio,5
Neri,Giampiero,39,44,59
Netti,Adele,93
Niccolai,Giulia,5,14-15,25,35,44,65,84
Niceforo,Guido,17-18
Nicolao,Federico,60,62,63,65,67
Nicolini,Milena,32-33,45
Nizan,Paul,13
Noël,Bernard,55
Nono,Luigi,63
Notarnicola,Sante,10
Novello,Neil,97
Novello,Riccarda,64,65,66,67,69,71,73,75,84,86
Nuvolari,Mimma,44
Oan Kyu,74,75,80
Obino,Maria,79,80,84,91
Oleschinski,Brigitte,64
Olivato,Luciano,34
Ollier,Claude,57,58,60,63,75
Olmeda,Piero A.,37
Oneroso,Fiorangela,67
Oppezzo,Piera,45,52,57
Oppo,Franco,63
Organizzazioni sindacali FILTA CISL e FILT CGIL,4
Orsino,Margherita,72,73,74,76,77,79,80,83,89,96,97
Ortesta,Cosimo,57,60
Oster,Pierre,70,83
Otto,Walter Friedrich,76
Pacchetti,Marco,17-18
Pagani,Maria Pia,72,74,77,81
Pagnanelli,Remo,34
Palma Ferruccio,46
Palou,Joan,13,22
Paniccia,Nicola,11-12,14-15,34,39,44
Paoli,Feliciano,65,66,69,77,80,85,89,90,91,92
Papa,Domenico,68
Paquet,Basil T.,11-12
Paris,Fabio,22
Paris,Federico,95
Parri,Mario Graziano,17-18,22
Parrinello,Laura,22
Partito comunista italiano,sezione di Illasi,4
Pascoli,Giovanni,86
Passerini,Luisa,37
Patella,Giuseppe,56,68
Pavan,Aldo,7
Pavan,Anna Maria,5
Pavanello,Giancarlo,5,34,39,45
Pavoni,Lilli,3,4,5,6,7,10,11-12,13,14-15,16,17-18,20-21
Pecora,Elio,19,35
Pedace,Pietro,43
Peduzzi,Anna Chiara,80,81,82,83,85,88,94,97
Pegorari,Daniele Maria,83
Pegoraro,Silvia,49,54
Pellegrini,Elisa,31
Pellegrino,Giuseppe,74,79
Penco,Carlo,83,91
Pennati,Camillo,54,63,73,81,91,93
Peressa,Aldo,32-33
Perez,David,20-21
Perfetti,Michele,17-18
Pernaiachi,Gianfranco,56
Perniola,Mario,56
Perotti,Pia M.,11-12
Perrotta,Raffaele,22,34,40,51,56,64
Petrin,Umberto,34,38
Piattella,Oscar,92
Piazza,Raffaele,40
Piccolboni,Marisa,2,3
Piccoli,Renzo,46
Piemontese,Felice,20-21
Pierno,Rosa,44,46,47,49,54,56,61,66,70,73,75,77,79,81,82,84,86,88,90,92,94,96,98
Piersanti,Umberto,39
Pietropaoli,Antonio,56,68,83
Pignotti,Lamberto,6,17-18,20-21,37,45
Inciroli,Gianmarco,97
Pinya,Jaume,13,17-18
Pistoia,Andrea,58
Pitozzi,Ugo,4,16
Pizarnik,Alejandra,83,91,94,97
Pizzi,Marina,34,45
Pizzuto,Antonio,57,77
Pizzuto,Maria,61
Platke,Stan,11-12
Pleynet,Marcelin,90
Polvani,Paolo,10,40
Ponge,Francis,81,82
Pontiggia,Giancarlo,14-15,25,35,38
Porta,Antonio,11-12
Pozzana,Claudia,67,94
Pozzi,Catherine,75
Prabulos,Stephanie,76
Precerutti,Roberto,26-27
Prete,Antonio,70,74,76,78,80,94,95
Pretti,Emma,31
Previ,Leonardo,54,58
Prezzo,Rosella,91
Provenzali,Delfina,68
Pucci,Pietro,37
Pusek,Dubravko,8-9
Pusterla,Fabio,65,66,68,87
Quesada,Mario,5
Quignard,Pascal,74,77,78
Quintavalla,Maria Pia,57
Raboni,Giovanni,69
Rabuffetti,Emi,31
Racine,Charles,67
Raff,Agostino,10
Raffo,Silvio,91
Ramous,Mario,34,40,55
Rampinelli,Pierluigi,5
Ranchetti,Michele,67,69,71,73,77
Ranieri,Carlo,17-18
Rao,Carlo,6
Raos,Andrea,88
Rappaport-Jaccottet,Shoshana,67,81
Raveggi,Patrizia,16
Razzi,Fausto,63
Reading,Peter,38
Recalcati,Claudio,46
Reed,Lou,58,66
Reitani,Luigi,72,88,94,95
Rella,Franco,50,51,52,53,59,76,78,82,86,88,90,92,96
Resta,Caterina,58
Reverdy,Pierre,90
Ribeiro,P.J.,13
Ricci,Antonello,41,52
Riccio,Franco,58,64,68
Righetti,Nicola,16
Rilke,Rainer Maria,95
Rimbaud,Arthur,75
Riponi,Alfredo,95
Risset,Jacqueline,63
Rizza,Massimo,43
Robaey,Jean,31,38,45,67,70
Robotti,Andreina,5,13,17-18
Roche,Maurice,19,63,95
Rofena,Cecilia,75,80,84
Romani,Romano,70
Romano,Lalla,35
Roncari,Stefania,80
Rosa,Leonardo,62,76
Rosati,Sofia Demetrula,88
Rosoldi,Alessio,71,73,77,79,81,82,86,88,92
Rossani,Ottavio,38
Rosselli,Amelia,34,95
Rossi,Antonio,53,58,95
Rossi,Gianni,41
Rossi,Tiziano,34
Roubaud,Jacques,76
Roud,Gustave,67,70,85
Rovagnati,Gabriella,80
Rovatti,Pier Aldo,57
Royet-Journoud,Claude,82,87
Ruan Zhangjing 16
Ruffato,Cesare,13,40,50
Ruffilli,Paolo,7,39
Saffaro,Lucio,50,52,53,56,68,73,79,83,86
Saglimbeni,Sebastiano,4
Sala,Luca,50,55
Salari,Tiziano,59,61,65,67,70,75,76,80,85,90,92
Salvaneschi,Enrica,59,73,76,91
Salvemini,Giacomo,17-18
Sandri,Giovanna,29-30,31,38,48,52,55,58
Sanesi,Andreas,73
Sanesi,Roberto,31,46
Sanguineti,Edoardo,17-18,48,54,57,62,63
Sani,Nicola,63
Sanmann,Angela,75
Sannelli,Massimo,61
Sartori,Cesare,89
Sartorio,Diego,31
Sasia,Roberto,32-33,38,41,44,46,47
Sauvage,Cécile,56
Saviani,Lucio,52,54,57,58,62,68,70,75,84,95
Savio,Guido,6,8-9,10,13,14-15,16,17-18,19
Sbisà,Marina,66
Sbrilli,Antonella,37,41,54
Sbuelz,Antonella,34,38,40,41,42,44,46,47
Scalise,Gregorio,11-12,16,25,28,40
Scelsi,Giacinto,90
Schellino,Andrea,90
Schiavo Campo,Giovanni,53,57
Schieppati,Alberto,25,35,39,44
Schillaci,Filippo,48
Schmied Federico,44
Schneider,Wolfgang Christian,96
Schulze,Klaus,48
Scialoja,Toti,37,39,54,56,57
Scomparin,Paolo,10
Scorretti Claudio G.,22
Scorza,Angela,34
Scotto,Fabio,61,62,90
Scutari,Nadia,3,7,16,31
Sebaste,Beppe,28,32-33
Secchieri,Filippo,32-33,38
Sekiguchi,Ryoko,90
Selleri,Aldo,26-27
Semeli,Ugo,60
Senaldi,Marco,10
Serrao,Achille,10,16
Servetti,Mirko,17-18
Sessa,Lucio,71,72,79,82,87
Sessi,Frediano,35,41
Seyve,Claude,17-18
Signori,Lino,10,11-12,13,16,17-18,20-21
Siles,Jaime,71
Silesius,Angelus,92
Simeone,Bernard,52,91
Simonetti,Oscar,17-18
Sindacati provinciali dei lavoratori tessili,Verona,4
Sindacato nazionale scrittori,5,7
Sini,Carlo,58,68,73,78,82,91
Sitta,Carlo Alberto,4,11-12,13,37
Slacik,Anne,85
Sollazzo,Lucia,59
Sonego,Nelio,78
Sottile,Totò,10,14-15
Spagnuolo,Antonio,3,4,5,14-15,25
Spatola,Adriano,25,31,38
Spinella,Mario,37,46
Sproccati,Sandro,29-30,31,35,36,41,42,43,45
Stapleton,Wilson,14-15
Stecca,Lucio,32-33
Strazzabosco,Stefano,50,51,52,54,58
Stus,Vasyl,74
Sughi,Erio,19
Suied,Alain,61
Tabacco,Costanza,87
Taborelli,Giorgio,61
Tagliaferri,Aldo,50,59
Tagliapietra,Andrea,93
Tarkovskij,Arsenij,96
Tarizzo,Davide,63,64,73,75
Tartaglia,Ferdinando,67
Tatasciore,Carlo,97
Tava,Cristina,28
Tavilla,Elio,31,40,46
Terminelli,Pietro,2,6
Tesauro,Alessandro,34
Teti,Ranieri,29-30,34,46,47,50,53,59,65,69,72,74,76,78,80,82,85,87,89,91,93,95,97
Texto Poetico,13
Thenot,Jean-Paul,20-21
Théoret,France,69,74,77
Thibaudeau,Jean,55,58
Tjutčev,Fëdor I.,86
Tobia,Angelo,43,
Tomatis,Francesco,85,97
Tomiolo,Alberto,13
Tomlinson,Charles,71
Tommasoli,Sirio,41,43,45,47,51,53,60,69,73,75
Toni,Alberto,22,31,38
Torchio,Alvaro,38,41
Tornar,Marco,31
Torre,Carmelo,13,22
Toti,Gianni,4,5,7,19,25,34,37,45
Trakl,Georg,94,97
Travi,Ida,38,42,43,46,47,49,51,53,54,57,59,64,67,71,73,74,76,78,80,82
Trebbi,Giampiero,10,13
Trione,Aldo,68,82,88,90,95
Trotzig,Birgitta,60,62,66,73
Tsukahara,Sachihiko,25
Tulipano,Marco,41
Turati,Paolo,4
Tuzet,Giovanni,64
Ugo,Vittorio,58
Unali,Lina,26-27
Ungaretti, Giuseppe,87,95
Urban, Edith, 77
Urban,Janos,22
Urbani,Angelo,78
Valente,José ángel,61,66,69,70,78
Valentini,Tonino,40
Valentino,Antonello,32-33
Valéry,Paul,96
Valesio,Paolo,22,28,29-30,34,35,36,40,42,45,47
Vallese,Gian Maria,38,43
Valtolina,Amelia,82,83
Vangelisti,Paul,20-21
Varagnolo,Sandro,82,88
Varèse,Edgar,63
Vargaftig,Bernard,82,89
Vassalli,Sebastiano,3,16
Vattimo,Gianni,62
Vegetti,Matteo,73
Velez,Antonio,52,91
Venier,Federica,56,64,69
Vercellone, Federico,87,91
Verdi,Franco,1,2,3,4,5,6,7,8-9
Veruda,Dorian,38
Vicinelli,Patrizia,35,38
Vianello,Giancarlo,98
Villalta,Gian Mario,38,43,56
Vit,Giacomo,6
Vitacchio,Alberto,10,14-15
Vitiello,Ciro,16,25,79
Vitiello,Vincenzo,56,66,70,72,74,76,83,89,91,94,97
Voce,Lello,32-33
Wang Hong,16
Weber,Gerhard,38
Weiss,Beno,22
Witold,René,17-18
Wolf,Christa,56,59
Wühr,Paul,64,65,69,71,84,86
Xardel,Victoria,86
Xerra,William,11-12,16
Yan Zhen,16
Yang Lian,67,94
Yu Jan,71
Zaccaria,Gino,96,97
Zagarrio,Giuseppe,37
Zagoricnik,Franci,16
Zamparini,Grazia,22
Zandomeneghi,Franco,31
Zanghì,Sara,26-27
Zaninetti,Teresio,17-18
Zanzotto,Andrea,38,48,51,60,67
Zappi,Gario,60,96
Zeichen,Valentino,37
Zekri,Caroline,80
Zerboni,Giancarlo,38,43
Ziegler,Martin,74
Zolla,Elémire,50
Zoppetti,Aida Maria,4,22,32-33,43,46,47
Tematiche e serie
PRIMA SERIE
La parola rizomatica. Aperti in squarci
1 —> 9 1976-78
SECONDA SERIE
Forme dell’infrazione
10 —> 22 1978-83
TERZA SERIE
Le ragioni della poesia
23-24 Daidalos 1983
25 Le ragioni della poesia 1984
26-27 L’itinerario della parola nel testo 1984
28 I romanzi 1985
29-30 La citazione nel testo 1985
31 Limen uno 1986
32-33 Limen due 1986
34 La digressione 1987
35 I luoghi geografici della letteratura 1987
36 Exempla I 1988
37 Figure della recensione 1988
38 Exempla II 1989
39 Passaggi uno 1989
40 Passaggi due 1990
41 Specchio e nominazione 1990
42 Versanti 1991
43 Mimetismo della parola 1991
44 Il frammento 1992
45 Varianti 1992
46 Soggetti e oggetti 1993
QUARTA SERIE
Figure della duplicità
47 Mappa albale 1993
48 L’imperfezione 1994
49 Verso 1994
50 L’infinito eccesso del verbo 1995
51 = 0 1995
52 Uguale a zero 1996
53 Ante Rem 1996
54 L’Aperto 1997
55 Metaxy 1997
56 L’Altro 1998
57 Epoché 1998
58 Eterotopie 1999
59 Endiadi 1999
60 Nomothetes 2000
61 Poros e Penia 2000
62 Grados 2001
QUINTA SERIE
Elementi della percezione
63 La poesia pensa il suono 2001
64 Antipensiero 2002
65 Il perturbante 2002
66 Figure del perturbante 2003
67 Lo straniero 2003
68 Pensare l’Antiterra 2004
69 L’Antiterra 2004
70 Nozione di ospitalità 2005
71 L’ospite 2005
72 Hairesis 2006
73 L'esperienza della percezione 2006
74 Anacrusi 2007
75 Dire 2007
76 Dire la vita 2008
77 Forme di vita 2008
78 Apostrophé 2009
79 Tu 2009
SESTA SERIE
L'esperienza poetica del pensiero
80 L'esperienza poetica del pensiero 2010
81 Poetiche del pensiero 2010
82 Pathos del dire ulteriore 2011
83 Di un altro dire 2011
84 La contiguità alle cose 2012
85 L'irriducibile al sé
86 Dire l'essere
87 Nel pericolo del dire
88 Per crescita di buio
89 A dire il vero
90 Le vie dell'errore
91 L'altrove dell'erranza
92 La natura del lavoro poetico
93 La poesia non è un genere letterario
94 Non c'è fine al principio
95 L'altrove poetico
96 Oltre le apparenze
97 Per oscuri sentieri
98 Perché la poesia?
Numero 100 (giugno 2020)
372 pagine, 175 poetesse e poeti di ogni lingua e di ogni parte del mondo, in ordine cronologico per nascita, dal 497 a.C. al 1987. Un numero aureo. La poesia parla sempre "da un'altra lingua".
Per ordinarlo scrivere a premio.montano@anteremedizioni.it

Numero 99 (dicembre 2019)

È in corso di distribuzione il numero 99 di “Anterem” (dicembre 2019), volume di forti convergenze tra pensiero e poesia, come già si può rilevare dal sommario.
Il titolo del numero è “All’insorgere di un’altra lingua”; così lo descrive Flavio Ermini nell’editoriale: “Chiamare da un’altra lingua significa dare scacco al linguaggio a noi noto e farne nascere uno nuovo, sconosciuto. Significa tornare a celebrare autenticamente il battesimo delle cose, insorgendo contro l’apatia del pensiero e contro le grandi macchine dell’estetica”.
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi, in un succedersi avvincente di poesie e saggi che si legano alle opere visive di Marina Bindella.
Anticipiamo per i nostri lettori il testo poetico di Domenico Brancale.
Il numero può essere richiesto a premio.montano@anteremedizioni.it. Lo stesso indirizzo è utile per informazioni sull’abbonamento ad “Anterem”, che consente aggiornamenti costanti sulle più significative tendenze poetiche e teoriche internazionali.
È per noi motivo di orgoglio segnalare ai nostri lettori che gli abbonati riceveranno il n. 100 della rivista (giugno 2020), un numero speciale di oltre trecento pagine, un memorabile traguardo in avanzata fase di lavorazione: questo è un motivo in più per abbonarsi o provvedere al rinnovo dell’abbonamento.
Numero 98 (giugno 2019)

È in corso di distribuzione il numero 98 di “Anterem” (giugno 2019). È un volume di grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario. Un volume destinato come i precedenti a promuovere un ampio dibattito, sia sui giornali, sia nelle università, legato com’è ai bisogni essenziali della vita autentica e alla sua espressione più pura: la parola poetica.
Il tema cui il numero è dedicato è “Perché la poesia?”. A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «La poesia ci offre l’idea esatta di un costante avvicinamento all’essenza naturale, dove tutto succede perché deve accadere. Ci segnala che dall’altra parte della lingua giunge un segnale di guerra e di sedizione che rompe i ponti con lo stato di esilio e porta ad assentire allo stato di natura: un modo di essere in cui giocano un ruolo importante tutte le facoltà interroganti della parola. Questo può accadere perché dall’altra parte della lingua è ancora presente una comprensione autentica della verità, non legata a una teorizzazione umana, ma a una rivelazione della physis».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Anticipiamo per i nostri lettori i testi poetici del poeta viennese Michael Donhauser, tradotti da Gio Batta Bucciol, oltre che alcune riflessioni teoriche di Paul Éluard, tradotte da Adriano Marchetti.
Questo speciale numero (che conta tra i saggisti Martinengo, Vianello, Castelli Gattinara, Delogu, Madrussan, Locatelli, Merlini) può essere richiesto direttamente alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Allo stesso indirizzo possono essere richieste informazioni per abbonarsi ad “Anterem”, in modo da avere un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche e teoriche internazionali.
È per noi motivo di orgoglio segnalare ai nostri lettori che agli abbonati sarà riservato il n. 100 della rivista, un numero speciale di oltre trecento pagine, che già stiamo progettando per celebrare questo memorabile traguardo.
Questo è un motivo in più per abbonarsi o provvedere al rinnovo dell’abbonamento.
Ne parla Giorgio Mancinelli su La Recherche, Paola Ricci su 3A©T,
Numero 97 (dicembre 2018)

È in corso di distribuzione il numero 97 di “Anterem” (dicembre 2018). È un volume di grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario. Un volume destinato come i precedenti a promuovere riflessioni e dibattiti, sia sui giornali, sia nelle università, legato com’è ai bisogni essenziali della vita autentica.
Il tema cui il numero è dedicato è “Per oscuri sentieri”. A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «La parola poetica non può essere usata per portare qualche sollievo sull’arido cammino del pensiero. Il dire che le è proprio segue gli oscuri sentieri dell’interiorità, anche se i suoi abissi sono colmi di angoscia e di sofferenza; anche se nei suoi crepacci vige il nucleo del più profondo ammutolire».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di grande rilievo, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Anticipiamo per i nostri lettori alcune poesie di Ranieri Teti, oltre che i testi poetici della scrittrice portoghese Maria Gabriela Llansol, tradotti da Paola D’Agostino.
Questo speciale numero (che conta tra i saggisti Zaccaria, Vitiello, Giannetto, Jesenská, Berardini, Tatasciore, Tomatis, Pinciroli, Novello) può essere richiesto direttamente alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Allo stesso indirizzo possono essere richieste informazioni per abbonarsi ad “Anterem”, in modo da avere un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche e teoriche internazionali.
È per noi motivo di orgoglio segnalare ai nostri lettori che agli abbonati sarà riservato il n. 100 della rivista, un numero speciale di oltre trecento pagine, che già stiamo progettando per celebrare questo memorabile traguardo.
Ne parla Carlo Alessandro Landini su "Studi cattolici"
La redazione
Numero 96 (giugno 2018)

È in corso di distribuzione il numero 96 di “Anterem” (giugno 2018). È un volume di grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario. Un volume destinato come i precedenti a suscitare riflessioni e dibattiti, sia sui giornali, sia nelle università.
Il tema cui il numero è dedicato è “Oltre le apparenze”. A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «Nel testo poetico, la posta in gioco non è il possibile del progresso, bensì l’aspro orientarsi oltre le apparenze: verso l’inizio. Quell’inizio che coincide con il punto aurorale di strappo dal silenzio alla parola».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Anticipiamo per i nostri lettori i testi poetici di Paul Valéry (tradotti da Adriano Marchetti) e di Domenico Brancale, poeta che firma su queste pagine anche la traduzione dei testi di Benjamin Fondane.
Questo speciale numero (che conta tra i saggisti Rella, Cacciari, Zaccaria, Schneider, Borgna, Giachery, Cariolato, Cuozzo) può essere richiesto direttamente alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Allo stesso indirizzo possono essere richieste informazioni per abbonarsi ad “Anterem”, in modo di avere un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche e teoriche internazionali.
Le poesie di Flavio Ermini pubblicate su questo numero sono state tradotte da Crescenzio Sangiglio sulla rivista greca “εξιτήριον”.
Numero 95 (dicembre 2017)

È in corso di distribuzione il numero 95 di “Anterem” (dicembre 2017). È un volume di grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario.
Il tema cui il numero è dedicato è “L’altrove poetico”. A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «Il dire del poeta ci parla di un altrove dov’è in opera una prospettiva rovesciata rispetto al mondo sensibile. Grazie a questo dire, ciò che eccede il mondo sensibile si esprime nelle proprietà di ogni singola parola, conferendo fondatezza e legittimità a quanto può apparire soltanto empirico e casuale».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Significativamente il numero dà evidenza alle vertiginose poesie di Paul Celan e Rainer Maria Rilke, oltre che a testi di Maurice Roche, Jean Flaminien, Gian Giacomo Menon.
Questo speciale numero può essere richiesto direttamente alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Allo stesso indirizzo possono essere richieste informazioni per abbonarsi ad “Anterem”, in modo di avere un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche e teoriche internazionali.
Ne parlano Giorgio Mancinelli su LaRecherche, Elisabetta Bartoli su Semicerchio 57,
Numero 94 (giugno 2017)
.jpg)
È in corso di distribuzione il numero 94 di “Anterem” (giugno 2017). È un volume di grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario.
Il tema cui il numero è dedicato è “Non c’è fine al principio”. A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «Nella poesia la natura può ancora parlarci come all’origine parlava. Grazie alla poesia le antiche parole tornano alle nostre labbra. Sono parole strappate al silenzio; vere, quanto è vero lo sgomento dinanzi all’inconoscibile».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Significativamente il numero dà evidenza alle vertiginose prose poetiche di Alejandra Pizarnik, nella traduzione di Silvia Lavina, oltre che a testi di Georg Trakl nelle inedite traduzioni di Giampiero Moretti e di Gio Batta Bucciol.
Questo speciale numero può essere richiesto direttamente alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Allo stesso indirizzo possono essere richieste informazioni per ricevere con regolarità “Anterem”, in modo di avere un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Ne parla Danilo Di Matteo sul n. 33 della "Riforma".
Numero 93 (dicembre 2016)

È in corso di distribuzione il numero 93 di “Anterem” (dicembre 2016). È un volume di grande rilievo, come già si può rilevare dal sommario.
Il tema cui il numero è dedicato è “La poesia non è un genere letterario”.
A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: «La parola che parla nella poesia non fa segno, non entra come moneta di scambio nel commercio quotidiano; non fa opera di senso. Non è la parola ineffabile che scende dall’azzurrità, ma quella che sale come fumo e fuoco dal vulcano. È una lingua di “laggiù”, ma è l’unica che può dire cosa accade “qui”». Viene sottolineato in tal modo che «la poesia non è tanto un “genere” o una “categoria letteraria”, non è un mero ornamento dell’esserci e della sua finitudine, bensì una forma di vita che svela una natura probabilmente indefinibile, ma sulla quale non possiamo non riflettere».
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Significativamente il numero si apre con una delle più belle poesie di Marina Cvetaeva: “Poeti”, nella traduzione di Elena Corsino.
Segnaliamo ai nostri lettori un saggio breve di Danilo Di Matteo. Riguarda proprio questo numero di "Anterem" ed è pubblicato sul n. 11 della "Riforma" (17 marzo 2017).
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi. L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
È comunque possibile richiedere anche solo questo speciale fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Numero 92 (giugno 2016)

È in corso di distribuzione il numero 92 di “Anterem” (giugno 2016). È un numero eccezionale, come già si può rilevare dal sommario.
Il tema cui il numero è dedicato è "La natura del lavoro poetico". A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: “Il lavoro poetico consiste nel volgersi all’essenza delle cose, quella che comunemente non si vede, abbagliati come siamo dalle apparenze”. Indicando in tal modo che la natura del lavoro poetico sta nel rimettere in gioco la verità.
Convengono al dialogo su questo numero poeti e filosofi di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Di particolare importanza sono le poesie del poeta cubano Ronel González Sánchez, tradotte da Carmen Lorenzetti.
Va altresì segnalato il racconto di Yves Bonnefoy, tradotto da Feliciano Paoli.
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi. L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
È comunque possibile richiedere anche solo questo “speciale” fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere alla direzione: flavio.ermini@anteremedizioni.it
Condividiamo con i nostri lettori le preziose riflessioni interpretative di Nicola Licciardello.
Numero 91 (dicembre 2015)

È in distribuzione il numero 91 di "Anterem" (dicembre 2015). È un numero straordinario, da collezione. Con questo fascicolo festeggiamo i quarant’anni della rivista! Il tema cui il numero è dedicato è "L’altrove dell’erranza". A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: "Di fronte a una realtà incomprensibile, può sembrare ragionevole chinare il capo e rassegnarci. E invece lo scopo del nostro esserci è cercare una risposta alla precarietà dell’esistere".
Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Di particolare rilievo sono le poesie in lingua spagnola di Alejandra Pizarnik, tradotte da Silvia Lavina.
Vanno altresì segnalati i testi poetici di Remy de Gourmont, tradotti da Adriano Marchetti.
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
È comunque possibile richiedere anche solo questo "speciale" fascicolo, di cui ci parlano Paolo Steffan, Giorgio Mancinelli e Danilo Di Matteo.
Per richieste e informazioni scrivere a: direzione@anteremedizioni.it
Numero 90 (giugno 2015)
“Anterem” 90. Un numero da collezione!
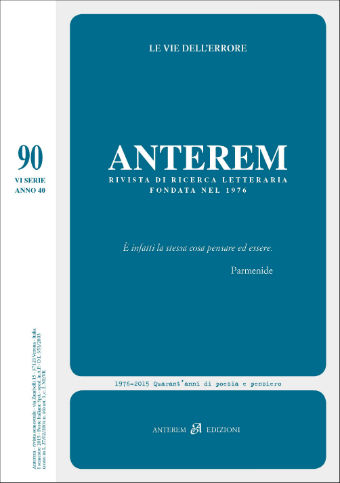
È in distribuzione il numero 90 di “Anterem” (giugno 2015). È un numero speciale, da collezione. Con questo fascicolo festeggiamo i quarant’anni della rivista! Il tema cui il numero è dedicato è “Le vie dell’errore”. A tale proposito Flavio Ermini registra nell’editoriale: “Confrontarci con le vie dell’errore significa riconquistare un rapporto genuino con il pensiero … significa ricominciare finalmente a riflettere su cos’è l’essere”.
Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi.
Di particolare rilievo sono le poesie in lingua francese di Marcelin Pleynet, tradotte da Andrea Schellino.
Vanno altresì segnalati i testi poetici del compositore Giacinto Scelsi, a cura di Domenico Brancale, e i testi di Pierre Reverdy, a cura di Adriano Marchetti.
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
È comunque possibile richiedere anche solo questo “speciale” fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere a: direzione@anteremedizioni.it
Da leggere: una segnalazione di Giorgio Mancinelli, una riflessione di Danilo Di Matteo, un saggio di Vincenzo Guarracino.
Numero 89 (dicembre 2014)

È in distribuzione il numero 89 di "Anterem" (dicembre 2014). Ha per titolo "A dire il vero" e si assume il compito di dare voce – come viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini – a quel particolare moto rivoluzionario che ha lo scopo di "portare a espressione la lingua muta delle cose, operando affinché nella parola umana trovi posto la lingua non comunicabile della physis, così affine a quello che noi non siamo più".
Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi, come già mette in evidenza il sommario.
Di particolare rilievo sono le poesie in lingua tedesca di Michael Donhauser (1956), tradotte da Gio Batta Bucciol.
Vanno altresì segnalati i testi poetici di Gian Giacomo Menon (1910-2000), poeta del quale solo in questi ultimi anni si sta riconoscendo la grandezza, grazie alla cura di un suo allievo, Cesare Sartori.
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. È comunque possibile richiedere anche solo questo fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere a: direzione@anteremedizioni.it
Danilo Di Matteo ne parla su "Riforma" n. 4, 30 gennaio 2015.
Numero 88 (giugno 2014)

È in distribuzione il numero 88 di “Anterem” (giugno 2014). Ha per titolo “Per crescita di buio” e registra – come con disincanto viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini – che “l’oscurità da cui nasce il dire può inabissarci a tale profondità da produrre smarrimento. Gli dei sono lontani e probabilmente mortali. Esattamente come siamo noi, com’è il mondo, com’è la volta celeste che nel buio comincia e finisce. Quel buio è l’immagine dell’esistenza”.
Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi avvincente di poesie e saggi, come già mette in evidenza il sommario.
Di particolare rilievo sono le prose poetiche di Yves Bonnefoy tradotte da Anna Chiara Peduzzi. L’apertura e la chiusura del numero sono affidate a Franz Josef Czernin, nella traduzione di Luigi Reitani.
A tutti coloro che, sulla base di questi elementi, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. È comunque possibile richiedere anche solo questo fascicolo.
Per richieste e informazioni scrivere a: direzione@anteremedizioni.it
Sul numero 25 della "Riforma", un approfondimento critico di Danilo Di Matteo.
Numero 87 (dicembre 2013)
È disponibile il numero 87 di “Anterem” (dicembre 2013). Ha per titolo “Nel pericolo del dire” e registra – come viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini – che “arduo è cercare l’essenza dell’essere là dove la terra è creduta salda, dove la parola sembra unire essere e verità. È invece possibile che la parola si raccordi pienamente con l’essere proprio là dove s’interrompe l’ordine del linguaggio, quando si apre una crepa nella frase, propriamente: nel pericolo del dire”.

Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare rilievo i frammenti poetici di Giuseppe Ungaretti, commentate da Pascal Gabellone e tradotte in tedesco da Paul Celan.
A tutti coloro che, sulla base di questi presupposti, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. È comunque possibile richiedere anche solo questo fascicolo, la cui tiratura è di quattromila copie.
Da oggi l’abbonamento è ancora più conveniente. Infatti, grazie a un accordo con l’editore Moretti&Vitali, tutti gli abbonati alla rivista avranno diritto a uno sconto del 30% sui libri in catalogo di questa casa editrice.
Per richieste e informazioni scrivere a: direzione@anteremedizioni.it
Ne parlano tra gli altri: Danilo Di Matteo sulla Riforma n. 3 del 2014.
Il saggio di Félix Duque viene ripreso da "L'Avvenire"del 20 giugno 2014.
Numero 86 (giugno 2013)
È in distribuzione il numero 86 di “Anterem” (giugno 2013). Ha per titolo “Dire l’essere” e registra – come viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini – che “la letteratura non ha altro compito che portare alla luce del pensiero l’essere nella sua essenza: questo essere che il tempo consuma e rovina, ma cui l’eternità sarebbe probabilmente insopportabile, così come sono insopportabili le illusioni che a essa conducono”.

Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare rilievo le poesie di Fëdor I. Tjutčev (una delle massime espressioni della poesia russa), tradotte da Elena Corsino.
A tutti coloro che, sulla base di questi presupposti, desiderano iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca consigliamo di abbonarsi.
L’abbonamento è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. È comunque possibile richiedere anche solo questo fascicolo.
Informazioni a tale proposito si trovano al link: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Riflessioni di Danilo Di Matteo sul settimanale "Riforma"; segnalazione su "Il Segnalibro"
Numero 85 (dicembre 2012)
È in distribuzione il numero 85 di “Anterem” (dicembre 2012). Ha per titolo “L’irriducibile al sé” ed è dedicato all’“atto del dire”, allorché siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di mantenere la parola in cammino, così come viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini: “Mantenere la parola in cammino significa renderla irriducibile al sé, consentendo in tal modo la piena apertura dell’essere, così com’è: nella sua evidenza, senza alterazioni”.

Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare rilievo la poesia di `Abd al-Rahmân Jâmî, poeta persiano del Quattrocento tradotto da Iman Mansub Basiri e Carla De Bellis.
Vanno altresì segnalate due nuove varianti della “cacciata dal giardino”, narrazioni scritte espressamente per “Anterem” da Yves Bonnefoy, nella traduzione di Feliciano Paoli.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il fascicolo ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca letteraria iniziato nel 1976:
www.anteremedizioni.it/chisiamo_presentazione
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Abbonarsi è facile. Per informazioni: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Su "Anterem" 85 riflessioni e notizie di Danilo Di Matteo, Paolo Cremisini,
Numero 84 (giugno 2012)
È in distribuzione il numero 84 di “Anterem” (giugno 2012). È dedicato all’esposizione del dire all’essere, nella particolare declinazione della “contiguità alle cose”, così come viene sottolineato nell’editoriale di Flavio Ermini: “Il senso della poesia, come quello dell’esistenza, sta nel suo prendere posizione per l’essere, prima di rivolgersi a qualsiasi altra destinazione”.

Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie, narrazioni e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare rilievo la sceneggiatura, mai portata sullo schermo, del poeta e scrittore francese Robert Desnos, proposta nell’inedita traduzione di Fidelio Bonaguro, con testo originale a fronte.
Il numero è introdotto da testi poetici di André du Bouchet, nella traduzione di Maria Obino.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il fascicolo ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di ricerca letteraria iniziato nel 1976: www.anteremedizioni.it/chisiamo_presentazione
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Abbonarsi è facile. Per informazioni: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Numero 83 (dicembre 2011)
È in distribuzione il numero 83 di “Anterem” (dicembre 2011). È dedicato al dire poetico quale «casa ospitale in cui nominazione e indicibile possono sostare, in un tenersi insieme dei differenti: nel loro contraddirsi e nel loro opporsi», come sottolinea nell’editoriale di Flavio Ermini.

Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori
di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie, narrazioni e saggi, come già risulta evidente dal sommario
Di particolare rilievo le poesie di Alejandra Pizarnik, proposte nell’inedita traduzione di Alessandro Ghignoli, con testo originale a fronte.
Il numero è introdotto da una riflessione di Silvano Martini (1923-92), poeta e co-fondatore della rivista, che avremo occasione di ricordare nel 2012, per il ventennale della sua scomparsa.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza iniziato nel 1976:
www.anteremedizioni.it/chisiamo_presentazione
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Abbonarsi è facile. Per informazioni: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Numero 82 (giugno 2011)
È in distribuzione il numero 82 di “Anterem” (giugno 2011). È dedicato all’incessante richiamo alla responsabilità che impone la parola poetica, come sottolinea nell’editoriale Flavio Ermini.

Convengono al dialogo su questo numero poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie, narrazioni e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare rilievo il saggio narrativo di Yves Bonnefoy, proposto nella traduzione di Anna Chiara Peduzzi, con testo originale a fronte.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza iniziato nel 1976: www.anteremedizioni.it/chisiamo_presentazione
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Abbonarsi è facile. Per informazioni: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Numero 81 (dicembre 2010)
È in distribuzione il numero 81 di “Anterem” (dicembre 2010). È dedicato a quegli elementi poetici con i quali il pensiero deve fare i conti quando si trova di fronte a ciò che è da-pensare e – in pari tempo – appaiono insufficienti le categorie finora conosciute, così come viene anticipato nell’editoriale di Flavio Ermini.

Convengono al dialogo su questa tematica poeti e pensatori di rilievo internazionale e storico, in un succedersi articolato di poesie, narrazioni e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare rilievo le poesie di Osip Mandel’stam, proposte nell’inedita traduzione di Maria Pia Pagani, con testo originale a fronte.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza iniziato nel 1976: www.anteremedizioni.it/chisiamo_presentazione
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. Abbonarsi è facile. Per informazioni: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Numero 80 (giugno 2010)
Il n. 80 di “Anterem”: l’esperienza poetica del pensiero

“Anterem” è una rivista di ricerca letteraria. Fondata nel 1976, il suo nome nasce porgendo attenzione al valore originario della parola, chiamata a essere il luogo di raccordo tra sensibilità e percezione. Questa espressione fa cenno all’«= 0» hölderliniano (Il significato delle tragedie) che a sua volta evoca l’«uguale a zero» di Sofocle (Edipo re).
L’opera su cui esplicitamente fa presa il nome “Anterem” è la Scienza nuova di Vico. Altri riferimenti si trovano nelle «archai» che Nietzsche colloca nel «sottosuolo della storia» (Umano, troppo umano) e che Deleuze e Guattari affidano a quella parola rizomatica (Rizoma) a cui è dedicata la prima serie della rivista.
Il lavoro di ricerca di “Anterem” ha le sue fondamenta nella grande poesia europea e le cinque serie lungo le quali fin qui si articola il suo cammino di conoscenza corrispondono alle diverse strategie messe in atto nell’ambito di questa tradizione per giungere a nominare la parola nel suo primitivo valore – poetante e insieme pensante –, con le sue inaugurali potenzialità di creazione della cosa, di creazione del mondo.
Il numero 80 di “Anterem” inaugura una nuova serie della rivista, la sesta, con la quale si fa esplicito il proposito di enunciare e approfondire alcune questioni relative all’esperienza poetica del pensiero.
È un numero problematico. Mette in pagina una pratica conoscitiva che, senza indulgere all’illusione di potersi costituire in sistema, si declina in molte articolazioni.
In ciò si rivela decisivo l’intervento di poeti e pensatori che, accogliendo nel pensiero qualcosa di impensato, aiutano a comprendere e a salvaguardare la parola nella sua purezza e nelle sue tonalità emotive. Ecco qualche nome: Aldo Giorgio Gargani, Yves Bonnefoy, Antonio Prete, André du Bouchet, Luce Irigaray.
Bisogna intendere bene cosa sia l’esperienza poetica del pensiero. Queste pagine cominciano a mostrare in quali radici affonda e in che cosa consiste la sua radicale differenza e irriducibilità rispetto ad altre forme di conoscenza, più specificamente filosofiche e scientifiche.
Flavio Ermini
Numero 79 (dicembre 2009)
Agli studiosi, ai poeti, agli storici della letteratura, agli appassionati di poesia

È in distribuzione l’atteso numero 79 di “Anterem”, dedicato ad alcune questioni letterarie e filosofiche connesse alla figura del “Tu”, così come viene anticipato nell'editoriale di Flavio Ermini.
Convengono al dialogo su questo tema poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie, narrazioni e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare interesse la poesia Natura morta di Iosif Brodskij, proposta nella traduzione di Elena Corsino, con testo originale a fronte.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza iniziato nel 1976: www.anteremedizioni.it/chisiamo_presentazione
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. Abbonarsi è facile. Per informazioni: www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
Numero 78 (giugno 2009)
Agli studiosi, ai poeti, agli storici della letteratura, agli appassionati di poesia
È in distribuzione l’atteso numero 78 di “Anterem”. Il fascicolo (96 pagine) è dedicato ad alcune questioni letterarie e filosofiche connesse all’affascinante figura dell’“Apostrophé”, così come viene anticipato nell’editoriale di Flavio Ermini.
Convengono al dialogo su questo tema poeti e pensatori di rilievo internazionale, in un succedersi articolato di poesie e saggi, come già risulta evidente dal sommario.
Di particolare interesse la poesia Il roveto di Marina Cvetaeva proposta nell’originale traduzione di Elena Corsino; così come la poesia In Aegipten di Paul Celan, proposta nella sua forma autografa e commentata da Clemens Carl Haerle.
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza iniziato nel 1976.
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali. Abbonarsi è facile.
Ulteriori informazioni sull’abbonamento:
www.anteremedizioni.it/rivista_abbonamenti_e_richieste
In occasione dell'uscita del numero si segnala l'intervista di Renzo Montagnoli a Flavio Ermini sul sito:
http://www.arteinsieme.net/renzo/index.php?m=42&det=5295
Numero 77 (dicembre 2008)
Agli appassionati di letteratura e di filosofia, ai poeti, ai filosofi, agli storici della letteratura impegnati in una personale ricerca stilistica e di pensiero

È in distribuzione l’atteso numero 77 di “Anterem”. Ha per titolo “Forme di vita” ed è dedicato a quella parola che si precisa quale “oscuro e insopprimibile tratto costitutivo della vita, un modo d’intendere che trasforma” come viene registrato nell’editoriale di Flavio Ermini. Convengono al dialogo su questo tema poeti, pensatori e artisti, in un succedersi articolato di testi poetici, teorici e segnici.
Elenco collaboratori
Pensiamo di farLe cosa gradita anticipando qui il sommario degli interventi e le pagine dedicate alla poesia di Velimir Chlebnikov il grande poeta definito da Tynjanov “il battistrada del linguaggio poetico” del Novecento Russo.


Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza, iniziato nel 1976.
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Costa 50 euro – da versare sul c.c. postale n. 10583375 intestato alla rivista – e dà diritto a ricevere quattro numeri della rivista.
Ricordiamo ai nostri lettori la formula di abbonamento “rivista con libri”. Costa solo 100 euro ed è estremamente vantaggiosa. In tal modo, infatti, oltre ad “Anterem” l’abbonato riceverà per due anni tutti i volumi pubblicati da Anterem Edizioni e tutti i libri di poesia in coedizione con Cierre Grafica (non meno di 20 volumi).
Da quest’anno c’è un’altra importante novità: i nostri abbonati entreranno a far parte della Giuria dei Lettori del Premio Lorenzo Montano. Avranno in tal modo il diritto di esprimere la loro valutazione sui tre libri vincitori della sezione “Opera edita”, concorrendo così a scegliere il “supervincitore”.
Ulteriori informazioni sull’abbonamento.
Attendiamo le vostre richieste.
Numero 76 (giugno 2008)
Agli appassionati di letteratura e di filosofia, ai poeti, ai filosofi, agli storici della letteratura impegnati in una personale ricerca stilistica e di pensieroÈ in distribuzione l’atteso numero 76 di “Anterem” dedicato ad alcune tra le più cruciali questioni letterarie e filosofiche connesse al “Dire la vita”, come viene puntualmente registrato nell’editoriale di Flavio Ermini [pdf 43 KB]. Convengono al dialogo su questo tema pensatori, poeti e artisti [pdf 68 KB], in un succedersi articolato di testi teorici, poetici e segnici.

Pensiamo di farLe cosa gradita anticipandoLe il sommario [pdf 62 KB] degli interventi e il testo della poesia di Hölderlin [pdf 42 KB] che sigla il fascicolo.

Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza, iniziato nel 1976.
L’abbonamento ad “Anterem” è biennale e consente un aggiornamento costante sulle più significative tendenze poetiche internazionali.
Costa 50 euro – da versare sul c.c. postale n. 10583375 intestato alla rivista – e dà diritto a ricevere quattro numeri della rivista.
Ricordiamo ai nostri lettori la formula di abbonamento “rivista e libri”. Costa solo 100 euro ed è estremamente vantaggiosa. In tal modo, infatti, oltre ad “Anterem” l’abbonato riceverà per due anni tutti i volumi pubblicati da Anterem Edizioni e tutti i libri di poesia in coedizione con Cierre Grafica (non meno di 20 volumi).
Dal 2008 c’è un’altra importante novità: i nostri abbonati entreranno a far parte della Giuria dei Lettori del Premio Lorenzo Montano. Avranno in tal modo il diritto di esprimere la loro valutazione sui tre libri vincitori della sezione “Opera edita”, concorrendo così a scegliere il “supervincitore”.
Ulteriori informazioni sull’abbonamento.
Attendiamo le vostre richieste.
Numero 76 (giugno 2008) - ristampa
Il n. 76 (giugno 2008) di "Anterem" - dedicato al tema Dire la vita e tirato in 3700 esemplari - è andato esaurito nel giro di due mesi. Abbiamo perciò deciso di approntarne la ristampa.I lettori che non sono riusciti a procurarsi il fascicolo possono dunque fin d'ora richiedercelo.

Desideriamo in pari tempo ricordare, a chi ci segue con regolarità, che il modo migliore per avere puntualmente "Anterem" - e non perdere un solo numero - è l'abbonamento biennale. Costa 50 euro - da versare sul c.c. postale n. 10583375 intestato alla rivista - e dà diritto a ricevere quattro numeri della rivista.
Segnaliamo inoltre ai nostri lettori la formula di abbonamento "rivista e libri". Costa soltanto 100 euro ed è estremamente vantaggiosa. In tal modo, infatti, oltre ad "Anterem" l'abbonato riceverà per due anni tutti i volumi pubblicati da Anterem Edizioni e tutti i libri di poesia in coedizione con Cierre Grafica (non meno di 20 volumi).
Ulteriori informazioni per l'abbonamento:
/rivista_abbonamenti_e_richieste
Numero 75 (dicembre 2007)

È finalmente in distribuzione l’atteso numero 75 di “Anterem” dedicato alla cruciale questione del “dire”.
Scrive Flavio Ermini nell’editoriale [pdf 44kb]:
Nel dire accade il ritrarsi e il salvaguardarsi dell’essere; il suo manifestarsi, nel suo sorgere come nel suo svanire. Il dire fonda un abitare in cui si danno convegno le parole colte nell’atto di assentire alle cose e non a una rappresentazione tranquillizzante delle stesse. È grazie a questo universo che la parola è parola. Una parola prima del pensiero, alla quale il nome “parola” forse non conviene più. “Sussurro”, magari, che si esprime nella forma elementare del respiro e dunque della vita. Proprio quel respiro ha voce nella poesia.
Convengono al dialogo su questo tema pensatori, poeti e artisti [pdf 70kb], in un succedersi articolato di testi teorici, poetici e segnici. Il sommario [pdf 62kb] ne dà conto con precisione.
Anticipiamo per i nostri lettori una poesia di Paul Celan [pdf 68kb], edita finora solo in Francia, e il saggio di Gabriella Caramore [pdf 65kb].
Per chi ancora non è abbonato alla rivista “Anterem”, riteniamo che questo sia il numero ideale per iniziare a confrontarsi con il nostro cammino di conoscenza.
Abbonarsi è facile e le formule che proponiamo sono convenienti
Attendiamo le vostre richieste.
Numero 74 (giugno 2007)

L’atteso numero 74 di “Anterem”, dedicato all’Anacrusi, è stato pubblicato.
Rilancia Flavio Ermini nell’editoriale: “Nelle scritture raccolte in questo numero di “Anterem” la parola è colta nell’attimo in cui l’involucro protettivo si spezza. Il silenzio involgente cede e ci restituisce a un movimento inarrestabile che torna a narrare la vicenda della nascita … In queste scritture si allude al viaggio verso le oscurità ctonie, verso tutto ciò che si colloca dopo il limite della temporalità. Si va allora dalla definizione dell’essere al suo seme iniziale. Dai gradini del tempo all’atemporalità …”
L’atto di preludere – su cui fa presa, nella durezza del silenzio e del vuoto, il vocabolo “anacrusi” – è l’esperienza inaugurale sulla quale convergono tutti i testi teorici e poetici proposti in questo numero di “Anterem”.
Esemplari sono a questo proposito la poesia di Vasyl’ Stus (1938-85), poeta dissidente ucraino, traduttore di Goethe e Rilke, candidato al Nobel per la letteratura nel 1985, e la scrittura di Magdalo Mussio (1925-2006), poeta e artista tra i più intensi e innovativi del secondo Novecento, curatore negli anni Sessanta della leggendaria rivista "Marcatre".
Entrambi i testi, qui anticipati, ci confermano quanto con assoluta precisione registra Pascal Quignard in questo stesso numero della rivista: "Il tempo non conosce altra direzione se non quella che nasce dal passato. La riproduzione è la fonte ... Cosa ci orienta? Il vuoto che si stende davanti a noi. Vuoti, buchi che noi invadiamo come ai sognatori piace fare nei sogni. Viviamo sempre nel periodo interglaciale del pleistocene che talvolta chiamiamo attualità. E' la frase che disse Mallarmé nel mese di febbraio del 1895: non esiste il presente. Disinformato colui che si crede un contemporaneo".
Questo numero – così come l’abbonamento alla rivista – potrà essere richiesto a: direzione@anteremedizioni.it
Numero 73 (dicembre 2006)
 Rivista Anterem Numero 73
Rivista Anterem Numero 73
Editoriale
L’esperienza della percezione
Gli uomini sono ossessionati dall’opinione che hanno delle cose, più che dalle cose stesse.
Epitteto
Tra le molteplici dimensioni in cui siamo gettati, e a cui non ci possiamo sottrarre, c’è quella dell’essere destinati a fare esperienza.
Ciascuno di noi è gettato nel tempo ed è condannato a crescere. Il che vuol dire riconoscere che siamo solo un punto tra i tanti, una particella impersonale in un universo sterminato.
Il soggetto non appare più come identità, ma come limite mobile. Si estingue come principio costitutivo del sapere per scoprirsi correlativo ai confini che esplora e alle scelte che compie.
L’esperienza della percezione: ne danno conto i poeti a cui si apre questo numero di “Anterem”. Accompagna i loro testi un nucleo di riflessioni che modula lo stesso tema dal punto di vista filosofico: sotto il profilo del tempo, della parola e della memoria. Ne sono autori Carlo Sini e i collaboratori della cattedra di filosofia teoretica della Statale di Milano.
Le cose sono nel raggio dell’attenzione. Ma, come ci dicono i poeti e i filosofi, non se ne coglie mai con esattezza l’essenza.
L’uomo conosce soltanto segni vuoti, non le cose in se stesse. Per conoscerle sono necessari all’uomo una mediazione (il linguaggio), delle leggi (quelle della ragione), l’osservazione (attraverso i sensi). Va da sé che l’uomo può conoscere solo la propria ombra (data dal linguaggio, dalle leggi, dai sensi) che lui stesso frappone tra sé e le cose. E con la parola può esprimere solo la propria opinione.
La parola non si aggiunge alla parola per dare estensione allo spazio delle cose, ma per modificare la situazione che si era venuta a creare tra le parole precedenti. Ci segnala che qualcosa si aggiunge a quanto già sappiamo.
Parola dopo parola, la mutazione del punto di vista linguistico introduce una mutazione del punto di vista psichico, infrangendone la fissità.
Queste incessanti variazioni ci fanno capire che l’io narrante va subendo una crescita.
La successione verbale non genera architetture, né dona alle cose luce maggiore. L’io narrante ne è consapevole: non mira al possesso scalare dell’oggetto: lo dà semplicemente come irraggiungibile. In un certo senso, egli è un interprete del principio di variabilità.
Il tempo dell’aggancio alle cose diviene un gioco interminabile di avvicinamenti e allontanamenti. E di scoperte minime, che, pur raggruppate, forniscono una somma solo parziale di dati. O una somma totale insensata; essendo l’ingrandimento di un solo addendo: quello più evidente per l’occhio che si muove sul mondo.
Il risultato ultimo, ammesso che ci possa essere, è sempre aleatorio. E quando circoscriviamo quello che ci sembra essere prossimo al vero, avvertiamo ancor più che il nostro calcolo richiede una revisione, che quasi sempre richiede il congedo dall’abituale modo di vivere e pensare.
Eppure, quando l’io narrante arriva a mettere a rischio i fondamenti del proprio sapere, a sfasciarne la logica, a distruggerne i più ovvi punti di riferimento, riesce a mettersi in contatto per un momento con l’essenza delle cose. Ma attenzione, non la cosa, dunque, ma l’essere di questa nel modo in cui di volta in volta si dà. Per cui, non di ridondanza dobbiamo parlare, ma forse di balzi percettivi.
La poesia, quindi, non acceca l’intelletto per consolare il cuore…
«La vera via» scrive Kafka «passa per una corda che non è tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo. Sembra destinata a far inciampare più che a essere percorsa».
Ma è la via più aderente alle cose. E l’io narrante non si stanca di ricercarla.
In direzione di un nuovo “qui” e di nuovo “adesso”, lo spazio indagato torna a esplodere interamente allo scattare di ogni istante. Fa intuire un altrove che non si sa mai dove sia.
Chi guarda, comprende che è fragile, smarrito: sul punto di essere soltanto nell’atto di scrivere. Chi scrive mostra la sua terra insicura, il suo cuore incerto.
L’opera poetica si costituisce propriamente come un disegno del pensiero. È formata da parole la cui successione evidenzia che il cielo circoscrive solo se stesso e che sulla terra la desolazione è compiuta. Ma in pari tempo delimita un habitat in cui, sia pure con disagio, è possibile vivere.
Come può accadere?
Un costante diniego letterario – il divieto di esistere, se non come linguaggio – trattiene questi lembi di vita fantomatica in un mondo di frammenti e di cose disperse. Qui l’io narrante avanza con tanta ignoranza. Ma solo qui può cadere la sua scelta, anche rischiando che la sua azione resti illeggibile.
Ogni sforzo di comprensione totale non può emergere che da questo sfondo abissale, dal caos, quale apertura, spalancamento, disponibilità per tutti i sensi; nell’estremo tentativo di attingere un’ulteriorità di senso nel fluttuare dell’indeterminato. Ne è ben cosciente Spinoza quando scrive: «La perfezione delle cose deve essere valutata soltanto in base alla loro natura e potenza; le cose non sono più o meno perfette perché dilettano o offendono i sensi degli uomini, o perché favoriscono la natura umana o la avversano».
Dentro la costante dell’inaffidabilità in cui si trova ad agire, l’io narrante cerca un’ossatura. Se non c’è, la inventa, in quel fondo di mistero che è la cosa; soprattutto perché vuole andare oltre gli oggetti imitati, oltre la loro fattezza esteriore, il loro fenomenico darsi secondo questa o quella modalità.
Nel forte ramo dell’esistenza, egli mette un incavo dove collocare o nascondere il tempo della nostra esperienza; consapevole che la scelta non è più tra verità e menzogna, ma tra parola che si spaccia per realtà e parola che si dà come tale, l’unica che sulle cose gli procuri una piccola garanzia di ancoraggio.
Ma noi fuggiamo senza posa da una cosa all’altra soltanto per farcene un’opinione e ci distruggiamo da soli. Non facciamo che scappare, fino a quando cessiamo di vivere.
Questo concetto è di tale importanza che (tratto da: Épictète, Enchiridion, X. Traduction de Montaigne, livre II, chap. XIV) lo troviamo tra “Les sentences peintes dans la ‘librairie’ de Montaigne”: «Les hommes sont tourmentés par l’opinion qu’ils ont des choses, non par les choses mêmes».
Flavio Ermini
Sommario
Rivista ANTEREM: Numero 73
L’esperienza della percezione
5 Editoriale
8 Philippe Lacoue-Labarthe Allusione a un inizio (tr. Davide Tarizzo)
14 Birgitta Trotzig Da Anima (tr. Daniela Marcheschi)
18 Katarina Frostenson Poesie (tr. Andreas Sanesi)
22 Friederike Mayröcker Poesie (tr. Riccarda Novello)
24 Ida Travi ‘Tu sei soltanto in allarme’
28 Michele Ranchetti Da Sequenze in levare
29 Enrica Salvaneschi - Silvio Endrighi Poesie
32 Matteo Vegetti La percezione e l’esperienza
36 Federico Leoni «Il mio corpo va fino alle stelle»
39 Matteo Bonazzi Il terzo occhio di Lacan
42 Carlo Sini Oceano e la percezione originaria
46 Franc Ducros Dasorte sillabe strappate (tr. Margherita Orsino)
52 Henry Bauchau Poesie (tr. Chiara Elefante)
62 Marcel Bélanger Da Strates (tr. Alfonso Cariolato)
69 Ottavio Fatica Poesie
72 Davide Campi Bisogni
74 Lucio Saffaro Scritture
78 Camillo Pennati Poesie
80 Giorgio Bonacini Da Sequenze di vento
82 Giovanna Frene Poesie
84 Madison Morrison Rangoon Retrospective (tr. Alessio Rosoldi)
88 Mara Cini Forbice
90 Rosa Pierno Da Trasversale
93 Autori di questo numero
94 Premio di poesia Lorenzo Montano
Esito della XX edizione e bando della XXI
Fotografie di Sirio Tommasoli
Numero 72 (giugno 2006)
 Rivista Anterem Numero 72
Rivista Anterem Numero 72
Editoriale
E sotto il cielo fugace del purgatorio
Noi dimentichiamo spesso che –
La custodia celeste e gioiosa
È la casa terrena che si distende.
Mandel’stam
1.
Un’abbagliata elevatezza ci sta alle spalle e lascia il posto al protendersi dell’uomo verso il fondamento del proprio essere finito: l’incompiuto. Questa eresia – propriamente hairesis, scelta – si è insediata nella parola poetica.
La parola si forma in un ricercare insistente all’interno di molte esperienze. Ma è negata l’eventualità di un dissolvimento in qualcuna di esse. Anzi, ogni posizione raggiunta stimola verso altre; e tutte, invece di elargire risposte, finiscono con l’acuire la tensione della ricerca stessa.
Nel suo ascolto terreno, la parola abbraccia il proprio senso e, insieme, il vuoto che la circonda: si china verso il limite per accoglierlo. In questo divergere da un assoluto armonico, s’inaugurano l’atto poetico e il gesto filosofico della modernità, che pure non smettono di interrogarsi sulla sensazione di vuoto lasciato da quella perdita.
La parola poetica esige la deliberazione e può essere esercitata esclusivamente su ciò che dipende da noi. In questo senso è connessa alla passione per la verità e fa sì che l’uomo sia il principio dei propri atti, come impone Aristotele.
Lì dove appare, la parola accoglie il bagliore che le esperienze hanno saputo esprimere. E lo trattiene, congiuntamente a quel buio che preme per salire, fino al tracciarsi della frase e al compiersi dell’opera. Sicché, come il gesto della mano che si leva “imita” il moto verso l’alto di ciò che è leggero, così il formarsi della frase e l’orizzontale sostare dell’opera “imitano” rispettivamente l’esserci e la stasi delle cose. In un corrispondere che mai è identificazione, né raggiungimento, né tanto meno compenetrazione.
L’affermazione del pensiero sta nel suo rimettersi all’oscurità della materia come a una forma più profonda di sapere e quale banco di prova per la scrittura.
2.
L’opera si costituisce come luogo di parola per la lingua muta delle cose. Accedere all’opera nel suo ricercante tracciarsi svela la vanità di una visione che pretenda di produrre o annientare le cose e mette in guardia dall’uso di parole che abbiano la presunzione di coincidere con la loro insistenza. La parola stessa è a un tempo tutt’uno con la cosa che indica, ma anche ulteriore e dissimile da essa. Per la parola, la cosa non è mai a fuoco nel punto giusto, tanto che il risultato poetico pone sempre un problema di assenza.
Insomma quel che accade nella formulazione di una frase è un continuo allontanarsi di quel confine che dovrebbe unire l’essenza delle cose all’opera. Eppure proprio questa estraneità consente all’opera di vivere una vita propria, indipendente dalle circostanze e dalle tonalità emotive in cui si è formata. Giungendo a manifestarsi in una sua pratica di cosa… Una pratica in cui il confronto con l’impensato diventerà assillante e ineludibile, e consentirà l’annunciarsi del non-detto e l’inaugurazione di quel colloquio originario che precede ogni dialogo tra gli uomini.
Accedere all’opera nel suo farsi presuppone la consapevolezza che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è alle radici dell’essere e attende di venire riconosciuto; e impone di volgere il dire in tutt’altro verso rispetto a quello del discorso, dove la parola semplicemente designa questa o quella cosa, come d’abitudine, e non ha più bellezza. Questa inversione del cammino ci porterà a un’esperienza estetica fondata su una più ampia autonomia del sensibile rispetto all’intelleggibile, e realizzata scegliendo una lingua sconosciuta, non ancora sottomessa al controllo della coscienza: la lingua dei poeti.
3.
Scrive Jünger: «Le cose non si modificano agli occhi di chi è sopra di esse e le osserva, ma mettono in mostra un altro lato della loro realtà». Sale dalle cose il respiro che posa realtà sulla parola e in essa si unisce all’acqua nascosta di un desiderio: trovare il golfo e attingere sicurezze inattaccabili, a difesa non soltanto dell’unicità personale, ma anche di quello stato prelogico ed emozionale che Vico chiama «sapienza poetica» e colloca ante rem.
Scrivere – quale atto di coraggio e di rischio – non rappresenta un abbandono della vita, ma un addentrarsi nel folto dell’esistenza, una disposizione ad aprirci verso noi stessi e ad ascoltarci, trovando nuove parole a cui consegnarci.
Scrivere significa conoscere. E conoscere vuol dire, con Novalis, «sprofondare lo sguardo nell’anima del vasto mondo». Questo movimento va trasformato in uno scorrere di vita, dove l’opera si disponga a dire qualcosa di noi dicendo se stessa. Ecco la cosa che l’opera trae a sé. (Ecco l’opera che la cosa chiama a sé.)
Va prestato ascolto ai poeti che rischiano una dimensione dell’estetica non più intesa come culto di un codice stilistico o rito della forma, ma quale espressione di una svolta cognitiva ed etica insieme, una svolta di portata complessiva del pensiero: uno strumento di comunicazione del materiale preverbale e di un’emozione che ancora non si sa di provare.
Flavio Ermini
Sommario
5 EDITORIALE
7 Osip Mandel’stam - Paul Celan Versioni (tr. Camilla Miglio)
15 Camilla Miglio Tre eresie. Celan traduttore di Mandel’stam
20 Luigi Reitani La scelta dell’eresia
22 Paul Celan Salmi (tr. Luigi Reitani)
28 Osip Mandel’stam Dal Terzo quaderno di Voronez (tr. Elena Corsino)
33 Vincenzo Vitiello Il tramonto di Zarathustra
36 Ingeborg Bachmann Salmo (tr. Luigi Reitani)
40 Christine Lavant Salmi (tr. Luigi Reitani)
42 Osip Mandel’stam Dal Secondo quaderno di Voronez (tr. Maria Pia Pagani)
48 Thomas Bernhard Da Nove salmi (tr. Luigi Reitani)
50 Franc Ducros Da sorte sillabe strappate (tr. Margherita Orsino)
55 Margherita Orsino «L’odeur des roses un matin d’enfance traversée»
56 Flavio Ermini Poesie
59 Susanna Mati Libertà dell’eretico
62 Ernst Jandl a dio (tr. Luigi Reitani)
63 Ranieri Teti Passaggi. Notturni
65 Peter Huchel Salmo (tr. Luigi Reitani)
66 Massimo Donà Ortodossia ed eresia. Figure dell’impossibile
70 Giampiero Moretti Eresia ospitale
73 Ginevra Bompiani Arcani
75 Félix Duque La fiaba, eresia del mito (tr. Lucio Sessa)
78 Marcello Gombos Dagli antichi flutti
79 Marco Ercolani Eresia e intransigenza
82 Marco Furia Abitare il tempo
84 Johann Heinrich Füssli Invenzione (tr. Patrizia Lischi)
86 Patrizia Lischi L’arte difficile della scelta
88 Georges Bataille L’amore divino (tr. Susanna Mati)
94 PREMIO DI POESIA LORENZO MONTANO
Esito della XX edizione
INCISIONI SU LEGNO DI JEAN-PAUL HÉRAUD
Numero 71 (dicembre 2005)
Editoriale
Eppure dalla china dell’orizzonte ultimo del monte il viaggiatorenon porta a valle un pugno di terra, a tutti indicibile, ma una parola conquistata […]
Noi forse siamo qui per dire: casa,
ponte, fontana, porta, brocca, albero da frutto, finestra,
al più: colonna, torre… Ma per dire, capisci,
per dire così, come nell’essenza le cose stesse
mai hanno inteso d’essere.
Rilke
L’OSPITE E LE COSE
Mettersi su ogni strada offerta dal mondo significa accogliere tutto del mondo. Significa non scartare alcuna possibilità e riconoscere l’oscillazione di senso propria dei fenomeni di cui viene fatta esperienza.
Quando osserviamo un fenomeno, noi possiamo con pazienza enumerarne i molteplici aspetti e sentirli interdipendenti. Ci è concesso, entro un certo perimetro di sicurezza, di attribuire a esso un carattere che lo preservi dall’incomprensibilità e dall’insidia del nulla. Entro questo limite, possiamo godere di una sufficiente tranquillità. Dice Socrate: «Le cose hanno ciascuna un suono, una figura, e molte anche un colore». Ebbene, quel suono, quella figura e quel colore sembrano rappresentare proprio la trasparente prossimità a noi delle cose, nello spazio e nel tempo del loro apparire. Eppure quando cerchiamo di gettare ponti tra fenomeno e fenomeno, tra fenomeno e cosa, tra cosa e cosa, vediamo accumularsi sulle nostre operazioni dubbi che ci sconfortano e questioni che minacciano la validità dei procedimenti adottati. Se sono accettabili i singoli termini e qualcuno dei risultati conseguiti, ci appare errata o quanto meno manchevole la conclusione.
«Noi forse siamo qui per dire», scrive Rilke, «… per dire così, come nell’essenza le cose stesse / mai hanno inteso d’essere». La parola poetica porta avanti questo compito con estrema precisione. Il suo è uno sguardo appassionato sulle cose e sulla loro luce oscura. È un approssimarsi alla loro figura, al fine di percepirne anche il più lieve movimento, tra suoni e colori. È una ricognizione per tendere un agguato alla loro lingua. Ma non c’è simmetria nel rapporto tra parola e cosa. Quest’ultima, infatti, tende a occultarsi alla parola che chiede di coglierne l’essenza. Nel suo celarsi, la cosa sottopone i fenomeni che la manifestano a metamorfosi rapidissime, di cui la parola non può afferrare che gli effetti più evidenti. Proprio per questo tenace negarsi, i nostri margini di libertà nel dire diventano ridottissimi e mostrano quanto sia illusorio il nostro crederci vicini al cuore delle cose, delle quali alfine dobbiamo imparare a vedere anche l’ostilità.
Il carattere di ogni procedura cognitiva – che abbia per oggetto, oltre che la parola «conquistata», l’ospite che la pronuncia e le cose – conduce al tema dominante: il desiderio di decifrare il mondo con sufficiente chiarezza pur nella precarietà degli equilibri su cui contare.
L’OSPITE E L’OPERA
Creare un’opera significa disporsi a un’attesa, dopo essersi incamminati su ogni strada offerta dal mondo. Nell’opera, a un’accensione interna corrisponde un’accensione esterna di pari intensità. L’opera parla senza interpreti con la stessa voce del luogo segreto che deve portare alla luce. È la bolla d’aria che da un fondale buio va a esplodere in superficie: una pellicola sensibilizzata da immagini contrastanti: una membrana ricevente che non può arginare né selezionare gli stimoli che la investono. Scrive a tale proposito Musil: «Il pensiero non è qualcosa che osservi ciò che è accaduto interiormente, ma è questo stesso accadere interiore. Noi non ci mettiamo a pensare su qualcosa; al contrario, qualcosa è emergente in noi pensanti. Il pensiero non consiste nel fatto che vediamo chiaramente ciò che si è sviluppato in noi, ma nel fatto che uno sviluppo interno si estende fino a questa zona chiara».
Nel mondo, la presenza è costretta a muoversi sul terreno dell’assenza, a lasciarsi disvelare dal suo stesso sottrarsi. Questo andare verso è anche un permanere… un continuo offrirsi all’aperto che Heidegger chiama Inständigkeit, insistenza… Creare un’opera significa dunque dare continuità a questa procedura creativa; perfezionarla; sospingerla in zone ancora più spettacolari e spericolate; negarle qualunque possibilità di assestamento; affondare le mani nel serbatoio di un magma profondo in perenne mutazione. Ecco perché il poeta aderisce a quel pensiero che è un rispondere a quanto si annuncia prima che l’indagine conoscitiva inizi la sua azione di discernimento. E fa sua una concezione instabile della forma, estranea a ogni sorta di controllo sulle emozioni. Ecco perché l’opera diventa il prodotto di un’esposizione e, insieme, di un ascolto nei confronti del mondo.
Il poeta conosce il distacco dalla conoscenza piena; sa di essersi incamminato verso quel mondo che dà ospitalità a tutte le strategie di percezione dell’essere. O forse sta inventandone di nuove. E torna a lasciarsi sopraffare dalla lingua muta delle cose, a subire la minaccia del silenzio, mettendo in conto manualità elementari, imperfezioni tecniche, automatismi. Il problema dell’unità di espressione, come fedeltà a se stessi e come riconoscibilità, viene emarginato. Al monolitismo di una sigla il poeta cerca di sostituire la frantumazione dello sguardo.
L’opera che non passa attraverso il controllo delle emozioni assume il carattere d’involontaria bellezza e impone una diversa logica del rapporto tra parola e senso. Accetta che qualcosa sia Inständigkeit, ma anche Haíresis. E si dà alle cose, e consente che abbia voce quanto alle cose è più proprio: il loro tempo: il presente. La pluralità espressiva promuove una situazione precaria ma esaltante: creare un’opera affrancata da ogni schiavitù a un ordine manifesto del sentire. Il poeta si avventura su quel suolo originario dal quale nascono sequenze di suoni affini, grumi disordinati di sillabe, balbettii, afasie. E domanda a sua volta: cosa significa pensare quando il pensare si rivela come qualcosa di molto diverso dal possedere? In questo numero, “Anterem” disegna una cartografia di questo arduo intendere.
Flavio Ermini
Sommario
Rivista ANTEREM: Numero 71
L’ospite
7 Paul Wühr Colui (tr. Riccarda Novello)
8 Friederike Mayröcker Sensi di socievolezza (tr. Sara Barni)
10 Ursula Krechel Poesie (trad. Riccarda Novello)
15 Michele Ranchetti Da Sequenze in levare
18 Maria Angela Bedini Poesie
21 Ida Travi Lo spavento del bambino nella culla
24 Giacomo Bergamini Il viaggio
27 Silvano Martini La bocca del vento
28 Giorgio Bonacini Da Un corpo estraneo
30 Rafael Courtoisie Pietra per il tempio (tr. Lucio Sessa)
32 Herberto Helder Poesia (tr. Domenico Ingenito)
38 Jaime Siles Poesie (tr. Alessandro Ghignoli)
40 José Lezama Lima Universalità dello sfioramento (tr. Franco Mogni)
42 Yu Jan Dossier 0 (tr. Alessio Rosoldi)
58 Charles Tomlinson Fuoco primordiale (tr. Franca Morandi)
60 Madison Morrison Il grande poema (tr. Alessio Rosoldi)
65 Davide Campi Oblazioni
67 Carlo Invernizzi Poesie
69 Mara Cini Poesie dal grembiule del tempo
72 Pierre Alferi La più breve distanza (tr. Daniele Gorret)
74 Nicole Brossard Poesie (tr. Silvana Colonna)
76 Mathieu Bénézet Petrarca, forse (tr. Alfonso Cariolato)
84 Autori di questo numero
86 PREMIO DI POESIA LORENZO MONTANO
Esito della XIX edizione e Bando della XX
Disegni di Renée Lavaillante
C’est un mythe vous savez que le désir dissout les obstacles
© Sodart (Montréal) 2005


